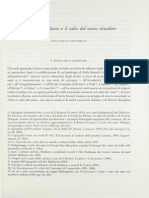Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
Artifoni Preistorie Del Bene Comune
Caricato da
Gustavo GonçalvesCopyright
Formati disponibili
Condividi questo documento
Condividi o incorpora il documento
Hai trovato utile questo documento?
Questo contenuto è inappropriato?
Segnala questo documentoCopyright:
Formati disponibili
Artifoni Preistorie Del Bene Comune
Caricato da
Gustavo GonçalvesCopyright:
Formati disponibili
CENTRO ITALIANO DI STUDI
SUL BASSO MEDIOEVO ACCADEMIA TUDERTINA
CENTRO ITALIANO DI STUDI
SUL BASSO MEDIOEVO ACCADEMIA TUDERTINA
IL BENE COMUNE:
IL BENE ECOMUNE:
FORME DI GOVERNO
GERARCHIE SOCIALI
FORME DI NEL
GOVERNO
GERARCHIE SOCIALI
BASSOEMEDIOEVO
NEL BASSO MEDIOEVO
Atti del XLVIII Convegno storico internazionale
Todi,Convegno
9-12 ottobre
2011
Atti del XLVIII
storico
internazionale
Todi, 9-12 ottobre 2011
FONDAZ ION E
C E NTR O I TALI ANO DI STUDI
S U LLALTO M E DIOE VO
S POLETO
2012
ENRICO ARTIFONI
Preistorie del bene comune.
Tre prospettive sulla cultura retorica
e didattica del Duecento
Alla memoria di Renato, con affetto
Laffermazione che esistano preistorie del bene comune prima
della sistemazione scolastica non certo originale. Il capitolo introduttivo del libro di Matthew Kempshall dimostra come il medioevo ricevette su questo tema una grande eredit antica 1, mentre sul
terreno della storia comunale, se vogliamo riferirci a studi di ampia
diffusione, Quentin Skinner ha individuato alcune voci di un linguaggio politico duecentesco disponibile ad articolarsi, in modi ancora da definire bene, con la riflessione degli scolastici. La ricostruzione di Skinner nasce soprattutto in collegamento con linterpretazione dellaffresco senese di Ambrogio Lorenzetti, ma anche quando
si sospenda il giudizio sulle implicazioni iconografiche, sulle quali
il dibattito aperto, ce ne rimangono contributi utili in s, che
hanno richiamato lattenzione sui testi della cultura pragmatica del
secolo XIII, dalle artes dictaminis alle opere didattiche ed enciclopediche alla manualistica per podest 2. Ancora per let comunale,
recente una ricerca di Andrea Zorzi sul bene comune e i conflitti
politici, in cui si propone una periodizzazione in varie fasi del lavo-
M. S. KEMPSHALL, The Common Good in late medieval political thought, Oxford, 1999,
pp. 1-25.
2
Q. SKINNER, Ambrogio Lorenzetti: the artist as political philosopher, in Proceedings of the
British Academy, 72 (1986), pp. 1-56; ID., Machiavellis Discorsi and the pre-humanist origins
of republican ideas, in Machiavelli and Republicanism, a cura di G. BOCK, Q. SKINNER, M. VIROLI, Cambridge, 1990, pp. 121-141, poi rielaborati con altri saggi in Q. SKINNER, Visions
of politics, II, Renaissance virtues, Cambridge, 2002 (una traduzione parziale del volume
Id., Virt rinascimentali, Bologna, 2006).
64
ENRICO ARTIFONI
ro intellettuale sulla nozione che ci interessa 3: alcune di queste fasi sono ben precedenti alla svolta rappresentata dallopera di Remigio de Girolami dallultimo decennio del secolo, risalgono anzi alla
met del Duecento.
Ma che cosa troviamo in questa preistoria duecentesca del bene
comune? Il richiamo al Girolami pu servire per istituire le giuste
differenze. Gi prima dei trattati de bono comuni, de bono pacis e de
iustitia, il sermone che Remigio indirizza nella prima met del
1295 ai Priori di Firenze, secondo di una serie di cinque sermoni,
unisce in modo perfetto il consiglio politico e unidea definita del
rapporto fra il tutto e le parti. I Priori sono esortati a quattro cose:
decidere secondo una provida deliberatio, condotta con scrupolo e
senza fretta; esprimersi in modo unanime in base a una comune e
concorde volont; badare che tutto sia fatto per il bene del comune
e non per il bene di famiglie, individui e gruppi, visto che chi
posto in carica per comune deve lavorare pro comuni bono; infine, portare a esecuzione quanto deliberato 4. Qui lidea del bene comune,
cio di un tutto che si istituisce come superiore alle parti che lo
compongono, chiaramente dispiegata con unattenzione particolare
alle condizioni istituzionali di svolgimento. Nella cultura pratica e
didattica dei governi comunali nei decenni precedenti non troviamo
accenti come questi. Troviamo invece un lavorio continuo su alcune
A. ZORZI, Bien Commun et conflits politiques dans lItalie communale, in De Bono Communi. The discourse and practice of the Common Good in the european city (13th-16th c.). Discours et
pratique du Bien Commun dans les villes dEurope (XIIIe au XVIe sicle), a cura di E. LECUPPREDESJARDINS, A.-L. VAN BRUAENE, Turnhout, 2010, pp. 267-290.
4
Il sermone si legge in G. SALVADORI, V. FEDERICI, I sermoni doccasione, le sequenze e i
ritmi di Remigio Girolami fiorentino, in Scritti vari di filologia [A Ernesto Monaci gli scolari,
MDCCCLXXVI-MDCCCCI], Roma 1901, p. 482, e in E. PANELLA, Nuova cronologia remigiana, in Archivum fratrum praedicatorum, 60 (1990), p. 189. Per la datazione cfr. SALVADORI, FEDERICI, I sermoni cit., p. 468 ( resta incerto se il discorso fu pronunciato nella prima
quindicina di febbraio, oppure tra il febbraio ed il luglio [1295] ), PANELLA, Nuova cronologia cit., p. 189 ( fine 1294-luglio 1295? ), S. GENTILI, Girolami, Remigio de, in Dizionario biografico degli Italiani, 56, Roma, 2001, p. 534 ( collocabile tra la fine del 1294 e
il luglio 1295 ). Al sermone attribuito particolare rilievo in J. K. HYDE, Contemporary
views on faction and civil strife in thirteenth- and fourteenth-century Italy, [1972], poi in ID.,
Literacy and its uses. Studies on late medieval Italy, a cura di D. WALEY, Manchester, 1993,
pp. 58-86, p. 64.
PREISTORIE DEL BENE COMUNE
65
idee-forza, da buono stato a pace, concordia, giustizia, citt e altre
che vedremo, le quali pervengono comunque a istituire un discorso
sul rapporto fra interessi particolari e utilit pubblica, un discorso
che, pur tenendo nel dovuto conto tutte le discontinuit, ci appare
come un grande sostrato geologico su cui potranno poggiare in seguito edifici pi robusti.
La questione, come si visto, gi stata affrontata, e per non
ripetere cose gi dette scelgo di trattarla attraverso fonti meno frequentate o guardando di altre fonti aspetti meno consueti. Dedicher una prima parte ad alcuni testi oratori tratti da quel continente
ancora insufficientemente esplorato che leloquenza dei laici nel
Duecento, una seconda parte a una umile letteratura etico-grammaticale di scuola, quella che Dionisotti chiamava una vegetazione
bassa, insieme effimera e tenacissima 5, una terza parte a un punto di non facile valutazione e di grande interesse, sul quale occorrer sviluppare le ricerche perch ne discendono conseguenze in ordine alla visione che taluni intellettuali pragmatici avevano del mondo comunale: cio alcune versioni effettivamente correnti nella seconda met del secolo sullorigine delle comunit umane. Tre scenari diversi come genere di appartenza, perch appunto potevano
essere diversificate le vie dellelaborazione pragmatica dei concetti.
1. Uninteressante notizia in un articolo di Paul Gehl serve a ribadire alcune avvertenze da tenere presenti nelluso dei testi oratori.
Un manoscritto italiano della Newberry Library di Chicago contiene una serie incompleta delle arringhe (i modelli di discorsi, soprattutto per ufficiali comunali) composte in volgare dal notaio bolognese Matteo dei Libri 6. La raccolta presumibilmente completa,
pubblicata da Eleonora Vincenti, conta sessantasei modelli, messi
C. DIONISOTTI, Leonardo uomo di lettere, [1962], poi in ID., Appunti su arti e lettere, Milano, 1995, p. 31, gi richiamato, nella prima edizione, in C. FROVA, La scuola nella citt
tardomedievale: un impegno pedagogico e organizzativo, in Le citt in Italia e in Germania nel
Medioevo: cultura, istituzioni, vita religiosa, a cura di R. ELZE, G. FASOLI, Bologna, 1981, pp.
119-143, p. 132, nota 25.
6
P. F. GEHL, Preachers, teachers and translators: the social meaning of language study in
Trecento Tuscany, in Viator, 25 (1994), pp. 289-323, p. 298.
66
ENRICO ARTIFONI
insieme in un periodo non determinabile negli anni Sessanta-Settanta del secolo (Matteo scompare nel 1275) 7. Nel manoscritto di
Chicago le carte di ognuna delle arringhe sopravvissute recano una
profonda piega orizzontale che dimostra come i singoli testi, usati
separatamente in occasioni diverse, fossero stati ridotti con una piegatura a dimensioni di facile portabilit, per stare in una tasca oppure in una manica. Una bella conferma in vitro di quanto gi molti anni fa diceva Cesare Segre, quando ricordava quei parlamenti
che il nuovo podest si teneva in tasca per fare bella figura presentandosi ai suoi sudditi 8. Questa era la fruizione standard delle
raccolte di discorsi, che non sono dunque da considerare in una
prospettiva di monumentalit trattatistica, ma alla stregua di unattrezzatura pratica per il mestiere della politica.
Si pu andare pi avanti, perch molti segnali, anche in scritti
di pi alta qualit culturale, indicano addirittura una smontabilit
interna delle orazioni e una loro possibilit di ricomposizione secondo geometrie ed esigenze variabili. Il celebre Liber de regimine civitatum di Giovanni da Viterbo contiene molti discorsi per podest,
alcuni organizzati in vere e proprie suites, tra cui emergono la serie
di tre discorsi di un nuovo podest che si presenta nel luogo di governo e quella di tre discorsi podestarili di guerra. Ognuno di questi testi presenta vere e proprie istruzioni per luso e indica alternative possibili. Per fare un esempio, nel caso della prima contio nove
potestatis si suggeriscono due formule iniziali diverse e cinque possibilit alternative per la parte immediatamente successiva dellorazione (a seconda che si parli in una citt indipendente, o soggetta
allimperatore, o al papa, o alla citt di Roma, o in altra situazione
non specificata), e analogamente i blocchi principali dei due discorsi successivi sono inframmezzati di vel sic, per suggerire, anche qui,
varie soluzioni possibili 9. In altro luogo del Liber, i tre discorsi di
MATTEO DEI LIBRI, Arringhe, a cura di E. VINCENTI, Milano-Napoli, 1974.
C. SEGRE, La sintassi del periodo nei primi prosatori italiani (Guittone, Brunetto, Dante),
[1952], poi in ID., Lingua, stile e societ. Studi sulla storia della prosa italiana, nuova ed. ampliata, Milano, 1974, p. 98.
9
IOHANNIS VITERBIENSIS Liber de regimine civitatum, a cura di G. SALVEMINI, in Scripta
anecdota glossatorum, III, Bologna, 1901(Bibliotheca iuridica medii aevi), capp. 45, 46, 47,
8
PREISTORIE DEL BENE COMUNE
67
guerra si riferiscono a un conflitto con un nemico pi potente, oppure pari o di poco minore, oppure decisamente inferiore: alcune
porzioni sono comuni ai tre testi, altre sono specificamente idonee
alla situazione in oggetto, e per altre ancora si suggerisce di ricorrere alquanto liberamente a parti dei discorsi precedenti 10. Una simile pratica di trasporto e ricollocazione di blocchi non ignota neppure in certi testi predicatori, ma nelloratoria civile diventa pressoch una costante 11. La spiegazione tocca alcune caratteristiche for-
pp. 230-232. Riporto il cap. 45, il pi breve: Ego facio pregum domino potestati et
sue compangie et sue curie et sapienti consilio huius civitatis et militibus et peditibus,
magnis et minoribus, et toti bone genti congregate huic arengo, quod per vestrum honorem ego debeam audiri et intelligi; vel: quod ipse potestas per suum honorem et vos per
vestrum me debeatis audire et intelligere, sive vulgariter scilicet: intendere usque ad finem. Et dicat et incipiat postea sic: Ego clamo merc et facio prego allaltissimo deo
nostro singnore, et gloriosissime virgini Marie sue matri, et ad messere sancto Iohanni,
seu alii precipuo sancto illius civitatis, et omnibus sanctis suis, quod ipse, per suam sanctissimam misericordiam et pietatem, mihi permittat et concedat dire id quod sit suus
honor sanctissimus et suum placere, et honor domini potestatis et sue compangie, sit honor et gloria; et magnitudo et incrementum, pax, concordia et bonus status totius communis huius civitatis, et omnibus amicis huius communis grandis allegrana et grandis favor et magnum in omnibus incrementum. Vel sic, si civitas est subdita imperatori, post
deum et sanctos dicat primo: Quod sit honor domini nostri imperatoris et reliqua, ut
supra. Si vero subiaceat domino pape dicat: Quod sid honor domini pape et Romane ecclesie. Vel si subiacet Romane urbi, dicat: Quod sit honor domini senatoris et Romani
populi. Vel aliter potest dicere ibi, scilicet post pietatem: Kal mio dire sibi debeat esse
ad placere, seu sibi debeat placere in id quod sit suus honor sanctissimus et cet. Postea
sic potest incipere, vel sic incipiat (segue il cap. 46). Sullinteressante impasto linguistico, tipico di una traccia latina per un discorso in volgare, cfr. G. FOLENA, Parlamenti
podestarili di Giovanni da Viterbo, in Lingua nostra, 20 (1959), pp. 97-105. Sui rituali degli
ingressi podestarili si veda C. DARTMANN, Adventus ohne Stadtherr. Herrschereinzge in den
italienischen Stadtkommunen, in Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken, 86 (2006), pp. 64-94.
10
IOHANNIS VITERBIENSIS Liber cit., capp. 132-134, pp. 270-273.
11
Per la predicazione, a titolo desempio, si veda il seguente caso da Les sermons et la
visite pastorale de Federico Visconti archevque de Pise (1253-1277), dition critique par N.
BRIOU, I. LE MASNE DE CHERMONT avec la collaboration de P. BOURGAIN, M. INNOCENTI, Rome, 2001, 47, p. 703, predica per la festa di santAgostino, 28 agosto: Prosequeris hanc
distinctionem prout habetur in VI sermone, dominica quarta Adventus, qui incipit: Sic nos
existimet homo ut ministros Christi et prosequeris eam quasi usque in finem illius sermonis;
et etiam eadem habentur in sermone VII quem fecimus apud Sanctum Xistum in fraternitate cappellanorum qui incipit: Qui bene presunt presbiteri .
68
ENRICO ARTIFONI
mali tipiche delleloquenza dei laici, prima fra tutte la sua derivazione dalle pratiche formulari dellars dictaminis, che funzionavano
come una specie di ordinatore mentale. un discorso tecnico, gi
svolto in altre occasioni, che ci portebbe lontano dal nostro argomento 12. Limitiamoci a prenderne in carico le conseguenze: occorre
esercitare uno sforzo di lettura che tenga ben presenti le concrete
condizioni duso di questi lacerti oratori, che non compongono di
solito dei trattati organici. Non unoccasione perduta in una prospettiva di storia del pensiero politico; al contrario, abbiamo cos la
possibilit di ricostruire una gran messe, non di trattati, ma di repertori di argomenti politici, i termini di una specie di parlato di
governo quotidianamente diffuso e rilanciato.
Ci detto, fermiamoci appunto sulle arringhe di Matteo dei Libri, raccolta che ebbe una certa fortuna, tant vero che ne derivano
almeno altre due opere, il Flore di parlare di Giovanni da Vignano e
le Dicerie di Filippo Ceffi 13. E notiamo in primo luogo uno spostamento esplicito della raccolta, che sta, ripetiamo, tra gli anni Sessanta e i Settanta, verso la dimensione pubblica: si tratta per lo pi
di orazioni per podest, consiglieri comunali, ambasciatori e capitani del popolo; e quando i parlatori non sono ufficiali pubblici, il
contenuto dellorazione tocca da vicino questioni di rilevanza collettiva, come discordie familiari e vendette. Le orazioni di tipo privato
12
Si veda, da ultimo, E. ARTIFONI, Loratoria politica comunale e i laici rudes et modice literati, in Zwischen Pragmatik und Performanz: Dimensionen mittelalterlicher Schriftkultur, a cura di C. DARTMANN, T. SCHARFF, C. F. WEBER, Turnhout, 2011, pp. 237-262 (con bibliografia precedente); rimane fondamentale P. VON MOOS, L ars arengandi italienne du XIIIe
sicle. Une cole de la communication, [1993], in ID., Entre histoire et littrature. Communication
et culture au moyen ge, Firenze, 2005, pp. 389-415. Utile ora in generale la raccolta di studi Cum verbis ut Italici solent ornatissimis. Funktionen der Beredsamkeit im kommunalen Italien/Funzioni delleloquenza nellItalia comunale, a cura di F. HARTMANN, Gttingen, 2011.
13
E. VINCENTI, Matteo dei Libri e loratoria pubblica e privata nel 200, in Archivio glottologico italiano, 54 (1969), pp. 227-237. Il caso di Matteo stato toccato anche in interventi
pi recenti, come SKINNER, Ambrogio Lorenzetti cit. e Machiavellis Discorsi cit., VON MOOS,
L ars arengandi italienne cit., pp. 407-409, V. COX, Ciceronian rhetoric in Italy, 1260-1350,
in Rhetorica, 17 (1999), pp. 239-288, pp. 256-257, e S. J. MILNER, Communication, consensus
and conflict: rhetorical precepts, the ars concionandi, and social ordering in late medieval Italy, in
The Rhetoric of Cicero in its medieval and early Renaissance commentary tradition, a cura di V.
COX, J. O. WARD, Leiden, 2006, pp. 365-408, pp. 380-384.
PREISTORIE DEL BENE COMUNE
69
o intrafamiliare che ancora comparivano, per esempio, nei Parlamenti ed epistole di Guido Faba, degli anni Quaranta, cedono il passo a
una risoluzione integrale del parlare nel parlare politico 14. Notiamo
in secondo luogo che, per la prima volta a mia conoscenza nei modelli oratori, il capitano del popolo assunto nel novero degli
oratori ufficiali, come a registrare la nuova geografia dei poteri urbani tipica della seconda met del secolo (a Bologna, patria di Matteo, la comparsa di un capitano del popolo del 1255). E infine
rileviamo che su sessantasei discorsi ben ventidue hanno a che fare
in senso lato con la divisione delle citt in partes, il perseguimento
dei responsabili di crimini di sangue, la discussione sulla giustizia
da esercitare nei confronti di chi ha compiuto delitti faziosi, la concessione di poteri al podest per la repressione delle discordie: la
condizione delle citt che vi contemplata come consueta una
condizione di divisione 15. Soprattutto intorno a questo stato di cose si articola il linguaggio di Matteo, organizzandosi, nella discontinuit tipica di una raccolta di brani, in due insiemi contrapposti.
Da un lato prende forma una sequenza positiva piuttosto usuale. Il fine del governo del rettore il buono stato della citt, bon
stato, bonu reposo, la nostra tranquilitate e bene , oppure lo nostro stato no se posse minuir de niente, ma sempre crescere e montare de ben in meglio , oppure kel bon stato nostro e pacifico
acresca sempre de ben in meglo , o ancora, nel discorso di congedo
di un podest: E voglio ke saati, signori, una cosa, ke tuto meo
pensero e tuta mia fede stato in dicere et in fare tuto quello ke
sia grandea, honori, bon stato e bon reposo de questo communo 16. Il traguardo del buono stato pu essere raggiunto attraverso
la pace e la concordia, perch vedemo ad oclo que la concordia et
lunitate acrese et avana tuti beni . Condizione di pace e concordia la giustizia: per quello ke ascuno homo k debitore a la
raxone ama iustitia, quel kama iustitia ama constante e perpetua
14
Unica eccezione esplicita larringa 48 (MATTEO DEI LIBRI, Arringhe cit., p. 137-141),
discorso di uno scolaro alla sua famiglia e ai suoi amici.
15
Ibid., arringhe 4, 5, 6, 11, 12, 14, 22, 23, 24, 42, 43, 44, 45, 47, 50, 51, 53, 54,
55, 56, 58, 59. Su quanto segue cfr. anche ZORZI, Bien Commun cit., pp. 275-277.
16
MATTEO DEI LIBRI, Arringhe cit., 2, p. 8; 5, pp. 18-19; 50, p. 147; 33, p. 99.
70
ENRICO ARTIFONI
voluntate de dare soa raxone a ascuno; e ki ama soa raxone a ascuno, ama tranquilitate e reposo, per le qual cose le terre montano
in grand grandea . In sintesi, giustizia ispira pace e concordia,
che a loro volta generano buono stato e prosperit 17.
Dalla parte negativa della vita civile, e con una rilevanza nettamente superiore nelle orazioni, alligna per la contrapposizione, la
contrastanza, che secondo lo schema genealogico gi visto adduce alla decadenza e al guasto della terra: contrastana, la quale
genera inimistate, e la inimistate genera batagle, le quale disogliano lege et abassa et guasta la terra . In uno dei pochi luoghi che
sembrano tradire una certa commozione, Matteo mette in bocca a
un capitano del popolo uninvettiva contro i furori cittadini, che
traduce nelloratoria una certa indubbia conoscenza del panorama
politico: Pensative de Florencia, de Sena, commo son gite per la
guerra dentru. Pensative de Milano, ke fo la maior terra de Lombardia, de molte altre terra de quella contrata, kenno quasi a niente de quello kerano. Pensative de Rimino, comm cono per lodio
dentro, e de multe terre de quella contrata 18. Posto il conflitto
come protagonista, il percorso ideale che abbiamo visto prima, da
giustizia a pace a prosperit, perde ogni carattere unanimistico e le
sue tappe diventano concretamente un durissimo esercizio di giustizia contro le partes, unimposizione armata della pace, e una prosperit o buono stato che si costruisce a partire dalla liquidazione dei
nemici dellordine.
In questa direzione abbiamo solo limbarazzo della scelta. Il discorso di presentazione di un podest al consiglio appena insediato
promette di punire arditamente li mafactori, e non guardando a
gentilea, n a ricchea, n che lo malfactore sia parente overo
amico , e continua minaccioso: Et per pregho ciascuno che bene
faccia et bene dica, et che si guardi del contrario . Poco prima un
17
Ibid., 5, p. 18; 10, p. 34. Sui diversi aspetti della parola di pace nelloratoria comunale, laica e religiosa, cfr. R. M. DESS, Pratiche della parola di pace nella storia dellItalia
urbana, in Pace e guerra nel basso medioevo, Spoleto, 2004 (Atti dei convegni del Centro italiano di studi sul basso Medioevo - Accademia Tudertina e del Centro di studi sulla spiritualit medievale, 40), pp. 271-312.
18
MATTEO DEI LIBRI, Arringhe cit., 10, p. 35; 50, p. 147.
PREISTORIE DEL BENE COMUNE
71
altro modello propone unorazione podestarile di richiesta al consiglio di maggiori poteri per una migliore salvaguardia dellordine:
E quella cosa, signori, per la quale le citate e le terre pl acresce
et avana questa, ke li malifitii se punisca. E se non se puniseno,
guardati et vedeti quanto si alargerebo le mane a li malfaturi e
quanto creserebbe lo male. E molte terre vedete keno gite a male,
perk li malifici non nno puniti . Che qui, come prima, i malfattori siano i cospiratori politici provato dallammonimento finale
ai consiglieri: prendete la decisione che vi pare migliore, perch
quelli che hanno un cuore colpevole, nel caso che qualcuno di loro
sia tra di voi, debbano infine sputare il loro veleno ( Conseliarite
quello, sa Deo place, ke ser le megle de voi, e perk quilli knno
reo core, salcun tra voi, dibia sputare via omne tosego et omne
reo ) 19. Siamo di fronte a unautorit comunale che si presenta secondo un volto eminentemente coercitivo. A questo volto i discorsi
proposti per i capitani del popolo aggiungono un tratto di inesorabilit, come nella straordinaria arringa 50 (straordinaria perch richiama una concretissima situazione istituzionale), un discorso in
cui un capitano del popolo richiama energicamente un podest ad
essere durissimo con le parti e, come abbiamo gi visto, descrive la
rovina delle citt che hanno lasciato mano libera alle fazioni. Aggiungo adesso che una citt per si distingue dal panorama, Bologna, in cui il popolo ha saputo frenare le congiure, ricavandone
prosperit: Pensati del gran stato in lo qual Bologna, per la
gran constana e la gran fermea in la qual ella stata, per lonorevole povolo de quella citate, la quale maior terra dItalia, per
quello ke, salcuno romore nascen quella terra, incontinenti vivamente se li fa denati e fa quello che viaamente se tol via 20.
Anche se non siamo informati con certezza sulla posizione politica personale di Matteo, di cui, oltre a queste arringhe, ci sono
19
Ibid., 35, pp. 104-105; 22, p. 69; 22, p. 70. Siamo in quella zona di discorsi politici aggressivi e ispirati a una logica di esclusione rilevata per lultimo quarto del Duecento e per il primo Trecento da P. CAMMAROSANO, lites sociales et institutions politiques des
villes libres en Italie de la fin du XIIe au dbut du XIVe sicle, in Les lites urbaines au moyen
ge. XXIXe Congrs de la S.H.M.E.S. (Rome, mai 1996), Paris, 1997, pp. 193-200, p. 196,
che non a caso cita come esempio Filippo Ceffi, appunto derivato da Matteo dei Libri.
20
MATTEO DEI LIBRI, Arringhe cit., 50, p. 147-148.
72
ENRICO ARTIFONI
giunti solo alcuni lavori di arte dettatoria studiati e in parte pubblicati
da Kristeller 21, non si sbaglier dicendo, vista la sua scelta di includere molti discorsi del capitano e di considerarlo come una parte stabile
della scena istituzionale e vista la stessa maggiore densit politica dei
discorsi capitaneali, che la sua raccolta nasce in unatmosfera di popolo, il che non stupirebbe quando si pensi che la societ dei notai bolognese fu uno dei punti di forza del governo popolare. Detto questo,
aggiungiamo un ultimo elemento al repertorio degli argomenti, dopo i
nuclei gi visti. I discorsi del capitano profilano chiaramente una autopresentazione del popolo fondata in sostanza su due punti. Da un lato la societ popolare non si presenta mai come una parte, sia pure la
maggiore, fra altre parti, bens come il presidio di interessi generali; e
daltro canto essa reclama o attua interventi durissimi ma sempre in
nome di un ordine generale cittadino rispetto al quale il capitano si
erige, ben pi del podest, a principale rappresentante. Con tutto ci,
per segnare delle soglie che continuo a credere doverose, questa riflessione politica pragmatica e intermittente mi pare che continui a situarsi al di qua di una certa linea di demarcazione rispetto al pensiero del
bene comune, perch questultimo presuppone una capacit di pensare
il Politico in termini categoriali e impersonali, laddove questi testi della prassi continuano a pensarlo essenzialmente in riferimento alle figure
dei rettori e alla loro maggiore o minore capacit di tutelare un interesse collettivo.
Unultima notazione ci porta verso il secondo argomento, quello
della letteratura scolastica. Eleonora Vincenti nella sua edizione di
Matteo dei Libri ha giustamente insistito sullo spirito sentenzioso del
notaio bolognese, tanto evidente da indurla a redigere un utile elenco
delle sentenze contenute nelle arringhe 22. Accanto al grande giacimento dei libri sapienziali, soprattutto i Proverbi e lEcclesiastico, lelenco
ci mostra i soliti rivoli in entrata nella cultura didattica duecentesca
21
P. O. KRISTELLER, Matteo de Libri, Bolognese notary of the thirteenth century, and his artes
dictaminis, in Miscellanea Giovanni Galbiati, II, Milano, 1951, pp. 283-320; le informazioni essenziali sono in G. TAMBA, Libri, Matteo, in Dizionario biografico degli Italiani, 65, Roma, 2005, pp. 64-65.
22
E. VINCENTI, Sentenze e spirito sentenzioso in Matteo e Per un repertorio delle sentenze, in
MATTEO DEI LIBRI, Arringhe cit., pp. CVIII-CXV, pp. CXXX-CLXIII.
PREISTORIE DEL BENE COMUNE
73
(nel caso di Matteo, peraltro, sempre mediati da quel grande bacino di
smistamento che furono i trattati di Albertano da Brescia); e dunque
troviamo gli onnipresenti Disticha Catonis, le Sentenze di Publilio Siro,
lo pseudo-Seneca della Formula honestae vitae (cio Martino da Braga), il
Moralium dogma philosophorum, il Pamphilus, una commedia anonima del
secolo XII presto ridotta a serbatoio di dicta. Non sar inutile un sondaggio sul significato di questa letteratura nella cultura comunale in
ordine al tema che ci interessa.
2. Si pu entrare in argomento per una via laterale, costituita
da due fonti narrative di cui indico brevemente le circostanze. La
prima la cronaca di Rolandino da Padova. Un certo giorno del
1249, mentre era da poco podest di Padova Ansedisio Guidotti,
nipote di Ezzelino da Romano e vicario imperiale nella Marca Trevigiana, si trovano come al solito a parlare nel palazzo podestarile
multi milites et burgenses 23. In una sala, sopra una pertica, c uno
sparviero. A uno dei presenti, aliquis litteratus, davanti allo sparviero vengono alla mente certi versi che stanno in libro qui appellatur Ysopus , e li recita (trad. Fiorese):
Per respingere gli attacchi del nibbio, le colombe
prendono a re lo sparviero, ma il re nuoce pi del nemico.
Incominciano a lagnarsi del re, perch era meglio
subire gli attacchi del nibbio che morire senza lottare 24.
I versi piacciono, sono messi per iscritto e cominciano a circolare sine fraude , senza malizia, dice il cronista, tant vero che li
23
Per quanto segue si veda ROLANDINO, Vita e morte di Ezzelino da Romano (Cronaca), a
cura di F. FIORESE, l. VI, cap. 4 e sgg., Milano, 2004, p. 276 sgg., con utile annotazione,
senza trascurare il commento in ROLANDINI PATAVINI Cronica in factis et circa facta Marchie
Trivixane, a cura di A. BONARDI, Citt di Castello, 1905-1908 (R.I.S., n.s., 8/1), p. 89 sgg.
Il Liber regiminum Padue (in ROLANDINI PATAVINI Chronica cit., p. 319) colloca linizio della
podesteria padovana di Ansedisio Guidotti, e i fatti conseguenti, nel 1250. Al brano rolandiniano ha dato rilievo di recente L. TANZINI, Dai comuni agli stati territoriali. LItalia
delle citt tra XIII e XV secolo, Parma, 2010, pp. 95-97.
24
ROLANDINO, Vita e morte cit., p. 279: Accipitrem, milvi pulsurum bella, collunbe/Accipiunt regem; rex magis hoste nocet./Incipiunt de rege queri, quia sanius esset /
milvi bella pati, quam sine marte mori .
74
ENRICO ARTIFONI
ascolta con diletto anche il giudice del podest. Ma alla fine, quando qualcuno li riporta ad Ansedisio, anche qui secondo il cronista
sine fraude , sono interpretati come unallusione politica esplicita: il podest fa incarcerare il suo stesso giudice e i cittadini coinvolti nella vicenda, una dozzina ( notarios et populares, qui ad audiendos versus steterant, et iudices quosdam etiam ). Pochi giorni
dopo arriva in citt Ezzelino da Romano, il quale in un furibondo
discorso denuncia dietro lepisodio una congiura dei Dalesmanini e
proclama di non essere affatto lo sparviero che divora le colombe,
bens il sollecito padre di famiglia deciso a ripulire la casa da scorpioni, rospi e serpi. La conclusione tragica, perch dapprima il
giudice del podest e poco dopo alcuni di quelli che Rolandino
chiama ormai illi de versibus, quasi tutti notai e giudici, sono alla fine decapitati 25. Rimando il commento e passo ad Asti, 1310. Il
cronista e mercante di spezie Guglielmo Ventura, a lungo militante
della societ popolare di Asti, inserisce a quellanno nella sua cronaca (il Memoriale de gestis civium Astensium) un capitolo di disposizioni
testamentarie riservate ai figli 26. Prima ancora dei beni materiali,
Guglielmo vuole trasmettere un patrimonio morale di insegnamenti, in un capitolo molto lungo che non si pu esaminare nei dettagli. Sintetizzando, al primo posto stanno il timore di Dio e il precetto di onorare la madre. Fa subito seguito la raccomandazione di
obbedire al comune, mostrandosi fedeli ad esso e pronti a prendere
le armi contro i nemici della citt, come sta scritto in Catone ( ut
in Catone scriptum est: Pugna pro patria ). I fratelli si amino fra
loro, coltivino le amicizie oneste e facciano molta elemosina. Curino
la loro cultura: leggano il pi spesso possibile i testi sacri, lascino
da parte le favole scritte nei libri che chiamano romanzi, che io, dice Guglielmo, ho sempre odiato ( fabulas scriptas in libris qui ro-
25
Ibid., l. VI, cap. 8, p. 29: De morte illorum de versibus .
Memoriale Guilielmi Venturae civis Astensis de gestis civium Astensium et plurium aliorum,
a cura di C. COMBETTI, in Monumenta Historiae Patriae, V, Torino, 1848, cap. 57, coll. 773776. Una lettura aggiornata della cultura del cronista in B. GAROFANI, Un cronista di popolo e le stirpi signorili: prospettive su Guglielmo Ventura, in Il Monferrato: crocevia politico, economico e culturale tra Mediterraneo e Europa, a cura di G. SOLDI RONDININI, Ponzone, 2002, pp.
141-155.
26
PREISTORIE DEL BENE COMUNE
75
mani vocantur, vitare debeant, quae semper odio habui ), e leggano attentamente Catone finch potranno, quel Catone che in una
sentenza esorta a non smettere di imparare: discere ne cesses, cura
sapientia crescit .
Qualche osservazione indispensabile. Il liber Ysopus a cui allude
Rolandino una silloge di sessanta favole in distici elegiaci, in realt di derivazione fedriana, in passato attribuita senza troppo fondamento da Hervieux a Gualtiero Anglico, che lavrebbe composta
verso il 1175. La favola citata da Rolandino fa effettivamente parte
di questa silloge, con il titolo De accipitre et columbis, e i versi sono
riportati testualmente 27. In quanto allepisodio in s, accolto in
una versione abbreviata anche nel Liber regiminum Padue, che daltra
parte riporta pi ampiamente la citazione esopica. Semmai lascia
perplessi nella versione di Rolandino laffermazione iterata che quei
versi su uno sparviero che divora le colombe fossero stati recitati, e
proprio nel palazzo del podest, davvero senza alcuna malizia. Nessun problema per il brano di Guglielmo Ventura, perch le favole
dei romanzi sono evidentemente la materia cavalleresca, a cui il cronista contrappone come modello etico e di cultura, due volte citato
ma presente nel passo al di l delle citazioni esplicite, i notissimi
Disticha Catonis, un manuale in versi di moralit urbana risalente al
III secolo che ebbe per tutto il medioevo, come ben noto, una
fortuna ininterrotta 28.
27
Si pu leggere, oltre che in tutte le raccolte degli auctores octo (per le ragioni dette
pi avanti nel testo), in L. HERVIEUX, Les fabulistes latins depuis le sicle dAuguste jusqu la
fin du moyen ge, II, Paris, 1884, p. 395 e, meglio, in appendice a Lyoner Yzopet. Altfranzsische bersetzung des XIII. Jahrhunderts [...] mit dem kritischen Text des lateinischen Originals
(sog. Anonymus Neveleti), a cura di W. FOERSTER, Heilbronn, 1882, p. 108 (in entrambe le
edizioni il testo 22). SullEsopo in distici si trovano schede precise, con bibliografia, in
Esopo toscano dei mercanti e dei frati predicatori, a cura di V. BRANCA, Venezia, 1989, pp. 4649 e in J. MANN, La favolistica, in Lo spazio letterario del Medioevo. 1. Il Medioevo latino, I/2,
Roma, 1993, pp. 171-195, pp. 181-182.
28
B. MUNK OLSEN, I classici nel canone scolastico altomedievale, Spoleto, 1991, pp. 59-63.
Su alcune ragioni dellenorme fortuna dellopera cfr. R. HAZELTON, The christianization of
Cato: The Disticha Catonis in the light of late mediaeval commentaries, in Mediaeval Studies,
19 (1957), pp. 157-173. Per i volgarizzamenti utile P. ROOS, Sentenza e proverbio nellantichit e i Distici di Catone, Brescia, 1984. Molto sui Disticha si trova ora in Tradition des
proverbes et des exempla dans lOccident mdival, a cura di H. O. BIZZARRI, M. ROHDE, Berlin,
76
ENRICO ARTIFONI
Sul perch si dia per scontato che un membro del ceto dirigente padovano potesse normalmente citare le favole di Esopo e perch
un mercante astigiano facesse della saggezza di Catone il perno di
un lascito morale e la filigrana di un lungo capitolo, in altre parole
perch questi materiali siano considerati tanto vulgati da non richiedere alcuna spiegazione, la risposta la pi semplice possibile
ma ha qualche conseguenza: i protagonisti ci avevano studiato sopra
imparando il latino. Tanto lEsopo quanto, ancora di pi, il Catone,
erano una parte fissa di quellinsieme di testi su cui si conduceva
lalfabetizzazione latina, come ancora ricordava a fine Trecento il
predicatore Giovanni Dominici, lodando gli antichi sistemi educativi contro la pedagogia umanistica:
Intendo i nostri antichi viddono lume dottrinando la puerizia, e i moderni fatti
son ciechi, fuor della fede crescendo lor figliuoli. La prima cosa insegnavano era
il saltero e dottrina sacra; e se gli mandavano pi oltre, avevano moralit di Catone, finzioni dEsopo, dottrina di Boezio, buona scienzia di Prospero tratta di
santo Agostino, e filosofia d Eva columba, o Tres leo naturas, con un poco di poetizzata Scrittura santa nello Aethiopum terras; con simili libri studiavano, de quali
nullo insegnava mal fare 29.
I rimandi non trasparenti vanno agli epigrammi di Prospero dAquitania e ad alcune opere indicate con lincipit: il Dittochaeon o Tituli
historiarum di Prudenzio (Eva columba), il Physiologus in versi (Tres leo
naturas), legloga di Teodulo (Aethiopum terras). Si richiama spesso su
questi temi il canone degli auctores octo, anche se di recente si insistito sul fatto che esso appare piuttosto una sistematizzazione posteriore
intervenuta con le prime edizioni a stampa 30. Limitiamoci perci a in-
2009, in cui interessano qui soprattutto i saggi di A. DAGOSTINO, Letteratura di proverbi e
letteratura con proverbi nellItalia medievale, pp. 105-129 e di D. CARRON, Prsence de la figure
de Caton le philosophe dans les proverbes et exemples mdivaux. Ses rapports avec les Disticha Catonis , pp. 165-190.
29
G. DOMINICI, Regola del governo di cura familiare, a cura di D. SALVI, Firenze, 1860, p. 134,
un brano spesso citato su cui si veda, per esempio, C. T. DAVIS, Listruzione a Firenze nel tempo
di Dante, [1965], poi in ID., LItalia di Dante, Bologna, 1988, pp. 135-166, p. 140.
30
Ricchissimo di informazioni sullargomento R. AVESANI, Quattro miscellanee medioevali e umanistiche. Contributo alla tradizione del Geta, degli Auctores octo, dei Libri minores e
di altra letteratura scolastica medioevale, Roma, 1967; nitida esposizione degli auctores octo,
PREISTORIE DEL BENE COMUNE
77
dividuare una zona, non rigidamente definita, di testi ricorrentemente
usati per linsegnamento della grammatica, da quelli citati da Giovanni Dominici ad alcuni altri che si potrebbero aggiungere 31; e questa
zona, nella quale Catone ed Esopo sempre compaiono, appare come
uno dei grandi fiumi di alimentazione della letteratura morale e didattica, perch ritroviamo per ogni dove i suoi contenuti, a volte buttati
l come massi erratici, ma sempre pronti alla memoria, perch avere
una certa conoscenza del latino significava essere entrati in contatto almeno con qualcuna di queste opere, e averla a disposizione nello strato
profondo della propria forma mentis. La polemica umanistica ha assunto
queste scritture didattiche come uno dei suoi bersagli e oggi si rischia
di trascurarle come un sedimento inerte. Ma le due fonti narrative da
cui ho preso le mosse mostrano invece unaltra situazione, mostrano
detto con tutta semplicit che si trattava di materiale attivo, cio che
con Catoni ed Esopi e simili si potevano istituire dei discorsi attuali.
Approfondiamo appunto il caso dei Disticha Catonis, che furono
senza alcun dubbio una scrittura diffusissima 32. Come accennato, il
Catone un manuale di comportamento in versi usato per studiare
il latino, vale a dire che la sua stessa fisionomia ci insegna due cose
fondamentali: come tutte le opere in versi era facilmente memorizzabile, una caratteristica ulteriormente esaltata dai metodi di insegnamento che tendevano a una vera e propria interiorizzazione del
testo; proponeva un contenuto di moralit che andava al di l del
livello tecnico-grammaticale, tanto che possiamo considerarlo il testo tipico di una grammatica considerata come unarte morale, secondo il titolo del bel libro di Paul Gehl 33. Ritornando alle parole
con bibliografia precedente, in FROVA, La scuola cit., pp. 128-130; P. F. GEHL, A moral art.
Grammar, society and culture in Trecento Florence, Ithaca, 1993, p. 13, parla degli auctores octo
come di a marketing come-on by french printers of the fifteenth century .
31
Anche sulla base di FROVA, La scuola cit., pp. 129-130.
32
P. F. GRENDLER, La scuola nel Rinascimento italiano, [1989], Roma-Bari, 1991, pp.
215-217; GEHL, A moral art cit., pp. 107-134 (capitolo dedicato a fruizione e fortuna dei
Disticha e dellEsopo); R. BLACK, Humanism and education in medieval and renaissance Italy,
Cambridge, 2001.
33
GEHL, A moral art cit., pp. 116-120, sulle forme di interiorizzazione mmemonica del
testo (con richiamo a M. CARRUTHERS, The Book of Memory. A study of memory in medieval
culture, Cambridge, 1990).
78
ENRICO ARTIFONI
di Giovanni Dominici, i Disticha Catonis erano al primo posto nella
lista di quei testi de quali nullo insegnava mal fare . E in quanto a questa etica risalente al III secolo, se lasciamo da parte una
quota di portata atemporale sui rapporti genitori-figli, marito-moglie, padroni e servi, sulla cautela necessaria in tutto, sul controllo
dei sentimenti, questa etica, a vederla da vicino offriva vari punti
di aggancio che potevano essere precisamente articolati con problemi forti della societ urbana duecentesca.
Il primo senzaltro la custodia delle parole, tema a cui non a
caso il giudice Albertano da Brescia dedic un trattato apposito nel
1245, la Doctrina dicendi et tacendi, unopera ripresa quasi integralmente da Brunetto Latini nel Tresor. Ora, sentenze come queste
contenute nei Disticha: Virtutem primam esse puta conpescere
linguam;/proximus ille deo est, qui scit ratione tacere (I, 3,
36) 34, oppure Contra verbosos noli contendere verbis:/sermo datur cunctis, animi sapientia paucis (I, 10, 42), o ancora Adversum notum noli contendere verbis:/his rebus minimis interdum
maxima crescunt (II, 11, 112), sentenze come queste e molte altre
consimili, cadevano appropriate in una societ che si interrogava costantemente sul parlare e sul tacere, sul significato e le conseguenze
dello scambio verbale 35. Una rilevanza non minore ha la questione
della fama, che centrale in una societ di interconoscenza, era normalmente evocata nelle procedure giudiziarie e aveva anche precise
applicazioni politiche quando si procedeva alla stesura di liste di
proscrizione. Su questo, Catone aveva qualcosa da dire: Luxuriam
fugito, simul et vitare memento/crimen avaritiae; nam sunt contraria famae (II, 19, 121); Si famam servare cupis, dum vivis, honestam,/fac fugias animo, quae sunt mala gaudia vitae (IV, 17,
213). Terzo, onnipresente, una convinzione profonda in merito al
fatto che luomo pu essere educato e migliorato attraverso la cul-
34
Cito secondo Disticha Catonis, a cura di M. BOAS, H. J. BOTSCHUYVER, Amsterdam,
1952, indicando fra parentesi tonde libro dellopera, numero della sentenza, numero di
pagina.
35
Basta ricordare il libro che ha indicato una nuova direzione di studio: C. CASAGRANDE, S. VECCHIO, I peccati della lingua. Disciplina ed etica della parola nella cultura medievale,
Roma, 1987.
PREISTORIE DEL BENE COMUNE
79
tura, linsegnamento, la lettura e la meditazione dei buoni esempi.
Qui lappello martellante: impara dallesempio di molti che cosa
seguire e che cosa evitare; impara qualcosa, la conoscenza rimarr
per le ore incerte; impara dai dotti e insegna agli indotti, la buona
conoscenza va fatta circolare; non smettere di imparare, la sapienza
cresce con limpegno ( una delle sentenze ricordate da Guglielmo
Ventura) 36. Lesortazione arriva talvolta a toni toccanti, sine doctrina vita est quasi mortis imago , e non si limita alla lode di
uneducazione liberale: applicati con zelo, qualunque arte tu impari,
perch come la cura aiuta lingegno, cos la mano aiuta la pratica 37.
Ora, questa fiducia nella migliorabilit umana, con tutto ci
che ne discendeva in termini di compiti educativi dei litterati,
esattamente il tema che sta alla base di una intensa stagione della
cultura comunale tra il 1240 e il 1270, quando lattivit degli intellettuali pragmatici si mosse verso una grande pedagogia dei costumi sociali, nel segno di quella volont di digrossare i cittadini (cio di raffinarli attraverso un processo educativo) che Giovanni
Villani attribu a Brunetto Latini in un famoso ricordo post mortem 38. E infine, non va affatto trascurato, se non altro perch labbiamo visto come uno dei precetti lasciati dal Ventura ai suoi figli,
il brevissimo pugna pro patria, che tutti potevano traslitterare men-
36
Disticha Catonis cit., III, 13, p. 168: Multorum disce exemplo quae facta sequaris,/quae fugias, vita est nobis aliena magistra ; IV, 19, p. 215: Disce aliquid, nam,
cum subito fortuna recessit,/ars remanet vitamque hominis non deserit unquam ; IV, 23,
p. 219: Disce sed a doctis, indoctos ipse doceto:/propaganda etenim est rerum doctrina
bonarum ; IV, 27, p. 227: Discere ne cessa, cura sapientia crescat:/rara datur longo
prudentia temporis usu .
37
Ibid., III, 1, p. 152: Instrue praeceptis animum, ne discere cessa;/nam sine doctrina vita est quasi mortis imago ; IV, 21, p. 217: Exerce studium, quamvis perceperis
artem:/ut cura ingenium, sic et manus adiuvat usum .
38
Si veda E. ARTIFONI, Prudenza del consigliare. Leducazione del cittadino nel Liber consolationis et consilii di Albertano da Brescia (1246), in Consilium. Teorie e pratiche del consigliare nella cultura medievale, a cura di C. CASAGRANDE, C. CRISCIANI, S. VECCHIO, Firenze,
2004, pp. 195-216, e ID., Tra etica e professionalit politica: la riflessione sulle forme di vita in
alcuni intellettuali pragmatici del Duecento italiano, in Vie active et vie contemplative au moyen
ge et au seuil de la Renaissance, a cura di C. TROTTMANN, Rome, 2009, pp. 403-423. Lallusione va a GIOVANNI VILLANI, Nuova cronica, l. IX, cap. 10, II, a cura di G. PORTA, Parma,
1991, pp. 27-28.
80
ENRICO ARTIFONI
talmente, come faceva il cronista astigiano, in combatti per il tuo
comune 39. In breve, per varie vie il Catone poteva essere letto, al
pari di altri testi che oggi rischiano di sembrarci pura archeologia
culturale, come la parola attuale di una saggezza che interveniva sul
nucleo fondamentale di unetica in via di definizione: la relazione
indispensabile tra la dimensione dei comportamenti privati e la sfera pubblica. Non intendo dire che portava risposte certe, oppure
che postulasse lindividuo come non pensabile al di fuori della relazione costitutiva con la citt (sono parole di Pietro Costa riferite
a Remigio de Girolami) 40. Portava unaltra cosa, cio materiali da
costruzione, contribuiva alla stesura di unagenda mentale, infiggeva nella memoria domande e voci di un vocabolario che potevano
confluire alloccorrenza in unorganizzazione pi sofisticata.
Fu ci che accadde, cio il riorientamento in direzione civica e poi
esplicitamente politica di una tradizione didattica. La saggezza dei Disticha, insieme con molte altre componenti su cui non possiamo soffermarci, fu uno dei mattoni con cui venne costruito ledificio dei trattati
morali di Albertano da Brescia, che nel loro insieme costituiscono negli anni Quaranta un grande libro del vivere cittadino, imperniato sul
rapporto tra individuo e societ. E fu uno degli affluenti del Tresor di
Brunetto Latini negli anni Sessanta, che allideale di uomo morale costruito anche con questa saggezza antica additava poi nella parte finale
dellopera un traguardo ulteriore, quello della politica come massima
realizzazione del percorso umano. Anzi, lenciclopedia di Brunetto, che
nel secondo libro sulletica fa convivere nelle stesse pagine i materiali
umili della didattica e i nuovi temi aristotelici, prelevati dal riassunto
latino dellEtica Nicomachea noto come Summa Alexandrinorum o Compendium Alexandrinum 41, simboleggia bene una specie di delicato punto di
passaggio, il depositarsi progressivo della novit intellettuale su un sostrato precedente.
39
Disticha Catonis cit., 23, p. 19 ( una delle sententiae breves anteposte allopera).
P. COSTA, Civitas. Storia della cittadinanza in Europa, I, Dalla civilt comunale al Settecento, Roma-Bari, 1999, p. 22.
41
Probabilmente con la mediazione del volgarizzamento della Summa eseguito da Taddeo Alderotti, come ritiene Sonia Gentili riprendendo una posizione di Concetto Marchesi:
S. GENTILI, Luomo aristotelico alle origini della letteratura italiana, Roma, 2005, pp. 41-49.
40
PREISTORIE DEL BENE COMUNE
81
3. Il nome di Brunetto ci introduce allultima parte, dedicata a
unantropologia politica presente nella cultura comunale degli anni
Sessanta e Settanta. Si pu mostrare la diffusione, in testi anche
molto diversi fra loro (il che prova una specie di circolazione orizzontale del tema), di racconti sulle origini delle comunit umane
imperniati sullidea di una originaria ferocia degli uomini, unidea
cio contraria sia ai miti dellet delloro sia alla convinzione di una
qualche naturalit dellassociazione umana. La politica, in questa
prospettiva, una dura conquista realizzata dagli uomini contro la
loro stessa eredit naturale, e appunto per questo sempre a rischio
e va quotidianamente difesa. Questi racconti indicano che potevano
esistere vie anche molto traverse, non aristoteliche, per arrivare a
dire qualcosa di non troppo lontano dal famoso si non est civis
non est homo di Remigio de Girolami.
Non uso il Brunetto del Tresor. Il terzo libro del Tresor sulla
politica certo importante per due motivi di struttura: da un lato
sposa in modo indissolubile politica e retorica, mettendo a frutto la
lunga meditazione brunettiana su Cicerone, dallaltro, ponendosi
come il culmine dellopera, indica, si gi accennato, la vita politica come lapprodo del percorso educativo svolto nei due libri precedenti. Su questi due punti di struttura la novit rilevantissima.
Ma al dunque la trattazione specifica del terzo libro svolge il tema
di retorica sostanzialmente attraverso una rielaborazione del de inventione ciceroniano e della dottrina dettatoria; e in quanto a politica, il fondamento preponderante costituito dal Liber de regimine civitatum di Giovanni da Viterbo 42.
Rivolgiamoci piuttosto alla Rettorica di Brunetto, scritta tra il
1260 e il 1266, come il Tresor ma probabilmente prima di questo,
durante lesilio in Francia dellautore dopo la sconfitta guelfa di
Montaperti. Si sa che la Rettorica essenzialmente una traduzione in
volgare toscano dei primi diciassette capitoli del de inventione, lope-
42
Il pi ampio contributo recente sulla fisionomia intellettuale di Brunetto E. FENZI,
Brunetto Latini, ovvero il fondamento politico dellarte della parola e il potere dellintellettuale, in
A scuola con ser Brunetto. Indagini sulla ricezione di Brunetto Latini dal medioevo al Rinascimento. Atti del Convegno internazionale di studi, Universit di Basilea, 8-10 giugno 2006, a cura di
I. MAFFIA SCARIATI, Firenze, 2008, pp. 323-369.
82
ENRICO ARTIFONI
ra giovanile di Cicerone che ebbe una fortuna costante nel medioevo in quanto usata come introduzione a qualunque insegnamento
retorico. Alla sua traduzione Brunetto aggiunge un commento che
firma come lo sponitore , un commento molto pi ampio del testo tradotto e presentato come un lavoro non servile ma come un
vero e proprio contributo originale, tanto da spingerlo nel proemio
a dichiarare linsieme dellopera come il frutto di un doppio autore:
Marco Tulio Cicero, il pi sapientissimo de Romani e Brunetto Latino cittadino di Firenze 43. Il de inventione contiene nelle
pagine iniziali un racconto sullorigine di retorica che in realt
anche una narrazione sullorigine delle comunit umane, di cui cito
linizio nella traduzione di Brunetto:
Acci che fue un tempo che in tutte parti isvagavano gli uomini per li campi in
guisa di bestie e conduceano lor vita in modo di fiere, e facea ciascuno quasi tutte cose per forza di corpo e non per ragione danimo; et ancora in quello tempo
la divina religione n umano officio non erano avuti in reverenzia. Neuno uomo
avea veduto legittimo managio, nessuno avea connosciuti certi figliuoli, n aveano pensato che utilitade fosse mantenere ragione et agguallianza 44.
Da questo incubo prepolitico il genere umano riesce a uscire
perch uno uomo grande e savio per virt di eloquenza costrinse e raun in uno luogo quelli uomini che allora erano sparti
per le campora e partiti per le nascosaglie silvestre 45. Comincia
insomma un faticoso viaggio verso la dimensione politica scandito
43
BRUNETTO Latini, La rettorica, testo critico di F. MAGGINI, prefazione di C. SEGRE, Firenze, 1968, p. 6: L autore di questa opera doppio: uno che di tutti i detti de filosofi
che fuoro davanti lui e dalla viva fonte del suo ingegno fece suo libro di rettorica, ci fue
Marco Tulio Cicero, il pi sapientissimo de Romani. Il secondo Brunetto Latino cittadino di Firenze, il quale mise tutto suo studio e suo intendimento ad isponere e chiarire ci
che Tulio avea detto; et esso quella persona cui questo libro appella sponitore, cio ched
ispone e fae intendere, per lo suo propio detto e de filosofi e maestri che sono passati, il
libro di Tulio, e tanto pi quanto allarte bisogna di quel che fue intralasciato nel libro di
Tulio, s come il buono intenditore potre intendere avanti . Sulla rilevanza del doppio
autore cfr. G. BALDASSARRI, Prologo e Accessus ad auctores nella Rettorica di B. Latini, in
Studi e problemi di critica testuale, 12 (1976), pp. 102-116.
44
LATINI, La rettorica cit., p. 17.
45
Ibid., p. 21.
PREISTORIE DEL BENE COMUNE
83
dalla costruzione di citt e di istituzioni civili e dalla diffusione
delle leggi. Ma attenzione, il processo non garantito, perch nel
seguito vede sempre affrontarsi nella storia degli uomini coloro che
hanno sapienza congiunta a eloquenza, e coloro che magari hanno
imparato a parlare ma non hanno raggiunto la saggezza e usano
dunque la retorica per scopi personali. Questo il nucleo ciceroniano su cui Brunetto interviene con un commento amplissimo che
impossibile sintetizzare, che ribadisce con forza la ferinit come stato originario del genere umano, la conquista ardua della dimensione
politica e la instabilit di questa stessa politica, che non acquisita
una volta per tutte ma anzi il luogo di uno scontro perenne tra i
parladori savi e guerniti di senno e i gridatori e favellatori
molto grandi 46. opportuna qualche osservazione. La prima
che il pensiero ciceroniano sullorigine delle comunit umane non
riducibile a questo mito, perch per esempio nel de officiis (per non
dire del de re publica), si postula una naturale tendenza degli uomini
ad associarsi, una tendenza che deve comunque essere risvegliata attraverso la persuasione 47. Rimane il fatto che nel de inventione, opera giovanile, laccento batte fortemente sul momento negativo e
prepolitico, ed su questa linea che si sono di solito svolti i commenti medievali al passo, ricostruiti da Cary Nederman 48, ed su
questo che ulteriormente insiste Brunetto. La seconda osservazione
riguarda il fatto che il commento brunettiano debitore, come ha
dimostrato Giancarlo Alessio, di una anonima ars rethorice del secolo
46
Ibid., pp. 31-32. Riscontri del racconto ciceroniano-brunettiano nella Cronica di Dino Compagni sono ora forniti in D. CAPPI, Dino Compagni tra Cicerone e Corso Donati: i pericoli della parola politica, in Studi medievali, s. III, 50 (2009), pp. 605-671.
47
C. J. NEDERMAN, Nature, sin and the origins of society: the ciceronian tradition in medieval
political thought, [1988] e ID., The union of wisdom and eloquence before the Renaissance: the Ciceronian orator in medieval thought, [1992], poi entrambi in ID., Medieval aristotelianism and
its limits. Classical traditions in moral and political philosophy, 12th-15th century, Aldershot,
1997, saggi XI e XII; M. S. KEMPSHALL, De re publica 1.39 in medieval and Renaissance political thought, in Ciceros Republic, a cura di J. G. F. POWELL, J. A. NORTH, London, 2001,
pp. 99-135; V. SYROS, Founders and kings versus orators: medieval and early modern views on the
origins of social life, in Viator, 42 (2011), pp. 383-408 (molto utile per il tema che si sta
trattando qui).
48
NEDERMAN, The union of wisdom and eloquence cit.
84
ENRICO ARTIFONI
precedente 49. Ma questa fonte fatta propria e rilanciata da Brunetto dentro un discorso ben pi ampio e attuale, un discorso, vedremo ora, che trova anche qualche altro testimone, dando luogo a
una specie di aria di famiglia fra testi diversi.
Durante gli anni dellesilio di Brunetto, tra la fine del 1262 e
linizio del 1263, Guittone dArezzo, nella scia del turbamento ancora vivo per la disfatta di Montaperti, scriveva unepistola famosa
ai Fiorentini (Infatuati miseri Fiorentini) 50. Lepistola, la XIV della
raccolta, presenta complessi rapporti tematici e testuali con le tre
canzoni guittoniane Gente noiosa e villana, Ahi lasso, or stagion de
doler tanto e O dolce terra aretina, canzoni da inserire a loro volta fra
altri esempi di poesia politica toscana degli anni Cinquanta e Sessanta 51, ma trova una sua specificit, notata da tutti, sia nella sua
altissima temperatura retorica sia in una delle principali architetture che la sorreggono ( 4-9), fondata, spiega Margueron, su un
doppio sillogismo che si intreccia ripetutamente: la ragione distingue luomo dalle bestie, i Fiorentini hanno perso il senno per i loro
dissidi e dunque non sono uomini ma fiere; la citt in s un luogo di giustizia e di pace, Firenze ridotta a una spelonca di ladri,
dunque non pi una citt, ma un selvaggio paese alpestre 52. E allora: Unde vedete voi se vostra terra cit, e se voi citadini omini siete . Il seguito, che si snoda per sette pagine nelledizione a
stampa e non si pu ovviamente analizzare per intero, in parte
una potente verbalizzazione di questo nucleo di pensiero:
E dovete savere che non cit fa gi palagi n rughe belle, n omo persona bella
n drappi ricchi; ma legge naturale, ordinata giustizia e pace e gaudio intendo
che fa cit, e omo ragione e sapienza e costumi onesti e retti bene. O che non
49
G. C. ALESSIO, Brunetto Latini e Cicerone (e i dettatori), in Italia medioevale e umanistica,
22 (1979), pp. 123-169.
50
GUITTONE DAREZZO, Lettere, XIV, a cura di C. MARGUERON, Bologna, 1990, pp. 155162, con commento a pp. 163-179.
51
E. PASQUINI, Intersezioni fra prosa e poesia nelle Lettere di Guittone, in Guittone dArezzo
nel settimo centenario della morte, a cura di M. PICONE, Firenze, 1995, pp. 177-217, pp. 195199; F. BRUNI, La citt divisa. Le parti e il bene comune da Dante a Guicciardini, Bologna,
2003, pp. 81-86.
52
Ho parafrasato qui il commento di Margueron in GUITTONE DAREZZO, Lettere cit., p. 165.
PREISTORIE DEL BENE COMUNE
85
pi sembrasse vostra terra deserto, che cit sembra, e voi dragoni e orsi che citadini! Certo, s come voi no rimaso che membra e fazione d omo, ch tutto laltro bestiale, ragion fallita, no a vostra terra che figura di cit e casa, giustizia
vietata e pace; ch, come da omo a bestia no gi che ragione e sapienza, non da
cit a bosco che giustizia e pace 53.
E pi avanti:
Unde onni abitaculo domo pacifico esser vorria; ma pur cit dico che specialissimo loco o gaudio e pace trovare sempre si dea e ove dea refuggire chi gaudio e
pace chiere; e s loco a guerra reputato alcuno, no cit, ma alpi, ove alpestri e
selvaggi se sogliano trovare omini come fere. Ma a la gran mattezza dei citadini
alpe son cit fatte, e cit alpe, e citadini alpestri in guerra tribulando, e alpestri
citadini gaudendo in pace 54.
Piacerebbe citare a lungo da questo testo, trattando anche di altri aspetti della lettera, dal mito di Roma alla sofferenza degli esiliati, ma il punto il cuore politico di questa riflessione. Pur essendo sufficientemente provata la conoscenza da parte di Guittone della Summa Alexandrinorum, il gi citato compendio di temi aristotelici 55, la lettera XIV ai Fiorentini ne riporta in realt una traccia assai tenue e poco significativa 56. Assai pi importanti sono le analogie, segnalate da Margueron, con luoghi brunettiani sul medesimo
argomento, tra cui quelli che abbiamo esaminato dalla Rettorica,
luoghi non considerabili certo come fonti ma appunto come passi
paralleli. Credo si possa andare pi avanti e pensare senza troppe
difficolt anche a una risonanza nel testo guittoniano del grande
mito iniziale del de inventione, lettura scontata in un poeta della caratura retorica di Guittone, e soprattutto della sua parte negativa,
53
Ibid., p. 157, 7-8.
Ibid., p. 159, 26-27.
55
C. MARGUERON, Recherches sur Guittone dArezzo. Sa vie, son poque, sa culture, Paris,
1966, pp. 318-332.
56
Si veda come, dopo una prima ricognizione alquanto inclusiva (ibid., pp. 322-331),
nel commento alle Lettere guittoniane Margueron colleghi la Summa a una sola frase della
lettera XIV ( 51), p. 162: catuno ami ben se stesso , posta in parallelo a p. 179 con
Debitum est ut homo amet se ipsum veraciter della Summa (C. MARCHESI, LEtica Nicomachea nella tradizione latina medievale, Messina, 1904, p. LXXIX).
54
86
ENRICO ARTIFONI
la feritas originaria del genere umano. Se la citt il luogo della
giustizia e della pace, quando queste mancano per discordia interna
non c pi citt, e la comunit degli uomini varca a ritroso la soglia primordiale del Politico, con una regressione inarrestabile verso
quello stato brutale che sempre in agguato, verso quella dimensione non civile che sta allorigine stessa della storia umana 57.
Ho lasciato per ultima la testimonianza pi enigmatica, che si trova nella Composizione del mondo di Restoro dArezzo, terminata nel
1282. Primo esempio italiano di prosa scientifica in volgare, il trattato
di Restoro si compone di due libri: il primo, breve, di descrizione
astronomica e astrologica; il secondo, lunghissimo, impegnato a mettere in movimento quella stessa descrizione istituendo un fascio di relazioni tra i pianeti, i segni dello Zodiaco e la vita degli uomini. Siccome se noi volemo asegnare rascione de la composizione del mondo,
mestieri che noi faciamo un altro mondo simile de questo 58, dice
Restoro, tutto il secondo libro vede lautore impegnato nel montaggio
progressivo, come in una raffigurazione a scopo didattico, di una grande macchina delluniverso, compaginata nelle sue parti, a loro volta
esaminate nei loro reciproci influssi. Delle fonti di Restoro tutto ci
che sappiamo si deve a un articolo di Herbert Austin del 1913, che si
limita a esaminare gli autori esplicitamente citati da Restoro stesso, e
attraverso eliminazioni successive mostra che le sue conoscenze principali erano attinte da Alfragano, nella traduzione latina di Gerardo da
Cremona 59. Ma non ha quella provenienza il lungo brano che ci interessa, sul quale occorreranno dunque altre ricerche specialistiche e
di cui ci si limita qui a prendere atto, come parte di uninterroga-
57
Utile materiale sul tema della feritas nella poesia duecentesca in F. MAZZONI, Tematiche politiche fra Guittone e Dante, in Guittone dArezzo cit., pp. 351-383. Altra analogia (concettuale) fra la lettera XIV guittoniana e la Rettorica brunettiana segnalata in C. LE LAY,
Le dsastre de Montaperti chez Guittone dArezzo, in Arzan, 11 (2005), pp. 17-45, p. 24 (numero dedicato a La posie politique dans lItalie mdivale, a cura di A. Fontes Baratto, M.
Marietti, C. Perrus).
58
RESTORO DAREZZO, La composizione del mondo, a cura di A. MORINO, Parma, 1997, II,
1, 2, p. 79, e cfr. p. XV dellintroduzione del curatore.
59
H. D. AUSTIN, Accredited citations in Ristoro dArezzos Composizione del mondo, in Studi medievali, 4 (1912-1913), pp. 335-382, pp. 376-377 per un quadro riassuntivo che cita
anche alcune altre possibili fonti (tra cui Zahel) di incidenza nettamente minore.
PREISTORIE DEL BENE COMUNE
87
zione che si direbbe diffusa, nella seconda met del Duecento, intorno ai momenti aurorali della storia umana, uninterrogazione alla
quale si poteva rispondere secondo percorsi svariati e non aristotelicamente rassicuranti.
Trattando degli uomini posti sotto linfluenza di Saturno, cio i
lavoratori della terra, Restoro li descrive cos (riduco al minimo le
citazioni di un brano molto lungo):
E questa gente saturnina, per cascione del lavorio de la terra e per cascione chelli
sacompagnano e participano e usano colle bestie, so gente che se descreciano poco da le bestie, e per rascione so gente menscipia e bestiale e senza senno [...]; e
per lo poco senno so envediosi e occidonse e tolle luno a laltro, e fanose male
aseme, e so ignari e non cognoscono iustizia n rascione e so senza lege 60.
Una gente ignara e bestiale , tra cui non chi li amaestri
n chi li punisca del maleficio, quando elli se fanno male . Ma la
gente ignara e bestiale, prosegue, deve essere piuttosto ammaestrata
e ammonita che punita. Venga dunque, come un Giove pacificatore, un eroe civilizzatore, uno profeta il quale dia a loro le leggi
e la religione e li faccia partecipare a una societ:
e d a loro lege, e empaurali de le pene de laltro mondo, e predica la via de Deo
perch non se occidano e non se facciano male e stieno in pace, che per la pace lo
regname se possa abetare e mantenere; e questo amonitore de rascione dea ssare
vestito e pasciuto da loro.
Ancora una volta, per strade tortuose, si riaffaccia lidea inquietante di unalba selvaggia del genere umano, una stirpe feroce da
trasformare con leggi e istituzioni e da portare verso la storia civile,
al di l della sua stessa originaria natura.
60
RESTORO DAREZZO, La composizione del mondo cit., II, 2, 1-II, 2, 2, pp. 115-122.
Potrebbero piacerti anche
- Conflittualita Politica in Un Comune Ad Autonomia Limitata-LibreDocumento30 pagineConflittualita Politica in Un Comune Ad Autonomia Limitata-LibreGustavo GonçalvesNessuna valutazione finora
- IGOR MIMEOOO, E. Cose in Comune e Bene Comune. L'Ideologia Della Comunità in Italia Nel Tardo MedioevoDocumento30 pagineIGOR MIMEOOO, E. Cose in Comune e Bene Comune. L'Ideologia Della Comunità in Italia Nel Tardo MedioevoGustavo GonçalvesNessuna valutazione finora
- 1 PBDocumento21 pagine1 PBGustavo GonçalvesNessuna valutazione finora
- PACCIOCO, R. Le Canonizzazioni Papali Nei Secoli XII e XIIIDocumento23 paginePACCIOCO, R. Le Canonizzazioni Papali Nei Secoli XII e XIIIGustavo GonçalvesNessuna valutazione finora
- Storia Di PadovaDocumento5 pagineStoria Di PadovaGustavo GonçalvesNessuna valutazione finora
- TODESCHINI, G. Commerciare Nell'occidente Medievale: Il Sacro QuotidianoDocumento12 pagineTODESCHINI, G. Commerciare Nell'occidente Medievale: Il Sacro QuotidianoGustavo GonçalvesNessuna valutazione finora
- RIGON, A. - S. Antonio Da Pater Padue A Patronus CivitatisDocumento13 pagineRIGON, A. - S. Antonio Da Pater Padue A Patronus CivitatisGustavo GonçalvesNessuna valutazione finora
- BALBI - Governare La Città - Pratiche Sociali e Linguaggi Politici - Livro InteiroDocumento380 pagineBALBI - Governare La Città - Pratiche Sociali e Linguaggi Politici - Livro InteiroGustavo GonçalvesNessuna valutazione finora