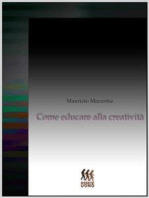Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
Tommaso D'aquino
Caricato da
Lorenzo Alfano0 valutazioniIl 0% ha trovato utile questo documento (0 voti)
5 visualizzazioni2 pagineTitolo originale
tommaso d'aquino
Copyright
© © All Rights Reserved
Formati disponibili
PDF, TXT o leggi online da Scribd
Condividi questo documento
Condividi o incorpora il documento
Hai trovato utile questo documento?
Questo contenuto è inappropriato?
Segnala questo documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formati disponibili
Scarica in formato PDF, TXT o leggi online su Scribd
0 valutazioniIl 0% ha trovato utile questo documento (0 voti)
5 visualizzazioni2 pagineTommaso D'aquino
Caricato da
Lorenzo AlfanoCopyright:
© All Rights Reserved
Formati disponibili
Scarica in formato PDF, TXT o leggi online su Scribd
Sei sulla pagina 1di 2
La figura del maestro in Tommaso d’Aquino
Il problema del ruolo del maestro viene formulato da Tommaso
d’Aquino. La sua posizione è stata da sempre molto rigida,
infatti Tommaso dice categoricamente che l’uomo non può
insegnare in quanto soltanto Dio può causare il sapere in un
altro essere.
Per poter raggiungere una risposta alla questione da lui
sollevata, Tommaso decide di ascoltare e studiare le varie
opinioni dei suoi colleghi studiosi.
La prima proposta alla risoluzione del problema viene realizzata
dall’aristotelico: Averroè che dice:”unico è l’intelletto
possibile di tutti gli uomini”. Con questa affermazione Averroè
sostiene che esiste un unico intelletto comune a tutti gli
uomini, chiamato: intelletto potenziale. Questo termine indica
una conoscenza ed una intelligenza che risiedono in noi e che è
pari a tutti. Quindi Averroè spiega che la figura del maestro,
come dice Tommaso, non può instillare il sapere nell’allievo,
quanto più il compito del maestro è quello di accompagnare e
guidare l'allievo in un percorso che lo porterà a rendere
effettive le conoscenza finora ritenute potenziali.
Tommaso d’Aquino però non condivide che l’intelletto sia unico e
comune in tutte le persone e dunque continua ad ascoltare altri
pareri.
Rispondono i platonici la cui posizione è la seguente: i
platonici sostengono che la scienza sia presente nel soggetto
fin dalla tenera età ma a causa della vita terrena e materiale
che tutti noi compiamo, non riusciamo a scindere la nostra
conoscenza. Per questo il maestro ha il compito di sollecitare
l’allievo a ricordare in quanto l’apprendimento deve essere un
“ricordare le conoscenze già presenti in noi”.
Seguendo Aristotele, Tommaso afferma che l’uomo ottiene la
scienza da un principio interno e uno esterno (similitudine con
input e output). Aristotele dunque interpreta la figura del
maestro in un compito molto importante ovvero come tramite tra
la sapienza divina e l’alunno che non è da considerarsi una
tabula rasa ma bensì un detentore di un potere conoscitivo
potenziale e non ancora effettivo. Il maestro dunque ha
solamente il compito di innescare il processo che poi permetterà
all’alunno di trasformare il potere conoscitivo potenziale in
potere conoscitivo effettivo.
Il compito del maestro quindi è quello di puntare al
completamento della formazione dell’allievo suggerendogli esempi
sensibili oppure l’ordine che conduce i principi alla
conclusione per indurlo a concludere da ciò che già sa, delle
conclusioni che arricchiscono il suo sapere.
In conclusione, Tommaso concorda col fatto che il maestro debba
essere una guida e la scintilla che fa accendere la curiosità
dell'allievo
La pedagogia islamica e il passaggio
all’educazione rinascimentale
Potrebbero piacerti anche
- Un docente è per sempre: Forma cittadini consapevoli e ispira i tuoi studenti lasciando un’impronta indelebile nelle loro vite grazie al Coaching EdutematicoDa EverandUn docente è per sempre: Forma cittadini consapevoli e ispira i tuoi studenti lasciando un’impronta indelebile nelle loro vite grazie al Coaching EdutematicoNessuna valutazione finora
- Psicologia A Scuola - Un Percorso Pratico - Teorico Di LucchiariDocumento63 paginePsicologia A Scuola - Un Percorso Pratico - Teorico Di LucchiariFrancescaNessuna valutazione finora
- Come Insegnare Uno Strumento (Anna Maria Freschi) RIASSUNTODocumento1 paginaCome Insegnare Uno Strumento (Anna Maria Freschi) RIASSUNTOUrbano VIII100% (1)
- Come Insegnare Uno Strumento (Libro 9)Documento1 paginaCome Insegnare Uno Strumento (Libro 9)Urbano VIIINessuna valutazione finora
- Riassunto Libro Università Scienze Della FormazioneDocumento5 pagineRiassunto Libro Università Scienze Della FormazioneAurora VetranoNessuna valutazione finora
- Riassunto Aurora 2Documento5 pagineRiassunto Aurora 2Aurora VetranoNessuna valutazione finora
- Le Principali Teorie Psico-Pedagogiche 900Documento25 pagineLe Principali Teorie Psico-Pedagogiche 900elisabettaNessuna valutazione finora
- Maria Montessori Educatrice Dello Spirito UmanoDocumento9 pagineMaria Montessori Educatrice Dello Spirito UmanoGrazia MusumeciNessuna valutazione finora
- Didattica LaboratorialeDocumento13 pagineDidattica LaboratorialeSantino BrunoNessuna valutazione finora
- PAS 2014 - C450 - Materiale e Modalityz Di Esame Pedagogia - Prof. Galanti PDFDocumento27 paginePAS 2014 - C450 - Materiale e Modalityz Di Esame Pedagogia - Prof. Galanti PDFSerenaNessuna valutazione finora
- Il Potenziamento CognitivoDocumento14 pagineIl Potenziamento CognitivodeniseNessuna valutazione finora
- Esprimi-Amo Le Emo-AzioniDocumento10 pagineEsprimi-Amo Le Emo-AzionivaleNessuna valutazione finora
- Come Motivare All'apprendimento: Una Didattica Dell'esperienza.Documento12 pagineCome Motivare All'apprendimento: Una Didattica Dell'esperienza.Ga_V100% (1)
- Esame - Pedagogia Della Scuola - Libro Milani - Competenza Pedagogica e Progettualità Educativa - Con Appunti Lezioni Gallo e Boeris X TuttiDocumento90 pagineEsame - Pedagogia Della Scuola - Libro Milani - Competenza Pedagogica e Progettualità Educativa - Con Appunti Lezioni Gallo e Boeris X TuttiPaola GhisiNessuna valutazione finora
- PEDAGOGIA-GENERALE-E-SOCIALE IleDocumento51 paginePEDAGOGIA-GENERALE-E-SOCIALE IleIlenia TornabeneNessuna valutazione finora
- Lo specchio magico: Pensieri e parole di un formatore riflessivoDa EverandLo specchio magico: Pensieri e parole di un formatore riflessivoNessuna valutazione finora
- Field Trip Di Pedagogia e Educazione, Pedagoy and EducationDocumento3 pagineField Trip Di Pedagogia e Educazione, Pedagoy and EducationAzzurra SpreaficoNessuna valutazione finora
- La Scoperta Del Bambino Riassunto PDFDocumento29 pagineLa Scoperta Del Bambino Riassunto PDFAlessia Santoro75% (4)
- Riflessione Finale Sul PercorsoDocumento1 paginaRiflessione Finale Sul Percorsoanna franceschiniNessuna valutazione finora
- Pedagogia GeneraleDocumento32 paginePedagogia Generalesusanna alexanNessuna valutazione finora
- Educabilità Educazione e PedagogiaDocumento4 pagineEducabilità Educazione e PedagogiaGRETA VILLANINessuna valutazione finora
- Pedagogia Appunti Completi PDFDocumento72 paginePedagogia Appunti Completi PDFSimone Brio Brienza100% (1)
- Pedagogia KantianaDocumento2 paginePedagogia KantianaLorenzo AlfanoNessuna valutazione finora
- Riassunto Libro Psicologia Delleducazione Di Ligorio Cacciamani CompressDocumento54 pagineRiassunto Libro Psicologia Delleducazione Di Ligorio Cacciamani Compressjessica profiloNessuna valutazione finora
- DEWEYDocumento6 pagineDEWEYAgnese BoriNessuna valutazione finora
- Rousseau EmilioDocumento9 pagineRousseau EmilioErica Del CornoNessuna valutazione finora
- Antropologia Come EducazioneDocumento20 pagineAntropologia Come EducazioneAlessia MacconiNessuna valutazione finora
- ULTIMA - PED RELAZIONI DI AIUTO - Secondaria - I - II - GradoDocumento26 pagineULTIMA - PED RELAZIONI DI AIUTO - Secondaria - I - II - GradoSergio LaconcaNessuna valutazione finora
- Domande Aperte Didattica e Pedagogia SpecialeDocumento23 pagineDomande Aperte Didattica e Pedagogia SpecialeMarianna AlbaneseNessuna valutazione finora
- Psicologia Dell Educazione Ligorio Cacciamani 4Documento60 paginePsicologia Dell Educazione Ligorio Cacciamani 4stalkeroperte511Nessuna valutazione finora
- Riassunto - Psicologia Dell'educazioneDocumento54 pagineRiassunto - Psicologia Dell'educazioneDanilo ScanoNessuna valutazione finora
- Concettina Garofano, Rilevanze Antropologiche Del Principio Di Individuazione in Giovanni Duns Scoto. Tra Metafisica Ed EpistemDocumento23 pagineConcettina Garofano, Rilevanze Antropologiche Del Principio Di Individuazione in Giovanni Duns Scoto. Tra Metafisica Ed Epistemeles515Nessuna valutazione finora
- Fondamenti Educ, Educab, PedagogDocumento3 pagineFondamenti Educ, Educab, Pedagogursulone09Nessuna valutazione finora
- Commento ComenioDocumento1 paginaCommento ComenioPaola CiprianiNessuna valutazione finora
- Personalizzazione EducativaDocumento58 paginePersonalizzazione EducativaGa_V100% (1)
- Amedeo CenciniDocumento2 pagineAmedeo CenciniPimen MojzesNessuna valutazione finora
- Cesaro - MontaniDocumento5 pagineCesaro - MontaniMatteo NandaNessuna valutazione finora
- Chiarle, Quando Valutare A Scuola StancaDocumento24 pagineChiarle, Quando Valutare A Scuola StancaAngelo Chiarle83% (6)
- Metodologie Appunti CompletiDocumento80 pagineMetodologie Appunti CompletiGiadaNessuna valutazione finora
- I Dialoghi sull'Ermetismo: Il pensiero è MateriaDa EverandI Dialoghi sull'Ermetismo: Il pensiero è MateriaNessuna valutazione finora
- Pensiero Produttivo e Apprendimento UmanDocumento2 paginePensiero Produttivo e Apprendimento UmanALBERTO DI NAPOLINessuna valutazione finora
- La Pedagogia Sociale, Duccio DemetrioDocumento4 pagineLa Pedagogia Sociale, Duccio DemetrioMariaNessuna valutazione finora
- SCHEMIDocumento17 pagineSCHEMIfederica.testa01Nessuna valutazione finora
- Cosa È L' APPRENDIMENTO SIGNIFICATIVODocumento4 pagineCosa È L' APPRENDIMENTO SIGNIFICATIVOSimonetta ScavizziNessuna valutazione finora
- Cost Rutti Vis MoDocumento8 pagineCost Rutti Vis Momatilde mocataNessuna valutazione finora
- Storia Educazione Positivismo Romanticismo e Pedagogie Alternativa II ParteDocumento10 pagineStoria Educazione Positivismo Romanticismo e Pedagogie Alternativa II ParteOlimpia PossematoNessuna valutazione finora
- Questionario 1Documento9 pagineQuestionario 1Maria VittoriNessuna valutazione finora
- La mediazione pedagogica: Un percorso da Socrate a Reuven FeuersteinDa EverandLa mediazione pedagogica: Un percorso da Socrate a Reuven FeuersteinNessuna valutazione finora
- SFO 978-88-6137 961 9 Come Funziona L ApprendimentoDocumento19 pagineSFO 978-88-6137 961 9 Come Funziona L ApprendimentoyrbagNessuna valutazione finora
- Le Principali Teorie Psico-Pedagogiche 700 800Documento12 pagineLe Principali Teorie Psico-Pedagogiche 700 800elisabettaNessuna valutazione finora
- Il Metodo Della Pedagogia Scientifica Riassunti1Documento53 pagineIl Metodo Della Pedagogia Scientifica Riassunti1Chiara BenvenutiNessuna valutazione finora
- 1-Da Comenio A HerbartDocumento4 pagine1-Da Comenio A HerbartIsabellaNessuna valutazione finora
- RIASSUNTO ''Esperienza Ed Educazione'' J. DeweyDocumento11 pagineRIASSUNTO ''Esperienza Ed Educazione'' J. DeweyHorace BasileNessuna valutazione finora
- Avviamento Alla PedagogiaDocumento6 pagineAvviamento Alla PedagogiafedericaNessuna valutazione finora
- La Sfida Dell'Insegnamento (Didattica G)Documento2 pagineLa Sfida Dell'Insegnamento (Didattica G)antonellaseidita92Nessuna valutazione finora
- Metamorfosi Dell'immobilita'Documento56 pagineMetamorfosi Dell'immobilita'Veronica GabberoNessuna valutazione finora
- Antropologia culturale (razzismo)Documento46 pagineAntropologia culturale (razzismo)gabrama0000Nessuna valutazione finora
- Commemoriale Che GuevaraDocumento1 paginaCommemoriale Che GuevaraLorenzo AlfanoNessuna valutazione finora
- GDR ZombieDocumento3 pagineGDR ZombieLorenzo AlfanoNessuna valutazione finora
- Modulo PonDocumento16 pagineModulo PonLorenzo AlfanoNessuna valutazione finora
- Locande in D&DDocumento3 pagineLocande in D&DLorenzo AlfanoNessuna valutazione finora
- SenecaDocumento1 paginaSenecaLorenzo AlfanoNessuna valutazione finora
- Riunificazione Der Regni ItalianiDocumento1 paginaRiunificazione Der Regni ItalianiLorenzo AlfanoNessuna valutazione finora
- James Morrow e L'americaDocumento1 paginaJames Morrow e L'americaLorenzo AlfanoNessuna valutazione finora
- Modello ComposizionaleDocumento1 paginaModello ComposizionaleLorenzo AlfanoNessuna valutazione finora
- Lombardo RadiceDocumento1 paginaLombardo RadiceLorenzo AlfanoNessuna valutazione finora
- Teorie Sulla RiunificazioneDocumento1 paginaTeorie Sulla RiunificazioneLorenzo AlfanoNessuna valutazione finora
- MazziniDocumento1 paginaMazziniLorenzo AlfanoNessuna valutazione finora
- Tesi Argomentativa Su LeopardiDocumento2 pagineTesi Argomentativa Su LeopardiLorenzo AlfanoNessuna valutazione finora
- 1849 PiemonteDocumento1 pagina1849 PiemonteLorenzo AlfanoNessuna valutazione finora
- Geroge SeudatDocumento1 paginaGeroge SeudatLorenzo AlfanoNessuna valutazione finora
- Natura Di LeopardiDocumento1 paginaNatura Di LeopardiLorenzo AlfanoNessuna valutazione finora
- Morte Di Che GuevaraDocumento2 pagineMorte Di Che GuevaraLorenzo AlfanoNessuna valutazione finora
- Controllo SocialeDocumento2 pagineControllo SocialeLorenzo AlfanoNessuna valutazione finora
- Leese 99Documento2 pagineLeese 99Davide ColucciNessuna valutazione finora
- 1600 e Rivoluzione FranceseDocumento3 pagine1600 e Rivoluzione FranceseLorenzo AlfanoNessuna valutazione finora
- Indipendenza AmericanaDocumento7 pagineIndipendenza AmericanaLorenzo AlfanoNessuna valutazione finora
- Ottocento PedagogicoDocumento3 pagineOttocento PedagogicoLorenzo AlfanoNessuna valutazione finora
- William SummerDocumento2 pagineWilliam SummerLorenzo AlfanoNessuna valutazione finora
- RecanatenseDocumento1 paginaRecanatenseLorenzo AlfanoNessuna valutazione finora
- Stratificazione SocialeDocumento2 pagineStratificazione SocialeLorenzo AlfanoNessuna valutazione finora
- Maria MontessoriDocumento2 pagineMaria MontessoriLorenzo AlfanoNessuna valutazione finora
- Filosofia CartesianaDocumento6 pagineFilosofia CartesianaLorenzo AlfanoNessuna valutazione finora
- Sistema ScheletricoDocumento3 pagineSistema ScheletricoLorenzo AlfanoNessuna valutazione finora
- Not TataDocumento1 paginaNot TataLorenzo AlfanoNessuna valutazione finora
- Pedagogia KantianaDocumento2 paginePedagogia KantianaLorenzo AlfanoNessuna valutazione finora
- Razionalismo Ed EmpirismoDocumento2 pagineRazionalismo Ed EmpirismoGiulio JesiNessuna valutazione finora
- Croce Gobetti e PaciDocumento40 pagineCroce Gobetti e PaciRenato CalapsoNessuna valutazione finora
- Marx, Le Tesi Su FeuerbachDocumento2 pagineMarx, Le Tesi Su FeuerbachangelaNessuna valutazione finora
- Emanuele Severino La Cosa e Il Segno PDFDocumento27 pagineEmanuele Severino La Cosa e Il Segno PDFFederico VirgilioNessuna valutazione finora
- BergsonDocumento3 pagineBergsonsvevaNessuna valutazione finora
- Fulvio Papi, Antropologia e Civiltà Nel Pensiero Di Giordano Bruno, Firenze, La Nuova Italia, 1968 (Pubblicazioni Della Facoltà Di Lettere e Filosofia Dell'università Degli Studi Di Milano, 46)Documento371 pagineFulvio Papi, Antropologia e Civiltà Nel Pensiero Di Giordano Bruno, Firenze, La Nuova Italia, 1968 (Pubblicazioni Della Facoltà Di Lettere e Filosofia Dell'università Degli Studi Di Milano, 46)Alessandro ZabiniNessuna valutazione finora
- Leo Lugarini, La Logica Di HegelDocumento17 pagineLeo Lugarini, La Logica Di HegelmorenomilivintiNessuna valutazione finora
- Filosofia Del Diritto - 6/6 - Diritto e GiustiziaDocumento4 pagineFilosofia Del Diritto - 6/6 - Diritto e Giustiziaappuntigratis_unicamNessuna valutazione finora
- SCHELLINGDocumento1 paginaSCHELLINGgionx03 ggNessuna valutazione finora