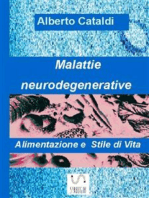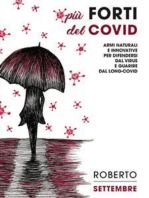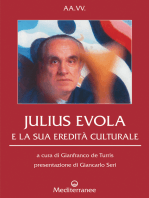Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
1
Caricato da
cersTitolo originale
Copyright
Formati disponibili
Condividi questo documento
Condividi o incorpora il documento
Hai trovato utile questo documento?
Questo contenuto è inappropriato?
Segnala questo documentoCopyright:
Formati disponibili
1
Caricato da
cersCopyright:
Formati disponibili
Nel 1815-1816 Leopardi fu colpito da alcuni seri problemi fisici di tipo reumatico
e disagi psicologici che egli attribuì almeno in parte — come la presunta scoliosi
— all'eccessivo studio, isolamento e immobilità in posizioni scomode delle lunghe
giornate passate nella biblioteca di Monaldo.[44] La malattia esordì con affezione
polmonare e febbre e in seguito gli causò la deviazione della spina dorsale (da cui
la doppia "gobba"), con dolore e conseguenti problemi cardiaci, circolatori,
gastrointestinali (forse colite ulcerosa o malattia di Crohn[8]) e respiratori
(asma e tosse), una crescita stentata[9], problemi neurologici alle gambe
(debolezza, parestesia con freddo intenso[45]), alle braccia e alla vista, disturbi
disparati e stanchezza continua; nel 1816 Leopardi era convinto di essere sul punto
di morire.[46]
Il marchese Filippo Solari di Loreto scrive poco dopo a Monaldo Leopardi:
«L'ho lasciato sano e dritto, lo trovo dopo cinque anni consunto e scontorto, con
avanti e dietro qualcosa di veramente orribile.»
Egli stesso si ispira a questi seri problemi di salute, di cui parlerà anche a
Pietro Giordani, per la lunga cantica L'appressamento della morte[47][48][49] e,
anni dopo, per Le ricordanze, in cui ripensa a questo e definisce la sua malattia
come un "cieco malor", cioè un male di non chiara origine, che gli fa pensare al
suicidio assieme all'angusto ambiente:
«Mi sedetti colà su la fontana / Pensoso di cessar dentro quell'acque / La speme e
il dolor mio. Poscia, per cieco / Malor, condotto della vita in forse, / Piansi la
bella giovanezza, e il fiore / De' miei poveri dì, che sì per tempo / Cadeva…[50]»
L'ipotesi più accreditata per lungo tempo (diffusa già nel XIX secolo e sostenuta
da medici di Recanati e da Pietro Citati) è che Leopardi soffrisse della malattia
di Pott (gli studiosi scartano la diagnosi dell'epoca, più volte riproposta anche
nel Novecento, di una normale scoliosi dell'età evolutiva)[9][51], cioè tubercolosi
ossea o spondilite tubercolare[52], oppure dalla spondilite anchilosante giovanile
(secondo Erik P. Sganzerla), una sindrome reumatica autoimmune che porta a una
progressiva ossificazione dei legamenti vertebrali con deformazione e rigidità del
rachide, uniti ad ampi disturbi infiammatori sistemici, oculari e neurologici-
compressivi[53] in casi gravi[8][54][55][56], il tutto unitamente a problemi
nervosi. Altri hanno parlato di concomitanza tra sindrome di Scheuermann e una
forma di diabete mellito[57] aggravata dalla nota passione del poeta per i
dolci[57], e altre diagnosi retrospettive.[54]
Alcune di queste sindromi hanno predisposizione genetica, derivabile dal matrimonio
tra consanguinei dei genitori. Tutti i fratelli Leopardi furono deboli di salute,
con l'eccezione di Carlo, forse però sterile, e Paolina, la quale presentava solo
una leggera asimmetria del viso.[58] Sempre Citati afferma che avesse anche dei
disturbi urinari e di probabile impotenza, e sarebbero stati questi, più che
l'aspetto fisico (a cui poteva ovviare essendo un nobile benestante) la causa del
suo rapporto difficile con le donne e la sessualità.[59]
Nel decennio seguente l'apparire dei disturbi, alcuni medici fiorentini, come altri
medici consultati in gioventù, a parte la deformità fisica asseriranno —
probabilmente in maniera erronea — che numerosi disturbi del Leopardi erano dovuti
a nevrastenia di origine psicologica (sempre in questo periodo comincia a soffrire
di crisi depressive che taluni attribuiscono all'impatto psicologico della malattia
fisica), come lui stesso a tratti sostenne, anche contro il parere di numerosi
dottori.[60][61][62][63]
Potrebbero piacerti anche
- Malattie neurodegenerative - Alimentazione e Stile di vitaDa EverandMalattie neurodegenerative - Alimentazione e Stile di vitaNessuna valutazione finora
- La fede e la ragione: Egidio da Viterbo tra predicazione, millenarismo politico e riformaDa EverandLa fede e la ragione: Egidio da Viterbo tra predicazione, millenarismo politico e riformaNessuna valutazione finora
- La Malattia Di MeniereDocumento11 pagineLa Malattia Di MeniereLancelot du LacNessuna valutazione finora
- Manuale Di Malattie CardiovascolariDocumento189 pagineManuale Di Malattie CardiovascolariVale Peanuts100% (1)
- Spalla CongDocumento57 pagineSpalla CongSaraNessuna valutazione finora
- Storia Scuola Medica Di BolognaDocumento20 pagineStoria Scuola Medica Di BolognaFrancesco SansoneNessuna valutazione finora
- Namias GiacintoDocumento4 pagineNamias GiacintoMassimo BertoldiNessuna valutazione finora
- EpittetoDocumento4 pagineEpittetoRicardo AndradeNessuna valutazione finora
- Manuale Di Malattie CardiovascolariDocumento121 pagineManuale Di Malattie Cardiovascolarimgibbin85Nessuna valutazione finora
- 4D. Degenerazione Epato-Cerebrale AcquisitaDocumento5 pagine4D. Degenerazione Epato-Cerebrale AcquisitaValeria MazzoliNessuna valutazione finora
- Tesi MMG Lombalgia CronicaDocumento44 pagineTesi MMG Lombalgia CronicaChiara GiardinaNessuna valutazione finora
- LOCKED-In SYNDROME o Sdme Del ChiavistelloDocumento3 pagineLOCKED-In SYNDROME o Sdme Del Chiavistelloartur333Nessuna valutazione finora
- Public - Cibo Ed EtnopsichiatriaDocumento10 paginePublic - Cibo Ed EtnopsichiatriaClaudia ChiurliaNessuna valutazione finora
- Pagine SIC PDFDocumento217 paginePagine SIC PDFFedericaNessuna valutazione finora
- GalenoDocumento9 pagineGalenoMarioneeeNessuna valutazione finora
- Pneumologia - Semeiotica GeneraleDocumento19 paginePneumologia - Semeiotica GeneraleandreaNessuna valutazione finora
- DadadaDocumento2 pagineDadadaFabioNessuna valutazione finora
- Sindrome Da ImmobilizzazioneDocumento7 pagineSindrome Da ImmobilizzazioneEnrico CarrettaNessuna valutazione finora
- Sindrome PotsDocumento17 pagineSindrome PotsElena MandaNessuna valutazione finora
- Interstiziopatia Polmonari PDFDocumento18 pagineInterstiziopatia Polmonari PDFPaoly PalmaNessuna valutazione finora
- Il Seicento - Storia (50): Storia della Civiltà Europea a cura di Umberto Eco - 51Da EverandIl Seicento - Storia (50): Storia della Civiltà Europea a cura di Umberto Eco - 51Nessuna valutazione finora
- Dispensa Marzullo - Serio AP1 PDFDocumento99 pagineDispensa Marzullo - Serio AP1 PDFUmberto CarbonaraNessuna valutazione finora
- Semeiotica DellDocumento15 pagineSemeiotica DellFaddy OrahaNessuna valutazione finora
- Calligaris e La MetafisiologiaDocumento6 pagineCalligaris e La MetafisiologiabruzzogiNessuna valutazione finora
- Freud Cinque Conferenze EARDocumento51 pagineFreud Cinque Conferenze EARSonia FumarolaNessuna valutazione finora
- 3° Lezione IagnoccoDocumento7 pagine3° Lezione IagnoccoGiuseppe FoggiaNessuna valutazione finora
- App. RespiratorioDocumento23 pagineApp. RespiratorioNefViGufaNessuna valutazione finora
- Guido Da Vigevano Tavole Anatomiche - ItalianoDocumento13 pagineGuido Da Vigevano Tavole Anatomiche - ItalianomauroNessuna valutazione finora
- Malattie NeuromuscolariDocumento34 pagineMalattie NeuromuscolariGiuseppe FoggiaNessuna valutazione finora
- DOTT. BALDASSARI 2 Diagnostica AncaDocumento13 pagineDOTT. BALDASSARI 2 Diagnostica AncaStudio miofitNessuna valutazione finora
- Catene Causali (Omeopatia Di Risonanza) (Ripristinato)Documento28 pagineCatene Causali (Omeopatia Di Risonanza) (Ripristinato)Giovanni Pansini100% (1)
- Connettivite Indifferenziata MistaDocumento20 pagineConnettivite Indifferenziata MistaLicia RoverottoNessuna valutazione finora
- Malattia Del MotoneuroneDocumento4 pagineMalattia Del MotoneuroneGabriele VolturoNessuna valutazione finora
- Coxartrosi PDFDocumento7 pagineCoxartrosi PDFrobertNessuna valutazione finora
- Psicologia Clinica Le OriginiDocumento4 paginePsicologia Clinica Le OriginiErica PuglieseNessuna valutazione finora
- Artrite e Medicina CineseDocumento32 pagineArtrite e Medicina CineseNino Ballarino100% (1)
- Julius EvolaDocumento29 pagineJulius EvolakusalanandaNessuna valutazione finora
- Più forti del Covid: Armi naturali e innovative per difendersi dal virus e guarire dal long-CovidDa EverandPiù forti del Covid: Armi naturali e innovative per difendersi dal virus e guarire dal long-CovidNessuna valutazione finora
- 3-Cardio 1Documento38 pagine3-Cardio 1Anna De SantisNessuna valutazione finora
- CARDIOLOGIADocumento39 pagineCARDIOLOGIAFedericoPppzPippoNessuna valutazione finora
- Anatomia Patologica Catedra B (1parte y 2 Parte) DefDocumento455 pagineAnatomia Patologica Catedra B (1parte y 2 Parte) DefPablo Novoa FernándezNessuna valutazione finora
- mcapocci,+MED 22 2 3 24 MazzarelloDocumento32 paginemcapocci,+MED 22 2 3 24 MazzarelloNick KolevNessuna valutazione finora
- Storia Della FolliaDocumento5 pagineStoria Della FolliafabromNessuna valutazione finora
- PDF News 239-SciatDocumento23 paginePDF News 239-SciatHati UlfNessuna valutazione finora
- Fisiopatologia Del Dolore RadicolareDocumento4 pagineFisiopatologia Del Dolore RadicolareCipriano D'AmbrosioNessuna valutazione finora
- Tunnel CarpaleDocumento9 pagineTunnel Carpalelapao82Nessuna valutazione finora
- La Neoartrosi InterspinosaDocumento11 pagineLa Neoartrosi Interspinosaweb3351Nessuna valutazione finora
- Capitolo 5 Storia Della MedicinaDocumento9 pagineCapitolo 5 Storia Della Medicinaelisaandronico1122Nessuna valutazione finora
- ComaDocumento86 pagineComaRamona StefaniaNessuna valutazione finora
- Historia de La Psicología de La Religión en ItaliaDocumento14 pagineHistoria de La Psicología de La Religión en ItaliaGabriel de Reina TartièreNessuna valutazione finora
- Manuale Di Cardiologia DefinitivoDocumento328 pagineManuale Di Cardiologia DefinitivoGiovanni Argiroffi100% (4)
- Edema Polmonare AcutoDocumento10 pagineEdema Polmonare AcutoTre Kadabra TesteNessuna valutazione finora
- Sclerosi Laterale AmiotroficaDocumento19 pagineSclerosi Laterale AmiotroficaFabio MaugeriNessuna valutazione finora
- Galeone - Diabete - Def - Web PDF - Adobe Acrobat ProDocumento130 pagineGaleone - Diabete - Def - Web PDF - Adobe Acrobat ProMunteanu IonelaNessuna valutazione finora
- Il Cinquecento - Storia (44): Storia della Civiltà Europea a cura di Umberto Eco - 45Da EverandIl Cinquecento - Storia (44): Storia della Civiltà Europea a cura di Umberto Eco - 45Nessuna valutazione finora
- Pensiero Di Ippocrate PDFDocumento29 paginePensiero Di Ippocrate PDFoxakiNessuna valutazione finora
- Ando 1990 La Verginita Come FolliaDocumento24 pagineAndo 1990 La Verginita Come FolliaCeciliaNessuna valutazione finora
- FdsfegrehbtrhDocumento1 paginaFdsfegrehbtrhcersNessuna valutazione finora
- FdsfegrehbtrhDocumento1 paginaFdsfegrehbtrhcersNessuna valutazione finora
- FdsfegrehbtrhDocumento1 paginaFdsfegrehbtrhcersNessuna valutazione finora
- FdsfegrehbtrhDocumento1 paginaFdsfegrehbtrhcersNessuna valutazione finora
- 1Documento2 pagine1cersNessuna valutazione finora
- FdsfegrehbtrhDocumento1 paginaFdsfegrehbtrhcersNessuna valutazione finora
- FdsfegrehbtrhDocumento1 paginaFdsfegrehbtrhcersNessuna valutazione finora
- 1Documento1 pagina1cersNessuna valutazione finora
- 1Documento1 pagina1cersNessuna valutazione finora
- DanteDocumento1 paginaDantelucasNessuna valutazione finora
- 26 - Anatomia II - 30-03-2017 (R)Documento10 pagine26 - Anatomia II - 30-03-2017 (R)SandroNessuna valutazione finora
- Veroval® Porta in Farmacia 11 Self-Test Per L'autodiagnosi A CasaDocumento3 pagineVeroval® Porta in Farmacia 11 Self-Test Per L'autodiagnosi A CasaEncantoPRNessuna valutazione finora
- Agnosia SemDocumento30 pagineAgnosia SemMassimo ApollonioNessuna valutazione finora
- Medicina InternaDocumento112 pagineMedicina InternaAutogeneratasiNessuna valutazione finora