Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
Report Florens 2010
Caricato da
Elisa BonaciniCopyright
Formati disponibili
Condividi questo documento
Condividi o incorpora il documento
Hai trovato utile questo documento?
Questo contenuto è inappropriato?
Segnala questo documentoCopyright:
Formati disponibili
Report Florens 2010
Caricato da
Elisa BonaciniCopyright:
Formati disponibili
Leconomia dei beni culturali e ambientali.
Una visione sistemica e integrata
Fondazione Florens 2010. TUTTI I DIRITTI RISERVATI. Questo documento stato ideato e preparato da The European House-Ambrosetti S.p.A. per la Fondazione Florens 2010.
Prefazione
PREFAZIONE
Come nata lidea di Florens 2010? E perch questo studio strategico? La crisi ha accelerato la necessit di un profondo ripensamento di tutti i modelli imprenditoriali e di consumo per individuare, accanto ai modelli economici tradizionali, nuove vie di sviluppo industriale. Da Firenze fiorita, perci, unoriginale iniziativa di politica industriale nel panorama economico internazionale, da cui il nome evocativo di Florens 2010. Lo scopo di far emergere idee e progetti per favorire lo sviluppo delleconomia dei beni culturali, un settore dalle grandi potenzialit che pu contribuire alla crescita del PIL e, dunque, ad un ritrovato dinamismo delleconomia internazionale e, in particolare, di quella italiana, oggi pi in difficolt a riposizionarsi negli scenari competitivi internazionali. ormai acquisito il ruolo della green economy nel cambiamento dei sistemi produttivi verso un minore consumo di risorse ambientali. Florens vuole favorire una crescita economica green; ma, accanto a questo, vuole lanciare un modello innovativo di golden economy per la valorizzazione industriale e la reinterpretazione di tutta leconomia e dello storico saper fare che ruota attorno ai beni culturali e ambientali. Un giacimento dalle straordinarie potenzialit di sviluppo: basta vedere sia i dati che emergono da questo lavoro, misurati attraverso unoriginale scala quali-quantitativa denominata Florens Index, sia i moltiplicatori economici del settore. Questo studio strategico ci aiuta, perci, a verificare numeri alla mano quanto pesa leconomia dei beni culturali. E i numeri sono rilevanti. Un dato su tutti, che troverete in queste pagine: 100 Euro di incremento di PIL nel settore culturale generano un aumento di 249 Euro di PIL nel sistema economico, di cui 62 Euro nella sola industria manifatturiera. Ecco il valore prodotto dal modello di green and golden economy proposto da Florens 2010. Un modello valido per lItalia, ma esportabile a tutte le realt internazionali ad alta concentrazione di beni artistici e ambientali, perch capace di conciliare cultura, ambiente ed economia. Con Florens 2010 il mondo dellimpresa lancia, dunque, da Firenze unidea ambiziosa: leconomia dei beni culturali un nuovo motore di crescita e un nuovo paradigma produttivo vincente che mette al centro la conservazione, la valorizzazione, la produzione e il consumo di beni culturali e ambientali, rilanciando sinergie innovative fra ricerca, capacit di fare, cultura ed espressione artistica. LItalia conosciuta nel mondo per arte, cultura, creativit, qualit manifatturiera, turismo: la filiera unica del Made in Italy, che abbiamo saputo valorizzare a livello internazionale come stile di vita, e che non riguarda solo il design e la grande qualit di fashion, food and forniture, ma comprende anche lespressione artistica in tutte le sue forme. Questo rende il nostro Made in Italy un bene culturale vivente. Firenze un punto deccellenza internazionale dove, accanto ad un grande patrimonio ereditato dal passato, presente una cultura viva fatta di grandi istituzioni e di imprese leader nei settori del restauro, delle tecnologie optoelettroniche, dellilluminazione, delleditoria, fino alla moda e alle produzioni di lusso del Made in Italy, in cui sono normali le contaminazioni fra arte, design e saper fare manifatturiero e artigianale di altissima qualit. Florens 2010 ha sviluppato questa impostazione strategica attraverso molteplici iniziative: un forum biennale, dove riunire i principali operatori della cultura e delleconomia, per discutere ed elaborare proposte innovative; poi la costituzione di reti tra operatori della cultura e delleconomia di livello internazionale, poich lo sviluppo di uneconomia dei beni culturali richiede la combinazione di approcci, modelli e conoscenze di diversa natura; ma soprattutto questo studio strategico, che comprende anche una survey internazionale sullatteggiamento del cittadino e del sistema economico nei confronti della fruizione dei beni culturali. Dalla lettura di questo lavoro emergono proposte e moltissimi spunti concreti per impostare politiche industriali innovative, azioni di branding strategico per i territori e unagenda di azioni per crescere ad attrarre capitali e talenti. Insomma, con Florens 2010 la via della golden economy tracciata; e con essa pu aprirsi una nuova prospettiva di sviluppo industriale sostenibile e duraturo. Giovanni Gentile Presidente di Florens 2010
3
Leconomia dei beni culturali e ambientali.
Una visione sistemica e integrata
Indice
INDICE
1. Il Progetto Florens 2010 1.1. La genesi del progetto Florens 2010 1.2. Gli obiettivi di Florens 2010 1.3. Gli strumenti metodologici e gli output progettuali di Florens 2010 2. La definizione del settore culturale e creativo e il modello interpretativo di riferimento 2.1. Introduzione 2.2. La definizione di settore culturale e creativo: un quadro di sintesi 2.3. Il settore culturale e creativo come motore di crescita e attrattivit del territorio 2.4. Il settore culturale e creativo e la sua rilevanza per il sistema economico 2.5. Il modello concettuale utilizzato per lanalisi comparativa nazionale ed internazionale: la matrice del settore culturale e creativo 3. Il Florens Index: analisi comparativa nazionale 3.1. Introduzione 3.2. Analisi comparativa nazionale: il quadrante Capitale Culturale e Ambientale 3.3. Analisi comparativa nazionale: il quadrante Media 3.4. Analisi comparativa nazionale: il quadrante Networking 3.5. Analisi comparativa nazionale: il quadrante Sistema Creativo 3.6. Analisi comparativa nazionale: il Florens Index per le Regioni italiane 4. Il Florens Index: analisi comparativa internazionale 4.1. Introduzione 4.2. Analisi comparativa internazionale: il quadrante Capitale Culturale e Ambientale 4.3. Analisi comparativa internazionale: il quadrante Media 4.4. Analisi comparativa internazionale: il quadrante Networking 4.5. Analisi comparativa internazionale: il quadrante Sistema Creativo 4.6. Analisi comparativa internazionale: il Florens Index per i Paesi selezionati 5. La stima dellimpatto diretto, indiretto e indotto del settore culturale e creativo in Italia 5.1. Metodologie di stima degli impatti economici 5.2. Struttura e obiettivi dellanalisi delle interdipendenze settoriali 5.3. La valutazione dellimpatto economico derivante da un potenziamento del settore culturale e creativo 5.4. Moltiplicatori e Florens Index 5.5. Sintesi dei principali risultati emersi 6. Le principali evidenze emerse dalla survey nazionale e internazionale sul settore culturale e creativo 6.1. Obiettivi, ambiti dellanalisi e Paesi considerati nellindagine sulla cultura 6.2. I risultati dellindagine sulla cultura 6.3. Considerazioni di sintesi 7. La normativa sulla definizione dei beni culturali e paesaggistici 7.1. Primi passi verso il riconoscimento dei beni culturali 7.2. Verso il riconoscimento dei beni paesaggistici 7.3. Passaggi storici chiave nella definizione di bene culturale 7.4. Il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio 8. Raccomandazioni e indicazioni di policy per il rilancio del settore culturale e creativo in Italia 8.1. Introduzione 8.2. Le aree-chiave dintervento per una rinascita culturale dellItalia e della Toscana 8.3. Considerazioni conclusive Principali fonti documentali di riferimento Allegato - Alcuni esempi di eccellenze del sistema culturale e creativo fiorentino 7 7 13 13 21 21 21 26 28 38 47 47 48 62 69 75 84 89 89 89 99 103 107 115 119 119 120 124 130 131 137 137 138 177 187 187 188 188 190 193 193 193 208 211 215
Leconomia dei beni culturali e ambientali.
Una visione sistemica e integrata
1. Il progetto Florens 2010
1. IL PROGETTO FLORENS 2010
Il progetto Florens 2010 uniniziativa di politica industriale che intende promuovere il legame tra Economia e Cultura soprattutto in unepoca in cui la crisi ha imposto un profondo ripensamento dei principali modelli imprenditoriali e di consumo, nonch un riposizionamento di tutti i sistemi produttivi. Firenze ha lanciato al mondo unidea ambiziosa: leconomia dei beni culturali e ambientali pu rappresentare un nuovo paradigma produttivo vincente e un nuovo motore dello sviluppo industriale: a tal fine, desiderio comune degli enti economici e delle Istituzioni riunite allinterno del Comitato Promotore di Florens 2010 sviluppare proposte per la crescita economica di tutti i territori ad alta concentrazione di beni culturali e ambientali, nellottica di conciliare cultura, ambiente, tecnologia ed economia.
1.1. La genesi deL progetto FLorens 2010
1.1.1. Il Comitato Promotore di Florens 2010
La Settimana Internazionale dei Beni Culturali e Ambientali promossa da un Comitato formato da: - Intesa Sanpaolo; - Banca Cassa di Risparmio di Firenze; - Confindustria Firenze; - Confederazione Nazionale Artigianato Piccola e Media Impresa Firenze. Florens 2010 ha inoltre il sostegno di: - Camera di Commercio di Firenze; - Ente Cassa di Risparmio di Firenze; - Ministero dellAmbiente e della Tutela del Territorio e del Mare; - Regione Toscana; - Provincia di Firenze; - Comune di Firenze; - Associazione Partners Palazzo Strozzi. Nel novembre 2010 tale Comitato si trasformato in una Fondazione permanente, a testimonianza della grande fiducia degli enti promotori nella possibilit che il sistema culturale ed ambientale possa giocare un ruolo di primissimo piano nel rilancio delleconomia fiorentina e del suo territorio. Il Consiglio di Amministrazione di Florens 20101 presieduto da Giovanni Gentile (Presidente, Confindustria Firenze), mentre la Direzione Artistica di Florens 2010 affidata a Davide Rampello (Presidente, Fondazione La Triennale di Milano). Il Project Management di Florens 2010 affidato a Niccol Manetti (Membro del Consiglio Direttivo, Confindustria Firenze).
Il Consiglio di Amministrazione di Florens 2010 composto da: Aureliano Benedetti (Presidente, Banca CR Firenze e Vice Presidente, Comitato Florens 2010), Mauro Fancelli (Presidente, CNA Firenze), Leonardo Ferragamo (Presidente, APPS Associazione Partners Palazzo Strozzi), Marco Frey (Professore Ordinario, Universit SantAnna di Pisa), Alessandro Laterza (Presidente, Casa Editrice Laterza), Vittorio Meloni (Direttore Relazioni Esterne, Intesa Sanpaolo), Luigi Nenci (Direttore, CNA Firenze) e Mauro Pagliai (Tesoriere).
7
Leconomia dei beni culturali e ambientali.
Una visione sistemica e integrata
1.1.2. Perch il settore dei beni culturali e ambientali
La crisi economica internazionale la cui onda lunga oggi si sta ancora facendo sentire soprattutto in un settore, come quello culturale, per sua natura dipendente dai finanziamenti pubblici - ha polarizzato i modelli di sviluppo, di solito alternativamente, verso settori innovativi (si pensi, ad esempio, al ruolo della green economy nel cambiamento dei sistemi produttivi verso un minore consumo di risorse ambientali) o anti-ciclici (ad esempio, i settori tradizionali come il settore alimentare o il farmaceutico). Al contrario, il settore dei beni culturali e ambientali un settore in cui entrambe le dimensioni possono coesistere reciprocamente luna con laltra, essendo di fatto simultaneamente anti-ciclico e ad alta potenzialit di innovazione, poich include al suo interno anche i cosiddetti settori creativi. Il settore culturale ricopre, tanto in Italia quanto in Europa, un ruolo fondamentale non solo a livello economico, ma anche a livello sociale: - contribuisce allo sviluppo di settori correlati, come il turismo; - un settore in cui la dimensione locale estremamente importante, non solo in termini di consumo, ma anche in termini di produzione (la delocalizzazione pi difficile che in altri settori); - rappresenta, a livello locale, un importante strumento di integrazione sociale e di coesione territoriale. La stessa Unione Europea, nel maggio 2007, ha lanciato unAgenda per la Cultura fondata sulla promozione di tre aree: la diversit culturale e il dialogo interculturale, la cultura come catalizzatore della creativit e la cultura come elemento essenziale nelle relazioni internazionali dellEuropa. In tempi recenti (marzo 2010), la Commissione Europea ha inoltre proposto la strategiaEuropa 2020 per uscire dalla crisi e preparare leconomia comunitaria ad affrontare le sfide del prossimo decennio, prevedendo misure specifiche a sostegno della crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva: in questambito la cultura pu svolgere un ruolo centrale nella promozione dellinnovazione (ad esempio, con le nuove tecnologie per la valorizzazione e conservazione dei beni culturali), della digitalizzazione (fenomeno dellalfabetizzazione mediatica e creazione di nuovi ambienti di produzione dei contenuti e accesso alla cultura) e di nuove competenze/ attivit professionali (si pensi, ad esempio, alle sinergie su media & web o alle opportunit legate alla formazione su temi interculturali e alla gestione dei beni culturali). Infine, un elemento cruciale e frequentemente sottovalutato - riguarda le ricadute economiche per il territorio degli investimenti in cultura, in termini economici ed occupazionali, soprattutto degli impatti indotti sul settore manifatturiero. Tutti questi aspetti verranno approfonditi nello sviluppo del presente rapporto, con lobiettivo di fornire una visione sistemica del settore culturale e creativo.
1.1.3. Perch Firenze e la Toscana
LItalia il primo Paese al mondo per numero di siti iscritti nella Lista del Patrimonio Mondiale dellUNESCO (lOrganizzazione delle Nazioni Unite per lEducazione, la Scienza e la Cultura)2, che riflette la ricchezza e la diversit del patrimonio culturale e naturale a livello globale. LItalia riunisce infatti 45 Patrimoni dellUmanit, pari al 5% dei 911 siti culturali e naturali tutelati dallUNESCO. Allinterno delle regioni italiane, la Toscana si colloca in seconda posizione (con 6 siti, pari al 13% del totale nazionale), a breve distanza dalla Lombardia3.
2
La Convenzione del 1972 sulla tutela del patrimonio culturale e naturale mondiale incoraggia i Paesi membri a identificare e tutelare il proprio patrimonio che sia o meno iscritto nella Lista del Patrimonio Mondiale. Dal 1979 fanno parte della World Heritage List quei beni culturali o ambientali che sono stati ritenuti appartenenti ai popoli del mondo intero, a prescindere dal territorio sul quale si trovano La differenza tra un sito del Patrimonio Mondiale e un sito del patrimonio nazionale risiede nel concetto di eccezionale valore universale. I siti scelti per costituire il Patrimonio Mondiale sono selezionati per le loro caratteristiche specifiche, che li rendono il miglior esempio possibile del patrimonio culturale e naturale di tutto il mondo. La Lombardia con 7 siti tutelati dallUNESCO (15% del totale nazionale) - possiede due siti iscritti nella Lista del Patrimonio dellUmanit UNESCO condivisi con la Svizzera (la ferrovia retica sulla tratta Albula-Bernina e il Monte San Giorgio) ed uno condiviso con il Piemonte (Sacri Monti di Piemonte e Lombardia).
8
1. Il progetto Florens 2010
Figura 1 Il posizionamento dellItalia e della Toscana per numero di siti inseriti nella Lista del Patrimonio dellUmanit dellUNESCO Fonte: rielaborazione The European House-Ambrosetti su dati UNESCO World Heritage List, 2010
Firenze, culla del Rinascimento e della lingua italiana, una delle poche citt in Italia e al mondo il cui sviluppo urbanistico e civile sono andati di pari passo con le principali fasi storiche e culturali del Paese di appartenenza. Ad esempio, oltre allinnegabile centralit rivestita dalla citt durante il Medioevo e, soprattutto, nel Rina- Tra i primi siti tutelati dallUNESCO scimento (dallarchitettura alla scultura e pittura, dalla un letteratura alla scienza e alleconomia), appare oppor- La concentrazione dima ricchissimo e variegato patrimonio storico-artistico, anche scientifico e naturalistico 4 tuno ricordare che - anche se per un breve periodo in uno spazio circoscritto e ben delimitato hanno fatto s - Firenze fu capitale dItalia dal 1865 al 1870. In che il Centro Storico di Firenze sia stato uno dei primi siti questi anni non solo numerose zone ed interi quartieri individuati dallUNESCO delle Nazioni Unite (1982) tra furono ristrutturati ed ampliati, o edificati ex novo, ma i luoghi da inserire nella Lista Mondiale del Patrimonio allo sviluppo urbanistico della citt si accompagn un dellUmanit. rinnovato fervore culturale e sociale. Oggi, ad eccezione di Roma, Firenze lunica citt italiana ad ospitare grandi Istituzioni culturali ai massimi livelli, in ambito sia museale che musicale. A livello museale, la Galleria degli Uffizi5 pu essere definita come un vero e proprio museo dentro la citt, che si distingue per tale peculiarit rispetto a tanti altri grandi musei del mondo. grazie agli Uffizi e ad una rete di eccellenze museali di primo piano che Firenze pu essere interpretata come un paradigma valido per tutte le maggiori citt darte italiane: una citt dei musei6.
Alla fine della seconda guerra di indipendenza, la Toscana si un al Regno dei Savoia nellItalia unificata e Firenze venne dichiarata Capitale al posto di Torino, prima che la sede venisse trasferita a Roma a seguito della sua annessione al Regno dItalia. Nel corso dei secoli le collezioni di opere darte delle famiglie dei Medici e dei Lorena hanno contribuito a rendere la Galleria degli Uffizi uno dei pi importanti musei del mondo per le sue collezioni di statue antiche, disegni e di dipinti, tra i quali si annoverano opere di Giotto, Simone Martini, Piero della Francesca, Beato Angelico, Filippo Lippi, Botticelli, Mantegna, Correggio, Leonardo da Vinci, Raffaello, Michelangelo, Caravaggio. Significative sono anche le raccolte di pittori tedeschi, olandesi e fiamminghi, tra i quali Drer, Rembrandt e Rubens. Cos si esprime Antonio Paolucci (Direttore dei Musei Vaticani, gi Ministro per i Beni Culturali e Sovrintendente del Polo Museale Fiorentino) nella sua introduzione al Piano di Gestione del Centro Storico di Firenze: Firenze dunque non citt museo ma citt dei musei. Perch se vero che i musei fanno lo scheletro della citt, la innervano e la significano, altrettanto vero che in nessun altro luogo dItalia si avverte con altrettanto evidenza il museo uscire dai suoi confini, occupare le piazze e le strade, farsi citt con antica naturalezza. Si veda: Ufficio Centro Storico Patrimonio Mondiale UNESCO - Assessorato alla Cultura del Comune di Firenze, Piano di Gestione del Centro Storico di Firenze 2006-2008, marzo 2006.
9
Leconomia dei beni culturali e ambientali.
Una visione sistemica e integrata
Il centro stesso di Firenze, costellato di chiese, palazzi antichi, musei e collezioni darte, giardini storici, angoli caratteristici, botteghe artigianali e negozi di grande tradizione permettono al visitatore di respirare la compenetrazione tra presente e passato e rendono la citt un museo diffuso, unopera darte vivente piuttosto che una galleria di opere darte allaperto. Al patrimonio museale fiorentino (sia statale che comunale) appartengono innumerevoli palazzi storici e collezioni di rilievo come quelle di Palazzo Pitti e dei suoi musei, della Galleria dellAccademia, del Museo Archeologico Nazionale, del Museo Galileo - Istituto e Museo di Storia della Scienza (una delle principali istituzioni internazionali attive nella museografia scientifica, nella produzione di iniziative per la diffusione della cultura scientifica e nelle attivit di documentazione e di ricerca), del Museo Nazionale del Bargello, del Museo Stibbert (noto per le preziose collezioni di porcellane e di armeria europea ed extra-europea) o del Museo di Zoologia La Specola (il pi antico museo scientifico dEuropa7). Tra i primi 30 musei, monumenti ed aree archeologiche statali italiani per numero di visitatori, ben 6 si trovano a Firenze, per un totale di 4,2 milioni di visitatori8 ogni anno.
Figura 2 Primi 30 musei, monumenti e aree archeologiche statali in Italia per numero di visitatori (istituti a pagamento), 2009 Fonte: rielaborazione The European House-Ambrosetti su dati dellUfficio di Statistica del Ministero per i Beni e le Attivit Culturali, rilevazione 2009
In campo musicale, il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino una delle pi prestigiose fondazioni lirico-sinfoniche in Italia e fra i pi importanti teatri dEuropa. Tra le sue attivit si inserisce il Festival del Maggio Musicale Fiorentino, il pi antico festival musicale italiano, fondato nel 1933, punto di riferimento internazionale per lampio repertorio e per la produzione contemporanea, che si tiene ogni anno nei mesi di maggio e giugno. Non un caso, quindi, che i due pi importanti cantieri di opere pubbliche attualmente aperti a Firenze siano rispettivamente il raddoppio della superficie espositiva degli Uffizi e il cantiere del nuovo Teatro del Maggio Musicale Fiorentino9.
7
Il Museo La Specola, fondato dal Granduca Pietro Leopoldo di Lorena e aperto al pubblico nel 1775, contiene la pi grande collezione al mondo di cere anatomiche, eseguite tra il 1770 ed il 1850, ed oltre 3.500.000 di animali (di cui circa 5.000 esposti al pubblico). Attualmente il museo una Sezione del Museo di Storia Naturale di Firenze. Nello specifico, si tratta di: Galleria degli Uffizi e Corridoio Vasariano, Galleria dellAccademia di Firenze, Circuito Museale Museo degli Argenti, Museo delle Porcellane, Giardino di Boboli, Galleria del Costume, Giardino Bardini, Circuito museale Galleria Palatina e Appartamenti Monumentali di Palazzo Pitti e Galleria dArte Moderna, Cappelle Medicee e Museo Nazionale del Bargello. Fonte: Ministero per i Beni e le Attivit Culturali, Ufficio di Statistica della Direzione Generale per lOrganizzazione, gli Affari generali, lInnovazione, il Bilancio e il Personale, Servizio I Affari Generali, Sistemi Informativi, Tecnologie Innovative, rilevazione 2009. Linaugurazione della sala principale prevista nel dicembre 2011, a coronamento dellanno che celebrer il 150 anniversario dellUnit dItalia.
10
1. Il progetto Florens 2010
Sempre nel settore culturale, Firenze sede di Istituzioni, Accademie ed enti culturali di primissimo piano. Basti citare: - la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, una delle pi importanti biblioteche europee, la pi grande in Italia10, nonch lunica che possa fregiarsi - insieme alla Biblioteca di Roma del titolo di Centrale, funzione conferitale quando Firenze era capitale dItalia; - lIstituto Geografico Militare Italiano, lEnte Cartografico dello Stato - trasferito nel 1865 da Torino a Firenze - che ha il compito di fornire supporto geotopocartografico alle Unit e ai Comandi dellEsercito Italiano; - lAccademia della Crusca che, fondata nella seconda met del XVI secolo, la pi antica accademia linguistica dEuropa ed oggi rappresenta il pi importante centro di ricerca scientifica dedicato allo studio e alla promozione della lingua italiana; - lAccademia dei Georgofili, storica istituzione fiorentina fondata nel 1753 per contribuire al progresso delle scienze e delle loro applicazioni allagricoltura in senso lato, alla tutela dellambiente, del territorio agricolo e allo sviluppo del mondo rurale. Infine, Firenze si distingue per una evidente dimensione internazionale, degna di una grande capitale europea11: lo testimoniano gli oltre 50 consolati esteri (di carriera e onorari) e pi di una trentina di universit americane presenti sul territorio fiorentino, nonch altri enti culturali stranieri distaccati a Firenze, come il Kunsthistorisches Institut di pertinenza del Max-Planck-Institute12. Non si deve infine dimenticare lo stretto legame tra economia e cultura: in Italia il Valore Aggiunto del settore culturale ammonta a circa 116 miliardi di Euro, pari al 9,3% del Valore Aggiunto nazionale, a fronte delloccupazione di quasi 2,8 milioni di addetti, pari all11,9% delloccupazione totale13.
Una citt con una spiccata vocazione internazionale
Firenze ha da sempre attratto studiosi e turisti da tutto il mondo. In particolare, tra la fine dellOttocento e il primo Novecento la citt ospit una vivace e numerosa comunit straniera. Ne fecero parte, ad esempio, il mercante ginevrino G.P. Vieusseux, il filosofo Sismondi, la poetessa vittoriana Elisabeth Barrett Browning, lo storico e giornalista Robert Davidshon ed il critico darte Bernhard Berenson. La capacit di attrarre visitatori da tutto il mondo si perpetuata fino ai giorni nostri.
In particolare, le attivit culturali in senso stretto (patrimonio culturale, arte contemporanea, architettura, musica e Performing Arts) detengono una quota del 17,2% del settore culturale e creativo italiano, con un Valore Aggiunto pari a 20 miliardi di Euro (l1,6% del PIL nazionale) del 15% in termini di occupati, ovvero circa mezzo milione di addetti (l1,7% delloccupazione nazionale). Tra le regioni italiane, la Toscana si distingue per un sistema dei beni culturali estremamente ricco e di rilievo. Secondo recenti indagini condotte sul sistema economico integrato dei beni culturali14, la Toscana ha registrato nel 2006 un Valore Aggiunto di 11,3 miliardi di Euro ed oltre 268.000 occupati.
10
11
12 13
14
La Biblioteca dispone di un patrimonio di 6.000.000 volumi a stampa, 120.000 testate di periodici di cui 15.000 in corso, 4.000 incunaboli, 25.000 manoscritti, 29.000 edizioni del XVI secolo e oltre 1.000.000 di autografi. Le scaffalature dei depositi librari coprono attualmente 120 Km lineari, con un incremento annuo di circa 2 Km. Si segnala che Firenze gemellata con numerose citt europee ed extra-europee, come Kassel (sede della mostra darte contemporanea pi rinomata al mondo, lesposizione Documenta, realizzata dal 1955 con cadenza quinquennale) e con Dresda, nota infatti con lappellativo di Firenze sullElba. La citt vanta la pi alta concentrazione in Italia di Istituti di cultura ed Universit estere con sede permanente a Firenze. Fonte: W. Santagata, Libro Bianco sulla Creativit. Per un modello italiano di sviluppo, Universit Bocconi Editore, Milano, 2009. Lo studio analizza il macro-settore culturale e creativo secondo tre componenti: il patrimonio storico e artistico, le industrie di produzione di contenuti, informazioni e comunicazione (industrie di contenuto) e le attivit legate alla cosiddetta cultura materiale. Fonte: Unioncamere - Ministero dei Beni e delle Attivit Culturali - Istituto Guglielmo Tagliacarne, Il Sistema Economico Integrato dei Beni Culturali, 2009. Tali dati si riferiscono alle seguenti categorie: Produzione industriale e artigianale, Beni e attivit culturali (gestione di musei e del patrimonio culturale, gestione di sale cinematografiche, teatri e sale da concerto, attivit di biblioteche e archivi, attivit di organizzazioni che perseguono fini culturali e ricreativi, creazioni e interpretazioni artistiche e letterarie, corsi di laurea, di diploma universitario e post-universitari, ecc.), Enogastronomia e produzioni tipiche, Architettura ed edilizia di riqualificazione ed Industria Culturale (attivit legate ai settori Editoria, Audiovisivi e Multimediale).
11
Leconomia dei beni culturali e ambientali.
Una visione sistemica e integrata
Inoltre, il capoluogo toscano rispetto ad altre citt italiane possiede intatto un inestimabile patrimonio artigianale in quanto il centro vive ancora di botteghe e aziende artigiane15, nucleo di un sistema creativo estremamente effervescente che spazia dal restauro delle opere darte al ricamo, dalla molatura ed incisione di cristalli alla numismatica. Sul fronte industriale, non mancano infine esperienze di successo nel settore dellindustria e dei servizi legati al settore culturale e creativo come maison del Sistema Moda affermate a livello internazionale, societ editoriali, dellarredamento, dellilluminotecnica e, pi in generale, del design. Firenze, la Toscana, lItalia costituiscono quindi, quasi per diritto naturale, la sede ideale di un laboratorio che sintetizzi pensieri e azioni volti alla valorizzazione innovativa dei beni culturali e ambientali. In particolare, Firenze possiede tutte le carte in regola per guidare un movimento di pensiero dedicato allinnovazione nel sistema dei beni culturali e ambientali quale motore di sviluppo economico, grazie alla peculiarit e, per certi versi, allunicit della sua offerta artistico-culturale e paesaggistico-naturale, del suo sistema economico-produttivo fortemente orientato ai settori creativi, nonch della storia del capoluogo toscano e del suo territorio.
Tradizione e tecnologia a Firenze: un binomio di successo
Una delle eccellenze fiorentine rappresentata dallOpificio delle Pietre Dure di Firenze, lIstituto Centrale del Ministero per i Beni e le Attivit Culturali specializzato nellattivit di restauro, conservazione e consulenza sui beni culturali. Nel territorio di Firenze sono insediate numerose ed interessanti espressioni di realt industriali legate alle tecnologie innovative, sia digitali che applicate alla conservazione dei beni culturali: oltre ad una fitta rete di PMI locali vi sono aziende come El.En. (fabbricazione di sistemi laser per applicazioni nel settore medicale e industriale - dal taglio, marcatura e saldatura di metalli, legno, plastica, vetro alla decorazione di pelli e tessuti fino al restauro conservativo di opere darte) e Centrica (servizi e prodotti nelle aree web, imaging e multimedia).
1.1.4. Perch Florens 2010
La scelta di chiamare Florens 2010 la Settimana Internazionale dei Beni Culturali e Ambientali dettata dalla volont di legare Firenze al concetto di fioritura delle arti e dellambiente. Come stato sottolineato, oggi Firenze certamente uno dei luoghi al mondo in cui ha pi senso elaborare una riflessione scientifica, ma anche divulgativa, sullarmonia che deve rifiorire tra il mondo dei beni culturali e ambientali e le citt. Florens 2010 vuole dunque preparare il terreno a una visione unitaria del concetto di cultura, attraverso la proposta di progetti e idee che coniughino i saperi artistici, artigiani e imprenditoriali. Non a caso, il fil rouge della Settimana fiorentina il legame tra valorizzazione e reinterpretazione, inteso come new economy dei beni culturali e ambientali: partendo da tale concetto, la manifestazione sviluppa in parallelo riflessioni scientifiche, originate e destinate al pubblico dei decision maker nel campo dei beni culturali e ambientali, e attivit divulgative, frutto del programma di eventi per i cittadini, gli studenti e i turisti a Firenze. Attraverso Florens 2010 si vuole indurre la collettivit a riflettere sulle ragioni di un cambiamento non solo nellambito della cultura e dei beni culturali ma anche nei sistemi di produzione del benessere, nelle organizzazioni sociali, nelle istituzioni politiche, nel mondo del lavoro e della formazione. Per Firenze e i comuni limitrofi coinvolti (Bagno a Ripoli, Fiesole, Campi Bisenzio e Scandicci) dal 12 al 20 novembre 2010, la Settimana, con 150 eventi fra convegni, mostre ed esibizioni, rappresenta inoltre un momento di grande prestigio per promuovere e valorizzare il patrimonio locale e per riconfermarsi nellambito delle arti e della cultura quale modello di riferimento su scala globale.
15
Si pensi, solo per citare alcuni esercizi di particolare notoriet, alla Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella (fondata nel 1612), alla Moleria Locchi (famosa in tutto il mondo per la qualit dei suoi restauri su preziosi oggetti di vetro e di cristallo), al Laboratorio di Ricamo di Loretta Caponi o alla Bottega di Restauro di Andrea Fedeli.
12
1. Il progetto Florens 2010
Lappuntamento della Settimana destinato a esperti, operatori del settore e decisori politici il Forum Internazionale dei Beni Culturali e Ambientali dal 18 al 20 novembre 2010, occasione di confronto per dibattere le principali tematiche e identificare e condividere linee dazione future.
Il logo di Florens 2010
Il marchio di Florens 2010, concepito dallo Studio Cerri & Associati, utilizza come elemento generatore il quadrato, posizionato a 45 gradi rispetto alla linea di base e iscritto in un altro quadrato ruotato di 15 gradi in senso antiorario rispetto al primo: da tale sovrapposizione si ottiene un segno grafico dalla connotazione fortemente geometrica e immediatamente riconoscibile. Inoltre, il marchio di Florens 2010 non solo rivolge una particolare attenzione alla teoria delle forme sulla percezione visiva e alla grafica costruttiva, ma anche contraddistinto dal rosso e dal bianco, colori della citt di Firenze.
1.2. GLI OBIETTIVI DI FLORENS 2010
Coerentemente con la propria missione, il progetto Florens 2010 intende: - proporre un modello interpretativo del sistema culturale e creativo che ne evidenzi le valenze, gli attori La missione di Florens 2010 e le principali prospettive di sviluppo; Creare a Firenze un laboratorio permanente inter- valorizzare la citt di Firenze, e pi in generale la nazionale di approfondimento e di confronto per Toscana, secondo un modello che sia coerente con la la classe dirigente e gli operatori sui temi dei Beni sua vocazione e le sue tradizioni e, allo stesso tem- Culturali e Ambientali quali strumenti chiave di po, benefici al massimo delle opportunit offerte dal sviluppo economico e benessere sociale. Promuovere un nuovo modello per la valorizzazione del mondo digitale e multimediale; - analizzare lo stato dellarte delle principali eccellenze patrimonio culturale e diffondere una visione uniper la valorizzazione economica del patrimonio cul- taria e sinergica tra cultura, ambiente, tecnologia ed economia. turale, paesaggistico e ambientale; - evidenziare le principali best practice internazionali; - coinvolgere esperti e classe dirigente su tali temi per offrire una opportunit di dialogo e confronto; - elaborare azioni e proposte per gli stakeholder istituzionali. Inoltre, lambizione della Settimana Internazionale dei Beni Culturali e Ambientali di Firenze di determinare importanti ricadute in termini di attrattivit territoriale e di coinvolgimento attivo dei cittadini e degli operatori economici locali. In generale, la Settimana Internazionale dei Beni Culturali e Ambientali aspira a suscitare una forte visibilit internazionale per Firenze, posizionandola come frontiera della sperimentazione nel settore dei beni culturali e ambientali.
1.3. GLI STRUMENTI METODOLOGICI E GLI OUTPUT PROGETTUALI DI FLORENS 2010
La metodologia di lavoro adottata per il progetto Florens 2010 ha previsto lattivazione in parallelo di pi strumenti di coinvolgimento dei principali stakeholder progettuali lattivazione di un Advisory Board di alto profilo e di tre Tavoli Tecnici costituiti ad hoc per la realizzazione del presente Studio Strategico e la definizione del programma della Settimana Internazionale dei Beni Culturali e Ambientali e del Forum Internazionale dei Beni Culturali e Ambientali di Firenze.
13
Leconomia dei beni culturali e ambientali.
Una visione sistemica e integrata
Figura 3 Gli strumenti metodologici e gli output progettuali di Florens 2010 Fonte: elaborazione The European House-Ambrosetti, 2010
1.3.1. LAdvisory Board e il Consiglio Scientifico
La realizzazione dello Studio Strategico e la progettazione del Forum Internazionale dei Beni Culturali e Ambientali di Firenze sono stati supportati dallattivit di un Advisory Board formato da un Consiglio Scientifico internazionale, dai Vertici di Florens 2010, da un mix di esperti, accademici, imprenditori e rappresentanti del Gruppo di Lavoro The European House-Ambrosetti.
Figura 4 Le funzioni dellAdvisory Board e del Consiglio Scientifico Internazionale di Florens 2010 Fonte: elaborazione The European House-Ambrosetti, 2010
LAdvisory Board, oltre alla validazione scientifica del lavoro svolto, ha portato un contributo attivo elaborando linee guida, spunti di riflessione e idee per la progettazione e la realizzazione dello studio strategico e dellimpianto concettuale e metodologico sviluppato allinterno dello Studio Strategico.
14
1. Il progetto Florens 2010
I componenti del Consiglio Scientifico di Florens 2010 sono: - Cristina Acidini (Soprintendente, Polo Museale Fiorentino); - Robert L. Dilenschneider (Presidente, The Dilenschneider Group); - Andrea Fedeli (Restauratore di Firenze, Fedeli Restauri); - Paolo Galluzzi (Direttore, Museo Galileo - Istituto e Museo di Storia delle Scienze di Firenze); - Terry Garcia (Executive Vice President, National Geographic Society); - Massimiliano Magrini (Fondatore e CEO, Annapurna Ventures; gi Country Manager, Google Italia); - Fabrizio Moretti (Presidente, Galleria Moretti); - Giovanni Puglisi (Rettore, IULM; Presidente, Commissione Nazionale Italiana per lUNESCO); - Davide Rampello (Presidente, Fondazione La Triennale di Milano; Direttore Artistico, Florens 2010); - Severino Salvemini (Professore Ordinario di Organizzazione Aziendale e Direttore del Corso di Laurea in Economia per le Arti, la Cultura e la Comunicazione, Universit Bocconi); - Alberto Tesi (Rettore, Universit degli Studi di Firenze). Il Consiglio Scientifico, dotato di una funzione consultiva per lo Studio Strategico e il Forum, ha la missione di indirizzare a livello macro il lavoro e di contribuire alla promozione, tra gli altri opinion leader, del progetto Florens 2010 nel mondo. Gli altri componenti dellAdvisory Board di Florens 2010 sono: - Patrizia Asproni (Presidente, Confcultura); - Francesco Caracciolo (Direttore, Confindustria Firenze); - Valerio De Molli (Managing Partner, The European House-Ambrosetti); - Paolo Fresco (Collezionista darte); - Giovanni Gentile (Presidente, Confindustria Firenze; Presidente, Florens 2010); - Niccol Manetti (Membro del Consiglio Direttivo, Confindustria Firenze; Project Manager, Florens 2010); - Antonio Mocenni (Dirigente, Rapporti Istituzionali e Territorio, Turismo e Cultura, Confindustria Firenze); - Luigi Nenci (Direttore, CNA Firenze); - Stefano Passigli (Presidente, Scala Group; Fondatore, Passigli Editori); Il Gruppo di Lavoro The European House-Ambrosetti formato da: Silvia Colombo, Daniela Bianco, Emiliano Briante, Pio Parma, Edoardo Pauletta dAnna, Massimiliano Sartori e Chiara Trabacchi.
1.3.2. I Tavoli Tecnici di Lavoro
Il progetto ha previsto il coinvolgimento dei principali stakeholder di riferimento nazionali e locali attraverso il meccanismo dei Tavoli Tecnici di Lavoro (Working Group). I protagonisti dei Tavoli Tecnici hanno contribuito attivamente allo Studio Strategico e al Forum, attraverso lo scambio e il confronto creativo.
Il coinvolgimento degli stakeholder di riferimento
Il progetto ha coinvolto complessivamente 11 Istituzioni nel Tavolo delle Istituzioni, 38 Enti nel Tavolo degli Enti Culturali e delle Universit e le rappresentanze in Italia di 15 Paesi nel Tavolo internazionale per il Patrimonio Culturale e Paesaggistico.
15
Leconomia dei beni culturali e ambientali.
Una visione sistemica e integrata
Tavolo delle Istituzioni
La missione del Tavolo delle Istituzioni stata di fornire spunti e idee per la progettazione e la realizzazione della Settimana Internazionale dei Beni Culturali e Ambientali, oltre a indicazioni per lo sviluppo del settore.
I componenti del Tavolo delle Istituzioni
Le Istituzioni aderenti al Tavolo sono: Ministero per i Beni e le Attivit Culturali, Senato della Repubblica, Regione Toscana, Provincia di Firenze, Comune di Firenze, Prefettura di Firenze, Arcivescovado di Firenze, Consolato statunitense a Firenze, Consolato francese a Firenze, Consolato tedesco a Firenze e Consolato inglese a Firenze.
Tavolo degli Enti Culturali e delle Universit
La missione del Tavolo delle Istituzioni stata di coinvolgere le principali Universit ed enti culturali presenti sul territorio fiorentino per raccogliere spunti e idee per la realizzazione dello Studio Strategico e del Forum Internazionale.
I componenti del Tavolo degli Enti Culturali e delle Universit
Gli enti rappresentati al Tavolo sono: Direzione Generale Politiche Formative, Beni e Attivit Culturali della Regione Toscana, Soprintendenza per i Beni Archeologici della Regione Toscana, Soprintendenza per i Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici per le province di Firenze, Pistoia e Prato, Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana, Direzione Sviluppo Economico e Programmazione della Provincia di Firenze, Direzione Innovazione, Attuazione del Programma del Comune di Firenze, Opificio delle Pietre Dure di Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, CNR-Istituto per la Conservazione e la Valorizzazione dei Beni Culturali, Accademia della Crusca, Accademia dei Georgofili, Accademia delle Belle Arti di Firenze, Polo Museale di Firenze (Galleria degli Uffizi, Galleria Accademia, Galleria di Arte Moderna), Museo Nazionale del Bargello, Museo Marino Marini, Musei Comunali di Firenze, Museo Galileo - Istituto e Museo di Storia della Scienza, Museo Stibbert, Fondazione Palazzo Strozzi, Fondazione Pitti Immagine, Fondazione Circolo Rosselli, Associazione Dimore Storiche Toscana, Il Maggio Musicale Fiorentino, Firenze Sapere, Conservatorio Musicale Luigi Cherubini di Firenze, Istituto Polimoda, Centro per larte contemporanea Luigi Pecci di Prato, Universit degli Studi di Firenze, The British Institute of Florence, Istituto Universitario Europeo, New York University di Firenze, Syracuse University di Firenze, Harding University di Firenze, Universit Internazionale dellArte di Firenze, Gabinetto Scientifico Letterario G.P. Vieusseux, Istituto Italiano di Scienze Umane e Villa I Tatti - The Harvard University Center for Italian Renaissance Studies.
Tavolo Internazionale per il Patrimonio Culturale e Paesaggistico
La missione del Tavolo Internazionale per il Patrimonio Culturale e Paesaggistico stata di aggiornare i rappresentanti in Italia dei principali Paesi in tema di sviluppo dei beni culturali e ambientali sugli obiettivi e le attivit della Settimana Internazionale di Firenze. I rappresentanti diplomatici aderenti al Tavolo hanno altres promosso liniziativa nei Paesi di appartenenza. Le riunioni del Tavolo Internazionale si sono tenute presso la sede del Ministero dei Beni e delle Attivit Culturali.
I componenti del Tavolo Internazionale per il Patrimonio Culturale e Paesaggistico
Le Istituzioni aderenti al Tavolo sono state: Ministero per i Beni e le Attivit Culturali, British Council in Italia, Ambasciata di Francia in Italia, Ambasciata di Germania in Italia, Ambasciata di Grecia in Italia, Ambasciata dellIndia in Italia, Ambasciata del Messico in Italia, Ambasciata di Spagna in Italia, Ambasciata degli Stati Uniti dAmerica in Italia, Ambasciata del Brasile in Italia, Ambasciata di Algeria in Italia, Ambasciata dEgitto in Italia, Ambasciata del Marocco in Italia, Ambasciata del Sud Africa in Italia ed Ambasciata della Turchia in Italia.
16
1. Il progetto Florens 2010
Il coinvolgimento della cittadinanza e delle community attive nel settore culturale e creativo stato realizzato anche attraverso il sito web delliniziativa (www.florens2010.com), nelle apposite sezioni dedicate al Social Networking. Inoltre, al fine di approfondire alcuni aspetti specifici sul sistema dei beni culturali e ambientali, sono state realizzate numerose interviste con opinion leader ed esperti del settore. Un particolare ringraziamento a: - Cristina Acidini (Soprintendente, Polo Museale Fiorentino) - Marco Bagnoli (Artista; Amministratore Delegato, Sammontana) - Mounir Bouchenaki (Direttore Generale, ICCROM International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property) - Lorenzo Bini Smaghi (Presidente, Fondazione Palazzo Strozzi di Firenze) - Marco Cammelli (Professore di Diritto Amministrativo presso la Facolt di Giurisprudenza, Universit degli Studi di Bologna) - Lorenzo Capineri (Professore presso il Dipartimento di Elettronica e Telecomunicazioni, Universit degli Studi di Firenze) - Sara Cedar Miller (Associate Vice President for Park Information, Central Park Conservancy di New York) - Maria Ann Conelli (Executive Director, American Folk Art Museum di New York) - Paolo Del Bianco (Presidente, Fondazione Romualdo Del Bianco di Firenze) - Laurent Fabius (Presidente, Rouen District Council; gi Primo Ministro, Francia; Parlamentare) - Jean-Paul Fitoussi (Presidente del Consiglio Scientifico, Institut dEtudes Politiques de Paris; Presidente, Observatoire Franais des Conjonctures Economiques) - Patrizio Fondi (Consigliere diplomatico, Ministero per i Beni e le Attivit Culturali) - Vittoria Franco (Senatrice, Commissione Cultura) - Vasco Galgani (Presidente, Camera di Commercio di Firenze) - Louis Godart (Direttore Ufficio per la conservazione del patrimonio artistico, Presidenza della Repubblica) - Isabella Lapi Ballerini (Sovrintendente, Opificio delle Pietre Dure di Firenze) - Robert L. Lynch (President and CEO, Americans for the Arts) - Glenn Lowry (Direttore, Museum of Modern Art MoMA di New York) - Marco Magnifico (Vice Presidente Esecutivo, FAI Fondo per lAmbiente Italiano) - Leonardo Masotti (Professore Ordinario di Elettronica, Universit degli Studi di Firenze; Presidente del Comitato Scientifico, El.En.) - Dario Nardella (Vice Sindaco e Assessore allo Sviluppo Economico, Comune di Firenze) - Antonio Paolucci (Direttore, Musei Vaticani; gi Ministro per i Beni Culturali e Sovrintendente del Polo Museale Fiorentino) - Jeffrey H. Patchen (President and CEO, Childrens Museum of Indianapolis) - Anne Radice (former Director, The Institute of Museum and Library Services; Principal, The Dilenschneider Group) - Gian Bruno Ravenni (Coordinatore Area Cultura e Sport della Direzione Generale Politiche Formative, Beni Attivit Culturali, Regione Toscana)
17
Leconomia dei beni culturali e ambientali.
Una visione sistemica e integrata
- Peter Reed (Senior Deputy Director for Curatorial Affairs, Museum of Modern Art MoMA di New York) - Mario Resca (Direttore Generale per la Valorizzazione del Patrimonio Culturale, Ministero dei Beni e delle Attivit Culturali) - Cristina Scaletti (Assessore alla Cultura, al Turismo e al Commercio, Regione Toscana) - Robert Shackelford (Director, Harding University di Firenze) - Patrizio Tancredi (Dirigente del Settore Promozione e Sostegno della Ricerca, Regione Toscana) - Simone Tani (Dirigente Area Innovazione e Attuazione del Programma, Comune di Firenze)
1.3.3. Lo Studio Strategico di Florens 2010
Lo Studio Strategico intende analizzare il settore culturale e creativo secondo una logica integrata e sistemica e ne esamina lapporto alla crescita economica e occupazionale del nostro Paese, fornendo dei confronti regionali ed internazionali e un sondaggio sui comportamenti dei cittadini. Lo studio contiene anche un insieme di raccomandazioni finalizzate alla piena valorizzazione e allo sviluppo del settore culturale e creativo in Italia. Di seguito una breve descrizione dei diversi capitoli che compongono lo Studio Strategico:
Lanalisi di benchmark nazionale ed internazionale: il Florens Index
Uno degli elementi centrali del lavoro svolto il c.d. Florens Index, uno strumento di analisi che permette di realizzare confronti su base nazionale - tra la Toscana e le altre Regioni italiane - ed internazionale - tra lItalia e altri Paesi europei ed extra-europei selezionati16 - rispetto al potenziale e al dinamismo espresso dal settore culturale e creativo. Come si vedr in maggior dettaglio nei Capitoli 3 e 4 del presente rapporto, il Florens Index si basa sul modello della matrice del settore culturale e creativo, che per ciascun territorio propone una lettura sistemica e integrata delle componenti economiche, artisticoculturali, ambientali e sociali afferenti al settore, distinguendo 4 quadranti diversi (Capitale Culturale e Ambientale, Media, Networking e Sistema Creativo). Il Florens Index rappresenta una rilevazione del posizionamento di ciascun territorio rispetto al potenziale del settore culturale e creativo. Il modello concettuale di analisi stato sviluppato a partire dalla raccolta e analisi dei riferimenti bibliografici pi rilevanti sul tema. Grazie allanalisi di una serie di indicatori statistici (55 indicatori per il confronto nazionale e 40 indicatori per il confronto internazionale), allattribuzione di punteggi e alla ponderazione dei risultati stato possibile (sia per ognuno dei quattro quadranti della matrice sia che per lintero modello) evidenziare le aree di forza e di debolezza di ciascun territorio.
La stima del valore del settore culturale e creativo in Italia
Nellambito dello Studio Strategico stata calcolata una stima del valore economico del settore culturale e creativo (Capitolo 5) attraverso lapplicazione della teoria delle interdipendenze settoriali. In particolare, attraverso una serie di rielaborazioni ottenute partendo dalle cosiddette matrici input-output dellISTAT, si potuto ottenere una stima del valore generato dal settore culturale e creativo nel nostro Paese: le evidenze emerse hanno offerto lo spunto per alcune riflessioni in merito al rendimento di scelte di investimento in questo settore in termini di sviluppo economico diretto e indotto e di nuova occupazione.
Lindagine sulla cultura in Italia e allestero
Lo studio contiene anche unindagine sulla cultura (Capitolo 6) realizzata presso un campione rappresentativo di cittadini (4.000 individui in Italia e 1.000 in ciascuno dei seguenti Paesi: Francia, Germania, Spagna, Regno Unito e Stati Uniti, stratificati per sesso, et, livello di istruzione e macro-area di residenza), con riferimento alla conoscenza dellofferta culturale e linteresse verso i beni culturali, i comportamenti, le esigenze e le scelte degli individui in relazione a temi culturali, lutilizzo delle nuove tecnologie nelle iniziative culturali e lattitudine al mecenatismo e donazioni nei confronti di attivit culturali.
16
A livello internazionale il Florens Index stato calcolato per i seguenti Paesi: Italia, Francia, Germania, Spagna, Grecia, Giappone, Stati Uniti e Regno Unito.
18
1. Il progetto Florens 2010
La normativa dei beni culturali e paesaggistici
stata condotta una overview sulla legislazione nel settore dei beni culturali in Italia (Capitolo 7), con particolare attenzione allevoluzione del concetto di bene culturale e paesaggistico e sulle principali disposizioni normative in materia.
Raccomandazioni e indicazioni di policy
Le analisi svolte e i risultati delle analisi quali-quantitative realizzate nel corso del progetto (Florens Index, indagini presso i cittadini e confronto allinterno dellAdvisory Board e dei Tavoli Tecnici) hanno permesso di elaborare una serie di raccomandazioni ed indicazioni di policy finalizzate alla piena valorizzazione e allo sviluppo del settore culturale e creativo in Italia (Capitolo 8).
1.3.4. La Settimana Internazionale dei Beni Culturali e Ambientali e il Forum Internazionale di Florens 2010
Come stato ricordato precedentemente, la Settimana Internazionale dei Beni Culturali e Ambientali di Firenze (12 - 20 novembre 2010) mira a promuovere il patrimonio culturale e ambientale quale volano di sviluppo economico e sociale, proponendo un modello innovativo di golden economy per la valorizzazione industriale del giacimento di beni culturali e ambientali. Il tema-guida della manifestazione, La valorizzazione reinterpretazione, vuole indurre infatti ad una riflessione sulle ragioni e necessit del cambiamento, non solo nellambito culturale, ma anche presso i sistemi di produzione e le istituzioni, a favore del miglioramento della qualit della vita, dellaumento della competitivit intellettuale ed imprenditoriale. Partendo da questo concetto, liniziativa proporr 150 eventi tra workshop, mostre, lectio, dialoghi, convegni, percorsi e riflessioni scientifico-culturali rivolti sia ad un pubblico di addetti ai lavori sia a studenti, cittadini e turisti. Florens 2010 ospiter personalit ed esperienze di rilevanza mondiale ed al contempo le eccellenze culturali, artistiche ed economiche del territorio. Lintera citt di Firenze sar coinvolta: dai luoghi del sacro a quelli delle Istituzioni civiche, dai palazzi privati alle piazze, dai musei alle universit, dagli spedali alle biblioteche, dai teatri alle librerie, fino ai comuni limitrofi di Scandicci, Fiesole, Campi Bisenzio e Bagno a Ripoli17. Alla fine della settimana si terr il Forum Internazionale dei Beni Culturali e Ambientali (dal 18 al 20 novembre 2010), le cui finalit sono di: - costituire il punto di riferimento per gli operatori del settore in Italia e nel mondo sulla situazione e prospettive dei beni culturali e ambientali come volano economico; - valorizzare in senso innovativo la citt di Firenze e la sua vocazione alla tutela e valorizzazione dei beni culturali; - presentare una proposta innovativa di riflessione e discussione sulleconomia dei beni culturali e ambientali, frutto del lavoro dellAdvisory Board e dei Tavoli Tecnici. Le tre giornate del Forum vedranno riuniti esperti, rappresentanti dei pi importanti musei del mondo, organizzazioni e istituzioni internazionali a discutere e confrontarsi sui principali temi relativi al futuro dei beni culturali e ambientali in Italia e nel mondo, con focus sullevoluzione economica delle citt darte, sulla gestione del patrimonio e sulle nuove tecnologie per costruire innovazione. Nelle intenzioni del Comitato Promotore, liniziativa diventer un appuntamento periodico nel panorama degli eventi internazionali dedicati al sistema dei beni culturali e ambientali: ogni due anni, i rappresentanti dei Governi e le principali Istituzioni culturali mondiali si incontreranno a Firenze per fare il punto sulle agende e sviluppare nuovi progetti, facendo del capoluogo fiorentino una delle capitali delleconomia culturale e creativa, non solo per il grande patrimonio ereditato dal passato, ma per la presenza in questo territorio di una cultura viva fatta di grandi Istituzioni e di imprese leader nei settori del restauro, delle tecnologie optoelettroniche, dellilluminazione, delleditoria fino alla moda e alle produzioni di lusso del Made in Italy, per le quali sono frequenti le contaminazioni fra arte, design e saper fare manifatturiero e artigianale di altissima qualit.
17
Il programma della manifestazione disponibile sul sito web di Florens 2010: www.florens2010.com.
19
Leconomia dei beni culturali e ambientali.
Una visione sistemica e integrata
20
2. La definizione del settore culturale e creativo e il modello interpretativo di riferimento
2. LA DEFINIZIONE DEL SETTORE CULTURALE E CREATIVO E IL MODELLO INTERPRETATIVO DI RIFERIMENTO 2.1. introduzione
Questo capitolo, oltre a voler delineare in un quadro sintetico la dimensione economica a livello nazionale ed internazionale del settore, intende definire il settore culturale e creativo (principale oggetto di studio del presente Rapporto e delliniziativa Florens 2010) sotto il profilo concettuale. Lanalisi quantitativa condotta a livello nazionale ed internazionale sul settore (presentata nei capitoli seguenti) si basa infatti su un impianto concettuale che stato sviluppato a partire da una ricognizione dei contribuiti scientifici pi importanti in merito e della letteratura di riferimento sul tema. Lobiettivo di tali riflessioni definire con ragionevole precisione - o quantomeno secondo una metodologia strutturata - il contorno di una vasta gamma di attivit economiche che, per qualit delloutput e/o per caratteristiche culturali e creative relative al processo produttivo, possono essere ricondotte a ci che nelle prossime pagine sar definito settore culturale e creativo. La concettualizzazione del settore qui presentata stata realizzata dal Gruppo di Lavoro The European House-Ambrosetti in stretta collaborazione con lAdvisory Board Florens 20101, i cui componenti, oltre alla validazione scientifica del lavoro svolto, hanno contributo attivamente elaborando linee guida, spunti di riflessione e idee per la progettazione e la realizzazione sia dello Studio Strategico (nel complesso), sia dellimpianto concettuale e metodologico su cui si basano le elaborazioni quantitative presentate. Inoltre, la definizione di settore culturale e creativo stata formulata anche con la precisa finalit di poter effettuare confronti territoriali rispetto al potenziale e al dinamismo espresso dal settore in oggetto.
2.2. La deFinizione di settore cuLturaLe e creativo: un quadro di sintesi
Come si vedr pi in dettaglio nel seguito del capitolo (dove saranno illustrati i numeri che emergono dallapprofondimento dellanalisi economica del settore), il settore culturale e creativo ha assunto un peso crescente allinterno delle economie industrializzate qualificandosi sempre pi come un driver fondamentale per il rilancio dei sistemi economici e sociali dei territori (regioni, nazioni, ecc.). La rilevanza economica del settore e le potenzialit che esso potrebbe essere in grado di esprimere come volano di sviluppo economico e sociale sono state infatti prese in considerazione e studiate gi a partire dagli anni del Dopoguerra. Numerose sono le diverse tipologie di approccio strutturato alla modellizzazione delle industrie culturali e creative. Tra queste si segnala il Libro Bianco sulla Creativit di Walter Santagata2 che, oltre a rappresentare un contributo recente e ad alto livello scientifico, propone una sintesi dei principali approcci secondo cui sono state studiate le industrie culturali e creative a livello internazionale. Di seguito sono riportati sinteticamente i contributi pi interessanti. Il modello delle Industrie Culturali Un primo contributo di rilievo noto come il modello delle Industrie Culturali (The Cultural Industries Model) ed stato proposto da T.W. Adorno e M. Horkheimer nel 1947. Tale modello si basa su una definizione di industria culturale (la principale innovazione laffiancamento della parola industria alla parola culturale) fondata sulle caratteristiche di riproducibilit (caratteristiche dellindustria) e la funzione di comunicazione dei prodotti generati. In accordo con questa definizione, la misurazione del fenomeno si basa principalmente su criteri tecnico-economici e il settore indagato sulla base dei criteri giuridici della protezione intellettuale e dei diritti dautore associati ai contenuti culturali.
1
In merito alla composizione dellAdvisory Board e del Consiglio Scientifico costituito al suo interno si rinvia al Capitolo 1 del presente Rapporto. Walter Santagata, Libro Bianco sulla Creativit. Per un modello italiano di sviluppo, Universit Bocconi Editore, Milano, 2009. Il rapporto stato elaborato con il contributo di: W.Santagata, T.Cuccia, P.Leon, S.Salvemini, I.Tinagli, M.Trimarchi, A.Vettese, S.Rolando, P.Baldi, E.Sciacchitano, A.Cicerchia, G.Da Empoli, G.P.Manzella ed E. Scridel.
21
Leconomia dei beni culturali e ambientali.
Una visione sistemica e integrata
I settori considerati in tale modello sono principalmente leditoria, la produzione di film, la produzione televisiva e radio, la stampa, ecc.. Sulla base di questa classificazione, quindi, le industrie culturali sono rappresentate da un cluster relativamente ristretto di analisi, che rende tuttavia possibile una raccolta accurata di dati statistici e unanalisi economica pi dettagliata del settore a livello macro. Tale approccio, seppur sviluppato alcune decine di anni fa, stato recentemente adottato dal Dpartement Des tudes, de la Prospective e des Statistiques del Ministero della Cultura e della Comunicazione in Francia e dallEurostat (il Dipartimento di Statistica della Commissione Europea) proprio poich consente un approccio quantitativo univoco per la rilevazione di dati omogenei e per lelaborazione di statistiche sulle industrie culturali. Il modello dellIndustria Creativa Il concetto di creativit ad estensione della definizione di settore culturale in senso stretto stato introdotto in Europa negli anni Novanta, quando il Ministero britannico per la Cultura, i Media e lo Sport (Department for Culture, Media and Sport) ha deciso di assegnare ad un gruppo di lavoro specializzato (Creative Task Force) il compito di porre sotto la lente di ingrandimento ci che stato appunto definito industria creativa. Tale attivit ha portato ad una serie di pubblicazioni di riferimento, tra cui: The Creative Industries Mapping Document (1988, 1998 e 2001), Staying Ahead: The economic performance of UKs creative industries (2007) e Creative Industry Performance (2007). Tale processo, voluto dalle istituzioni britanniche, rappresenta un tentativo di individuazione di quei settori di attivit economica in cui aspetti quali, ad esempio, la creativit individuale, labilit e il talento sono i fattori principali nel processo di produzione. Secondo questo approccio anglosassone, le industrie creative sono classificate in base ad una concettualizzazione molto ampia, e comprendono sia le industrie culturali tradizionali sia altri settori economici come larchitettura, la pubblicit, le attivit digitali, lo sviluppo di software, le arti e lo spettacolo, la moda, il design, il mercato dellarte e dellantiquariato, ecc.. Tra i principali contributi scientifici sul tema, si segnala anche un altro modello interpretativo che approfondisce il concetto delle industrie creative: si tratta dellapproccio sviluppato ad Hong Kong su commissione dal Dipartimento per le Politiche Culturali (Centre for Cultural Policy Research). In questo caso, si pone laccento su due ulteriori elementi che approfondiscono ed allargano il concetto di creativit e di industria culturale e creativa. In primo luogo, lo studio enfatizza il ruolo svolto della creativit nei processi produttivi che generano significati sociali o culturali (come, ad esempio, la pubblicit, la moda o il design). In secondo luogo, tale studio evidenzia un aspetto molto importante che caratterizza il settore culturale e creativo: una spiccata attitudine alla generazione di esternalit positive, intese come ricadute economiche e sociali positive su altri settori delleconomia e sulla societ. Il modello proposto dalla World Intellectual Property Organisation (WIPO) Il metodo di analisi del settore culturale e creativo adottato dalla World Intellectual Property Organisation (WIPO) si concentra invece sullanalisi dei diritti di propriet intellettuale (in particolare, dei diritti dautore), legati alla creazione di beni o servizi. Secondo tale approccio, il settore delle industrie del copyright si articola su quattro livelli concentrici a seconda del grado di importanza che hanno i diritti di propriet intellettuale sul valore complessivo della merce (prodotto/servizio). Al centro vi sono quei settori che generano prodotti il cui valore pressoch completamente basato sul diritto dautore, quali - ad esempio - leditoria, il cinema, la musica, lo sviluppo di software, lintrattenimento, la TV e la radio. Un secondo livello comprende invece i settori che producono beni che solo in parte o solo per certi aspetti sono coperti da copyright, come i gioielli, oggetti di design e giocattoli. Il terzo livello costituito dal risultato dellattivit di marketing nelle industrie protette dal diritto dautore
22
2. La definizione del settore culturale e creativo e il modello interpretativo di riferimento
(ad esempio, la pubblicit), mentre la quarta categoria di industrie consiste nelle cosiddette industrie connesse, ossia quelle industrie i cui prodotti rappresentano i mezzi per il consumo di prodotti protetti da copyright, come - ad esempio - lettori CD e DVD, televisori e computer, strumenti musicali, ecc.. La principale forza di questo approccio labbinamento diretto tra la definizione delle industrie e la classificazione statistica utilizzata per misurare le variabili economiche pi significative a livello nazionale. Il modello proposto dalla Conferenza delle Nazioni Unite sul Commercio e lo Sviluppo (UNCTAD) Anche la Conferenza delle Nazioni Unite sul Commercio e lo Sviluppo (UNCTAD) ha proposto di recente un modello innovativo per lo studio del settore culturale e creativo, lanciato nel 2008 con la pubblicazione del rapporto Creative Economy 20083. Lapproccio dellUNCTAD individua quattro principali aree delleconomia culturale e della creativit: il patrimonio culturale, le arti visive e dello spettacolo, i media, e le industrie creative. Allorigine di tutte le espressioni culturali e artistiche di ciascun Paese vi il patrimonio culturale, che comprende musei, archivi, biblioteche, monumenti e siti di interesse culturale, ecc.. La seconda categoria identificata nel lavoro dellUNCTAD costituita delle arti visive e dello spettacolo, e comprende tutti i beni e i servizi generati da qualsiasi sorta di espressione artistica, come ad esempio gli spettacoli (teatrali, concertistici, ecc.) e gli oggetti darte. La categoria dei media raggruppa invece beni e servizi prodotti dalle industrie culturali tradizionali, come libri, film e musica. Infine, le industrie creative (che letteralmente sono definite nello studio come functional creations) identificano quei servizi e beni connotati da un forte contenuto simbolico che supera il valore funzionale (questo gruppo include, ad esempio, i prodotti della moda e del design, i servizi di architettura e di pubblicit, la creazione di software e videogiochi). Un aspetto rilevante della classificazione dellUNCTAD il fatto che essa sia stata concepita tenendo in considerazione la reperibilit di dati statistici attraverso cui poter misurare in primo luogo il commercio internazionale di prodotti culturali e creativi (coerentemente con la mission dellUNCTAD). Il modello proposto dalla Commissione Europea Lultimo approccio presentato quello proposto dalle principali istituzioni di governo dellUnione Europea, il quale propone un punto di vista che, come sar pi in dettaglio chiarito nel seguito, pu essere riconosciuto come una sintesi dei modelli presentati in precedenza. Gi nel 2004 il Consiglio Europeo ha identificato la necessit di approfondire la conoscenza di questo settore nellambito dellAgenda di Lisbona, con la realizzazione di uno studio sulle modalit attraverso cui la creativit, le industrie creative e le partnership pubblico-privato nel settore culturale contribuiscono al potenziale economico, sociale e culturale dellEuropa e, quindi, al raggiungimento degli obiettivi di Lisbona.
United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), Creative Economy Report 2008: The challenge of assessing the creative economy towards informed policy-making, 2008.
23
Leconomia dei beni culturali e ambientali.
Una visione sistemica e integrata
Il ruolo del settore culturale e creativo nella strategia Europa 2020
Il settore culturale e creativo riconosciuto come un catalizzatore di sviluppo dellattivit economica e della creazione di posti di lavoro in tutta lUnione Europea. Inoltre, limpatto economico delle molteplici industrie creative conferma la loro importanza strategica per tutti i Paesi, europei e non. Anche sul mercato del lavoro, la creativit sta assumendo unimportanza crescente. La domanda di professionalit creative sta crescendo sia allinterno sia allesterno delle industrie creative sia nei vecchi che nuovi Stati Membri dellUE. Le industrie creative sono inoltre anche dei generatori di innovazione e svolgono un ruolo chiave nella diffusione di innovazioni (si pensi, ad esempio, alle case editrici come pionieri delle-business), con ricadute positive generate sia allinterno del settore stesso sia trasversali a tutto il sistema economico. Gli operatori nei settori creativi sono in genere aziende di piccole dimensioni. Per questo motivo tali aziende devono spesso confrontarsi con problematiche di accesso a fondi/fonti di finanziamento ed altre problematiche di tipo strutturale che possono generare il rischio di situazioni di sotto-investimento. Tuttavia, la caratteristica di bene pubblico degli output di alcuni settori creativi giustifica (anzi richiede) lutilizzo di approcci mirati a sostegno di alcuni sub-settori che pi di altri stimolano linnovazione e contribuiscono al patrimonio intellettuale e culturale dei Paesi. Una risposta in tal senso offerta dal recente Libro Verde Unlocking the potential of cultural and creative industries, che sottolinea con forza la necessit di mettere in opera politiche volte a migliorare la competitivit e linnovazione in questi settori, sostenendo il ruolo chiave dellUE per garantire efficaci strumenti di tutela internazionale della propriet intellettuale e per rafforzare il mercato unico relativo ai servizi e ai prodotti generati nelle industrie creative.
Anche la Commissione Europea, negli scorsi anni, ha mostrato crescente attenzione al tema della valorizzazione dellindustria culturale e creativa come volano per lo sviluppo economico e sociale delle nazioni e dei territori. Tra i lavori editi dalla Commissione Europea sul tema utile ricordare il Libro Verde Unlocking the potential of cultural and creative industries del 2010. Nellattuale contesto di accelerazione globale, linnovazione e la creativit sono diventate, in modo molto pi marcato rispetto al passato, fattori chiave per la competitivit dei sistemi economici (a tutti i livelli), rappresentando i fattori della produzione per la generazione di valore immateriale (tra cui il valore culturale), determinante fondamentale - oggi - del valore materiale. Al fine di valutare gli impatti socio-economici (diretti e indiretti) del settore della cultura in Europa, la Direzione Generale per lEducazione e la Cultura della Commissione Europea nel 2006 ha commissionato unanalisi volta a dimensionare leconomia della cultura (lavoro noto con il nome di Jan Figel Report)4. Come detto, il lavoro della Commissione Europea ha fornito una definizione del settore culturale e creativo basata sulle interpretazioni adottate in 30 diversi Paesi ed elaborate dalle principali organizzazioni internazionali5. Lo schema proposto dalla Commissione Europea connotato da unimpostazione concentrica, poich si basa sulla necessit di distinguere tra il settore culturale inteso come insieme delle attivit artistiche tradizionali e delle industrie culturali, i cui prodotti sono esclusivamente culturali e il settore creativo, che riunisce le rimanenti industrie ed attivit che utilizzano la cultura come un valore aggiunto per la produzione di prodotti non strettamente culturali. Di conseguenza, secondo tale schema di riferimento, il settore culturale e creativo si sviluppa secondo quattro macro-aree, formate al loro interno dalle seguenti componenti: - Arti: Arti visive, Arti dello Spettacolo, Patrimoni; - Industrie culturali: Film e video, TV e radio, Videogiochi, Musica, Editoria; - Industrie creative: Design, Architettura, Pubblicit; - Industrie connesse: ICT, MP3, Telefonia mobile.
4
KEA European Affairs, The Economy of Culture in Europe. Study prepared for the European Commission (Directorate-General for Education and Culture), ottobre 2006. Lo studio anche noto come Jan Figel Report, dal nome del Commissario Europeo allIstruzione, Formazione, Cultura e Multilinguismo. Lo studio ha considerato, tra le altre, le definizioni di settore culturale e di settore creativo fornite da OECD, UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization), WIPO (World Intellectual Property Organization) ed Eurostats LEG Task Force.
24
2. La definizione del settore culturale e creativo e il modello interpretativo di riferimento
Figura 1 Le componenti del settore culturale e creativo secondo lindagine condotta dalla Commissione Europea Fonte: rielaborazione The European House-Ambrosetti su dati KEA European Affairs, The Economy of Culture in Europe, 2006
Infine, il cerchio pi esterno contiene le industrie collegate, ossia quei settori che producono e commercializzano servizi di supporto per la fruizione di beni e servizi erogati dalle industrie culturali e creative. Lapproccio adottato dal Figel Report appare molto ampio, dato che lanalisi include attivit di business anche di frontiera rispetto al comparto culturale-creativo in senso stretto, ma consente di cogliere limpatto economico della cultura e della creativit, la quale rappresenta un elemento di innovazione che utilizza la cultura come input per influire su molteplici settori economici. In generale, secondo questo approccio per certi versi eclettico, possibile osservare che il settore culturale e creativo connotato da attivit che presentano, normalmente, tre caratteristiche: - comportano una certa forma di creativit nella loro produzione; - riguardano la creazione e la comunicazione di un significato simbolico; - il loro risultato implica, potenzialmente, una qualche forma di propriet intellettuale.
Figura 2 Le principali caratteristiche delle attivit del settore culturale e creativo Fonte: rielaborazione The European House-Ambrosetti da David Throsby Economics and culture, 2001
25
Leconomia dei beni culturali e ambientali.
Una visione sistemica e integrata
Figura 3 Prospetto di sintesi di classificazione delle industrie culturali e creative secondo alcuni dei principali modelli di riferimento in letteratura Fonte: W. Santagata, White Paper on Creativity, 2009
2.3. iL
settore cuLturaLe e creativo come motore di crescita e attrattivit
deL territorio
Come si vedr nei successivi paragrafi, il settore culturale e creativo detiene un peso rilevante rispetto ad altri comparti industriali in termini di occupati, volume daffari generato e contributo al Prodotto Interno Lordo e di conseguenza appare indiscutibile la sua rilevanza in chiave strategica per la crescita dei sistemi territoriali. In tal senso, lattrattivit diviene la nuova frontiera della competizione globale tra realt territoriali analoghe che devono confrontarsi tra loro per attrarre investitori6. Per un Paese come lItalia che, pur essendo dotato di un patrimonio culturale e artistico invidiabile, subisce i contraccolpi di una ridotta attrazione di Investimenti Diretti Esteri e di scarsi investimenti in Ricerca e Sviluppo al confronto con i principali competitor, lattrattivit costituisce sempre pi un tema prioritario che chi governa (sia a livello nazionale, sia regionale e provinciale) deve affrontare in modo sistematico, adottando unottica strategica di lungo periodo, anche e soprattutto con riferimento al settore culturale e creativo.
6
Per approfondimenti, si vedano le Ricerche realizzate da The European House-Ambrosetti in collaborazione con Siemens: Gli indicatori e le politiche per migliorare il Sistema Italia e la sua attrattivit positiva (2003), Migliorare la cultura pro-business del nostro Paese per migliorarne attrattivit e competitivit (2005) e Osservatorio Siemens per migliorare lattrattivit positiva del Sistema Italia (2007).
26
2. La definizione del settore culturale e creativo e il modello interpretativo di riferimento
Infatti lattrattivit aumenta il livello di investimenti esteri e, arricchendo un territorio sia di risorse nuove (finanziarie e umane) che di competenze e know-how innovativo, favorisce un incremento della sua competitivit. Questo a sua volta stimola un miglioramento e accentua e promuove la cultura del confronto con Paesi e regioni concorrenti, comportando cos un ulteriore miglioramento in termini di attrattivit. Si innesca dunque un circolo virtuoso che si rinnova ed autoalimenta ciclicamente (figura seguente).
Figura 4 Il circolo virtuoso dellattrattivit - Fonte: Ricerca Siemens - The European House-Ambrosetti, Gli indicatori e le politiche per migliorare il Sistema Italia e la sua attrattivit positiva, 2003
Secondo questo meccanismo il settore culturale e creativo agisce come driver centrale per lo sviluppo del territorio, in quanto si tratta di un comparto che pi di altri soggetto allazione dei quattro macro-trend che connotano trasversalmente lattuale scenario tecnologico e sociale: - Continui sviluppi scientifici e tecnologici; - Accelerazione; - Globalizzazione; - Mutamento progressivo del mix demografico. Questi fenomeni hanno originato e continuano ad originare discontinuit a livello di scelte strategiche e organizzative, soluzioni tecnologiche e finanziarie. Inoltre, lincremento dei contenuti di R&S, knowhow e livello di istruzione della forza lavoro impiegata nella produzione industriale fa s che il settore culturale e creativo costituisca un terreno fertile per lemergere di soluzioni innovative e la diffusione di nuove avanguardie. Lattenzione al tema confermata dal fatto stesso che da alcuni anni si iniziato a parlare di capitale creativo, che ha in un certo senso integrato e arricchito i concetti di capitale umano e di capitale sociale.
27
Leconomia dei beni culturali e ambientali.
Una visione sistemica e integrata
2.4. iL settore cuLturaLe e creativo e La sua riLevanza per iL sistema economico
2.4.1. I principali Facts and Figures del settore culturale e creativo
Come gi anticipato nella prima parte del capitolo, il settore culturale e creativo pu comprendere una variet di attivit, sia di tipo strettamente Culturale (musei, teatri, opere ecc.), sia alcune attivit che si possono definire a contenuto industriale (come ad es. leditoria, la televisione, il cinema e la musica ma anche la Ricerca e Sviluppo, il Design, la pubblicit, le attivit fieristiche, ecc.) ma che attraverso un processo che comprende un contenuto di creativit, in misura variabile, generano un output con una valenza di tipo culturale. Tuttavia, in Italia e nel mondo, quando si parla in termini generali di cultura scatta una reazione istintiva di diffidenza di fronte ai tentativi di evidenziare gli aspetti economici e di possibile organizzazione a carattere imprenditoriale delle attivit collegate (soprattutto se ci si riferisce a quella parte del settore denominata Capitale Culturale e Ambientale). Anche se oramai accettato che le attivit culturali possano essere organizzate in forma dimpresa, emerge comunque una preferenza della societ civile e dei policy maker per modalit e strumenti operativi che in qualche modo restino inseriti o fortemente collegati alla sfera pubblica. In ogni caso, linsieme delle attivit economiche legate alle suddette dimensioni pu essere denominato economia creativa7, volendo intendere linsieme delle attivit che si fondano sulla conoscenza e che fanno un uso intensivo di talenti in grado di utilizzare tecniche e tecnologie innovative per produrre valore aggiunto e accrescere il capitale intellettuale8. Seppure, come detto, il concetto di economia creativa possa suscitare la perplessit di alcuni, esistono degli studi scientifici sul settore che dimostrano come tale sistema economico contribuisca ogni anno alla generazione della ricchezza delle nazioni e alla crescita economica dei sistemi territoriali. Anche nellattuale contesto economico che, nel corso degli ultimi anni, ha registrato la pi rapida ed estesa crisi dal Dopoguerra, il settore culturale e creativo si mostrato fortemente dinamico e anticiclico. Basta citare pochi dati per comprendere limportanza e la vitalit del settore su scala mondiale9: - Negli USA lindustria culturale del cinema ha registrato un aumento dell8,8% nel fatturato durante la crisi; - in Europa (30 Paesi) leconomia creativa occupa circa 6 milioni di persone e genera quasi 700 miliardi di Euro di fatturato e dal 1995 al 2005 il tasso di crescita dellexport di prodotti creativi si attestato al 45%; - lOCSE ha evidenziato come negli ultimi dieci anni il settore culturale e creativo cresciuto a tassi superiori a qualsiasi altro settore manifatturiero e rappresenta in termini di Valore Aggiunto, produzione e reddito dal 2% al 6% del Prodotto Interno Lordo dei Paesi considerati; - leconomia creativa rappresenta il 3,5% di tutto il commercio internazionale e si attestata su valori intorno ai 450 miliardi di dollari. Seppure questi dati appaiano molto significativi, i valori economici effettivamente riferiti al settore potrebbero subire un ulteriore incremento o una diminuzione se il campo di attivit ricondotte alla categoria del settore culturale e creativo fosse variato. Ad oggi, infatti, non esistono statistiche precise e aggiornate in modo puntuale sul settore culturale e creativo nel mondo, in Europa e in Italia. Seppure non manchino numerosi studi sul settore pubblicati da autorevoli enti ed istituzioni pubbliche e private, come visto nei paragrafi precedenti, i dati economici in essi inclusi spesso differiscono poich costruiti sulla base di classificazioni differenti delle attivit culturali e creative generando cos un primo problema di confrontabilit dei risultati.
7
8 9
Creative Economy, definizione data dallOrganizzazione delle Nazioni Unite con riferimento alle attivit economiche legate al settore culturale e creativo. Organizzazione delle Nazioni Unite, 2009. Fonte: UNCTAD, Creative Economy. The Challenge of Assessing the Creative Economy: Towards Informed Policy-making, Report 2008.
28
2. La definizione del settore culturale e creativo e il modello interpretativo di riferimento
Una seconda criticit strutturale con cui inevitabilmente ci si scontra volendo analizzare il settore dal punto di vista della sua rilevanza economica relativa alla bassa frequenza con cui vengono aggiornati i dati (prevalentemente contenuti in pubblicazioni a cadenza pluriennale). Per questo motivo molto spesso si costretti a ragionare su questi temi con uno sfasamento temporale anche considerevole rispetto al periodo di rilevazione dei dati che si studiano. Tra gli studi pi recenti sul settore, il rapporto pubblicato dalla Commissione Europea dal titolo The Economy of Culture in Europe (2006) rappresenta una delle fonti pi aggiornate ed attendibili in materia. Questo studio stato elaborato con lo specifico obiettivo di valutare la dimensione e il contributo apportato dal settore culturale al sistema economico. Secondo tale fonte, il settore culturale e creativo10 ha registrato nel 2003 (ultimo anno disponibile) un fatturato pari a circa 640 miliardi di Euro (che rappresentano il 6,4% del PIL dellUE-25) ed un Valore Aggiunto pari a quasi 260 miliardi di Euro, che rappresenta circa il 2,6% del Prodotto Interno Lordo dellUnione Europea. Passando allanalisi a livello nazionale, la medesima fonte indica per lItalia dei valori non molto distanti rispetto alla media UE-25 se si considera il fatturato del settore, pari a circa 85 miliardi di Euro (6,3% del PIL nazionale), e loccupazione, con gli occupati del settore che rappresentano circa il 2,1% rispetto al totale degli occupati (rispetto ad un valore medio in Europa pari al 2,4%). Un divario pi sensibile si registra invece se si considera il Valore Aggiunto, che si attesta al livello di 30,7 miliardi di Euro (2,3% del PIL).
Tabella 1 Alcune dimensioni-chiave del settore culturale e creativo nei Paesi dellUE-25 Fonte: rielaborazione The European House-Ambrosetti su dati Commissione Europea, The economy of Culture in Europe, 2006 e Eurostat, 2007
10
Il settore creativo, come si vedr meglio in seguito, secondo lapproccio adottato dalla Commissione Europea, comprende le attivit legate a Visual arts, Performing arts, al Patrimonio Culturale, al Cinema, allEditoria, alla Musica, allattivit TV & Radio, allo sviluppo di Software, alla Moda, al Design, allArchitettura, alla Pubblicit, ecc..
29
Leconomia dei beni culturali e ambientali.
Una visione sistemica e integrata
Al fine di migliorare lattendibilit e la frequenza di aggiornamento dei dati sul Valore Aggiunto, sul fatturato e sul numero degli occupati del settore (che ancora derivano prevalentemente da stime), lEurostat ha gi da alcuni anni messo in atto un progetto per il miglioramento del processo di rilevazione e aggregazione dei dati sulle industrie culturali e per il costante aggiornamento degli stessi. Nonostante le limitazioni collegate alla qualit dei dati, che peraltro rappresentano una doverosa premessa metodologica, comunque possibile compiere alcune valutazioni e comparazioni sia sui principali parametri a livello aggregato del settore, sia sullefficienza economica del settore culturale in Europa e nel nostro Paese. Sia pure sulla base delle precedenti premesse metodologiche, il rapporto tra Valore Aggiunto (pari alla differenza tra ricavi generati dalloutput e costi sostenuti per lacquisizione degli input) e fatturato (cio il valore delle vendite) pu offrire una misura della capacit di efficienza economica del settore culturale. Se si considera questa elaborazione, ad esempio, la Francia presenta il livello di efficienza pi alto rispetto a qualsiasi altro Paese europeo, con un rapporto tra Valore Aggiunto e fatturato pari al 68,3%. Inoltre, sempre relativamente al confronto tra la Francia e gli altri Paesi europei, interessante rilevare come questa nazione sia in grado di generare a partire da un valore complessivo del fatturato inferiore a quello dellItalia (79,4 miliardi di Euro contro gli 84,4 miliardi di Euro dellItalia), o di altri Paesi europei come il Regno Unito, un valore aggiunto nettamente superiore (pari ad oltre 54 miliardi di Euro a fronte dei 31 circa generati nel settore italiano), potendo evidentemente contare su una maggiore efficienza nel processo produttivo. In altre parole, ci dimostra come il settore culturale e creativo italiano (per come definito nelle fonti che pubblicano i dati qui presentati e discussi), seppur dimostrando unalta incidenza (in termini di fatturato) delleconomia creativa rispetto alla maggior parte delle altre nazioni europee (tra cui la Francia), presenti un ampio potenziale inespresso a cui si collegano enormi possibilit di miglioramento (levidenza dimostra infatti un impiego meno efficiente delle risorse, dimostrato da un rapporto tra Valore Aggiunto e fatturato che si attesta al 36,4%, quasi la met di quello della Francia e inferiore anche a quello della Germania 42,9%). Una ulteriore conferma di queste evidenze pu essere riscontrata nei dati relativi alla profittabilit annuale del settore (margine operativo), che, secondo la medesima fonte di riferimento, nel periodo 1999-2003 stata mediamente pari all8,5% rispetto al fatturato per lItalia e al11,1% per la Francia. Anche analizzando il commercio internazionale di beni culturali e creativi si conferma un ruolo di rilevo della cosiddetta economia creativa, che genera export di beni creativi. LUNCTAD ha recentemente pubblicato uno studio sul commercio internazionale dei cosiddetti beni creativi: con questo termine si fa riferimento a quelle categorie di prodotto e servizio che utilizzano nel processo di produzione la creativit e il capitale intellettuale come un input primario. Pi nello specifico, si tratta di un raggruppamento molto ampio di categorie merceologiche, tra cui: antichit e oggetti artistici e/o artigianali, libri, giornali, musica e film (riprodotti in diversi formati digitali e non), oggetti di design (moda, arredamento, ecc.), servizi di natura creativa (pubblicit, architettura, R&S, ecc.)11. Sulla base di tale classificazione, lUNCTAD stima per il 2005 (ultimo anno disponibile) un valore complessivo a livello mondiale delle esportazioni di beni creativi pari a 335,5 miliardi di Euro, di cui circa 200 scambiati tra le economie sviluppate, con un crescita complessiva pari circa all80% (che equivale a circa 150 miliardi di Euro) rispetto al 1996. La principale categoria merceologica esportata a livello internazionale quella dei prodotti del Design (rappresentato dallaggregato dei prodotti del Graphic Design, del Fashion Design, dellInterior Design e dellattivit di Design nel settore dei gioielli, degli occhiali da sole e dei giocattoli): la sola categoria del Design rappresenta infatti il 65% delle esportazioni complessivamente generate ogni anno a livello internazionale.
11
Per il dettaglio di tutte le categorie merceologiche identificate dallUNCTAD come beni creativi si rinvia al gi citato documento Creative Economy Report 2008: The challenge of assessing the creative economy towards informed policy-making , scaricabile gratuitamente dal sito web dellistituzione (www.unctad.org).
30
2. La definizione del settore culturale e creativo e il modello interpretativo di riferimento
Figura 5 Ripartizione del valore dellexport mondiale di beni e creativi (definiti dallUNCTAD) per categoria merceologica Fonte: rielaborazione The European House-Ambrosetti su dati UNCTAD - United Nations Conference on Trade and Development, 2008
Sempre considerando le esportazioni di beni creativi, lItalia risulta il Paese leader a livello globale. Il valore delle esportazioni complessive di beni creativi si attesta infatti per lItalia a quasi 30 miliardi di dollari, che rappresentano l8,3% di tutti i beni creativi esportati a livello internazionale.
Tabella 2 Classifica dei primi 10 Paesi sviluppati esportatori di beni creativi Fonte: elaborazione The European House-Ambrosetti su dati UNCTAD - United Nations Conference on Trade and Development, 2008
31
Leconomia dei beni culturali e ambientali.
Una visione sistemica e integrata
Anche un recente studio sul settore culturale e creativo gi citato in precedenza, il Libro Bianco sulla Creativit. Per un modello italiano di sviluppo, riporta numerosi spunti specifici per lItalia, utili per inquadrare il settore sia nella sua dimensione economica e per quanto riguarda la rilevanza rispetto al sistema economico nazionale, sia sotto il profilo concettuale. Come gi stato presentato, il Libro Bianco individua tre principali categorie (a loro volta declinabili in un elenco di sub-settori) che insieme identificano loggetto di analisi considerato nello studio. Le tre categorie principali sono: il patrimonio storico e artistico, le industrie di produzione di contenuti, informazioni e comunicazione (industrie di contenuto) e le attivit legate alla cosiddetta cultura materiale. Tali principali componenti sono declinate nel seguente modo: Patrimonio storico e artistico, composto da: - Patrimonio culturale; - Arte contemporanea; - Architettura; - Musica e Performing Arts; Industrie di contenuto, che raccolgono le attivit legate alle seguenti categorie: - Cinema; - Software; - Editoria; - Pubblicit; - TV & Radio; Cultura materiale: - Moda; - Design e artigianato; - Food & wine; Le stime sulle principali dimensioni economiche relative al macrosettore (cos come viene definito da Santagata), Valore Aggiunto e addetti, sono basate su elaborazioni dellIstituto Guglielmo Tagliacarne12 e si riferiscono allanno 2004 (ultimo dato disponibile). Poich le analisi condotte sul settore a livello nazionale sono state elaborate con metodologie differenti e in base ad una definizione che differisce (anche se non in modo sostanziale) dallapproccio adottato a livello europeo (nello specifico dalla Commissione Europea), i dati di riferimento relativi allItalia differiscono rispetto a quelli presentati in precedenza; tuttavia appare in ogni caso interessante un approfondimento dellanalisi a livello nazionale. La definizione di settore culturale e creativo adottata per lanalisi a livello nazionale, include infatti sia le attivit economiche pi strettamente riferite alla cultura (come quelle riguardanti la gestione di musei e teatri, la produzione di spettacoli e leditoria), sia quelle aventi valenza culturale, ossia che sono in qualche modo collegate alle attivit culturali in senso stretto e/o attivate da queste (come le produzioni artigianali o la fabbricazione di prodotti connessi alla fruizione culturale, il turismo culturale e i servizi di mobilit indotti, ecc.).
12
Primaria istituzione nazionale che realizza analisi e studi economico-statistici sui diversi settori delleconomica a livello nazionale e territoriale.
32
2. La definizione del settore culturale e creativo e il modello interpretativo di riferimento
Tabella 3 Stima del Valore Aggiunto e delloccupazione nel settore culturale e creativo in Italia nel 2004 Fonte: rielaborazione The European House-Ambrosetti su dati MiBAC Istituto Guglielmo Tagliacarne, 2007
La stima complessiva del Valore Aggiunto attribuibile al macrosettore (considerando le categorie indicate nella tabella precedente), ammonta a circa 116 miliardi di Euro, pari 9,3% del Valore Aggiunto nazionale complessivo. Il numero degli addetti coinvolti nel settore invece pari a 2,8 milioni di unit, che rappresentano quasi il 12% del totale nazionale. Rispetto al Valore Aggiunto complessivo che si registra per il macrosettore, il peso delle attivit pi strettamente culturali (patrimonio storico-artistico) rappresenta una quota pari a circa il 17% del totale (per un ammontare complessivo pari a circa 20 miliardi di Euro), mentre la quota-parte del numero di addetti nellambito delle attivit legate al patrimonio culturale pari al 14% rispetto al totale (che rappresenta circa 400.000 unit). Le tabella riportata mette anche in luce alcune caratteristiche peculiari delle industrie creative e culturali in Italia. In primo luogo, la Moda risulta essere il settore economicamente pi rilevante tra le industrie culturali e creative: tale dato anche confermato dal fatto che i settori della sfera della cultura materiale (Moda, Design Industriale e Artigianato, Industria del Gusto) contribuiscono per pi del 50% al valore dellintero macrosettore. In secondo luogo, il settore dei Computer e Software ha un peso considerevole tra le industrie dei contenuti, dellinformazione e delle comunicazioni. La sua importanza dimostra come leconomia italiana, sebbene con alcuni ritardi, sia comunque orientata verso le tecnologie informatiche e le ICT13.
13
Fonte: Libro Bianco sulla Creativit, W. Santagata, 2009
33
Leconomia dei beni culturali e ambientali.
Una visione sistemica e integrata
Si tratta di numeri considerevoli, che dovrebbero generare una profonda riflessione relativamente alla rilevanza che il settore ha per leconomia nazionale: si pensi, ad esempio, che il comparto dellautomotive (settore di eccellenza italiano che molto spesso oggetto di dibattito politico e destinatario di elevati incentivi pubblici), rappresenta il 5,5% del Valore Aggiunto manifatturiero italiano (che a sua volta una porzione del manifatturiero totale). Un ulteriore spunto di analisi molto interessante sul settore rappresentato dalla spaccatura del contributo del settore al PIL nazionale analizzando le diverse fasi della filiera produttiva e distributiva dei beni culturali e creativi. La fonte di riferimento per questo tipo di analisi - il Libro Bianco sulla Creativit - individua quattro principali componenti della catena del valore dei beni culturali e creativi e sulla base di queste propone un punto di vista frammentato del contributo alleconomia generato dal macrosettore. Le componenti della filiera sono le seguenti: - concezione e produzione; - attivit connesse alla concezione e alla produzione; - distribuzione; - attivit connesse alla distribuzione.
Figura 6 Ripartizione in base alle fasi della catena di produzione del valore del contributo del macrosettore alleconomia Fonte: rielaborazione the European House-Ambrosetti su dati W. Santagata, MiBAC Istituto Guglielmo Tagliacarne, 2009
Osservando i dati riportati in figura, emerge come sia la fase di concezione e produzione a generare il contributo pi elevato al PIL nazionale. Le attivit connesse alla produzione e concezione di prodotti culturali (ossia i settori di attivit che interagiscono vendendo prodotti o servizi impiegati nel processo creativo e produttivo di prodotti o servizi culturali) rappresentano la seconda quota di contribuzione al PIL generato dal settore (2,69%). La Distribuzione, terza fase considerata nella filiera, ricopre invece un ruolo fondamentale nei settori legati alla sfera della cultura materiale, ed in particolare nel settore della Moda e del Design Industriale, dove il processo distributivo dei prodotti rappresenta una fase ad alto Valore Aggiunto. La fase distributiva e le attivit ad essa connesse sono invece poco rilevanti nella dimensione del Patrimonio Storico e Artistico, dove la fruizione dei beni e servizi culturali pi diretta (come nel caso dei beni e attivit del Patrimonio Culturale o nella Musica e Spettacolo) oppure vengono erogati servizi su committenza (come nel caso dellArchitettura).
34
2. La definizione del settore culturale e creativo e il modello interpretativo di riferimento
2.4.2.
La spesa pubblica e privata per le attivit culturali in Italia
Al di l della rilevanza economica del settore rispetto al sistema economico complessivo, risulta essenziale capire quale sia la modalit pi opportuna per consentire alleconomia creativa di continuare a crescere e svilupparsi, nel caso specifico dellItalia, attraverso la valorizzazione degli innumerevoli asset culturali di cui il Paese dotato. Affinch qualsiasi settore possa crescere e svilupparsi, necessario infatti che esso sia alimentato con adeguate fonti di finanziamento, che possono essere di natura pubblica o privata. Oggetto di questo paragrafo sono quindi le fonti di finanziamento del settore. In modo simile a quanto accade per i principali dati macroeconomici relativi al settore, anche in questo caso i dati disponibili relativi alla spesa pubblica e privata per le attivit culturali consentono solo in parte di approfondire lanalisi, essendo essi rilevati unicamente in forma di macro aggregati e non essendo aggiornati con una frequenza adeguata. La spesa pubblica per le attivit culturali in Italia Dagli ultimi dati di contabilit pubblica disponibili14, relativi allanno 2005, emerge per lItalia una spesa complessiva per attivit creative e culturali pari a circa 11 miliardi di Euro, di cui 7 attribuibili agli enti locali. Dallanalisi dellevoluzione storica dei dati di spesa pubblica in percentuale del PIL nazionale (elaborati dallISTAT), emerge un profilo sostanzialmente stabile tra il 1990 e il 2005, che testimonia una scarsa focalizzazione sul fronte pubblico in termini di investimenti per il settore. La Spesa Pubblica per il settore si attesta infatti a livelli nellintorno dell1,6% - 1,7% del Prodotto Interno Lordo Nazionale, come evidenziato nella figura seguente.
Figura 7 Incidenza sulla spesa pubblica pubblica centrale e locale per attivit culturali sul PIL, 1990-2005 Fonte: elaborazione The European House-Ambrosetti su dati ISTAT, 2008
14
I dati sono elaborati dallIstituto Nazionale di Statistica (ISTAT), che considera nellaggregato delle spese per la cultura i seguenti settori: produzioni e distribuzioni cinematografiche e di video e gestione di sale di proiezione cinematografiche; attivit radiotelevisive; attivit di biblioteche e archivi; gestione di musei e del patrimonio culturale; gestione degli orti botanici, dei parchi naturali e del patrimonio naturale; creazioni e interpretazioni artistiche e letterarie; gestione di teatri, sale da concerto e altre sale di spettacolo e attivit connesse; circhi e altre attivit di intrattenimento e di spettacolo; attivit delle agenzie di stampa.
35
Leconomia dei beni culturali e ambientali.
Una visione sistemica e integrata
Come si pu osservare nel grafico, la spesa statale centralizzata destinata alle attivit culturali rappresenta in proporzione una quota intorno al 35-40% rispetto alla spesa totale, mentre la quota rimanente complessivamente attribuita alle amministrazioni territoriali. Sul piano funzionale, gli stessi dati elaborati dallISTAT comprendono lammontare della Spesa Pubblica destinata ad investimenti (e quindi non alla gestione corrente, costo del lavoro, costi operativi, ecc.), che quantificata in circa 2,5 - 3 miliardi di Euro annui nel periodo di riferimento, di cui 2 fanno capo agli enti territoriali (che, in proporzione al budget a disposizione per il settore, investono una quota pi significativa rispetto alle amministrazioni centrali). Dallinterpretazione di questi dati risulta che lo Stato Italiano, proprietario dei musei e dei siti archeologici pi importanti dal punto di vista del valore culturale e dellattrattivit di visitatori, destina, a livello centralizzato, meno di 0,5 miliardi di Euro annui (pari allo 0,03% del PIL) ad investimenti nel settore delle attivit culturali. Si tratta di un dato molto preoccupante in termini di possibilit di sviluppo e di capacit attrattiva del settore. I dati appena mostrati (che riguardano esclusivamente i siti pubblici e, tra questi, in prevalenza, quelli di propriet dello Stato), indicano un impatto economico tuttaltro che trascurabile, ma evidenziano anche i limiti della Spesa Pubblica rispetto alle esigenze di recupero di una quantit di beni che necessitano di restauro, di valorizzazione o in moltissimi casi semplicemente di una sede ove essere esposti. Tuttavia, ci presuppone ulteriori investimenti e quindi capacit di rinvenire risorse in molti casi ingenti, per il cui reperimento diviene essenziale incrementare le entrate connesse alla valorizzazione e alla fruizione. inoltre evidente che la sola vendita dei biglietti dingresso possa dare un contributo limitato e garantire un ritorno in tempi molto differiti rispetto agli investimenti. Per questo motivo auspicabile un sensibile incremento delle entrate derivanti dallo sviluppo di forme di collaborazione tra pubblico e privato nel settore culturale. Per quanto riguarda lo spettacolo (ed in particolare le performing arts come il teatro e lattivit concertistica insieme al cinema), tali ragionamenti sul ruolo della spesa pubblica e sul coinvolgimento di privati mutano sensibilmente, anche perch si tratta di attivit di tipo diverso da quelle di valorizzazione dei beni culturali e per questo pi attrattive per un coinvolgimento del privato. Nel 2005, il Fondo Unico per lo Spettacolo - FUS (il principale sostegno finanziario pubblico erogato dallo Stato), ha stanziato circa 380 milioni di Euro. Secondo il MiBAC, nel biennio 2006-2007 le risorse stanziate sono aumentate da 377 a 441 milioni di Euro (+17%), mentre la distribuzione delle risorse tra le varie attivit risulta la seguente: 65% alla musica (lirica, concerti e danza), 17% alla prosa e 18% al cinema. Tuttavia, secondo una recente stima pubblicata da Il Sole 24 Ore, non solo negli ultimi cinque anni gli stanziamenti destinati a tale fondo si sono ridotti di anno in anno, bens se si compara il valore odierno reale del fondo con la dotazione nel 1985 (anno in cui il fondo fu istituito), levidenza dimostra come il valore impiegabile oggi a disposizione del fondo sia (in parit di potere dacquisto) la met rispetto al 1985. La spesa privata per le attivit culturali in Italia Il mercato di riferimento del settore culturale di dimensioni considerevoli e la spesa che lutenza impiega annualmente per servizi culturali e collegati alla fruizione della cultura rappresenta un capitolo rilevante delleconomia nazionale. Nel 2006 la spesa delle famiglie italiane per servizi ricreativi e culturali, secondo i dati ISTAT, stata pari a circa 22 miliardi di Euro, che rappresentano il 2,5% della spesa totale delle famiglie (stimata dallISTAT in circa 890 miliardi di Euro) e addirittura il 20% del totale della spesa delle famiglie per turismo e tempo libero (stimata dallISTAT in circa 115 miliardi di Euro).
36
2. La definizione del settore culturale e creativo e il modello interpretativo di riferimento
Figura 8 Ripartizione della spesa delle famiglie italiane per turismo e tempo libero Fonte: elaborazione The European House-Ambrosetti su dati ISTAT, 2008
Il turismo culturale Al di l della spesa diretta per la fruizione dei beni del sistema culturale, la vocazione culturale di un territorio pu essere un catalizzatore molto efficace di flussi turistici. Il turismo culturale rappresenta infatti una realt che va assumendo sempre pi una propria autonomia come motivazione principale o esclusiva degli spostamenti delle persone. In genere le visite ai beni culturali possono anche rappresentare un elemento aggiuntivo rispetto alle motivazioni tipiche della vacanza, cio svago e riposo. Tuttavia, per lItalia, la motivazione culturale dei flussi turistici ha storicamente, e continua a mantenere, un peso rilevante. Un dato significativo in tal senso dato dalle presenze turistiche nelle citt di interesse storico ed artistico che, tra il 2000 e il 2007, sono aumentate del 22% circa rispetto ad un aumento delle presenze totali del 7,3%. La figura che segue riporta levidenza regionale della quota di presenze nelle citt di interesse storico-artistico rispetto al totale delle presenze turistiche nella Regione (levidenza relativa alle 10 Regioni che presentano lincidenza maggiore).
37
Leconomia dei beni culturali e ambientali.
Una visione sistemica e integrata
Figura 9 Incidenza delle presenze nelle citt dinteresse storico-artistico rispetto alle presenze turistiche totali nelle prime 10 Regioni italiane per presenza nelle citt di interesse storico-artistico, 2007 - Fonte: rielaborazioni The European House-Ambrosetti su dati ISTAT - TCI, Annuario del Turismo e della Cultura 2009
A supporto di tale risultato i dati dellUfficio Italiano Cambi15 (UIC) evidenziano che le presenze di stranieri in Italia per turismo culturale tra il 2004 e il 2006 sono aumentate del 25% rispetto ad un aumento del 12% del totale delle presenze straniere. Si stima16 che nel 2007 la spesa turistica sia stata di circa 90 miliardi di Euro, di cui due terzi sono rappresentati dalla spesa degli italiani e un terzo quella degli stranieri. Le presenze turistiche registrate nel 2005 nelle citt di interesse storico ed artistico sono state circa 96 milioni rispetto ai 364 milioni delle presenze complessive, quindi circa un quarto: se tale proporzione rimanesse invariata anche per lammontare della spesa, si potrebbe stimare una spesa legata al turismo culturale superiore ai 20 miliardi di Euro lanno.
2.5. iL modeLLo concettuaLe utiLizzato per LanaLisi comparativa nazionaLe ed internazionaLe: La matrice deL settore cuLturaLe e creativo
A fronte dellanalisi dei principali contributi scientifici sul tema e dellinquadramento dei principali numeri del settore rispetto al sistema economico nazionale, in questo paragrafo presentato lapproccio concettuale alla modellizzazione del settore dei beni culturali e ambientali nellambito di Florens 2010. Infatti, come sar illustrato nel seguito del paragrafo e nella descrizione metodologica dellindice sintetico del settore culturale e creativo elaborato per il confronto nazionale ed internazionale (denominato Florens Index17), nel presente Rapporto si scelto di ricondurre il settore culturale e creativo ad alcuni ambiti ben precisi di attivit: da un lato si tratta ispirazione dallo studio della Commissione Europea e da altri spunti bibliografici tra cui quelli citati in precedenza, dallaltro sono stati introdotti alcuni ambiti non strettamente contemplati da tali lavori ma giudicati comunque rilevanti, in quanto alla base del tessuto imprenditoriale e suscettibili di influenzare e/o definire nuovi modelli aziendali organizzativi e produttivi18.
15 16 17 18
Dati tratti da Federculture, Quarto rapporto annuale, 2007. Ministero dello Sviluppo Economico - DPS, Rapporto Annuale, 2007 e Ministero del Turismo, Rapporto sul Turismo Italiano, 2009. Si rinvia ai Capitoli 3 e 4 del presente Rapporto. Ad esempio, non sono state considerate le industrie connesse, in quanto maggiormente globalizzate, mentre stato considerato il settore enogastronomico, maggiormente connotato a livello territoriale.
38
2. La definizione del settore culturale e creativo e il modello interpretativo di riferimento
A partire da quanto presentato e discusso nel paragrafo precedente, la definizione di settore culturale e creativo adottata per lanalisi comparativa si basa su due dimensioni principali: 1. Riproducibilit delloutput; 2. Tipologia delloutput. Con il concetto di riproducibilit delloutput ci si riferisce allattitudine dei beni e servizi di natura culturale ad essere destinati al consumo immediato o alla distribuzione e riproduzione di massa. Alcuni beni e servizi culturali possono essere sia collezionabili, sia perfettamente ed esattamente replicabili nello spazio e nel tempo, come, ad esempio, un libro, un brano musicale su supporto digitale (CD, MP3, ecc.), un film o una pubblicazione scientifica. Altri, invece, non sono replicabili in modo perfettamente identico nello spazio e nel tempo come, ad esempio, unopera teatrale, unopera lirica, una lezione universitaria o un bene storico-architettonico. Per tipologia delloutput si intende invece la prevalenza della dimensione culturale dei beni e servizi prodotti attraverso un processo che utilizza input culturali (tradizioni, valori, sensibilit, patrimoni, conoscenza, ecc.). Per alcuni beni e servizi la dimensione culturale da ritenersi prevalente: un quadro, un libro, un film, un quotidiano, ecc.. Le attivit che portano alla produzione di questa tipologia di beni e servizi saranno pertanto classificate, nella presente analisi, quali suscettibili di produrre un output culturale. Laddove invece le attivit analizzate utilizzano elementi culturali (tradizioni, valori, sensibilit, patrimoni, conoscenza, ecc.) per produrre output non necessariamente culturali in senso stretto, si parler di output creativo. Attivit quali la pubblicit, la moda, il design o la ricerca applicata generano un prodotto prevalentemente caratterizzato dalla dimensione della creativit. Rientrano in questa categoria anche attivit formative di life-long learning, manifestazioni fieristiche e strumenti di connettivit digitale come la banda larga e siti web, che, agendo da strumenti di networking, favoriscono lo scambio di idee, prospettive, valori, ecc.. Incrociando le due dimensioni si perviene alla matrice del settore culturale e creativo, che coincide con la definizione settoriale utilizzata per lanalisi comparativa (si veda la Figura 10) e a partire dalla quale stato costruito un indicatore sintetico di confronto tra territori differenti (regioni o nazioni). Le due dimensioni identificate (tipologia delloutput e riproducibilit delloutput), incrociandosi nella matrice del settore culturale e creativo danno origine a quattro quadranti, a cui possono essere ricondotte (in una sorta di processo di clusterizzazione) numerose tipologie di attivit economiche attinenti al macro-settore dellindustria culturale e creativa. I quattro quadranti originati dallincrocio delle due variabili di riferimento sono: - Capitale Culturale e Ambientale; - Media; - Networking; - Sistema Creativo. Lindicatore di sintesi per la misurazione dei posizionamenti dei territori nei quattro quadranti stato denominato Florens Index. La rappresentazione del settore culturale e creativo e la selezione degli ambiti che lo compongono sono state realizzate con la finalit principale di realizzare confronti a livello regionale e nazionale: dunque la disponibilit di informazioni statistiche comparabili stata presa in massima considerazione, tanto nellideazione e sviluppo della matrice, quanto della successiva analisi.
39
Leconomia dei beni culturali e ambientali.
Una visione sistemica e integrata
Figura 10 La matrice del settore culturale e creativo Fonte: elaborazione The European House-Ambrosetti, 2009
2.5.1. Il quadrante Capitale Culturale e Ambientale
Al quadrante del Capitale Culturale e Ambientale riconducibile la maggior parte degli asset culturali e ambientali di un qualsiasi territorio (nazione, regione, ecc.) intesi come patrimonio storico-artistico, citt darte, parchi naturali, paesaggi, ecc.: tali asset culturali rappresentano una dotazione non riproducibile e di tipo strettamente culturale.
Figura 11 Due esempi di Capitale Culturale e Ambientale: il centro storico di Firenze con la statua del David di Michelangelo e il panorama della Val DOrcia (entrambi inseriti nella World Heritage List dellUNESCO)
Oltre alla dotazione patrimoniale di tipo culturale e ambientale, questo quadrante intercetta anche le attivit legate alle cosiddette Performing arts (spettacoli teatrali, concertistici, ecc.) e Visual Arts (mostre, esposizioni, ecc.). In questo caso si tratta infatti di attivit che generano output di tipo culturale non riproducibile (non infatti possibile generare una riproduzione esatta di un quadro cos come una performance teatrale o concertistica dal vivo non pu essere ripetuta esattamente uguale a s stessa).
40
2. La definizione del settore culturale e creativo e il modello interpretativo di riferimento
Oltre a Visual Arts, Performing Arts e Patrimoni Culturali e Ambientali, sono stati ricondotti a questo primo quadrante anche il sistema formativo generalista (inteso come istruzione terziaria) e il sistema formativo specifico artistico-culturale. Si ritiene infatti che un input primario per lo sviluppo del capitale culturale sia il capitale umano. A tal fine, non sono rilevanti solo i percorsi formativi specifici per le Visual e le Performing Arts, ma anche il sistema formativo di terzo livello (Universit), che rappresenta un viatico fondamentale per il potenziamento del capitale umano di un territorio, anche ai fini della sua attitudine a generare capitale culturale e/o a diventarne fruitore. Nella figura riportata di seguito sono indicate le principali dimensioni intercettate dal quadrante del Capitale Culturale e Ambientale con lesemplificazione di alcune categorie economiche o dotazioni patrimoniali riconducibili a ciascuna delle dimensioni che compongono il quadrante.
Figura 12 Le principali dimensioni che compongono il quadrante del Capitale Culturale e Ambientale Fonte: elaborazione The European House-Ambrosetti, 2010
2.5.2. Il quadrante Media
Il quadrante Media identifica i settori che generano output di tipo culturale e caratterizzati da riproducibilit. Si tratta quindi di attivit dotate di un contenuto di tipo culturale (seppure con intensit variabile) e destinati ad una riproduzione su larga scala attraverso supporti fisici o digitali, come ad esempio libri, film, CD musicali, quotidiani, ecc., ma anche trasmissioni televisive e radiofoniche (attivit di broadcasting televisivo e radiofonico).
Figura 13 - Alcuni esempi di attivit riconducibili al quadrante Media: broadcasting televisivo e radiofonico, distribuzione cinematografica, editoria e stampa e media digitali
41
Leconomia dei beni culturali e ambientali.
Una visione sistemica e integrata
Il quadrante Media pu essere suddiviso in quattro principali categorie: lattivit di broadcasting televisivo e radiofonico, la distribuzione cinematografica e digitale, il settore delleditoria e della stampa e lattivit media digitale.
Figura 14 Le principali dimensioni che compongono il quadrante Media Fonte: elaborazione The European House-Ambrosetti, 2010
2.5.3. Il quadrante Networking
Il quadrante denominato Networking identifica i settori e le attivit che generano un output di tipo prevalentemente creativo e non riproducibile. Come gi definito in precedenza, loutput definito di tipo creativo viene realizzato in quei settori in cui input di tipo culturale (tradizioni, valori, sensibilit, patrimoni, conoscenza, ecc.) vengono trasformati in output non strettamente culturali. Ad esempio - come si vedr meglio in seguito nella presentazione del quadrante relativo al Sistema Creativo - attivit quali la pubblicit, la moda, il design, la ricerca applicata generano un prodotto prevalentemente caratterizzato dalla dimensione della creativit (seppure a partire da input di tipo culturale). Rientrano pertanto in questo quadrante attivit quali le manifestazioni fieristiche o le attivit formative di life-long learning che, agendo da strumenti di networking, favoriscono lo scambio di idee, di esperienze, contribuendo, secondo percorsi non istituzionalizzati, alla formazione del capitale umano.
Figura 15 Alcuni esempi riconducibili alle principali dimensioni che costituiscono il quadrante Networking: lattivit fieristica e lattivit di aggiornamento permanente
42
2. La definizione del settore culturale e creativo e il modello interpretativo di riferimento
Il quadrante Networking stato suddiviso in tre principali categorie (figura seguente).
Figura 16 Le principali dimensioni che compongono il quadrante Networking Fonte: elaborazione The European House-Ambrosetti, 2010
Si tratta in generale di un insieme di attivit collegate prevalentemente al mondo del business e dellimpresa, che nellepoca attuale di riduzione del ciclo di vita di conoscenze e competenze e di interconnessione a livello globale, sono fondamentali per lo sviluppo futuro del settore culturale e creativo. Le attivit di life-long learning consentono infatti il rinnovo del know-how contro lobsolescenza delle competenze. Le attivit di networking in senso stretto, quali fiere internazionali ed esposizioni, consentono non solo il confronto sullo stato dellarte di un determinato ambito o settore, ma determinano, per la creativit del territorio che le ospita, importanti ricadute di fertilizzazione incrociata (si pensi, ad esempio, a manifestazioni collaterali del tipo dei cosiddetti eventi fuori-salone che si svolgono a Milano contemporaneamente al Salone del Mobile). In questo quadrante sono state considerate, quale fattore abilitante, le infrastrutture digitali per il networking (nellaccezione Business to Business). Le tecnologie dellinformazione rappresentano infatti uno strumento imprescindibile per lo sviluppo del business della connettivit e quindi delle imprese attraverso la creazione e il consolidamento di una rete di contatti con stakeholder, clienti, fornitori ecc. sia a livello locale/nazionale sia a livello internazionale.
2.5.4. Il quadrante Sistema Creativo
I settori che generano un output riproducibile su larga scala e connotato da una natura di tipo prevalentemente creativo sono identificati dal quadrante del Sistema Creativo. Il sistema creativo integra una variet di settori in cui input di tipo culturale (di varia natura, tra cui ad esempio la conoscenza, le tradizioni, il know how, ecc.) sono trasformati attraverso unattivit di tipo creativo in prodotti riproducibili. questo, ad esempio, il caso dellattivit di Ricerca e Sviluppo finalizzata allingegnerizzazione di prodotti/processi innovativi. Lattivit di Ricerca e Sviluppo, con particolare riferimento alla ricerca svolta in ambito privato (in questo caso), muove infatti dalla conoscenza di base per identificare soluzioni di prodotto/processo pratiche ed innovative destinate a competere sul mercato. Un input di natura culturale viene cos trasformato attraverso un processo in cui la creativit rappresenta il principale fattore di conversione. Molti settori, come la moda, la pubblicit, il design, larchitettura, lartigianato, lenogastronomia, ecc., sono riconducibili alla categoria pocanzi descritta, e costituiscono nel complesso ci che nel presente Rapporto definito Sistema Creativo.
43
Leconomia dei beni culturali e ambientali.
Una visione sistemica e integrata
Figura 17 Alcune immagini rappresentative delle principali dimensioni che costituiscono il quadrante Sistema Creativo: Creazione Pubblicitaria, Moda, Design, Ricerca e Sviluppo, Artigianato
Pi in dettaglio, le categorie che compongono il quadrante del Sistema creativo sono: Ricerca e Sviluppo, Design e Architettura, Moda, Enogastronomia e Artigianato.
Figura 18 Le principali dimensioni che compongono il quadrante Sistema Creativo Fonte: elaborazione The European House-Ambrosetti, 2010
Come si pu osservare nella figura sopra riportata, lattivit di Ricerca e Sviluppo considerata nel quadrante del Sistema Creativo non comprende il settore universitario che, come gi anticipato allinizio del presente capitolo, rientra nella dimensione del sistema di generazione e trasmissione dei saperi culturali, misurato nellambito del quadrante del Capitale Culturale e Ambientale.
44
2. La definizione del settore culturale e creativo e il modello interpretativo di riferimento
Una particolare attenzione meritano, inoltre, gli ambiti legati al Design, allEnogastronomia e allAgroalimentare.
Il design un processo, unattivit, e non solo i risultati di tale attivit
Come evidenziato dalle diverse definizioni presentate in diversi punti del capitolo, il design unattivit, un processo che segue una determinata metodologia e una serie di passaggi quali la ricerca, la concettualizzazione, la modellazione, la sperimentazione e il re-design. Il design comporta la sintesi e lunione tra un numero anche elevato di discipline. Come tale, esso pu essere considerato come un ponte tra creativit ed innovazione, tra tecnologia e utente, tra discipline scientifiche-tecniche e commerciali.
Il design implica la considerazione e la gestione di una vasta gamma di aspetti
Il design consta in un approccio olistico che richiede che siano tenuti in considerazione una serie di fattori che vanno ben al di l dellestetica, tra cui: funzionalit, ergonomia, usabilit, accessibilit, sicurezza del prodotto, sostenibilit, costi, ecc..
Il design riguarda prodotti, servizi, sistemi, contesti e comunicazione
Molti designer lavorano in imprese manifatturiere e si occupano di prodotti e imballaggi, tuttavia il design una disciplina applicabile anche ai servizi - pubblici e privati - cos come ai sistemi (come nel caso della pianificazione urbana) e persino alle esperienze. Un designer di servizi pu ad esempio studiare lesperienza emotiva di un paziente trasportato al pronto soccorso o di un cliente potenziale che per la prima volta entra in una banca. I designer urbani studiano invece, ad esempio, la valenza esperienziale relativa alla visita del centro di una citt da parte di una persona anziana o disabile sotto il profilo dellaccessibilit. Il design di un nuovo modello di business invece una delle attivit legate allinnovazione organizzativa nelle aziende. Il graphic design fondamentale per la comunicazione visiva delle organizzazioni, in particolare nella creazione e rafforzamento delle identit e dei marchi, sia al livello della stessa organizzazione (corporate identity), sia relativamente ai suoi prodotti o servizi. Il design delle interfacce di comunicazione rappresenta il linguaggio visivo, il look, dei sistemi operativi dei computer, dei siti web, delle applicazioni software o dei dispositivi mobili di comunicazione. Fonte: Commissione Europea, Design as a driver of user-centred innovation, 2009
LEnogastronomia e lAgroalimentare come frontiere del Sistema Creativo
LEnogastronomia pu essere di diritto annoverata tra le attivit creative: si tratta di unarea che, per sua natura, associata allinnovazione di prodotto o di processo e al nascere di professioni originali. Si pensi, ad esempio, alla cosiddetta cucina molecolare ideata negli anni Novanta dallo chef catalano Ferran Adri e al connubio sempre pi stretto tra cibo e design: oggi la creativit in cucina sembra non volersi pi fermare a metodi di cottura e abbinamenti di ingredienti, ma si estende anche agli strumenti per cucinare e servire, che si trasformano in un aspetto-chiave dei piatti serviti per enfatizzare laspetto esperienziale della consumazione. La stessa Universit di Harvard ha recentemente avviato un corso di specializzazione denominato From Haute Cuisine to Soft Science, durante il quale gli studenti apprendono i segreti della chimica e della fisica applicata a ricette di cucina, con laiuto di alcuni tra i pi noti cuochi al mondo*. Pi in generale, la sensibilit verso le attivit legate alla valorizzazione della produzione agroalimentare e della protezione delle tradizioni culinarie appare incrementata significativamente rispetto al passato. Ne una testimonianza il successo del movimento Slow Food, fondato in Italia da Carlo Petrini alla fine degli anni Ottanta e diventato oggi unassociazione internazionale che conta 100.000 iscritti in 130 Paesi. La missione di Slow Food dare la giusta importanza al piacere legato al cibo, imparando a godere della diversit delle ricette e dei sapori, a riconoscere la variet dei luoghi di produzione e degli artefici, a rispettare i ritmi delle stagioni e del convivio. In tal modo si riesce a promuovere leducazione del gusto come difesa contro la cattiva qualit e le frodi e come esempio contro lomologazione dei pasti, sostenendo la salvaguardia delle cucine locali, delle produzioni tradizionali, delle specie vegetali e animali a rischio di estinzione e sostenendo un nuovo modello di agricoltura, meno intensivo e pi pulito. LItalia, in particolare, in grado di trasformare lenogastronomia in un grande mercato nazionale e internazionale che produce ricchezza per il Paese intero, grazie allelevato numero di prodotti tutelati e caratterizzati da qualit della materia, localizzazione geografica specifica e particolari tecniche di produzione (DOP, IGP, IGT, ecc.). *Fonte: The New York Times, At Harvard, the Kitchen as Lab,19 ottobre 2010.
45
Leconomia dei beni culturali e ambientali.
Una visione sistemica e integrata
Nei capitoli successivi si vedr come le definizioni precedenti e il quadro concettuale appena presentato in relazione alla matrice del settore culturale e creativo saranno declinati in una serie di analisi quantitative e qualitative, in alcuni casi connotate da un forte carattere innovativo.
46
3. Il Florens Index: analisi comparativa nazionale
3. IL FLORENS INDEX: ANALISI COMPARATIVA NAZIONALE 3.1. introduzione
Sulla base della definizione di settore culturale e creativo illustrata nel Capitolo 2 del presente Rapporto, in questo capitolo saranno presentate le evidenze emerse dallanalisi quantitativa di comparazione tra le Regioni italiane in termini di potenziale e dinamismo espresso dal settore culturale e creativo. Il confronto tra le 20 Regioni stato effettuato selezionando per ogni quadrante della matrice sotto riportata (gi presentata nel Capitolo 2) un gruppo di indicatori (KPI Key Performance Indicators). I KPI selezionati costituiscono un cruscotto sintetico di indicatori in grado di misurare i principali elementi che determinano e spiegano il posizionamento dei sistemi territoriali nella matrice del settore culturale e creativo1.
Figura 1 La matrice del settore culturale e creativo Fonte: elaborazione The European HouseAmbrosetti, 2010 La misurazione dei valori registrati dai sistemi territoriali nei diversi KPI stata resa omogenea attraverso lassegnazione di punteggi. I punteggi sono assegnati nel modo seguente: si attribuisce 5 al territorio che presenta il livello pi alto in relazione alla grandezza misurata dallindicatore e 1 al territorio per il quale viene rilevato il valore pi basso tra quelli presi in considerazione. Ai restanti sistemi territoriali viene assegnato un punteggio compreso tra 1 e 5 in modo proporzionale al valore assoluto dellindicatore (in comparazione al valore massimo e minimo registrato per il KPI in esame), secondo una scala ottenuta utilizzando la seguente metodologia: SCALA = (valore massimo valore minimo) / (punteggio massimo punteggio minimo) Una volta fissata la scala, il punteggio di ogni sistema territoriale calcolato come segue: PUNTEGGIO = [(valore del territorio valore minimo) / scala] + 1 Tale metodologia ha permesso di ottenere per ciascun KPI punteggi omogenei compresi tra 1 e 5, tra loro confrontabili ed aggregabili come indicatore di sintesi sia di ciascun quadrante, sia a livello generale, ottenendo in questultimo caso lindicatore denominato Florens Index.
I KPI sono indicatori statistici quantitativi provenienti da database predisposti da fonti istituzionali nazionali ed internazionali.
47
Leconomia dei beni culturali e ambientali.
Una visione sistemica e integrata
Laddove necessario, i KPI sono stati relativizzati attraverso un opportuno denominatore per aumentarne la significativit nellambito del confronto comparativo territoriale. I dati riguardanti i consumi, ad esempio, sono normalmente pi significativi se rapportati ai bacini di utenza. Allo stesso modo, i dati espressi in volume daffari settoriale sono comparabili in modo pi immediato se rapportati al Prodotto Interno Lordo, e cos via. Lindicatore di sintesi calcolato per ciascun quadrante della Matrice rappresenta il contributo comparato della dimensione di analisi rispetto al settore culturale e creativo di ciascuna Regione. Il Florens Index rappresenta invece un indicatore sintetico del livello di sviluppo comparato del settore culturale e creativo territoriale. Si tratta pertanto, in entrambi i casi, di misurazioni relative.
3.2. anaLisi comparativa nazionaLe: iL quadrante capitaLe cuLturaLe e ambientaLe
Il quadrante Capitale Culturale e Ambientale include gli output culturali caratterizzati da non riproducibilit ed stato suddiviso in cinque principali categorie: - Patrimonio culturale; - Beni Ambientali; - Sistema di formazione dei saperi culturali; - Visual Arts; - Performing Arts. In particolare, oltre a Visual Arts, Performing Arts, Patrimonio culturale e Beni Ambientali, sono stati inclusi il sistema formativo generalista e il sistema formativo artistico-culturale. Si ritiene infatti che un input primario per lo sviluppo del capitale culturale sia il capitale umano. A tal fine, non sono rilevanti solo i percorsi formativi specifici per le Visual e le Performing Arts, ma anche il sistema formativo di terzo livello, che rappresenta un viatico fondamentale per il potenziamento del capitale umano di un territorio anche ai fini della sua attitudine a generare capitale culturale o a diventarne fruitore. Lanalisi ha preso in considerazione le performance delle 20 Regioni italiane su 20 KPI, relativamente allultimo anno reso disponibile dalle fonti statistiche utilizzate. Gli indicatori presi in considerazione2 e i pesi di ponderazione utilizzati sono indicati nella Tabella 1, che sintetizza brevemente, per ciascun indicatore identificato, le motivazioni che hanno portato alla selezione dellindicatore e gli eventuali fattori (driver) di relativizzazione utilizzati per la misurazione. Ciascun KPI stato selezionato con lobiettivo specifico di misurare il posizionamento del sistema territoriale di riferimento in relazione ad uno o pi ambiti previsti dallimpianto metodologico utilizzato. In alcuni casi, non essendo possibili rilevazioni puntuali del fenomeno da misurare a causa della scarsa disponibilit di dati e/o a causa della natura del fenomeno stesso, sono state utilizzate approssimazioni (proxy) ad hoc al fine di misurare ugualmente il fenomeno. Ad esempio, il conteggio del numero di volumi presenti nelle biblioteche regionali rappresenta unapprossimazione del patrimonio librario complessivo detenuto allinterno della Regione.
La scelta del portafoglio di indicatori e dei relativi pesi di ponderazione risponde sia ad una valutazione dellAdvisory Board che alla effettiva disponibilit di dati completi, omogenei e confrontabili tra le diverse Regioni italiane.
48
3. Il Florens Index: analisi comparativa nazionale
Tabella 1 KPI selezionati per il confronto nazionale nel quadrante Capitale Culturale e Ambientale Fonte: rielaborazione The European House-Ambrosetti
49
Leconomia dei beni culturali e ambientali.
Una visione sistemica e integrata
A titolo esemplificativo, di seguito sono riportate le evidenze emerse dallanalisi di alcuni tra i KPI pi significativi che sono stati misurati e che contribuiscono al calcolo del punteggio finale per ciascuna Regione allinterno del perimetro oggetto del confronto nazionale. Patrimonio Culturale Per quanto riguarda la categoria del Patrimonio Culturale, il primo indicatore selezionato per lanalisi stato il Numero di siti culturali e naturali iscritti nel Patrimonio dellUmanit UNESCO3.
Figura 2 Quadrante Capitale Culturale e Ambientale: numero di siti culturali e naturali iscritti nel Patrimonio dellUmanit UNESCO, 2010 Fonte: rielaborazione The European House-Ambrosetti su dati UNESCO, 2010
A livello nazionale, la Toscana si colloca in seconda posizione per numerosit di siti UNESCO (13% del totale nazionale), a breve distanza dalla Lombardia (7 siti). Per questo motivo la Lombardia ottiene il punteggio massimo, pari a 5. Le Regioni italiane che, al contrario, non dispongono di alcun sito tutelato dallUNESCO ottengono il punteggio minimo, pari a 1. Il punteggio attribuito alle altre Regioni invece proporzionale al numero di siti UNESCO ospitati sul proprio territorio (ad esempio, il Lazio ottiene 3,3 punti grazie ai 4 siti UNESCO posseduti).
I siti UNESCO in Italia sono complessivamente 45, tuttavia 2 sono condivisi tra pi regioni (i Sacri Monti, condivisi tra Lombardia e Piemonte e le Dolomiti, condivise tra Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Veneto).
50
3. Il Florens Index: analisi comparativa nazionale
I siti culturali e naturali italiani tutelati dallUNESCO (ordine per anno di iscrizione)
I siti dellItalia inseriti nella World Heritage List dellUNESCO sono nel complesso 45, quasi interamente di natura culturale (ad eccezione di 3 patrimoni naturali: le Isole Eolie, Monte San Giorgio e le Dolomiti): 1979 - Arte Rupestre della Val Camonica 1980 - Centro storico di Roma, le propriet extraterritoriali della Santa Sede nella citt e San Paolo fuori le Mura La Chiesa e il Convento di Santa Maria delle Grazie e il Cenacolo di Leonardo Da Vinci 1982 - Centro storico di Firenze 1987 - Venezia e la sua Laguna Piazza del Duomo a Pisa 1990 - Centro Storico di San Gimignano 1993 - I Sassi e il Parco delle Chiese Rupestri di Matera 1994 - La citt di Vicenza e le ville del Palladio in Veneto 1995 - Centro storico di Siena Centro storico di Napoli Crespi dAdda Ferrara, citt del Rinascimento, e il Delta del Po 1996 - Castel del Monte Trulli di Alberobello Monumenti paleocristiani di Ravenna Centro storico di Pienza 1997 - La Reggia di Caserta del XVIII con il Parco, lacquedotto del Vanvitelli e il Complesso di San Leucio Le Residenze Sabaude LOrto botanico di Padova Portovenere, Cinque Terre e Isole (Palmaria, Tino e Tinetto) Modena: Cattedrale, Torre Civica e Piazza Grande Aree archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata Costiera Amalfitana Area Archeologica di Agrigento La Villa Romana del Casale di Piazza Armerina Villaggio Nuragico di Barumini 1998 - Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, con i siti archeologici di Paestum, Velia e la Certosa di Padula Centro Storico di Urbino Zona Archeologica e Basilica Patriarcale di Aquileia 1999 - Villa Adriana (Tivoli) 2000 - Isole Eolie Assisi, La Basilica di San Francesco e altri siti Francescani Citt di Verona 2001 - Villa dEste (Tivoli) 2002 - Le citt tardo barocche della Val di Noto 2003 - Sacri Monti del Piemonte e della Lombardia 2004 - Necropoli Etrusche di Cerveteri e Tarquinia La Val dOrcia 2005 - Siracusa e le necropoli rupestri di Pantalica 2006 - Genova, le Strade Nuove e il Sistema dei Palazzi dei Rolli 2008 - Mantova e Sabbioneta La ferrovia retica nel paesaggio dellAlbula e del Bernina 2009 - Le Dolomiti 2010 - Monte San Giorgio Fonte: Unesco, World Heritage List, 2010
51
Leconomia dei beni culturali e ambientali.
Una visione sistemica e integrata
Figura 3 Quadrante Capitale Culturale e Ambientale: presenze nelle citt dinteresse storico e artistico, 2007 Fonte: rielaborazione The European House-Ambrosetti su dati Istat-Touring Club Italiano, Annuario del Turismo e della Cultura 2009
Un altro indicatore a cui stato attribuito un peso rilevante nella categoria Patrimonio Culturale stato il Numero di presenze nelle citt dinteresse storico-artistico nella Regione. Osservando i dati emerge chiaramente il ruolo egemonico di Roma per il Lazio, mentre pi sorprendente pu risultare il dato rilevato per lUmbria, spiegabile dalla presenza di numerose citt darte (come, ad esempio, Assisi, Gubbio e Spello) e dallassenza del mare. Anche in questo caso la Regione Toscana risulta una delle Regioni che mostrano il valore maggiore relativamente a questo KPI. Nel 2007, ultimo dato disponibile per questo indicatore, oltre il 35% delle presenze turistiche toscane si concentrato nelle citt di interesse storico e artistico. Infine, un ulteriore indicatore preso in considerazione per misurare il patrimonio culturale nella sua dimensione museale ed archeologica stato il Numero di visitatori a musei, monumenti e aree archeologiche statali a pagamento. Lindicatore stato rapportato alla popolazione regionale per depurare il fenomeno dalla dimensione demografica di ciascuna Regione analizzata.
52
3. Il Florens Index: analisi comparativa nazionale
Figura 4 Quadrante Capitale Culturale e Ambientale: visitatori a musei, monumenti e aree archeologiche statali a pagamento, 2008 - Fonte: rielaborazione The European House-Ambrosetti su dati Ufficio di Statistica del Ministero per i Beni e le Attivit Culturali 2008, 2010. Nota: i valori assoluti sono riportati nella figura dalla linea rossa (asse destro) mentre listogramma rappresenta il dato relativo (asse sinistro), sulla base del quale stato calcolato il punteggio
Figura 5 Numero medio di visitatori mensili per metro quadrato nei primi 25 musei al mondo Fonte: rielaborazione The European House-Ambrosetti su dati Ufficio di Statistica Ministero dei Beni Culturali 2008 e Siti Internet dei Musei, 2010
53
Leconomia dei beni culturali e ambientali.
Una visione sistemica e integrata
La figura precedente mostra come il Molise risulti la Regione italiana con il valore pi alto di visitatori a musei, monumenti e aree archeologiche, con una media su base annua di 3,4 visitatori per abitante, seguito, con un certo distacco dalla Basilicata (2,7 visitatori). La terza Regione il Lazio, che in termini assoluti la prima Regione con circa 9 milioni di visitatori, seguita dalla Toscana con circa 5 milioni di visitatori e dal Veneto con quasi 4 milioni di visitatori.
Il numero di visitatori dei primi 25 musei mondiali
Se si osservano i dati relativi al numero di visitatori mensili per metro quadrato di superficie museale (considerandoli, quindi, in rapporto allo spazio espositivo, anzich in valori assoluti), emerge una performance di eccellenza internazionale relativamente ai Musei Vaticani, che si posizionano al secondo posto a livello mondiale, e alla Galleria degli Uffizi (in quarta posizione). Ci conferma limpareggiabile qualit e prestigio delle opere darte custodite in tali musei, che generano crescente attrattivit verso visitatori stranieri e non senza pari al mondo.
Beni Ambientali e Paesaggistici La seconda dimensione identificata per il Capitale Culturale e Ambientale quella relativa ai Beni Ambientali. Tale dimensione si riferisce al patrimonio ambientale e paesaggistico delle diverse Regioni. A titolo esemplificativo, nella figura seguente sono riportati i valori dellindicatore relativo al Numero di parchi naturali regionali.
Figura 6 Quadrante Capitale Culturale e Ambientale: numero di parchi naturali, 2010 Fonte: rielaborazione The European House-Ambrosetti su dati Parks.it-Federparchi, 2010
54
3. Il Florens Index: analisi comparativa nazionale
Rispetto a questo KPI, Lombardia e Piemonte sono le Regioni per cui stata rilevata la maggiore dotazione di parchi, con ben 24 parchi naturali ciascuna. Seguono, pi distanziate, Emilia Romagna e Lazio, rispettivamente con 14 e 13 parchi4.
Il patrimonio forestale italiano
Il patrimonio forestale ricopre pi di un terzo dellItalia (10,5 milioni di ettari, pari al 34,7% della superficie nazionale). In particolare, i boschi coprono il 29,1% dellintero territorio nazionale e i distretti pi densamente boscati sono la Liguria e il Trentino che, grazie a un grado di copertura percentuale superiore al 60%, costituiscono gli unici ambiti amministrativi in cui il bosco copre pi della met del territorio. Tra le Regioni, il Trentino Alto Adige, il Friuli Venezia Giulia, la Liguria, la Toscana, lUmbria, lAbruzzo, la Calabria e la Sardegna presentano un coefficiente di boscosit sensibilmente superiore a quello nazionale. Fonte: Corpo Forestale dello Stato, 2010
Una ulteriore proxy del livello di attrattivit del territorio rappresentata dal saldo della bilancia commerciale turistica, che misura la differenza tra lammontare speso nella Regione da cittadini stranieri e da altri cittadini italiani e la spesa degli abitanti della Regione allestero e nelle altre Regioni italiane. Lindicatore esprime quindi lattrattivit turistica espressa dalla Regione misurata in termini economici. La Valle dAosta, nel confronto con le 20 Regioni italiane, mostra il saldo attivo della bilancia turistica pi alto in proporzione al Prodotto Interno Lordo generato. La terza Regione con la maggiore incidenza del saldo della bilancia turistica sul PIL regionale la Toscana, a cui vengono attribuiti (secondo la metodologia descritta in precedenza) 2,4 punti. Nel grafico la linea indica i valori assoluti, che mostrano come la Regione spicchi in Italia per valore assoluto registrato dalla bilancia turistica, seguita da Veneto ed Emilia Romagna mentre Campania, Molise, Lombardia, Basilicata, Umbria e Piemonte presentano un saldo negativo della bilancia turistica regionale.
Figura 7 Quadrante Capitale Culturale e Ambientale: saldo della bilancia commerciale turistica per le 20 Regioni italiane, 2007 Fonte: rielaborazione The European House-Ambrosetti su dati Rapporto sul Turismo Italiano, 2008-2009
Nella lettura dei risultati emersi dallanalisi di questo indicatore necessario tenere in considerazione il fatto che lindicatore non stato costruito sulla base della superficie complessiva (a causa della difficolt nel reperire informazioni omogenee tra le Regioni).
55
Leconomia dei beni culturali e ambientali.
Una visione sistemica e integrata
Sistema di formazione dei saperi culturali Il sistema formativo generalista e il sistema formativo specifico artistico-culturale, poich generatori di capitale umano (input primario per lo sviluppo del capitale culturale e del capitale creativo), sono stati inclusi come componente determinante del quadrante del capitale culturale. In particolare si sono distinti i percorsi formativi specifici per le Visual e le Performing Arts dal sistema formativo di terzo livello. La figura seguente mostra i risultati per lindicatore relativo al numero di laureati in ciascuna Regione. Poich lobiettivo del KPI quello di misurare la concentrazione di laureati nella Regione (e non una misura della performance del sistema universitario regionale), lindicatore stato rapportato alla popolazione regionale e non a quella universitaria.
Figura 8 Quadrante Capitale Culturale e Ambientale: numero di laureati per Regione per 100 abitanti, 2008 Fonte: rielaborazione The European House-Ambrosetti su dati ISTAT, 2008
Il punteggio pi alto (5 punti) stato assegnato al Lazio, Regione che - con 15,1 laureati ogni 100 abitanti residenti - presenta il valore pi elevato per questo indicatore. Seguono Liguria, (12,8), Emilia Romagna e Lombardia (11,5) e Toscana (11,4), che anche relativamente a questo KPI appare ben posizionata. In relazione al numero assoluto di laureati, la Lombardia la prima Regione italiana, con oltre 1,1 milioni di laureati. Come proxy della concentrazione di laureati nellambito delle discipline artistiche (elemento generatore di forti ricadute positive sul sistema creativo e culturale), stato preso in considerazione lindicatore Iscritti a scuole di Alta Formazione Artistica e Musicale5. Tale indicatore non stato relativizzato rispetto alla dimensione regionale, in quanto ci che rileva misurare la dimensione assoluta del fenomeno, che incide direttamente sulle ricadute per il sistema. Per chiarire meglio, i diplomati dalle scuole di Alta Formazione Artistica e Musicale sono stati considerati una risorsa della Regione in termini assoluti, poich, trattandosi di formazione focalizzata sul talento artistico-creativo, ciascuno di essi in grado di contribuire singolarmente al patrimonio di competenze della Regione in cui si colloca listituto di Alta Formazione.
Le scuole di Alta Formazione Artistica e Musicale considerate (censite da Ministero dellistruzione) sono: Accademie di Belle Arti, Accademie Nazionali di Arte Drammatica, Accademie Nazionali di Danza, Conservatori di Musica, Istituti Musicali Pareggiati, Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, Accademie legalmente riconosciute.
56
3. Il Florens Index: analisi comparativa nazionale
Figura 9 Quadrante Capitale Culturale e Ambientale: iscritti a scuole di Alta Formazione Artistica e Musicale, 2009 Fonte: rielaborazione The European House-Ambrosetti su dati Ministero dellIstruzione, dellUniversit e della Ricerca, 2009
La Regione con il maggior numero di iscritti a scuole di Alta Formazione Artistica e Musicale la Lombardia (quasi 9.500 iscritti), seguita dalla Puglia e dallEmilia Romagna. La Toscana si posiziona poco al di sopra della mediana (3.636 iscritti nel 2009).
Esperienze di successo nel sistema toscano della formazione artistica e musicale
Tra le eccellenze pi significative nellambito della formazione artistica e musicale in Toscana (numerose di queste inserite nel comparto AFAM - Alta Formazione Artistica e Musicale del MIUR) si segnalano, in particolare: - LOpificio delle Pietre Dure di Firenze: attualmente lOpificio uno degli Istituti Centrali del Ministero per i Beni e le Attivit Culturali. La sua attivit si esplica in tre branche principali: la conservazione propriamente detta (tramite gli undici settori specialistici di restauro ed i circa 60 restauratori), la ricerca (sia pura che applicata a casi concreti di restauro), la didattica (tramite la Scuola di Alta Formazione) e unintensa attivit di stage in rapporto con analoghi istituti italiani e internazionali. - LAccademia delle Belle Arti di Firenze: deriva dallantica Vasariana Accademia del Disegno, universalmente riconosciuta come una delle prime istituzioni europee che poneva fra i suoi compiti, accanto a quello di confraternita di eminenti artisti ai quali era demandato il governo e la tutela del patrimonio culturale della Toscana, anche quello dellinsegnamento delle arti e delle scienze, segnando cos linizio del moderno concetto di Accademia. Nel corso dei secoli hanno dato vita a questa istituzione i pi importanti artisti, da Michelangelo al Vasari, dal Bronzino al Giambologna, da Benvenuto Cellini a Giovanni Fattori. Oggi lAccademia delle Belle Arti di Firenze si orienta secondo un percorso di studi di tipo universitario. - Il Conservatorio di Musica Luigi Cherubini di Firenze: fondato nel 1849, vanta una lista di musicisti di fama internazionale che vi hanno studiato e insegnato. Lattuale offerta formativa del Conservatorio fiorentino composta da corsi tradizionali del Vecchio Ordinamento, corsi sperimentali di Triennio e Biennio Specialistico e corsi abilitanti (previsti dal D.M. 137/07). Altre esempi di eccellenza nel campo della formazione musicale in Toscana sono offerti dagli Istituti Superiori di Studi Musicali Rinaldo Franci di Siena (fondato nel 1834), Luigi Boccherini di Lucca (fondato nel 1842), Piero Mascagni di Livorno (fondato nel 1953) e dalla Scuola di Musica di Fiesole (fondata nel 1974). - LIstituto Superiore per le Industrie Artistiche (ISIA) di Firenze: costituito nel 1975 con Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione raccogliendo la ricca esperienza dei Corsi di Disegno Industriale, questo istituto statale di livello universitario si occupa di design nel senso pi ampio del termine, e propone unofferta formativa di primo e secondo livello in diversi indirizzi: design del prodotto, della comunicazione, della moda e della mobilit. - LIstituto Polimoda: un centro di formazione per il settore Moda, riconosciuto tra le migliori Fashion School europee. Con sede a Firenze, Polimoda nato nel 1986 da uniniziativa progettata e finanziata dai Comuni di Firenze e Prato, dalle associazioni imprenditoriali e in collaborazione con il Fashion Institute of Technology (FIT) di New York. LIstituto offre unampia offerta formativa che, attraverso corsi preparatori, post diploma e master, copre tutti i profili del settore moda, dal design, al marketing, al management, alla comunicazione.
57
Leconomia dei beni culturali e ambientali.
Una visione sistemica e integrata
Visual Arts Tra gli indicatori selezionati per misurare il fenomeno delle Visual Arts, si propone lindicatore Ingressi a mostre ed esposizioni per 100 abitanti.
Figura 10 Quadrante Capitale Culturale e Ambientale: ingressi a mostre ed esposizioni per 100 abitanti, 2008 Fonte: rielaborazione The European House-Ambrosetti su dati SIAE, Annuario dello spettacolo, 2008
Laggregato mostre ed esposizioni include, oltre alle mostre culturali, anche attivit espositive con finalit commerciali: in questa categoria rientrano, quindi, anche le mostre di beni destinati alla commercializzazione (antiquariato, tappeti, ecc.) e le fiere campionarie. Sono invece escluse da tale rilevazione le visite ai musei. LEmilia Romagna la Regione che registra il livello pi alto di ingressi a mostre ed esposizioni, con una media di 67,9 ingressi ogni 100 abitanti. Per le Regioni Lombardia e Veneto si rilevano invece poco meno di 50 ingressi ogni 100 abitanti. La Toscana, con 31,9 ingressi ogni 100 abitanti rappresenta lottava Regione italiana. Il grafico presenta anche il dato in valore assoluto, rappresentato nel grafico dalla linea rossa. In questo caso la Regione leader la Lombardia, seguita da Emilia Romagna e Lazio. Performing Arts Un indicatore simile stato impiegato tra i KPI relativi allarea Performing Arts: Ingressi a spettacoli teatrali per 100 abitanti, riportati nella figura seguente.
58
3. Il Florens Index: analisi comparativa nazionale
Figura 11 Quadrante Capitale Culturale e Ambientale: Ingressi a spettacoli teatrali per 100 abitanti, 2008 Fonte: rielaborazione The European House-Ambrosetti su dati SIAE, Annuario dello spettacolo, 2008
Anche in questo caso, al fine dellattribuzione di un punteggio a ciascuna Regione, il numero di ingressi a spettacoli stato rapportato alla popolazione regionale. Come si osserva dagli istogrammi della Figura 11, la Regione che presenta il valore comparato pi alto in relazione a questo indicatore, con un valore 3 volte superiore alla Regione in seconda posizione, il Friuli Venezia Giulia, con 176 ingressi per 100 abitanti. Per la Toscana stata rilevata una media di 42,7 ingressi ogni 100 abitanti. Nel grafico, la linea indica i valori assoluti che mostrano il primato della Lombardia, seguita da Lazio e Veneto. Il sistema teatrale e concertistico del Friuli Venezia Giulia
La posizione geografica del Friuli Venezia Giulia (che dallItalia si affaccia verso lAustria e larea dei Balcani) ha favorito nel corso della storia contaminazioni in ambito teatrale e musicale, regalando al territorio una vivacit culturale di altissimo livello in tali discipline. Anche per questo motivo, quindi, numerosi e intensamente frequentati sono i luoghi della musica e dello spettacolo. La citt di Trieste il principale centro culturale della regione, che nel tempo ha saputo coniugare in modo virtuoso diverse culture: ad esempio, il Teatro Verdi il simbolo della cultura musicale del Friuli Venezia Giulia che, scenario di grandi eventi, ha ospitato i maggiori compositori e maestri dorchestra. Lirica e musica classica di altissimo livello vengono ospitati anche nella cattedrale di San Giusto, nella Cappella Civica, e nel Teatro Stabile di Trieste. Tra i teatri si possono citare anche il Teatro Politeama Rossetti, il Teatro dei Fabbri ed il Teatro Miela Reina. Anche Gorizia, bench sia un centro dalle dimensioni pi contenute rispetto a Trieste, presenta un panorama musicale di rilievo per strutture e programmazione. Il Teatro Giuseppe Verdi di Gorizia, ad esempio, ospita diversi generi, dai musical alla prosa, alla musica classica e alla lirica. Inoltre, sempre a Gorizia, risulta vivace lattivit della Kulturni Dom, dove si possono ammirare esperienze musicali mutuate da culture diverse. Nella provincia di Gorizia riscuote successo anche il festival musicale internazionale Nei suoni dei luoghi, che coinvolge anche diverse localit della Slovenia. A questo evento solitamente sono abbinati, agli spettacoli musicali, itinerari nei luoghi naturali ed abbinamenti eno-gastronomici con la tipica cucina friulana. A Pordenone la maggior parte della produzione musicale avviene allAuditorium Concordia, anche se esistono sul territorio numerose associazioni che operano nel campo come, ad esempio, lAssociazione per la Musica Sacra Vincenzo Colombo e lIstituto di Musica della Pedemontana (che unisce i Comuni di Aviano, Budoia, Polcenigo e Caneva). Infine, a Udine lo scenario teatrale di maggior prestigio il Teatro Nuovo Giovanni di Udine, struttura versatile ben strutturata dove si tengono eventi di vario genere musicale. Si segnala, inoltre, lattivit del Conservatorio Statale di Musica Jacopo Tomadini.
59
Leconomia dei beni culturali e ambientali.
Una visione sistemica e integrata
Indicatore di sintesi del Quadrante del Capitale Culturale e Ambientale Lattribuzione di un punteggio a ciascuna Regione per ognuno dei 20 KPI analizzati e la ponderazione dei risultati ottenuti con i pesi indicati in Tabella 1 ha permesso di ottenere un indice sintetico intermedio relativo al quadrante del Capitale Culturale e Ambientale per le 20 Regioni considerate. Levidenza cos ottenuta rappresentata nella figura seguente. Secondo la metodologia adottata, il contributo comparato di ciascun quadrante al Florens Index complessivo pu essere: - Molto Alto: indice intermedio maggiore di 3,0; - Alto: indice intermedio compreso tra 2,5 e 3,0; - Medio: indice intermedio compreso tra 2,0 e 2,5; - Basso: indice intermedio minore di 2,0.
Figura 12 Quadrante Capitale Culturale e Ambientale: analisi di benchmark nazionale, indicatore di sintesi Fonte: elaborazione The European House-Ambrosetti, 2010
Il Lazio la Regione che presenta il contributo pi significativo del Capitale Culturale e Ambientale al Florens Index (3,01 - un contributo che pu essere definito molto alto). Segue la Toscana, poco distanziata con un valore di 2,83, davanti a Emilia Romagna, Lombardia e Umbria. Queste quattro Regioni mostrano un alto contributo del Capitale Culturale e Ambientale. Pi distanziate risultano il Veneto, il Friuli Venezia Giulia e le Marche. La Regione del Sud Italia che presenta il punteggio pi alto nella dimensione del Capitale Culturale e Ambientale la Campania. Al contrario, Calabria, Valle dAosta e Sardegna sono le regioni che presentano il pi modesto contributo comparato del Capitale Culturale e Ambientale al Florens Index regionale. La Toscana ottiene punteggi molto elevati nellarea del Patrimonio Culturale: oltre ai gi citati siti UNESCO, si segnalano anche la pi alta consistenza di volumi nelle biblioteche e un elevato numero di citt iscritte nella lista dei Borghi pi belli dItalia.
60
3. Il Florens Index: analisi comparativa nazionale
Un connubio ideale tra piccoli centri urbani e patrimonio artistico-culturale
Sono 16 i borghi toscani iscritti nella lista dei Borghi pi belli dItalia, redatta dallomonimo Club costituito nel 2001 su impulso della Consulta del Turismo dellAssociazione dei Comuni Italiani (ANCI) per tutelare i borghi minori italiani dallemarginazione dai flussi turistici e commerciali. Nello specifico, si tratta di: Anghiari, Barga, Buonconvento, Castelfranco di Sopra, Cetona, Coreglia Antelminelli, Giglio Castello, Loro Ciuffenna, Montefioralle, Montescudaio, Pitigliano, Poppi, San Casciano dei Bagni, Scarperia, Sovana e Suvereto. Le altre Regioni italiane con un significativo numero di borghi artistici sono Umbria, Liguria, Abruzzo e Marche. Fonte: ANCI Associazione Borghi pi belli dItalia , 2010
Nel Patrimonio Ambientale toscano spicca la concentrazione di agriturismi, mentre la densit di aziende agricole e il numero di parchi naturali (come gi visto) appaiono inferiori alla media nazionale.
Una rete agrituristica estremamente sviluppata
Il sistema delle aziende agrituristiche rappresenta un patrimonio fondamentale per tutelare le tradizioni culturali e gastronomiche delle aziende agricole del nostro Paese ed in grado di favorire importanti ricadute economiche sul territorio. La Toscana prima in Italia per numero di aziende agrituristiche: se ne contano 456, un numero quasi triplo rispetto a quello vantato dallUmbria (153), in seconda posizione. Fonte: Agriturismo.it, 2010
Per quanto riguarda il sistema di formazione dei saperi culturali, la Toscana pu vantare 4 universit presenti tra le 500 censite nel prestigioso Performance Ranking of Scientific Papers for World Universities e un elevato tasso di laureati. Il numero di studenti iscritti alla formazione universitaria in generale e il numero degli studenti iscritti a scuole di Alta Formazione Artistica e Musicale, in particolare, appaiono invece in linea con i dati nazionali.
Lombardia e Toscana ai vertici della ricerca scientifica del sistema universitario italiano
Le accademie toscane presenti nella classifica elaborata annualmente dal Council of Taiwan per misurare la performance nel campo della ricerca scientifica delle 500 maggiori Universit mondiali in base al numero assoluto di pubblicazioni scientifiche sono quattro: le Universit degli Studi di Firenze, Siena, Pisa e la Scuola Superiore Normale di Pisa. In Italia solo la Lombardia ottiene un risultato migliore, con 5 universit presenti in classifica. Fonte: Higher Education Evaluation & Accreditation Council of Taiwan, 2010
Infine, gli indicatori relativi ai visitatori a mostre ed esposizioni (Visual Arts) e a spettacoli teatrali e concertistici (Performing Arts), cos come i relativi indicatori economici e di volume di affari, mostrano per la Regione Toscana un discreto posizionamento, anche se Regioni come Lombardia, Lazio ed Emilia Romagna ottengono risultati pi soddisfacenti. A tutti gli effetti, quindi, il Capitale Culturale e Ambientale della Regione Toscana rappresenta un notevole giacimento di opportunit nel settore culturale e creativo, in parte gi ben utilizzato, in parte ulteriormente da potenziare. Di seguito riportata una rappresentazione di sintesi dei punteggi attribuiti alla Toscana a seguito del processo di comparazione con le altre Regioni italiane in relazione ai 20 KPI selezionati.
61
Leconomia dei beni culturali e ambientali.
Una visione sistemica e integrata
Figura 13 Contributo comparato del Capitale Culturale e Ambientale al Florens Index calcolato per la Regione Toscana Fonte: elaborazione The European House-Ambrosetti, 2010
3.3. anaLisi comparativa nazionaLe: iL quadrante Media
Il quadrante Media identifica i settori economici che generano output di tipo culturale e caratterizzati da riproducibilit. Il quadrante Media stato suddiviso in quattro principali categorie: - attivit di broadcasting televisivo e radiofonico; - distribuzione cinematografica e musicale; - settore delleditoria e della stampa; - attivit media digitale. Per ciascuna di queste categorie stato identificato un set di indicatori per la misurazione di alcune grandezze ritenute rilevanti per la misurazione della dimensione Media nellambito del settore culturale e creativo. Tali indicatori sono stati utilizzati per il confronto tra le 20 Regioni italiane. In particolare, lanalisi ha esaminato il posizionamento delle 20 Regioni italiane su 12 KPI, relativamente allultimo anno reso disponibile dalle fonti statistiche utilizzate. Gli indicatori presi in considerazione6 e i pesi di ponderazione utilizzati sono indicati nella Tabella 2. Ciascun KPI stato selezionato con lobiettivo specifico di misurare il posizionamento del sistema territoriale di riferimento in relazione ad uno o pi ambiti previsti dallimpianto metodologico utilizzato. In alcuni casi, non essendo possibili rilevazioni puntuali del fenomeno da misurare a causa della scarsa disponibilit di dati e/o a causa della natura del fenomeno stesso, sono state utilizzate approssimazioni (proxy) ad hoc al fine di misurare ugualmente il fenomeno. La tabella che segue sintetizza brevemente, per ciascun indicatore identificato, le motivazioni che hanno portato alla selezione dellindicatore e gli eventuali driver di relativizzazione utilizzati per la misurazione.
La scelta del portafoglio di indicatori e dei relativi pesi di ponderazione risponde sia ad una valutazione dellAdvisory Board che alla effettiva disponibilit di dati completi, omogenei e confrontabili tra le diverse Regioni italiane.
62
3. Il Florens Index: analisi comparativa nazionale
Tabella 2 KPI selezionati per il confronto nazionale nel quadrante Media Fonte: elaborazione The European House-Ambrosetti, 2010
A titolo esemplificativo, di seguito sono riportate le evidenze emerse dallanalisi di alcuni tra i KPI pi significativi che sono stati considerati e che contribuiscono al calcolo del punteggio finale per ciascuna Regione allinterno del perimetro oggetto del confronto nazionale. Attivit di broadcasting televisivo e radiofonico
Figura 14 Quadrante Media: numero di emittenti televisive nazionali e locali basate nella Regione, 2007 Fonte: rielaborazione The European House-Ambrosetti su dati FRT - Federazione Radio Televisioni, 2009
63
Leconomia dei beni culturali e ambientali.
Una visione sistemica e integrata
Nella categoria del quadrante Media dedicata al Broadcasting televisivo e radiofonico il primo indicatore considerato stato il numero di emittenti televisive nazionali e locali. Tale indicatore stato selezionato per misurare lattitudine delle Regioni ad attrarre ed ospitare attivit di broadcasting. In Italia, la Lombardia la Regione che registra la presenza pi elevata di emittenti televisive (se si sommano le emittenti pubbliche e private). La Toscana, con 11 emittenti televisive, rappresenta la quinta Regione italiana per emittenti televisive basate sul territorio; insieme ad Emilia Romagna, Veneto e Lazio, completa il gruppo delle Regioni che in questo indicatore ricevono un punteggio relativo maggiore di 3. A parte il caso della Lombardia, nelle altre Regioni la polarizzazione del fenomeno appare meno evidente del previsto. Un ulteriore indicatore utilizzato nellanalisi, a livello logico simile a quello appena presentato, il Numero di emittenti radiofoniche locali e nazionali basate nella Regione, considerato al fine di ottenere una misura dellattivit di broadcasting radiofonico della Regione. In questo caso per la Toscana sono state rilevate 40 emittenti radiofoniche sul territorio, a fronte delle 96 emittenti localizzate in Lombardia (la Regione che presenta il numero maggiore).
Figura 15 Quadrante Media: numero di emittenti radiofoniche nazionali e locali basate nella Regione, 2007 Fonte: rielaborazione The European House-Ambrosetti su dati FRT - Federazione Radio Televisioni, 2009
Il sistema radio-televisivo lombardo
Tra le regioni italiane, la Lombardia quella che presenta la pi alta concentrazione di sedi di emittenti televisive(*) (21) e radiofoniche (96), sia nazionali che locali. Il primato della Lombardia trainato dal fatto di ospitare sul proprio territorio le sedi delle tre reti del Gruppo Mediaset (Canale 5, Italia 1, Rete 4), quelle del Gruppo Telecom Italia Media (La 7 e MTV Italia), pi quelle di numerose emittenti televisive locali e primarie radio nazionali e locali (quasi tutte le pi importanti in termini di ascolti, fatturati ed occupazione).
(*)
Sono state considerate le emittenti private con un fatturato da pubblicit superiore a 1 milione di Euro. Fonte: dati Audiradio ed FRT Federazione Radio Televisioni, 2009
64
3. Il Florens Index: analisi comparativa nazionale
Distribuzione cinematografica e musicale La seconda categoria che rientra nel quadrante Media riguarda la Distribuzione cinematografica e musicale e il numero di ingressi regionali pro capite a spettacoli cinematografici rappresenta una prima misura del fenomeno della distribuzione cinematografica a livello regionale.
Figura 16 Quadrante Media: ingressi pro capite a spettacoli cinematografici nella Regione, 2008 Fonte: rielaborazione The European House-Ambrosetti su dati SIAE, 2009
Il Lazio la Regione italiana che presenta il maggior La Top 3 degli ingressi ad attivit cinematogranumero di ingressi annui pro capite a spettacoli fiche nel 2008 cinematografici, con una media di 2,8 ingressi per In termini assoluti, gli ingressi ad attivit cinematografiche abitante. Tuttavia, in termini assoluti, la Lombardia in Lombardia (20,3 milioni) hanno generato un volume - come prevedibile - la Regione italiana con pi daffari pari a 172,5 milioni di Euro nel 2008. Il Lazio si ingressi a spettacoli cinematografici, con circa conferma la seconda regione in Italia per numero di in20 milioni di ingressi nel 2008. In questo caso la gressi (15,9 milioni), a fronte di un fatturato di 99,2 milvariabile stata relativizzata rispetto alla popolazione ioni di Euro. Al terzo posto si classifica lEmilia Romagna, regionale, per evitare che le Regioni con un maggior con 11,5 milioni di ingressi ed un volume daffari di 76,7 numero di abitanti fossero avvantaggiate nel milioni di Euro. calcolo dellindicatore (a parit di propensione alla Fonte: dati SIAE, Annuario dello Spettacolo 2009 frequentazione di cinema). La Toscana risulta essere la quarta Regione italiana per ingressi pro capite a spettacoli cinematografici, a pari merito con Valle dAosta, Lombardia e Liguria. Settore dellEditoria e della Stampa LEditoria e la Stampa costituiscono la terza categoria che compone il quadrante Media (seppur non in ordine di importanza). Lanalisi di benchmark a livello nazionale in questambito stata condotta utilizzando 5 KPI (Numero di nuove pubblicazioni librarie, Numero di libri prodotti, Vendite giornaliere medie di quotidiani, Numero di editori di testate giornalistiche, Quota di abitanti che hanno letto almeno un libro negli ultimi 12 mesi).
65
Leconomia dei beni culturali e ambientali.
Una visione sistemica e integrata
Figura 17 Quadrante Media: vendite giornaliere medie di quotidiani nelle Regioni italiane (per 100 abitanti), 2007 Fonte: rielaborazione The European House-Ambrosetti su dati FIEG - Federazione Italiana Editori Giornali, 2010
Come emerge dalla lettura del grafico sopra riportato, la Regione con il maggior numero di vendite pro capite di quotidiani la Liguria, con 15,9 copie di quotidiani vendute mediamente ogni giorno (per 100 abitanti della Regione). La Toscana la sesta Regione italiana davanti a Lazio e Lombardia (la Regione con il maggior numero assoluto di copie di quotidiani vendute, oltre un milione ogni giorno). Per il calcolo dellindicatore appena presentato, anche in questo caso, la variabile stata rapportata alla popolazione regionale al fine di eliminare la distorsione che deriva dalle diverse dimensioni demografiche delle Regioni italiane. La linea indica, nel grafico, i valori assoluti delle vendite di quotidiani nella Regione.
Figura 18 Quadrante Media: quota di abitanti di 6 anni e pi che hanno letto almeno un libro nellarco di 12 mesi nelle Regioni italiane (per 100 abitanti con le medesime caratteristiche), 2009 Fonte: rielaborazione The European House-Ambrosetti su dati ISTAT, 2009
66
3. Il Florens Index: analisi comparativa nazionale
La misurazione dellattivit delleditoria nellanalisi di benchmark nazionale si basata su 3 indicatori: di questi, la quota di abitanti regionali che hanno letto almeno un libro nellarco di 12 mesi, oltre ad incidere in modo significativo nel calcolo dellindicatore finale, rappresenta un utile esempio. Lobiettivo, in questo caso, la misurazione sia dellattitudine della popolazione verso la lettura di libri come fonte di cultura e informazione, sia del dinamismo espresso dal settore delleditoria a livello locale. Se si considera questo indicatore in un confronto con le 20 Regioni italiane, la Toscana occupa la settima posizione a livello nazionale con circa il 50% degli abitanti (dai 6 anni di et in poi) che dichiara di aver letto almeno un libro nellarco di 12 mesi. Tale quota sale a circa il 60% nel caso del Trentino Alto Adige (province autonome di Bolzano e Trento), Regione leader in Italia per questo indicatore.
Gli indicatori della produzione libraria regionale
Il numero di nuove pubblicazioni librarie (titoli) un indicatore della creativit nella produzione libraria, mentre il numero di libri stampati nella regione pu essere interpretato come una proxy della potenza nella riproduzione libraria: in questultima classifica, con 22 milioni di libri pubblicati nella regione, la Toscana terza in Italia alle spalle di Lombardia (124 milioni) e Piemonte (36,6 milioni), a conferma della presenza di numerosi ed importanti operatori del settore editoriale. Fonte: dati ISTAT, 2010
Attivit dei Media digitali Lultima dimensione di analisi allinterno del quadrante Media si riferisce alla categoria dei Media digitali, che intercetta il potenziale in termini di industrie culturali e creative collegato alla diffusione via internet di contenuti culturali. La proxy utilizzata per la misurazione di questo fenomeno la diffusione della connessione a banda larga (condizione necessaria per usufruire delle tecnologie web based di nuova generazione, quale ad esempio il Web 2.0) tra le famiglie residenti nelle Regioni italiane7.
Figura 19 Quadrante Media: famiglie con accesso ad internet a banda larga nelle Regioni italiane (% sul totale delle famiglie nella Regione), 2009 Fonte: rielaborazione The European House-Ambrosetti su dati ISTAT, 2009
Seppure la proxy scelta presenti alcuni limiti, si ritenuto fondamentale includere questo aspetto nellanalisi soprattutto per la sua rilevanza prospettica.
67
Leconomia dei beni culturali e ambientali.
Una visione sistemica e integrata
In Italia la pi alta penetrazione della connessione ad Internet a banda larga si riscontra nel Lazio. La Toscana, insieme a Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Marche, la seconda Regione italiana con il 43% delle famiglie che dispone di una connessione veloce alla rete. La dotazione di infrastrutture digitali appare pi scarsa in alcune Regioni del Sud Italia come Puglia, Basilicata, Calabria e Molise, per le quali la penetrazione della banda larga tra le famiglie inferiore al 30%. Indicatore di sintesi del Quadrante Media Lattribuzione di un punteggio a ciascuna Regione per ognuno dei 12 KPI analizzati e la ponderazione dei risultati ottenuti con i pesi indicati nella Tabella 2 ha permesso di ottenere un indice sintetico intermedio relativo al quadrante Media. Lindicatore cos calcolato rappresenta il contributo comparato dellattivit Media al settore culturale e creativo della Regione, ed rappresentato nella figura seguente8.
Figura 20 Quadrante Media: analisi di benchmark nazionale, indicatore di sintesi Fonte: rielaborazione The European House-Ambrosetti, 2010
Non sorprende che la Lombardia appaia la Regione italiana con la maggiore incidenza della dimensione Media sul settore culturale e creativo. Seguono Lazio, Emilia Romagna, Toscana, Veneto e Piemonte. Le Regioni del Sud mostrano invece maggiore debolezza insieme alla Valle DAosta. Lanalisi comparativa nel quadrante Media ha posto in evidenza per la Toscana alcuni punti di forza e di debolezza. Tra i primi si pu citare in particolare un buon livello di dinamismo (nel confronto con le altre Regioni italiane) espresso dallattivit di distribuzione cinematografica. Tra le debolezze, invece, si segnalano scarse performance regionali nelle attivit di broadcasting televisivo e radiofonico.
Anche in questo caso, secondo la metodologia adottata, il contributo comparato di ciascun quadrante al Florens Index complessivo stato valutato sinteticamente: Molto Alto (indice intermedio maggiore di 3,0), Alto (indice intermedio compreso tra 2,5 e 3,0), Medio (indice intermedio compreso tra 2,0 e 2,5) e Basso (indice intermedio minore di 2,0).
68
3. Il Florens Index: analisi comparativa nazionale
Lelevato valore dellindice sintetico calcolato per la Lombardia deriva da una forte polarizzazione (a livello nazionale) delle attivit legate alleditoria, alla stampa, alla produzione e distribuzione cinematografica e al broadcasting televisivo e radiofonico. Tale tipologia di attivit condotta infatti prevalentemente da grandi societ multinazionali che per motivi diversi (tra cui il profilo socio-economico del territorio, il percorso storico di evoluzione della Regione, lalta concentrazione di attivit finanziaria, ecc.) sono prevalentemente localizzate in Lombardia e Lazio, non a caso le due Regioni che presentano il pi alto indice sintetico relativo al quadrante media. Di seguito riportata una rappresentazione di sintesi dei punteggi attribuiti alla Toscana a seguito del processo di comparazione con le altre Regioni italiane in relazione ai 12 KPI selezionati.
Figura 21 Contributo comparato del Capitale Culturale e Ambientale al Florens Index calcolato per la Regione Toscana Fonte: rielaborazione The European House-Ambrosetti, 2010
3.4. anaLisi comparativa nazionaLe: iL quadrante NetworkiNg
Il quadrante denominato Networking identifica le attivit che generano un output di tipo prevalentemente creativo e non riproducibile per la competitivit dei sistemi territoriali: gli scambi economici e lo sviluppo del capitale umano. Il quadrante Networking stato suddiviso in tre principali categorie: - attivit fieristica; - aggiornamento permanente/lifelong learning; - interconnettivit digitale (Business to Business). Per ciascuna area stato identificato un set di indicatori (KPI) utilizzati per il confronto tra le 20 Regioni italiane. Relativamente a questo quadrante, lanalisi ha preso in considerazione i dati rilevati per le 20 Regioni italiane su 8 KPI, calcolati per lultimo anno disponibile per ciascuna delle fonti statistiche utilizzate. Gli indicatori presi in considerazione e i pesi di ponderazione utilizzati sono indicati nella tabella seguente9.
La scelta del portafoglio di indicatori e dei relativi pesi di ponderazione risponde sia ad una valutazione dellAdvisory Board che alla effettiva disponibilit di dati completi, omogenei e confrontabili tra le diverse Regioni italiane.
69
Leconomia dei beni culturali e ambientali.
Una visione sistemica e integrata
In alcuni casi, non essendo possibili rilevazioni puntuali del fenomeno da misurare a causa della scarsa disponibilit di dati e/o a causa della natura del fenomeno stesso, sono state utilizzate approssimazioni (proxy) ad hoc al fine di misurare ugualmente il fenomeno. La tabella che segue sintetizza brevemente, per ciascun indicatore identificato, le motivazioni che hanno portato alla selezione dellindicatore e gli eventuali driver di relativizzazione utilizzati per la misurazione.
Tabella 3 KPI selezionati per il confronto nazionale nel quadrante Networking Fonte: elaborazione The European House-Ambrosetti, 2010
A titolo esemplificativo, sono riportate di seguito le evidenze emerse dallanalisi di alcuni tra i KPI pi significativi che sono stati misurati e che contribuiscono al calcolo del punteggio finale per ciascuna Regione allinterno del perimetro oggetto del confronto nazionale. Sistema fieristico Il sistema fieristico rappresenta il principale comparto economico riconducibile al quadrante in oggetto. Lanalisi comparativa a livello nazionale sulla dimensione del sistema fieristico stata condotta analizzando 5 KPI, ai quali stato attribuito un peso complessivo pari al 60% nel calcolo dellindicatore sintetico aggregato per il quadrante.
70
3. Il Florens Index: analisi comparativa nazionale
Figura 22 Quadrante Networking: ripartizione regionale del numero complessivo di visitatori nazionali ed internazionali a fiere internazionali, 2008 Fonte: rielaborazione The European House-Ambrosetti su dati AEFIAssociazione Esposizioni e Fiere Italiane, 2009
La spaccatura regionale del numero di visitatori (nazionali ed internazionali) a fiere internazionali mostra una forte incidenza in Italia del sistema fieristico lombardo, che peraltro uno tra i pi sviluppati al mondo (come si vedr pi nel dettaglio in seguito). Questo indicatore rappresenta una misura della capacit del sistema fieristico locale di attrarre visitatori nazionali ed internazionali, i quali possono originare ricadute economiche, sociali e culturali anche molto significative sul territorio di riferimento. La Lombardia quindi la Regione per la quale si rileva il numero medio annuo di visitatori a fiere internazionali pi elevato in Italia. La Toscana si posiziona al sesto posto. Relativamente a questo indicatore sei Regioni italiane presentano un valore nullo: ci avviene poich sul loro territorio non stato rilevato, nellanno di riferimento (2008), alcun evento fieristico di livello internazionale (lente statistico di riferimento a livello nazionale lAssociazione Esposizioni e Fiere Italiane - AEFI, fonte dei dati considerati per il calcolo dellindicatore). Lindicatore complementare al numero dei visitatori alle fiere costituito dal numero di espositori fieristici internazionali nelle fiere che si tengono nella Regione.
71
Leconomia dei beni culturali e ambientali.
Una visione sistemica e integrata
Figura 23 Quadrante: Networking: ripartizione regionale del numero complessivo di espositori fieristici internazionali, 2008 Fonte: rielaborazione The European House-Ambrosetti su dati AEFI - Associazione Esposizioni e Fiere Italiane, 2009
In questo indicatore sono stati considerati i soli espositori internazionali, al fine di privilegiare i sistemi Il Salone Nautico Internazionale di Genova fieristici che dimostrino una maggiore apertura Nellottobre 2010 si tenuta la cinquantesima edizione internazionale. La presenza di espositori internazionali del Salone Nautico Internazionale di Genova, con (che quindi lasciano il proprio territorio per promuovere 260.300 visitatori registrati. i propri prodotti allestero) denota un riconoscimento Pur provenendo da un biennio difficile per il settore a livello internazionale del potenziale di networking nautico, la cinquantesima edizione del Salone ha espresso dal sistema fieristico regionale in esame. confermato i caratteri distintivi dellevento grazie alla Inoltre, lindicatore stato rapportato al numero presentazione dellofferta completa della filiera nautica (italiana ed estera) e alla particolare funzionalit delle complessivo di fiere per eliminare un effetto di strutture espositive a terra e in acqua. polarizzazione verso le Regioni con un numero maggiore di fiere (lindicatore Numero di fiere Con oltre 2.200 giornalisti accreditati (provenienti da 29 tra cui campionarie internazionali stato infatti considerato diversi Paesi,412.000Paesi emergenti come Cina, Corea e India), circa visitatori del sito web ufficiale (3,2 separatamente). milioni di pagine visitate), il Salone si posiziona oggi come La Liguria, con una media di 265 espositori levento annuale di riferimento a livello mondiale per internazionali per fiera, la Regione con il valore pi il settore della nautica. elevato, mentre la Toscana risulta sesta in classifica, con una media di 91 espositori internazionali per fiera. Fonte: Salone Nautico Internazionale di Genova, 2010 In generale, la Lombardia, il Lazio e il Veneto sono le tre Regioni che, nel corso dellanno di riferimento, hanno ospitato il maggior numero, in assoluto, di espositori fieristici internazionali. Interconnettivit digitale Un secondo comparto rilevante e riconducibile al quadrante Networking legato allinterconnettivit digitale e allutilizzo di tecnologie dellinformazione per applicazioni business-to-business o businessto-customer. Per la misurazione dei posizionamenti regionali in questo ambito sono stati considerati due indicatori che sembrano rappresentare una ragionevole approssimazione dellentit che si intende misurare (per sua stessa natura difficile da inquadrare in tutte le sue possibili declinazioni e, di conseguenza,
72
3. Il Florens Index: analisi comparativa nazionale
difficilmente misurabile attraverso parametri diretti). Tali indicatori sono la percentuale di imprese che dispone di un sito Internet e la percentuale di imprese che dispone di una connessione a banda larga.
Figura 24 Quadrante Networking: quota percentuale di imprese che dispongono di un sito web (% del totale delle imprese della Regione, 2008) Fonte: rielaborazione The European House-Ambrosetti su dati ISTAT, 2010
In Toscana circa unimpresa su due risulta disporre di un sito web (per la presentazione dellazienda, per la commercializzazione dei prodotti, per la comunicazione della propria immagine, ecc.); relativamente a questo parametro la Regione risulta essere la settima a livello nazionale. La Regione best performer il Trentino Alto Adige10 (dove quasi il 70% delle imprese dispone di un proprio sito internet), seguito dalla Lombardia (66,2%). Indicatore di sintesi del Quadrante Networking Lattribuzione di un punteggio a ciascuna Regione per ognuno degli 8 KPI analizzati e la ponderazione dei risultati ottenuti con i pesi indicati nella Tabella 3 ha permesso di ottenere un indice sintetico intermedio relativo al quadrante Networking. Levidenza cos ottenuta, che rappresenta il contributo comparato del networking al settore culturale e creativo della Regione, indicata in sintesi nella figura seguente11.
10
11
Il valore registrato per il Trentino Alto Adige potrebbe conseguire da una vasta diffusione di siti sviluppati da imprese nel settore turistico come veicolo di promozione della propria offerta. Il contributo comparato di ciascun quadrante al Florens Index complessivo stato valutato sinteticamente applicando i seguenti giudizi sintetici: Molto Alto (indice intermedio maggiore di 3,0), Alto (indice intermedio compreso tra 2,5 e 3,0), Medio (indice intermedio compreso tra 2,0 e 2,5), Basso (indice intermedio minore di 2,0).
73
Leconomia dei beni culturali e ambientali.
Una visione sistemica e integrata
Figura 25 Quadrante Networking: analisi di benchmark nazionale, indicatore di sintesi Fonte: elaborazione The European House-Ambrosetti, 2010
La Lombardia la Regione italiana che presenta il contributo comparato del quadrante Networking al Florens Index pi alto, seguita dallEmilia Romagna. Al sesto posto si colloca la Toscana, che ottiene un punteggio di poco superiore al Piemonte e al Friuli Venezia Giulia. Calabria, Campania e Molise sono invece le Regioni che mostrano un posizionamento pi debole nel quadrante.
Il sistema fieristico lombardo e lesperienza di Fiera Milano
La capacit espositiva italiana si polarizza in tre regioni principali, che rivestono un ruolo di primo piano anche a livello europeo: insieme alla Lombardia (Milano), lEmilia Romagna (Bologna) e il Veneto (Verona) coprono quasi i due terzi dellofferta totale nazionale. In particolare, il sistema fieristico lombardo non solo spicca a livello nazionale, ma anche uno dei network pi sviluppati a livello internazionale. La Fiera, sorta nel 1906 in occasione dellapertura del Traforo del Sempione per accogliere a Milano lEsposizione Universale, attualmente costituita da due disgiunti poli espositivi: Fieramilanocity, nel comune di Milano, e Fieramilano, in unarea compresa tra i comuni di Rho e Pero, che - inaugurata nel 2005 - ospiter al suo interno e nelle vicinanze lEXPO 2015: oggi il sistema fieristico milanese uno dei pi sviluppati al mondo e si colloca ai primi posti in Europa per estensione: oltre 448.000 metri quadrati di superficie espositiva(*) nei due centri.
(*)
I padiglioni dellarea di Rho-Pero mettono a disposizione 345.000 metri quadrati lordi espositivi coperti e 60.000 allaperto, cui si aggiungono i 43.000 metri quadrati espositivi di Fieramilanocity. Fonte: Fiera Milano, 2010
Per quanto riguarda la Toscana, si segnala unarea di miglioramento per quanto riguarda il sistema fieristico locale, nonostante lesistenza di alcuni casi di particolare interesse e notoriet.
74
3. Il Florens Index: analisi comparativa nazionale
Eventi fieristici di alto livello a Firenze
Il sistema fieristico fiorentino legato soprattutto al settore della Moda. Pitti Immagine infatti organizza alcune tra le manifestazioni di moda pi importanti del mondo: fiere internazionali del tessile-abbigliamento di qualit ed esposizioni, eventi di comunicazione e iniziative culturali e di ricerca riferiti al Sistema Moda e alla Moda come espressione estetica ed evoluzione globale del gusto. il caso di Pitti Immagine Uomo (collezioni moda uomo), Pitti_W Woman Pre-collection (pre-collezioni moda donna), Pitti Immagine Bimbo (collezioni moda 0-14 anni) e Pitti Immagine Filati (collezioni di filati per maglieria). Tutte queste manifestazioni si tengono a Firenze due volte allanno. Nel settore dellenogastronomia, si segnala la fiera Taste: ledizione del 2010 dedicata al gusto e alle eccellenze dellenogastronomia italiana di nicchia ha raggiunto oltre 10.000 presenze. Fonte: Pitti Immagine, 2010
Di seguito riportata una rappresentazione di sintesi dei punteggi attribuiti alla Toscana a seguito del processo di comparazione con le altre Regioni italiane in relazione agli 8 KPI selezionati.
Figura 26 Contributo comparato del Networking al Florens Index calcolato per la Regione Toscana Fonte: rielaborazione The European House-Ambrosetti, 2010
3.5. anaLisi comparativa nazionaLe: iL quadrante sistema creativo
Le attivit culturali che generano un output riproducibile su larga scala e connotato da una natura di tipo prevalentemente creativo sono identificate dal quadrante del Sistema Creativo. Pi in dettaglio, le categorie che compongono il quadrante del Sistema creativo sono: - Ricerca e Sviluppo; - Creazione pubblicitaria; - Design e Architettura; - Moda; - Enogastronomia; - Artigianato artistico. Relativamente a questo quadrante, sono stati considerati 15 KPI, calcolati per lultimo anno disponibile per ciascuna delle fonti statistiche utilizzate. Gli indicatori presi in considerazione e i pesi di ponderazione utilizzati sono indicati nella tabella seguente12.
12
La scelta del portafoglio di indicatori e dei relativi pesi di ponderazione risponde sia ad una valutazione dellAdvisory Board che alla effettiva disponibilit di dati completi, omogenei e confrontabili tra le diverse Regioni italiane.
75
Leconomia dei beni culturali e ambientali.
Una visione sistemica e integrata
76
3. Il Florens Index: analisi comparativa nazionale
Tabella 4 KPI selezionati per il confronto nazionale nel quadrante Sistema Creativo Fonte: elaborazione The European House-Ambrosetti, 2010
Ricerca e Sviluppo Il numero di brevetti registrati allufficio Italiano Brevetti e Marchi nelle 20 Regioni italiane uno degli indicatori che contribuiscono alla determinazione dellindice sintetico di valutazione delle performance regionali nel quadrante Sistema Creativo, come riportato nella figura seguente.
Figura 27 Quadrante Sistema Creativo: numero di brevetti registrati nella Regione ogni 10.000 abitanti, 2009 Fonte: rielaborazione The European House-Ambrosetti su dati UIBM-Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, 2009
Al fine di eliminare uneventuale polarizzazione dellindicatore a vantaggio delle Regioni pi popolose (sulla base dellipotesi che, almeno in parte, la massa demografica di un territorio possa incidere sullintensit creativa e brevettuale), il numero di brevetti registrati nel periodo di riferimento stato rapportato alla popolazione regionale.
77
Leconomia dei beni culturali e ambientali.
Una visione sistemica e integrata
LEmilia Romagna, con una media di 8,7 brevetti ogni 10.000 abitanti depositati allufficio competente presenta lintensit brevettuale pi elevata in Italia, seguita dalla Lombardia (prima Regione italiana se si considera il totale dei brevetti depositati). La Toscana la sesta Regione italiana relativamente a questo indicatore. Le Regioni italiane che mostrano la minore intensit brevettuale sono, nellordine, Valle dAosta, Basilicata e Sardegna. Creazione Pubblicitaria Una seconda categoria di attivit economiche che rientra nel quadrante del Sistema Creativo la creazione pubblicitaria, area che potrebbe essere assunta quasi come simbolo della creativit. Lanalisi di benchmark nazionale relativa allattivit di creazione pubblicitaria stata condotta utilizzando come KPI di riferimento la suddivisione regionale del fatturato generato da tale attivit13.
Figura 28 Quadrante Sistema Creativo: fatturato della ideazione, produzione e distribuzione di campagne pubblicitarie ogni 1.000 Euro di PIL regionale, 2008 Fonte: rielaborazione The European House-Ambrosetti su dati Bureau Van Dijk (database AIDA), 2008
Anche in rapporto al PIL regionale, la Lombardia distanzia in modo netto tutte le altre Regioni italiane. La Lombardia , storicamente, la Regione di riferimento in Italia per lattivit di creazione pubblicitaria, principalmente in conseguenza della presenza sul territorio delle maggiori societ nazionali nel campo delleditoria, della produzione, del broadcasting televisivo, oltre allindotto del Sistema Moda, del settore del design, dellarchitettura, ecc..
La pubblicit italiana
Il sistema italiano della creazione pubblicitaria rappresenta un benchmark di riferimento a livello mondiale. In particolare, il settore pubblicitario italiano ha cominciato ad animarsi a partire dagli anni successivi alla fine della seconda guerra mondiale quando lindustria italiana, trovatasi allalbore di un periodo di florido sviluppo economico, ma dovendo fronteggiare allo stesso tempo una forte arretratezza tecnologica rispetto ai Paesi sviluppati del mondo di allora, scopre la vera funzione della pubblicit. La fusione di tale contingenza con le straordinarie capacit creative e artistiche degli italiani (gi ampiamente dimostrate nel corso della storia) ha consentito al settore di svilupparsi e raggiungere livelli di eccellenza.
13
Secondo la classificazione ATECO 2007, lattivit di creazione pubblicitaria identificata dal codice 74401. La principale fonte di dati finanziari relativi ad industrie classificate secondo codici ATECO il Bureau Van Dijk, origine anche dei dati utilizzati per la costruzione dellindicatore in oggetto.
78
3. Il Florens Index: analisi comparativa nazionale
Design e Architettura Design e architettura sono una ulteriore componente del quadrante del Sistema Creativo, a cui si riferiscono 2 indicatori (KPI): il numero di studenti iscritti alle facolt di architettura nella Regione e il numero di vincitori del premio Compasso dOro nella Regione.
Figura 29 - Quadrante Sistema Creativo: numero di studenti di iscritti alle facolt di architettura nelle universit delle Regioni italiane, a.a. 2008-2009 Fonte: rielaborazione The European House-Ambrosetti su dati MIUR, a.a. 2008-2009
La Toscana la quinta Regione italiana per numero di studenti iscritti alle facolt di Architettura, con una media di 0,7 studenti di architettura ogni 1.000 abitanti. LAbruzzo presenta la densit di studenti di architettura pi elevata in Italia (1,5 studenti iscritti ad architettura ogni 1.000 abitanti), seguito a distanza molto ravvicinata dal Lazio (che presenta un numero assoluto di studenti di architettura significativamente superiore, il pi alto in Italia). Quattro Regioni italiane (Molise, Trentino Alto Adige, Umbria e Valle dAosta) non possiedono facolt di architettura: per questo motivo il valore ad esse associato relativamente a questo indicatore minimo. In termini assoluti, osservando la linea riportata nel grafico precedente, la Regione con il maggior numero di studenti iscritti regolari alle facolt di Architettura il Lazio (circa 7.000 studenti), seguito dalla Lombardia (con circa 4.500 studenti). Moda Il posizionamento regionale nel comparto Moda affidato a due indicatori che misurano, rispettivamente, lentit del Sistema Moda locale in termini di tessuto imprenditoriale (densit di imprese nel Sistema Moda) e la propensione allesportazione del Sistema Moda locale: da un lato, il numero di imprese del Sistema Moda presenti nella Regione e, dallaltro, le esportazioni del Sistema Moda regionale. Si pu osservare che lexport generato dal Sistema Moda toscano incide sul PIL regionale in misura maggiore rispetto a tutte le altre Regioni italiane. Seguono le Marche e il Veneto: anche in questo caso si tratta di Regioni italiane che mostrano una elevata concentrazione di industrie tessili, conciarie, calzaturiere, ecc., riconducibili al Sistema Moda.
79
Leconomia dei beni culturali e ambientali.
Una visione sistemica e integrata
Figura 30 Quadrante Sistema Creativo: esportazioni del Sistema Moda regionale (% del PIL regionale), 2006 Fonte: rielaborazione The European House-Ambrosetti su dati ISTAT, 2009
Il Sistema Moda toscano
Il territorio toscano rappresenta storicamente la piattaforma creativa e produttiva di riferimento per il settore della Moda italiano ed internazionale. La Toscana accoglie infatti esempi di eccellenza pressoch in tutte le filiere principali del Settore Moda, con diverse polarizzazioni distrettuali a livello provinciale. Tra le filiere pi rilevanti che si possono localizzare in Toscana, ciascuna rappresentata da alcuni dei marchi pi noti a livello mondiale, si possono citare: - La filiera tessile; - La filiera dellabbigliamento; - La filiera della concia delle pelli; - La filiera della pelletteria e degli accessori in pelle; - La filiera delle calzature; - La filiera orafa.
Enogastronomia Anche il settore dellenogastronomia toscano rappresenta un sistema di eccellenza a livello italiano e globale. Se si considera il numero di vini DOCG14, DOC15 e SGT16, la Toscana risulta la seconda Regione italiana, preceduta solo dal Piemonte (altra Regione con una tradizione enologica ben radicata e ricca di territori di produzione vinicola).
14 15 16
Denominazione di Origine Controllata e Garantita. Denominazione di Origine Controllata. Specialit Tradizionale Garantita.
80
3. Il Florens Index: analisi comparativa nazionale
Figura 31 Quadrante Sistema Creativo: numero di vini che hanno ottenuto il riconoscimento DOCG, DOC e IGT riconducibili alla Regione, 2008 Fonte: rielaborazione The European House-Ambrosetti su dati Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, 2009
Il settore enogastronomico in Toscana
Il patrimonio enologico toscano, di assoluta eccellenza, costituito per oltre la met da vini di qualit, tra cui i c.d. grandi rossi toscani (volano dellevoluzione dellenologia italiana nel quadro dellenologia internazionale di qualit). Tra questi si ricorda il Chianti (miscela di Sangiovese, Canaiolo e Trebbiano Toscano) nelle versioni classico e gran riserva, il Brunello di Montalcino e altri DOCG di eccellenza come il Vino Nobile di Montepulciano o la Vernaccia di San Gimignano. Negli ultimi anni, oltre alle storiche province a vocazione vinicola, grandi ritmi di crescita si sono registrati nel grossetano col Morellino di Scansano e il Bianco di Pitigliano. Altri DOC deccellenza sono il Candia dei Monti Apuani, il Montecucco e i Montescudaio. Anima della gastronomia toscana sono invece i prodotti tipici e le materie prime, ambito in cui la Toscana ha saputo, nei secoli, proteggere e celebrare la biodiversit. Tra le zone di eccellenza in ambito gastronomico si ricordano, ad esempio: Firenze, i Colli Senesi, i Colli Pisani, la Garfagnana, Colonnata, la Val Tiberina, la Val di Chiana, il Lucchese, la Lunigiana e Livorno.
Artigianato Lartigianato rappresenta un settore creativo per eccellenza e la Toscana occupa notoriamente una posizione di leadership a livello nazionale ed internazionale in questo settore. La misurazione del fenomeno dellartigianato, a livello locale e nazionale, presenta alcune criticit intrinseche dovute al fatto che non esistono statistiche ufficiali a riguardo, n una classificazione univoca ed attendibile delle imprese di tipo artigianale (che ne permetta il riconoscimento e la collazione di dati comparabili a livello territoriale). Infatti, in Italia la classificazione delle imprese artigiane di tipo dimensionale: le imprese sono quindi considerate artigiane sulla base del livello del fatturato e del numero dei dipendenti. Per il calcolo dellindicatore utilizzato per il confronto nazionale relativamente al settore dellartigianato stata adottata quindi la seguente metodologia:
81
Leconomia dei beni culturali e ambientali.
Una visione sistemica e integrata
- A partire dalla bibliografia di riferimento sul tema, sono stati individuati i codici ATECO 200717 relativi a ciascuna categoria produttiva nellambito di cui possono ricadere le imprese di artigianato artistico (ad es. lavorazioni della carta, rilegature e affini, ceramica, porcellane, lavorazione di metalli pregiati, ecc.). - Sono stati estratti dal database AIDA18 tutti i bilanci delle imprese appartenenti alle categorie identificate con fatturato compreso tra 200.000 Euro e 2 milioni di Euro e, per ogni Regione, sono state conteggiate le imprese con tali caratteristiche. Tale metodologia ha consentito, a partire dai dati a disposizione, di ricostruire un indicatore dellattivit artigianale confrontabile tra le diverse Regioni italiane19. Come evidenziato nella figura seguente, la Toscana la seconda Regione italiana per numero di imprese di artigianato artistico, seguita dal Veneto e preceduta dalla Lombardia. Basilicata, Molise e Valle dAosta risultano essere le Regioni con la diffusione pi bassa dellartigianato artistico nel tessuto imprenditoriale locale.
Figura 32 Quadrante Sistema Creativo: ripartizione regionale di un campione di 8.643 imprese italiane di tipo artigianale, 2008 Fonte: rielaborazione The European House-Ambrosetti su dati AIDA, 2009
Indicatore di sintesi del Quadrante Sistema Creativo Lattribuzione di un punteggio a ciascuna Regione per ognuno dei 15 KPI analizzati e la ponderazione dei risultati ottenuti con i pesi indicati nella Tabella 4 ha permesso di ottenere un indice sintetico intermedio relativo al quadrante Sistema Creativo. Levidenza cos ottenuta, che rappresenta il contributo comparato al settore culturale e creativo della Regione, rappresentata nella tabella seguente20.
17
18
19
20
La classificazione delle attivit economiche ATECO una tipologia di classificazione adottata dallIstituto Nazionale di Statistica italiano (ISTAT) per le rilevazioni statistiche nazionali di carattere economico. AIDA il nome del database on-line di propriet del Bureau Van Dijk che include i bilanci di tutte le societ italiane suddivise per codice ATECO 2007. Il conteggio finale potrebbe contenere alcune imperfezioni conseguenti allimpossibile verifica puntuale di tutte le oltre 8.000 imprese che compongono il campione (potrebbero infatti essere comprese alcune imprese industriali con un fatturato compreso nel range stabilito poich prossime al dissesto). Tuttavia questa approssimazione offre un quadro generale sufficientemente affidabile della distribuzione delle imprese artigianali tra le Regioni italiane. Il contributo comparato di ciascun quadrante al Florens Index complessivo stato valutato sinteticamente, anche nel caso del quarto quadrante, applicando i seguenti giudizi sintetici: Molto Alto (indice intermedio maggiore di 3,0), Alto (indice intermedio compreso tra 2,5 e 3,0), Medio (indice intermedio compreso tra 2,0 e 2,5) e Basso (indice intermedio minore di 2,0).
82
3. Il Florens Index: analisi comparativa nazionale
Figura 33 Quadrante Sistema Creativo: analisi di benchmark nazionale, indicatore di sintesi Fonte rielaborazione The European House-Ambrosetti, 2010
Anche nel caso del quadrante Sistema Creativo lanalisi comparativa a livello nazionale ha posto in evidenza alcuni punti di forza ed alcuni punti di debolezza della Toscana. Un settore della Moda molto sviluppato, la forte presenza dellartigianato artistico (legato anche allo stesso Sistema Moda regionale) e lenogastronomia sono tra le caratteristiche che consentono alla Toscana di esprimere un livello di eccellenza in questa dimensione. Artigianato, Enogastronomia e Moda sono stati infatti misurati utilizzando complessivamente 6 KPI e contribuiscono al calcolo dellindicatore di sintesi con un peso relativo pari al 30%. Il Sistema Moda toscano, in particolare, rappresenta forse lasset creativo pi rilevante per la Regione: esso incide per quasi il 10% sul PIL regionale ed costituito da un tessuto produttivo di eccellenza e capillare sul territorio. In tutti i settori manifatturieri, ed in particolare nel settore della Moda, la creativit un processo diffuso e a rete e il processo di innovazione parte spesso dalla rete di fornitura (rappresentata in Toscana da un florido network di laboratori artigianali che in gran parte compongono le filiere produttive di alcuni dei maggiori gruppi internazionali nel settore della Moda e del Lusso). La creativit infatti non delegata solo agli stilisti, e i fornitori contribuiscono in modo sostanziale ad alimentare il sistema creativo regionale. Lultimo indicatore considerato (il numero stimato di imprese dellartigianato artistico), seppur non univocamente collegato al fenomeno Moda, intercetta in larga parte tale categoria di imprese creative legate al Sistema Moda. Tra i punti di debolezza, si segnala la Ricerca e Sviluppo, in termini di occupati e di spesa complessiva a finanziamento di tale attivit, e lintensit brevettuale. Tuttavia, a riguardo necessario ricordare come tali prestazioni siano solo in parte sotto il diretto controllo degli operatori regionali e degli organi istituzionali locali. Il problema dello scarso incentivo alla Ricerca e Sviluppo, la modesta intensit brevettuale, ecc., sono criticit che accomunano generalmente tutte le Regioni italiane e rappresentano un problema nazionale ormai da diversi decenni (questo tema sar approfondito con maggiore dettaglio nel capitolo dedicato allanalisi di benchmark internazionale). Un ultimo punto di attenzione riguarda le attivit di creazione pubblicitaria, anchessa con prestazioni modeste relative al sistema Toscana. Tale evidenza tuttavia conseguente ad una forte polarizzazione dellattivit di creazione pubblicitaria verso la Lombardia, che in questo ambito ha un ruolo egemone a livello nazionale.
83
Leconomia dei beni culturali e ambientali.
Una visione sistemica e integrata
Si riporta, infine, una rappresentazione di sintesi dei punteggi attribuiti alla Toscana a seguito del processo di comparazione con le altre Regioni italiane in relazione ai 15 KPI selezionati.
Figura 34 Contributo comparato del Sistema Creativo al Florens Index calcolato per la Regione Toscana Fonte: rielaborazione The European House-Ambrosetti, 2010
3.6. anaLisi comparativa nazionaLe: iL FloreNs iNdex per Le regioni itaLiane
Per la costruzione del Florens Index sono stati innanzitutto attribuiti dei pesi relativi ai quattro quadranti, come evidenziato nella figura che segue.
Figura 35 I pesi relativi associati a ciascun quadrante della matrice del settore culturale e creativo Fonte: elaborazione The European House-Ambrosetti, 2010
84
3. Il Florens Index: analisi comparativa nazionale
Lindicazione del peso relativo attribuito a ciascun quadrante della matrice del settore culturale e creativo frutto di una approfondita analisi della bibliografia di riferimento, delle indicazioni emerse dallAdvisory Board e delle ipotesi di lavoro formulate dal Gruppo di Lavoro The European House-Ambrosetti. Aggregando i punteggi calcolati per le 20 Regioni italiane nei diversi quadranti, si ottiene, attraverso una semplice media ponderata con i pesi identificati, lindice sintetico di posizionamento nella matrice del settore culturale e creativo denominato Florens Index, rappresentato nella figura seguente.
Figura 36 Analisi comparativa nazionale: il Florens Index per le Regioni italiane Fonte: elaborazione The European House-Ambrosetti, 2010
Nel confronto tra le Regioni italiane nellambito dei settori culturali e creativi, la Toscana risulta essere la quarta Regione in Italia rispetto al dinamismo espresso dal settore culturale e creativo del territorio. Se si considerano i quattro quadranti della matrice del settore culturale e creativo, la principale determinante del posizionamento della Regione risulta il Patrimonio Culturale e Ambientale (a sua volta composto da: Patrimonio Culturale, Beni Ambientali, Sistema di formazione e trasmissione dei saperi artistici e culturali, Visual Arts e Performing Arts).
85
Leconomia dei beni culturali e ambientali.
Una visione sistemica e integrata
Oltre allelevato contributo fornito dal Capitale Culturale e Ambientale, la Toscana pu contare su un buon posizionamento anche nelle dimensioni Media e Sistema Creativo (nellambito del quale compreso il Sistema Moda territoriale, tra i punti di riferimento a livello mondiale per il settore del Fashion & Luxury goods) che contribuiscono positivamente al calcolo del Florens Index per la Regione. Sebbene caratterizzata da una minor dotazione di Capitale Culturale e Ambientale, la Lombardia ottiene un ottimo posizionamento nellindicatore di sintesi del settore culturale e creativo (Florens Index) ed evidenzia una configurazione territoriale capace di fare leva sui settori ad alta creativit (Sistema Creativo), sul quadrante Media e sulla dimensione del Networking (nellambito del quale rappresenta un benchmark di eccellenza a livello internazionale). A conclusione dellesposizione dellanalisi condotta sulle 20 Regioni italiane, di seguito, per una selezione di Regioni (Lombardia, Lazio, Toscana ed Emilia Romagna), riportato un raffronto schematico relativo ai quattro quadranti che compongono il Florens Index (Capitale Culturale e Ambientale, Media, Networking, Industrie Creative). La Lombardia, la Regione italiana che presenta il valore del Florens Index pi elevato, presenta un mix di industrie culturali e creative polarizzato principalmente verso i quadranti Media, Networking e Sistema Creativo mentre gli indicatori relativi al Capitale Culturale e Ambientale non contribuiscono in modo significativo al Florens Index regionale (figura seguente).
Figura 37 Contributo delle quattro dimensioni del settore Culturale e Creativo al Florens Index della Lombardia Fonte: elaborazione The European House-Ambrosetti, 2010
Il Lazio, come si pu vedere nella figura riportata di seguito, ottiene invece punteggi significativamente inferiori alla Lombardia nelle dimensioni Media e Networking compensando tuttavia con la leadership nel quadrante del Capitale Culturale e Ambientale (in relazione al quale il Lazio risulta essere la prima Regione italiana).
86
3. Il Florens Index: analisi comparativa nazionale
Figura 38 Contributo delle quattro dimensioni del settore Culturale e Creativo al Florens Index del Lazio Fonte: elaborazione The European House-Ambrosetti, 2010
A differenza di Lombardia e Lazio, il Florens Index calcolato per la Toscana mostra un sostanziale bilanciamento tra le quattro dimensioni fondamentali considerate, a testimonianza di una situazione di equilibrio tra le diverse componenti dei settori culturali e creativi quali motori di sviluppo del sistema regionale. Pur presentando ottimi livelli di dotazione e performance in tutte le quattro dimensioni, la Toscana conferma una spiccata vocazione per il Patrimonio Culturale e Ambientale.
Figura 39 Contributo delle quattro dimensioni del settore Culturale e Creativo al Florens Index della Toscana Fonte: elaborazione The European House-Ambrosetti, 2010
Infine, lanalisi sul dinamismo espresso dai settori culturali e creativi mostra, per lEmilia Romagna, un ruolo preponderante della dimensione del networking, a testimonianza di un sistema fieristico ben sviluppato ed una ottima dotazione di infrastrutture digitali.
87
Leconomia dei beni culturali e ambientali.
Una visione sistemica e integrata
Figura 40 Contributo delle quattro dimensioni del settore Culturale e Creativo al Florens Index dellEmilia Romagna Fonte: elaborazione The European House-Ambrosetti, 2010
Nel capitolo seguente saranno illustrati i confronti condotti a livello internazionale prendendo in considerazione una selezione di Paesi benchmark. A conclusione del lavoro quantitativo condotto sulle 20 Regioni italiane presentato nei paragrafi precedenti, stata studiata la correlazione tra il Florens Index e il livello di PIL pro capite in ciascuna Regione italiana. Il risultato di tale analisi una correlazione positiva e discretamente significativa (coefficiente di correlazione pari a 0,73), da cui si pu desumere una relazione positiva tra sviluppo del settore culturale e creativo e sviluppo economico. Nella figura seguente sono riportati i risultati di tale analisi.
Figura 41 Risultati dellanalisi della correlazione tra Florens Index e PIL pro capite nelle 20 Regioni italiane Fonte: rielaborazione The European House - Ambrosetti su dati ISTAT, 2010
88
4. Il Florens Index: analisi comparativa internazionale
4. IL FLORENS INDEX: ANALISI COMPARATIVA INTERNAZIONALE 4.1. introduzione
Lo stesso tipo di analisi presentata nel precedente capitolo, costruita sulla base della definizione di settore culturale e creativo descritta nel Capitolo 2, stata realizzata anche per valutare e confrontare il potenziale e il dinamismo espresso dal settore culturale e creativo in Italia e in altri sette Paesi benchmark europei ed extra-europei: Francia, Germania, Regno Unito, Spagna, Grecia, Giappone e Stati Uniti. Si tratta in particolare dei primi Paesi classificati nella World Heritage List dellUNESCO a cui si aggiungono alcuni ulteriori Paesi europei ed internazionali che sono stati ritenuti un importante benchmark di riferimento in tema di economia dei beni culturali. Per questi 8 Paesi la metodologia adottata la medesima utilizzata per il confronto nazionale (si veda il Paragrafo 3.1). In particolare, come nel caso del confronto effettuato tra le 20 Regioni italiane, anche lanalisi di confronto tra sistemi nazionali stata realizzata selezionando per ogni quadrante della matrice del settore culturale e creativo (si veda la Figura 10 del Capitolo 2) un gruppo di indicatori (KPI Key Performance Indicators)1. Anche nel caso del confronto internazionale stato quindi calcolato il Florens Index come indicatore di sintesi finale. Inoltre, in funzione della disponibilit di dati comparabili da fonti aggiornate ed attendibili, il perimetro di analisi, esclusivamente per alcuni indicatori, stato esteso anche alle seguenti nazioni: Cina, Egitto, India, Messico, Russia e Turchia. Per tali Paesi non stato tuttavia possibile calcolare il Florens Index.
4.2. anaLisi comparativa internazionaLe: iL quadrante capitaLe cuLturaLe e ambientaLe
Lanalisi di confronto internazionale sul quadrante Capitale Culturale e Ambientale ha preso in considerazione il posizionamento delle nazioni selezionate su 14 KPI, relativamente allultimo anno reso disponibile dalle fonti statistiche utilizzate. Gli indicatori presi in considerazione2 e i pesi di ponderazione utilizzati sono indicati in Tabella 1.
I KPI utilizzati nellanalisi comparativa internazionale non sono esattamente gli stessi di quella nazionale, per motivi legati allindisponibilit di alcuni di essi su scala internazionale. In tali casi sono stati pertanto selezionati indicatori sostitutivi simili, che misurano le medesime grandezze. La scelta del portafoglio di indicatori e dei relativi pesi di ponderazione risponde sia ad una valutazione dellAdvisory Board che alla effettiva disponibilit di dati completi, omogenei e confrontabili tra i diversi Paesi.
89
Leconomia dei beni culturali e ambientali.
Una visione sistemica e integrata
Tabella 1 KPI selezionati per il confronto internazionale nel quadrante Capitale Culturale e Ambientale Fonte: elaborazione The European House-Ambrosetti, 2010
90
4. Il Florens Index: analisi comparativa internazionale
Nei successivi paragrafi, a titolo esemplificativo, sono riportate le evidenze emerse dallanalisi di alcuni tra i KPI pi significativi che sono stati misurati e che contribuiscono al calcolo del punteggio finale per ciascuna nazione allinterno del perimetro oggetto del confronto internazionale. Patrimonio Culturale Per quanto riguarda la categoria del Patrimonio Culturale, il primo indicatore selezionato per lanalisi stato il numero di siti culturali e naturali iscritti nel Patrimonio dellUmanit dellUNESCO.
Figura 1 Quadrante Capitale Culturale e Ambientale: numero di patrimoni dellUmanit iscritti nella World Heritage List dellUNESCO, 2010 Fonte: rielaborazione The European House-Ambrosetti su dati UNESCO, 2010
LItalia si colloca in prima posizione per numerosit di siti UNESCO (45 siti), seguita a distanza ravvicinata dalla Spagna (42 siti). La prima posizione in classifica consente allItalia di ottenere il punteggio massimo, pari a 5. Alcuni tra i Paesi che non fanno parte del perimetro base di confronto internazionale presentano una dotazione di rilievo di siti censiti dallUNESCO: tra questi spiccano in particolare la Cina (40), il Messico (31), lIndia (28) e la Russia (24). Al contrario, la nazione che tra quelle appartenenti al perimetro di misurazione presenta il minor numero di siti censiti dallUNESCO il Giappone (con un punteggio assegnato in relazione a questo indicatore pari a 1). Solo Turchia ed Egitto (come detto, questi ultimi per non inclusi nel perimetro di assegnazione dei punteggi per il calcolo del Florens Index), possiedono un numero inferiore di siti. Beni Ambientali e Paesaggistici La seconda dimensione identificata per il Capitale Culturale e Ambientale quella relativa ai Beni Ambientali e Paesaggistici. Tale dimensione si riferisce al patrimonio ambientale e paesaggistico dei diversi Paesi. Sono stati considerati due KPI: la superficie complessiva dei parchi naturali nazionali (a cui stato attribuito un peso relativo pari al 10%) e la superficie delle aree di protezione della biosfera di rilevanza internazionale (a cui stato attribuito un peso relativo pari al 5%). La figura seguente illustra il posizionamento dei Paesi analizzati rispetto al primo dei due indicatori.
91
Leconomia dei beni culturali e ambientali.
Una visione sistemica e integrata
Figura 2 Quadrante Capitale Culturale e Ambientale: superficie dei parchi naturali nazionali in % della superficie nazionale, 2010 Fonte: rielaborazione The European House-Ambrosetti su dati Federparchi, 2010
La nazione che occupa la prima posizione relativamente a questo indicatore la Grecia con una superficie dedicata a parchi naturali nazionali pari all11,1% circa della superficie nazionale, per un totale di 11 parchi nazionali. LItalia, sebbene dotata di 24 parchi naturali nazionali, si posiziona in quarta posizione con una superficie dei parchi naturali pari al 5,3% del totale della superficie nazionale. Chiudono questa classifica a pari merito gli Stati Uniti (seppure si tratti della nazione con la maggiore dotazione in termini assoluti) e il Giappone, con il 2,2% della superficie nazionale occupata da parchi. Tra le nazioni non comprese nel perimetro di assegnazione dei punteggi spiccano la Russia per dimensione in termini assoluti e il Messico, che presenta unincidenza della superficie dei parchi naturali pari al 6,8%.
Il Sistema dei Parchi Nazionali degli USA e le riserve delle biosfere in Messico
Gli Stati Uniti sono il Paese con la pi estesa superficie occupata da aree protette. La tutela delle aree protette affidata alla legislazione sia nazionale che federale e, allinterno di ogni Stato, numerose aree sono tutelate a livello locale e regionale. Un ruolo centrale affidato al National Park Service, lagenzia federale dipendente dal Dipartimento dellInterno istituita nel 1916 per promuovere e regolare luso delle aree federali come parchi, monumenti e riserve nazionali: tale organismo responsabile di tre tipi di aree (naturali, storiche e attrezzate), rappresentate da circa 16 categorie appartenenti al Sistema dei Parchi Nazionali, in cui rientrano, ad esempio, parchi nazionali, monumenti nazionali, riserve nazionali, aree attrezzate nazionali, siti storici nazionali, parchi storici nazionali, aree costiere nazionali, ecc.. Delle 319 aree amministrate dal National Park Service, tuttavia, solo una sessantina designata ufficialmente con il nome di Parco Nazionale. Listituzione del Parco Nazionale di Yellowstone nel 1872 ha segnato lavvio del movimento mondiale finalizzato a proteggere queste aree dichiarandole monumenti nazionali. Oggi gli USA possono vantare 11 siti naturali su 21 complessivi inseriti nella lista del Patrimonio dellUmanit: tra i pi noti si possono citare i parchi nazionali delle Great Smoky Mountains (9,5 milioni di visitatori nel 2009), del Grand Canyon (4,3 milioni), di Yosemite (3,7 milioni) e di Yellowstone (3,3 milioni). Nonostante la crisi, nel 2009 il sistema dei parchi americani ha attratto 285 milioni di visitatori: il National Park Service ha rilevato nel 2009 un incremento di 10 milioni di visitatori (+3,6%) rispetto al 2008. Anche una quota rilevante della superficie del Messico, come si visto, occupata da aree naturali protette. Il Paese, che si inserisce tra le nazioni al mondo con il maggior tasso di biodiversit, ospita numerosi parchi naturali, riserve della biosfera (intese come ecosistemi non disturbati dallazione delluomo), aree per la protezione della fauna e della flora, santuari o aree dedicate alla diversit delle specie. In particolare, quattro riserve messicane sono tutelate dallUNESCO: la Riserva della Biosfera del Sian Kaan (un parco marino tra i pi importanti del Paese, con foreste tropicali, lagune, paludi e barriere coralline), il Santuario delle Balene di El Vizcaino (importante sito per la riproduzione di balene, leoni marini ed elefanti marini), le isole e le aree protette del Golfo della California e la Riserva della Biosfera delle Farfalle Monarca (estesa su una superficie di 56.000 ettari e creata per proteggere lhabitat invernale delle farfalle monarca). Fonte: UNESCO World Heritage List, U.S. National Park Service, 2010
92
4. Il Florens Index: analisi comparativa internazionale
Sistema di formazione dei saperi culturali Il sistema formativo generalista e il sistema formativo specifico artistico-culturale, poich generatori di capitale umano (input primario per lo sviluppo del capitale culturale e del capitale creativo), sono stati inclusi come componente determinante del quadrante del capitale culturale. In particolare si sono distinti i percorsi formativi specifici per le Visual e le Performing Arts (misurati dallindicatore Numero medio annuo di laureati in discipline artistiche) dal sistema formativo di terzo livello. Con riferimento al sistema formativo di terzo livello, la figura seguente mostra i risultati per lindicatore relativo al numero di studenti universitari in ciascun Paese.
Figura 3 Quadrante Capitale Culturale e Ambientale: numero di studenti universitari ogni 100 abitanti, 2008 Fonte: rielaborazione The European House-Ambrosetti su dati OECD, 2010
Gli Stati Uniti si posizionano al primo posto nella classifica internazionale, sia in termini assoluti (con circa 18 milioni di studenti universitari), sia in termini relativi (con 5,8 studenti ogni 100 abitanti). LItalia, a pari merito con la Francia, si posiziona in quinta posizione con 3,4 studenti universitari ogni 100 abitanti. Visual Arts A causa della difficolt nel reperimento di dati comparabili relativi a mostre ed esposizioni per il confronto internazionale, la categoria delle Visual Arts stata misurata utilizzando come approssimazione il numero medio mensile di visitatori dei primi 25 musei mondiali (classificati per numero di visitatori). Nella figura seguente inoltre riportata lindicazione del numero medio mensile di visitatori per metro quadrato. Al primo posto della classifica si posiziona la Francia con quasi 16 milioni di visitatori (1,3 milioni al mese), seguita da Regno Unito, Stati Uniti e Italia, che occupa la quarta posizione con 8,8 milioni di visitatori annui. Chiudono questa classifica Germania e Grecia, che presentano un valore nullo (che deriva dal fatto che tali nazioni non posseggono musei annoverati tra i primi 25 al mondo per numero di visitatori).
93
Leconomia dei beni culturali e ambientali.
Una visione sistemica e integrata
Figura 4 Quadrante Capitale Culturale e Ambientale: numero medio mensile di visitatori ai primi 25 musei mondiali 2008 Fonte: rielaborazione The European House-Ambrosetti su dati City Arts, 2010
Performing Arts La dimensione delle Performing Arts stata misurata attraverso due indicatori: il numero di spettacoli teatrali e il numero di spettacoli concertistici. Di seguito riportata levidenza emersa dallanalisi comparativa del numero di spettacoli teatrali tenuti in un anno. Il numero complessivo di spettacoli stato rapportato alla popolazione nazionale. Come si osserva nella figura seguente, il Paese meglio posizionato relativamente a questo indicatore la Francia (a cui sono stati assegnati quindi 5 punti nel calcolo del punteggio finale) con 11,1 spettacoli teatrali ogni 1.000 abitanti. La Spagna si posiziona in ultima posizione tra le nazioni considerate, mentre lItalia si posiziona sesta con 2,6 spettacoli ogni 1.000 abitanti nel periodo di riferimento. In termini assoluti, invece, gli Stati Uniti sono la nazione con il maggior numero annuo di spettacoli teatrali (quasi 1,5 milioni di spettacoli allanno).
94
4. Il Florens Index: analisi comparativa internazionale
Figura 5 Quadrante Capitale Culturale e Ambientale: numero annuo di spettacoli teatrali per 1.000 abitanti, 2007 Fonte: rielaborazione The European House-Ambrosetti su dati Ministre de la Culture et de la Communication/DMTS, SIAE-Societ Italiana degli Autori ed Editori, Sociedad General de Autores y Editores, Statistische mter des Bundes un der Lnder e London Development Agency, 2010
Le principali manifestazioni dedicate alle visual and performing arts in Francia e nel Regno Unito
Tra le principali iniziative dedicate alle visual and performing arts in Francia, oltre allannuale Festival International du Film di Cannes, si possono menzionare anche il Festival de Marseille (manifestazione con spettacoli di danza, teatro, musica e arte, nel mese di luglio), il Festival dAix-en-Provence (festival dellarte lirica con musica classica, opere e balletti, nel mese di luglio), il Festival di Avignone e il Festival della Normandia Impressionista. In particolare, il Forum Internazionale di Avignone riunisce ogni anno nella cittadina provenzale artisti, produttori cinematografici, pubblicitari, partner finanziari e industriali, operatori dei settori Internet & Media e leader politici per discutere in una logica sinergica di Cultura, Economia e Media: la 64 edizione del Festival, tenutasi nel luglio del 2010, stata caratterizzata da 50 spettacoli per un totale di 250 performance dal vivo e vendite di 116.000 biglietti. Il Festival della Normandia Impressionista, la cui prima edizione si tenuta nellestate del 2010, ha previsto iniziative aperte a tutti i visitatori e a tutte le forme despressione artistica, dalla pittura alla fotografia, dalla musica classica alle rievocazioni storiche, per celebrare il movimento artistico che ha reso celebre la Normandia nel mondo. Quanto al Regno Unito, probabilmente la manifestazione pi nota a livello internazionale il Festival di Edimburgo dedicato a performance teatrali, musicali e cinematografiche. Il Festival stato istituito nel 1947 da Rudolf Bing (allepoca General Manager della Glyndebourne Opera), Henry Harvey Wood (allepoca Direttore del British Council scozzese) e da un gruppo di stakeholder della citt di Edimburgo. Lobiettivo dei fondatori era quello arricchire il contesto culturale europeo (nonch britannico) ed offrire una piattaforma per far rinascere lo spirito umano: oggi con 180 eventi e pi di 2.200 performer (nel 2009), lEdinburgh International Festival una rassegna di riferimento per opere teatrali e concerti di musica classica, e si tiene ogni anno da agosto a inizio settembre nella capitale scozzese. Ledizione 2009 ha attratto quasi 400.000 visitatori (il 15 % provenienti da fuori Regno Unito) per incassi al botteghino pari a 2,58 milioni di sterline per gli eventi del Festival. Ad esso si affianca lEdinburgh Festival Fringe dedicato a commedie, musica, danza e teatro, che nel 2009 ha venduto 1,8 milioni di biglietti, a fronte di 34.265 rappresentazioni messe in scena da 2.098 compagnie artistiche provenienti da 60 Paesi. Fonte: Festival dAvignon, Impressionist Normandy Festival, Edinburgh International Festival, 2010
Indicatore di sintesi del Quadrante del Capitale Culturale a Ambientale Lattribuzione di un punteggio a ciascuna nazione per ognuno dei 14 KPI analizzati e la ponderazione dei risultati ottenuti con i pesi indicati nella Tabella 1 ha permesso di ottenere un indice sintetico intermedio relativo al quadrante del Capitale Culturale e Ambientale per gli 8 Paesi considerati.
95
Leconomia dei beni culturali e ambientali.
Una visione sistemica e integrata
Levidenza cos ottenuta rappresentata nella figura seguente.
Figura 6 Quadrante Capitale Culturale e Ambientale: analisi di benchmark internazionale, indicatore di sintesi Fonte: elaborazione The European House-Ambrosetti, 2010
Il primo posto della classifica occupato saldamente dagli Stati Uniti (3,63), seguiti dal Regno Unito (3,38). Pi distanziata, al terzo posto, si colloca la Francia (3,01), con un vantaggio comunque piuttosto netto sui Paesi seguenti.
Il ruolo-chiave delle associazioni culturali e artistiche no-profit negli Stati Uniti dAmerica
Un recente studio svolto sulle associazioni no-profit statunitensi attive nel settore delle arti e della cultura* rivela che tale comparto rappresenta per il Paese un fondamentale driver economico: si tratta di un settore in crescita che garantisce posti di lavoro, genera entrate e contribuisce allincremento dei flussi turistici. Negli USA, ogni anno lindustria artistica e culturale senza fini di lucro genera un giro daffari di 166,2 miliardi dollari: di questi 63,1 miliardi dollari rappresentano la spesa delle organizzazioni e 103,1 miliardi di dollari sono invece legati alla spesa del pubblico in eventi correlati. Inoltre, limpatto dellattivit di queste organizzazioni significativo a livello nazionale, in quanto si attivano: - 5,7 milioni di posti di lavoro equivalenti a tempo pieno; - 104,2 miliardi dollari in reddito familiare; - 7,9 miliardi dollari in entrate fiscali per lAmministrazione locale; - 9,1 miliardi dollari in entrate fiscali per lAmministrazione centrale; - 12,6 miliardi dollari in entrate fiscali a livello federale. * Americans for the Arts, Arts & economic prosperity III: The economic impact of nonprofit arts and culture organizations and their audiences, 2010. Lo studio, il pi ampio mai condotto negli USA, analizza limpatto economico dellindustria artistica e culturale senza fini di lucro in 156 comunit e regioni statunitensi (116 citt e contee, 35 regioni e 5 Stati), coprendo tutti i 50 Stati e il Distretto di Columbia. Fonte: Americans for the Arts, 2010
LItalia occupa il 4 posto, ottenendo un punteggio (2,54) di poco superiore alla Germania e alla Spagna in questo quadrante.
96
4. Il Florens Index: analisi comparativa internazionale
Infine, Grecia e Giappone chiudono la classifica parziale relativa al quadrante del Capitale Culturale e Ambientale. Lanalisi comparativa ha posto in evidenza per lItalia alcuni punti di forza e di debolezza. Tra i primi si possono citare in particolare la presenza di ben 45 patrimoni dellUmanit iscritti nella World Heritage List dellUNESCO (primo Paese al mondo), la discreta incidenza di laureati sulla popolazione e il buon tasso di visitatori nei musei pi importanti a livello internazionale. Tra le debolezze, invece, si segnala lultima posizione tra i Paesi presi in considerazione come numero di visitatori a musei e aree archeologiche (statali), consistenza di volumi nelle biblioteche pubbliche e superficie di aree di protezione della biosfera di rilevanza internazionale. Inoltre, il nostro Paese fa registrare un basso numero di spettacoli teatrali e concertistici in relazione alla popolazione. Di seguito riportata una rappresentazione di sintesi dei punteggi attribuiti allItalia a seguito del processo di comparazione con gli altri Paesi in relazione ai 14 KPI selezionati.
Figura 7 Contributo comparato del quadrante Capitale Culturale e Ambientale al Florens Index calcolato per lItalia Fonte: rielaborazione The European House-Ambrosetti, 2010
Lelevato punteggio degli Stati Uniti frutto invece soprattutto del primo posto ottenuto in indicatori quali la consistenza di volumi nelle biblioteche pubbliche, il numero di ingressi per abitante a musei, monumenti e siti archeologici, il numero di citt presenti tra le World Top Cities to live in for cultural experience, il numero di universit comprese tra le Top 500 mondiali e il numero di studenti universitari iscritti. Gli Stati Uniti appaiono invece pi deboli sotto il profilo del numero di patrimoni dellUmanit censiti nella World Heritage List dellUNESCO, della superficie dei parchi nazionali rispetto alla superficie nazionale e della superficie di aree di protezione della biosfera di rilevanza internazionale. Il Regno Unito, invece, il primo Paese per numero medio di laureati in generale e di laureati in discipline artistiche in particolare. Si trova inoltre al secondo posto, dopo la Francia, per numero di spettacoli concertistici e teatrali per 1.000 abitanti. Tra le debolezze del Regno Unito si segnala invece il basso numero di ingressi per abitante a musei, monumenti e siti archeologici.
97
Leconomia dei beni culturali e ambientali.
Una visione sistemica e integrata
4.3. anaLisi comparativa internazionaLe: iL quadrante Media
Lanalisi di confronto internazionale sul quadrante Media ha preso in considerazione le performance delle nazioni considerate su 9 KPI, relativamente allultimo anno reso disponibile dalle fonti statistiche utilizzate. Gli indicatori presi in considerazione3 e i pesi di ponderazione utilizzati sono indicati in Tabella 2. Ciascun KPI stato selezionato con lobiettivo specifico di misurare il posizionamento del sistema territoriale di riferimento in relazione a una serie di ambiti riferimento individuati. In alcuni casi, non essendo possibili rilevazioni puntuali del fenomeno da misurare a causa della scarsa disponibilit di dati e/o a causa della natura del fenomeno stesso, sono state utilizzate approssimazioni (proxy) ad hoc al fine di misurare ugualmente il fenomeno. La tabella che segue sintetizza brevemente, per ciascun indicatore identificato, le motivazioni che hanno portato alla selezione dellindicatore e gli eventuali driver di relativizzazione utilizzati per la misurazione.
Tabella 2 KPI selezionati per il confronto internazionale nel quadrante Media Fonte: elaborazione The European House-Ambrosetti, 2010
A titolo esemplificativo, di seguito sono riportate le evidenze emerse dallanalisi di alcuni tra i KPI pi significativi che sono stati misurati e che contribuiscono al calcolo del punteggio finale per ciascuna nazione allinterno del perimetro oggetto del confronto internazionale. Attivit di broadcasting televisivo e radiofonico Larea dedicata al broadcasting televisivo e radiofonico stata analizzata considerando il numero di canali televisivi a diffusione nazionale (sono stati esclusi i canali visibili solo a pagamento a causa dellindisponibilit di dati attendibili e comparabili a riguardo). Il Paese meglio posizionato relativamente a questo indicatore la Germania che dispone di 13 canali visibili gratuitamente sul territorio nazionale. LItalia si colloca in terza posizione, mentre Giappone e Regno Unito chiudono la classifica relativa a questo indicatore.
3
La scelta del portafoglio di indicatori e dei relativi pesi di ponderazione risponde sia ad una valutazione dellAdvisory Board che alla effettiva disponibilit di dati completi, omogenei e confrontabili tra i diversi Paesi.
98
4. Il Florens Index: analisi comparativa internazionale
Figura 8 Quadrante Media: numero di canali televisivi a diffusine nazionale, 2008 Fonte: rielaborazione The European House-Ambrosetti su dati Euromonitor, 2009
Distribuzione cinematografica e musicale La seconda categoria che rientra nel quadrante Media riguarda la Distribuzione cinematografica e musicale. Relativamente a questa dimensione, nellanalisi comparativa a livello internazionale sono stati considerati complessivamente quattro indicatori: numero di ingressi a spettacoli cinematografici, numero di premi internazionali per il cinema vinti da film della nazione, numero di presenze nella classifica Top 50 Global Best Selling Album, numero di CD musicali (album e singoli) venduti.
Figura 9 Quadrante Media: numero di ingressi a spettacoli cinematografici ogni 100 abitanti, 2008 Fonte: rielaborazione The European House-Ambrosetti su dati UNESCO Institute for Statistics, 2010
99
Leconomia dei beni culturali e ambientali.
Una visione sistemica e integrata
Considerando lattivit cinematografica, gli Stati Uniti risultano essere il primo Paese per numero di ingressi a spettacoli cinematografici tra le nazioni benchmarck considerate. LItalia si posiziona in sesta posizione con una media di 1,7 ingressi annui. In termini assoluti per lIndia a dominare la classifica con quasi 3 miliardi di ingressi a spettacoli cinematografici nel 2008. Lindicatore Numero di CD musicali venduti ogni 100 abitanti stato preso in considerazione per la misurazione dellattivit di produzione e distribuzione musicale nella nazione, come evidenziato nella figura seguente.
Figura 10 Quadrante Media: numero di CD musicali venduti ogni 100 abitanti, 2008 Fonte: rielaborazione The European House-Ambrosetti su dati IFIP Statistics, 2010
Gli Stati Uniti sono il primo Paese per numero complessivo di CD musicali venduti (circa 328 milioni di dischi). Tuttavia, prendendo in considerazione le vendite in rapporto alla popolazione nazionale, il primo Paese del ranking il Regno Unito. In questo indicatore lItalia appare pi attardata, con soli 28 CD venduti ogni 100 abitanti allanno. Settore dellEditoria e della Stampa Leditoria e la stampa costituiscono la terza area che compone il quadrante Media. Lanalisi di benchmark a livello internazionale in questambito stata condotta analizzando il posizionamento dei Paesi in 3 KPI: numero di nuove pubblicazioni librarie, numero di libri letti mediamente per abitante, numero di quotidiani (copie) prodotti mediamente nel Paese.
100
4. Il Florens Index: analisi comparativa internazionale
Figura 11 Quadrante Media: numero di copie di quotidiani prodotte per abitante, 2008 Fonte: rielaborazione The European House-Ambrosetti su dati Euromonitor, 2010
Se si considera il numero di quotidiani prodotti annualmente per abitante, la nazione leader in relazione a questo indicatore il Giappone, con una media di 56 copie pro capite. LItalia si posiziona in quinta posizione con una media di 10,4 copie pro capite. Per il calcolo dellindicatore presentato, anche in questo caso, la variabile studiata stata rapportata alla popolazione al fine di eliminare la distorsione che potrebbe derivare dalle diverse dimensioni demografiche delle nazioni considerate. Attivit dei Media digitali Lultima dimensione di analisi allinterno del quadrante Media si riferisce alla categoria dei Media digitali, che intercetta il potenziale in termini di industrie culturali e creative collegato alla diffusione via internet di contenuti culturali. La proxy utilizzata per la misurazione di questo fenomeno la diffusione della connessione ad internet a banda larga tra le famiglie residenti nei Paesi considerati.
Figura 12 Quadrante Media: percentuale di famiglie con accesso ad internet a banda larga, 2008 Fonte: rielaborazione The European House-Ambrosetti su dati Eurostat, 2010
101
Leconomia dei beni culturali e ambientali.
Una visione sistemica e integrata
Nel confronto internazionale emerge che la diffusione pi elevata della connessione ad internet a banda larga si riscontra nel Regno Unito. LItalia si posiziona in settima posizione con il 51,7% delle famiglie che dispone di una connessione a banda larga alla rete internet. Indicatore di sintesi del Quadrante Media Lattribuzione di un punteggio a ciascuna nazione per ognuno dei 9 KPI analizzati e la ponderazione dei risultati ottenuti con i pesi indicati nella Tabella 2 ha permesso di ottenere un indice sintetico intermedio relativo al quadrante Media. Il ranking cos ottenuto, che rappresenta il contributo comparato dellattivit Media al settore culturale e creativo del Paese, rappresentato nella figura seguente.
Figura 13 Quadrante Media: analisi di benchmark internazionale, indicatore di sintesi Fonte: rielaborazione The European House-Ambrosetti, 2010
I riconoscimenti internazionali alla produzione cinematografica italiana
Se si sommano il numero di premi Oscar assegnati a film italiani nelle sezioni Miglior Film e Miglior Film straniero, di premi Palma dOro del Festival di Cannes e di premi Orso dOro del Festival Internazionale del Cinema di Berlino (in totale, 28 riconoscimenti tra il 1957 e il 2010), lItalia occupa la seconda posizione dopo gli Stati Uniti, a dimostrazione del fatto che lattivit cinematografica italiana in grado di generare prodotti di eccellenza riconosciuta a livello internazionale.
A livello internazionale, gli Stati Uniti occupano il primo posto nel ranking calcolato come media ponderata del punteggio ottenuto dalle 8 nazioni nei KPI considerati; segue il Regno Unito, in seconda posizione. Le prime due nazioni, che ottengono un punteggio medio superiore a 3 punti, presentano un contributo della dimensione Media al settore culturale e creativo che pu essere considerato molto alto. LItalia si posiziona solo settima, superando unicamente la Grecia nel confronto relativo a questo quadrante. Il posizionamento ottenuto dallItalia nellarea Media deriva principalmente da un basso posizionamento relativo nellattivit di distribuzione cinematografica e musicale e nella dimensione delleditoria e della stampa. A livello internazionale, infatti, il sistema di distribuzione cinematografica e musicale, seppur in grado di generare eccellenza riconosciuta a livello internazionale, risulta sottodimensionato rispetto a molte tra le nazioni considerate nel confronto.
102
4. Il Florens Index: analisi comparativa internazionale
Nonostante il posizionamento nella classifica relativa al quadrante, tra le performance rilevate emerge un punto di forza per lItalia in relazione alla capacit di generare output di eccellenza a livello internazionale nel comparto cinematografico.
Figura 14 Contributo comparato del quadrante Media al Florens Index calcolato per lItalia Fonte: rielaborazione The European House-Ambrosetti, 2010
4.4 anaLisi comparativa internazionaLe: iL quadrante NetworkiNg
Lanalisi di confronto internazionale sul quadrante denominato Networking ha preso in considerazione le performance delle nazioni considerate su 4 KPI, relativamente allultimo anno reso disponibile dalle fonti statistiche utilizzate. Gli indicatori presi in considerazione4 e i pesi di ponderazione utilizzati sono indicati in Tabella 3. Ciascun KPI stato selezionato con lobiettivo specifico di misurare il posizionamento del sistema territoriale di riferimento in relazione ad una serie di ambiti di riferimento individuati. In alcuni casi, non essendo possibili rilevazioni puntuali del fenomeno da misurare a causa della scarsa disponibilit di dati e/o a causa della natura del fenomeno stesso, sono state utilizzate approssimazioni (proxy) ad hoc al fine di misurare ugualmente il fenomeno. La tabella che segue sintetizza brevemente, per ciascun indicatore identificato, le motivazioni che hanno portato alla selezione dellindicatore e gli eventuali driver di relativizzazione utilizzati per la misurazione.
La scelta del portafoglio di indicatori e dei relativi pesi di ponderazione risponde sia ad una valutazione dellAdvisory Board che alla effettiva disponibilit di dati completi, omogenei e confrontabili tra i diversi Paesi.
103
Leconomia dei beni culturali e ambientali.
Una visione sistemica e integrata
Tabella 3 KPI selezionati per il confronto internazionale nel quadrante Networking Fonte: elaborazione The European House-Ambrosetti, 2010 Sistema fieristico Il sistema fieristico rappresenta il principale comparto economico riconducibile al quadrante in oggetto. Lanalisi comparativa a livello internazionale su questa dimensione stata condotta analizzando lunico indicatore che garantiva completezza dei dati per i Paesi selezionati, ovvero la superficie espositiva coperta disponibile.
Figura 15 Quadrante Networking: superficie espositiva fieristica coperta per 100 abitanti (m2), 2008 Fonte: rielaborazione The European House-Ambrosetti su dati su dati UFI The Global Association of the Exhibition Industry, 2010
In termini assoluti sono gli Stati Uniti il Paese con la maggiore dotazione di spazi espositivi coperti. Tuttavia, se lindicatore viene relativizzato attraverso il numero di abitanti per tenere conto della dimensione demografica dei Paesi, la nazione meglio posizionata in questo KPI la Germania, con 4 metri quadrati espostivi ogni 100 abitanti. LItalia si posizione immediatamente dietro la Germania, con 3,8 metri quadrati ogni 100 abitanti; seguono Spagna e Francia con una dotazione leggermente inferiore. La differenza tra la dotazione di questi due Paesi con il Giappone (appena 0,3 metri quadrati per 100 abitanti), che si posiziona allultimo posto, appare invece molto accentuata.
104
4. Il Florens Index: analisi comparativa internazionale
La Fiera dellArte Contemporanea dOCUMENTA a Kassel e la Fiera Internazionale del Libro a Francoforte
La Germania vanta due manifestazioni fieristiche in ambito culturale di assoluto rilievo a livello internazionale. La prima la rassegna dArte Contemporanea dOCUMENTA, fondata nel 1955 dal pittore e curatore tedesco Arnold Bode (1900-1977), che pone per 100 giorni la citt tedesca di Kassel al centro dellinteresse artistico mondiale. Ogni cinque anni, espositori diversi presentano rassegne di arte contemporanea - partendo dal proprio personale punto di vista - e con esse tutte le correnti sociali, le filosofie e le teorie: oggi tale manifestazione rappresenta lesposizione pi importante al mondo di arte contemporanea e moderna. Dalledizione 2007 anche il cinema ha acquisito una dignit pari alle altre forme darte gi presenti, con una sezione apposita. Ledizione 2007 di dOCUMENTA stata visitata da 754.301 persone a fronte di 113 artisti e di 516 opere esposte. La manifestazione fa capo allorganizzazione no-profit dOCUMENTA und Museum Fridericianum Veranstaltungs-GmbH, partecipata e finanziata dalla Citt di Kassel e dallo Stato Federale di Hessen e sostenuta dalla German Federal Cultural Foundation (Kulturstiftung des Bundes). Il costo delledizione 2007 dOCUMENTA 12 stato pari a 26,23 milioni di Euro. La seconda manifestazione fieristica invece legata alleditoria: si tratta della Fiera Internazionale del Libro di Francoforte (meglio nota come Frankfurter Buchmesse), che - dalla sua prima edizione nel 1949 - si affermata negli anni come il pi prestigioso appuntamento internazionale delleditoria. La Fiera si tiene ogni anno nel mese di ottobre e nel 2010 ha contato 300.000 visitatori per circa 7.000 espositori, coinvolto 110 Paesi e realizzato 2.500 manifestazioni. Anche in considerazione della rilevanza di questa fiera internazionale, non stupisce che la Germania sia, tra i Paesi analizzati, in prima posizione per numero medio di libri letti per abitante (4,7 nel 2008). Fonte: dOCUMENTA e Frankfurter Buchmesse, 2010
Lifelong learning Relativamente alle attivit di lifelong learning, la figura successiva mostra il posizionamento dei Paesi considerati in termini di percentuale della popolazione in et da lavoro che frequenta corsi e attivit di aggiornamento.
Figura 16 Quadrante Networking: tasso di partecipazione ad attivit di aggiornamento permanente, 2008 Fonte: rielaborazione The European House-Ambrosetti su dati su dati Eurostat, 2010
In questo indicatore il Regno Unito si posiziona nettamente davanti a tutti gli altri Paesi, con un tasso (20,1%) di persone che partecipano ad attivit di aggiornamento permanente quasi doppio rispetto alla Spagna, che occupa la seconda posizione.
105
Leconomia dei beni culturali e ambientali.
Una visione sistemica e integrata
LItalia, con il 6% di persone in et da lavoro coinvolte in attivit di lifelong learning, appare piuttosto attardata. Purtroppo per questo interessante indicatore, calcolato da Eurostat, non sono disponibili i dati relativi ai Paesi extra-europei, come Stati Uniti e Giappone. Interconnettivit digitale Linterconnettivit digitale rappresenta un altro comparto rilevante riconducibile al quadrante Networking. Per la misurazione del posizionamento dei Paesi in questo ambito stato considerato un indicatore di proxy che sembra rappresentare una ragionevole approssimazione dellentit che si intende misurare: si tratta della percentuale di utenti internet che utilizzano social network.
Figura 17 Quadrante Networking: percentuale di utenti internet che utilizzano social network, 2010 Fonte: rielaborazione The European House-Ambrosetti su dati Nielsen, 2010
Secondo i dati forniti dalla societ Nielsen, il nostro Paese quello meglio posizionato in questo particolare indicatore (il 78% degli utilizzatori di internet utilizza anche uno o pi strumenti di social network) e precede la Spagna (77%) e il Giappone (75%). Gli altri Paesi mostrano comunque percentuali simili, ad eccezione della Germania, che appare pi distanziata (63%). Indicatore di sintesi del Quadrante Networking Lattribuzione di un punteggio a ciascun Paese per ognuno dei 4 KPI analizzati e la ponderazione dei risultati ottenuti con i pesi indicati nella Tabella 3 ha permesso di ottenere un indice sintetico intermedio relativo al quadrante Networking. Levidenza cos ottenuta, che rappresenta il contributo comparato al settore culturale e creativo dei Paesi, indicata in sintesi nella figura seguente.
106
4. Il Florens Index: analisi comparativa internazionale
Figura 18 Quadrante Networking: analisi di benchmark internazionale, indicatore di sintesi Fonte: elaborazione The European House-Ambrosetti, 2010
Gli Stati Uniti sono il Paese che presenta il contributo comparato del quadrante Networking al Florens Index pi elevato (3,95), seguiti dalla Spagna (3,53) e dallItalia (3,49). In questo quadrante i Paesi sembrano essere tutti piuttosto allineati, ad eccezione di Giappone e Grecia, che beneficiano di un contributo al settore culturale e creativo molto pi basso dal quadrante Networking rispetto agli altri Paesi (rispettivamente 1,48 e 1,47). Di seguito riportata una rappresentazione di sintesi dei punteggi attribuiti allItalia in relazione ai 4 KPI selezionati. Appare evidente come i punti di forza dellItalia siano la disponibilit di unottima infrastruttura fieristica e la propensione allutilizzo di strumenti digitali di networking da parte dei cittadini.
Figura 19 Contributo comparato del Networking al Florens Index calcolato per lItalia Fonte: rielaborazione The European House-Ambrosetti, 2010
4.5. anaLisi comparativa internazionaLe: iL quadrante sistema creativo
Lanalisi di confronto internazionale sul quadrante Sistema Creativo ha preso in considerazione il posizionamento delle nazioni considerate su 13 KPI, relativamente allultimo anno reso disponibile dalle fonti statistiche utilizzate. Gli indicatori presi in considerazione5 e i pesi di ponderazione utilizzati sono indicati nella Tabella 4, che sintetizza anche le motivazioni che hanno portato alla selezione dellindicatore e gli eventuali driver di relativizzazione utilizzati per la misurazione.
5
La scelta del portafoglio di indicatori e dei relativi pesi di ponderazione risponde sia ad una valutazione dellAdvisory Board che alla effettiva disponibilit di dati completi, omogenei e confrontabili tra i diversi Paesi.
107
Leconomia dei beni culturali e ambientali.
Una visione sistemica e integrata
Tabella 4 KPI selezionati per il confronto internazionale nel quadrante Sistema Creativo Fonte: elaborazione The European House-Ambrosetti, 2010
108
4. Il Florens Index: analisi comparativa internazionale
In primo luogo stato analizzato lindicatore delle esportazioni nazionali di beni creativi, intesi, secondo la classificazione dellUnited Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), come i prodotti riconducibili allambito dellarchitettura, del design, della moda, del software, ecc.. Questo indicatore permette di misurare indirettamente la qualit e il successo riconosciuto a livello internazionale del Sistema Creativo di un Paese. Per il calcolo del punteggio il valore delle esportazioni stato relativizzato al PIL.
Figura 20 Quadrante Sistema Creativo: esportazioni nazionali di beni creativi in percentuale del PIL, 2005 Fonte: rielaborazione The European House-Ambrosetti su dati UNCTAD, 2008
LItalia risulta essere di gran lunga il maggior esportatore di beni creativi (1,5% del PIL, un valore quasi doppio rispetto a quello di Regno Unito, Germania e Francia), superando, in termini di valore assoluto dellexport, anche un Paese delle dimensioni degli Stati Uniti. Gli USA riescono ad esportare beni creativi per lo 0,2% del proprio Prodotto Interno Lordo, posizionandosi davanti soltanto al Giappone (0,1%) tra i Paesi considerati per lanalisi. Ricerca e Sviluppo Lattivit di Ricerca e Sviluppo una delle componenti principali che attengono alla categoria di attivit culturali e creative intercettate dal quadrante Sistema Creativo. Tuttavia lobiettivo del presente quadrante quello di misurare lattivit di Ricerca e Sviluppo svolta al di fuori delle universit, che fanno invece parte del sistema di generazione e trasmissione dei saperi artistici e culturali, gi misurato nel primo quadrante.
Figura 21 Quadrante Sistema Creativo: spesa nazionale per la Ricerca e Sviluppo in percentuale del PIL, 2008 Fonte: rielaborazione The European House-Ambrosetti su dati Eurostat, 2010
109
Leconomia dei beni culturali e ambientali.
Una visione sistemica e integrata
LItalia, relativamente alla spesa in R&S, presenta una problema di sotto-investimento molto rilevante. Lattivit di Ricerca e Sviluppo infatti una determinate chiave per la generazione di una crescita economica sostenibile, impattando sulla produttivit dei fattori della produzione e sullavanzamento della frontiera tecnologica del Paese; la sua promozione dovrebbe essere considerata pertanto una priorit irrinunciabile nellagenda strategica di ogni Paese. La nazione pi virtuosa tra le 8 oggetto del confronto internazionale il Giappone, con una spesa per il finanziamento di attivit di Ricerca e Sviluppo pari al 3,4% del PIL. Gli Stati Uniti si posizionano in seconda posizione (2,7%), seguiti dalla Germania (2,5%) e dalla Francia (2,0%). Creazione Pubblicitaria Una seconda categoria di attivit economiche che rientra nel quadrante del Sistema Creativo la creazione pubblicitaria. Il livello di dinamismo nellattivit di creazione pubblicitaria stato misurato utilizzando come proxy il numero di brand nazionali annoverati tra i primi 100 brand mondiali6. In questo modo stato possibile effettuare una comparazione a livello internazionale relativa allattitudine delle nazioni a generare eccellenze in campo pubblicitario.
Figura 22 Quadrante Sistema Creativo: numero di brand nazionali tra i primi 100 mondiali per valore, 2009 Fonte: rielaborazione The European House-Ambrosetti su dati Interbrand, 2010
Relativamente a questo indicatore, gli Stati Uniti si posizionano nettamente davanti agli altri Paesi considerati nel confronto internazionale (con uno scarto di 40 brand rispetto alla Germania, che si posiziona in seconda posizione).
In base al valore calcolato da Interbrand, societ internazionale di consulenza specializzata nellanalisi e nella valutazione di brand.
110
4. Il Florens Index: analisi comparativa internazionale
Marchi italiani di successo nel mondo
Nella classifica relativa al numero di brand nazionali tra i primi 100 mondiali per valore, lItalia occupa il quinto posto in classifica, a pari merito con il Regno Unito. I marchi italiani presenti in lista sono 4, di cui 3 legati al mondo della Moda: Gucci (al 41 posto), Prada (91 posto), Ferrari (93 posto) e Giorgio Armani (94 posto). Il primo brand a livello globale invece Coca Cola, con un valore stimato pari a quasi 60 miliardi di Euro. Fonte: Interbrand, 2010
Design e Architettura Design e Architettura rappresentano il terzo ambito di analisi allinterno del quadrante del Sistema Creativo e sono stati misurati attraverso due indicatori: il numero medio annuo di laureati in architettura ed il numero di vincitori del Prizker Architecture Prize (uno dei principali riconoscimenti a livello internazionale nel settore).
Figura 23 Quadrante Sistema Creativo: numero medio annuo di laureati in architettura ogni 10.000 abitanti, triennio 2006-2008 Fonte: rielaborazione The European House-Ambrosetti su dati OECD, 2010
Non essendo disponibili dati attendibili e confrontabili relativi alla concentrazione di architetti, stato preso in considerazione il numero medio di laureati nellarco di un triennio nelle facolt di architettura di ciascun Paese. Lindicatore stato relativizzato rapportando il numero medio di laureati in architettura alla popolazione nazionale. Relativamente a questo indicatore, lItalia si posiziona in prima posizione con una media annua di 3 nuovi laureati in architettura ogni 10.000 abitanti, seguita a breve distanza dal Regno Unito, mentre le altre nazioni considerate mostrano un distacco significativo dalla testa della classifica, che vede nelle ultime due posizioni rispettivamente Giappone e Stati Uniti.
111
Leconomia dei beni culturali e ambientali.
Una visione sistemica e integrata
Il Nobel dellArchitettura: il Pritzker Architecture Prize
Nel campione analizzato, i due Paesi che si contendono il primato in relazione al numero di vittorie del Premio Pritzker istituito dalla Fondazione Hyatt, sono Giappone e Stati Uniti, entrambi con 6 riconoscimenti ricevuti nel periodo 1979-2010. LItalia si posiziona al quarto posto, alle spalle del Regno Unito e a pari merito con la Francia: i due architetti italiani cui stato attribuito questo prestigioso premio sono Aldo Rossi (nel 1990) e Renzo Piano (nel 1998). Fonte: Pritzker Architecture Prize - Hyatt Foundation, 2010
Moda Il sistema moda nazionale rappresenta un ulteriore motore del settore culturale e creativo che viene intercettato dal quarto quadrante della matrice. Il dinamismo e la dotazione del sistema moda stato misurato attraverso tre indicatori ed incide per il 20% nella media ponderata attraverso cui calcolato lindicatore finale di sintesi. I KPI selezionati per il confronto internazionale sono il numero di marchi presenti tra i primi brand globali nel settore del lusso, il numero di vincitori del Fashion International Award e il livello di esportazioni generate dal Sistema Moda nazionale.
Figura 24 Quadrante Sistema Creativo: esportazioni nette del sistema moda nazionale, 2008 Fonte: rielaborazione The European House-Ambrosetti su dati UNCTAD, 2010
A livello internazionale, il Sistema Moda dellItalia genera annualmente lexport netto pi elevato tra i Paesi considerati nellanalisi, sia in termini assoluti che in percentuale del PIL nazionale. Tale risultato consente allItalia di ottenere il massimo del punteggio relativamente a questo indicatore (5 punti). La seconda posizione occupata dalla Francia, mentre le altre nazioni scontano un distacco considerevole rispetto alle due nazioni di testa. La Grecia chiude la classifica se si considerano i valori assoluti dellexport, mentre sono gli Stati Uniti la nazione che mostra il risultato pi basso se lexport netto viene rapportato al Pil nazionale. Enogastronomia La gastronomia nazionale italiana, misurata considerando il numero di ristoranti riconosciuti tra i primi 100 migliori al mondo, genera un livello di eccellenza che vale al Paese la quarta posizione nella classifica tra gli otto Paesi considerati.
112
4. Il Florens Index: analisi comparativa internazionale
Figura 25 Quadrante Sistema Creativo: numero di ristoranti tra i primi 100 nella classifica The San Pellegrino Worlds Best Restaurants, 2010 Fonte: rielaborazione The European House-Ambrosetti su dati The San Pellegrino World s best Restaurants, 2010
Sempre in ambito enogastronomico, lItalia mostra un buon posizionamento nella classifica internazionale delle prime 100 etichette di vino per qualit, dove si posiziona seconda dopo gli Stati Uniti (29 etichette) con 19 etichette. Artigianato Come gi nellanalisi di benchmark nazionale, anche nel confronto internazionale relativo al quadrante del Sistema Creativo stato considerato lartigianato. Data la difficolt nel reperimento di dati per la misurazione di questo aspetto (gi verificata anche a livello di analisi tra le Regioni italiane), per la misurazione dellartigianato nel confronto internazionale si scelto di utilizzare il numero di vincitori del premio per lartigianato assegnato dal WCC-World Craft Council: si tratta di un premio che ogni anno viene assegnato su incarico dellUnione Europea al miglior prodotto di artigianato realizzato durante lanno. I criteri sulla base di cui viene assegnato il premio sono loriginalit, leffettivo contenuto artigianale della lavorazione e la scelta del materiale adeguato per la realizzazione delloggetto. Relativamente a questo indicatore, lItalia si posiziona in quarta posizione che corrisponde ad un punteggio pari a 2, avendo ottenuto un solo premio dal 1993 (anno di istituzione del premio) ad oggi.
113
Leconomia dei beni culturali e ambientali.
Una visione sistemica e integrata
Figura 26 Quadrante Sistema Creativo: numero di vincitori del premio WCC-World Craft Award, 1993-2009 Fonte: rielaborazione The European House-Ambrosetti su dati WCC-Europe Award, 2010
Indicatore di sintesi del Quadrante Sistema Creativo Lattribuzione di un punteggio a ciascun Paese per ognuno dei 13 KPI analizzati e la ponderazione dei risultati ottenuti con i pesi indicati nella Tabella 4 ha permesso di ottenere un indice sintetico intermedio relativo al quadrante Sistema Creativo. Levidenza cos ottenuta, che rappresenta il contributo comparato al settore culturale e creativo della nazione, rappresentata di seguito:
Figura 27 Quadrante Sistema Creativo: analisi di benchmark internazionale, indicatore di sintesi Fonte rielaborazione The European House-Ambrosetti, 2010
Stati Uniti, Italia e Francia presentano posizionamenti analoghi in questo quadrante, con un contributo molto alto al Florens Index complessivo. Pi deboli Spagna e Grecia.
114
4. Il Florens Index: analisi comparativa internazionale
Anche nel caso del quadrante Sistema Creativo lanalisi comparativa a livello internazionale ha posto in evidenza alcuni punti di forza ed alcuni punti di debolezza del nostro Paese. La leadership assoluta nellesportazione di beni creativi, un Sistema Moda di eccellenza mondiale e la qualit del capitale umano nellambito del design e dellarchitettura rappresentano i maggiori punti di forza del Sistema Creativo italiano, che fornisce un contributo molto alto al posizionamento del nostro Paese allinterno del Florens Index. Tra i punti di debolezza dellItalia in questo quadrante si segnalano invece: i bassi investimenti in Ricerca e Sviluppo, la scarsa occupazione in settori high tech e la bassa propensione allinnovazione (misurata come numero di brevetti depositati). Si riporta di seguito una rappresentazione di sintesi dei punteggi attribuiti allItalia a seguito del processo di comparazione con gli altri sette Paesi.
Figura 28 Contributo comparato del quadrante Sistema Creativo al Florens Index calcolato per lItalia Fonte: rielaborazione The European House-Ambrosetti, 2010
4.6. anaLisi comparativa internazionaLe: iL FloreNs iNdex per i paesi seLezionati
Come nel caso dellanalisi comparativa nazionale (si veda il Paragrafo 3.6.), dopo lanalisi di posizionamento dei Paesi nei quattro quadranti della matrice del settore culturale e creativo, stato costruito il Florens Index per il confronto finale a livello internazionale. Per la costruzione dellindicatore di sintesi sono stati innanzitutto attribuiti dei pesi relativi ai quattro quadranti, come evidenziato nella figura seguente.
115
Leconomia dei beni culturali e ambientali.
Una visione sistemica e integrata
Figura 29 I pesi relativi associati a ciascun quadrante della matrice del settore culturale e creativo Fonte: elaborazione The European House-Ambrosetti, 2010
Aggregando i punteggi calcolati per gli otto Paesi nei diversi quadranti, si ottiene, attraverso una semplice media ponderata con i pesi identificati, lindice sintetico di posizionamento nella matrice del settore culturale e creativo denominato Florens Index.
116
4. Il Florens Index: analisi comparativa internazionale
Figura 30 Analisi comparativa internazionale: il Florens Index per i Paesi selezionati Fonte: elaborazione The European House-Ambrosetti, 2010
Sono gli Stati Uniti il Paese che ottiene la prima posizione nel Florens Index (3,45), grazie al posizionamento di vertice ottenuto in tutti e quattro i quadranti che compongono la matrice del capitale culturale e creativo. Seguono, piuttosto distanziati, il Regno Unito (3,10) e la Francia (2,91). Nel confronto tra gli 8 Paesi selezionati, lItalia si posiziona al quarto posto in termini di potenziale e dinamismo espresso dal settore culturale e creativo, con un punteggio finale di 2,62. Se si considerano i quattro quadranti della matrice del settore culturale e creativo, il maggior contributo al posizionamento dellItalia dato dal quadrante Sistema Creativo - nel quale il nostro Paese si posiziona al secondo posto, dietro gli Stati Uniti, potendo contare su numerosi elementi di eccellenza in diversi ambiti (moda, design, architettura, artigianato, ecc.) - e dal quadrante Networking (3 posto). Per quanto riguarda invece il quadrante del Capitale Culturale e Ambientale, il risultato ottenuto dal nostro Paese (4 Paese tra gli 8 analizzati) frutto della media tra uneccellente dotazione di patrimoni (ad esempio la maggior dotazione di siti Unesco tra gli 8 Paesi analizzati), e una performance non in linea con altri Paesi (in particolare Stati Uniti, Regno Unito e Francia) in termini di capacit di valorizzare tali asset (ad esempio, in termini di visitatori a musei ed aree archeologiche). Si tratta di unarea in cui il potenziale non sfruttato del nostro Paese notevole.
117
Leconomia dei beni culturali e ambientali.
Una visione sistemica e integrata
Infine, il settore dei Media quello sul quale il nostro Paese sembra far leva in misura minore, posizionandosi al settimo posto, davanti soltanto alla Grecia.
Figura 31 Contributo delle quattro dimensioni del settore Culturale e Creativo al Florens Index dellItalia Fonte: elaborazione The European House-Ambrosetti, 2010
Alle spalle dellItalia si posiziona la Germania, con un punteggio molto vicino (2,56), mentre appaiono pi distanziati Spagna (2,28) e Giappone (2,20). Infine, il Paese che fa registrare il pi basso livello di potenziale e dinamismo del settore culturale e creativo tra quelli analizzati la Grecia (1,62). Come evidenziato al termine dellanalisi realizzata a livello di Regioni italiane, anche con riferimento alla comparazione internazionale possibile rilevare una correlazione positiva discretamente significativa (coefficiente di correlazione pari a 0,75) tra PIL pro capite nazionale e punteggio ottenuto nel Florens Index, da cui si pu desumere una relazione positiva tra sviluppo del settore culturale e creativo e sviluppo economico.
Figura 32 Risultati dellanalisi della correlazione tra Florens Index e PIL pro capite degli 8 Paesi analizzati Fonte: rielaborazione The European House-Ambrosetti su dati Eurostat, 2010
118
5. La stima dellimpatto diretto, indiretto e indotto del settore culturale e creativo in Italia
5.
LA STIMA DELLIMPATTO DIRETTO, INDIRETTO E INDOTTO DEL SETTORE CULTURALE E CREATIVO IN ITALIA
5.1. metodoLogie di stima degLi impatti economici
Per comprendere meglio le potenzialit e limportanza attuale per lItalia del settore culturale e creativo, data anche la carenza di dati disponibili di dettaglio, stata realizzata unanalisi di sistema attraverso le matrici input-output. In letteratura e a livello empirico esistono differenti metodologie e tecniche per stimare gli impatti prodotti da eventi o manifestazioni culturali. In generale tali metodologie e tecniche di stima possono essere racchiuse in due grandi gruppi. Il primo stima le variazioni (impatti) apportate da una qualche azione, che in questo caso pu essere la presenza di un festival, un evento, una mostra, una rassegna musicale e la ristrutturazione di un quartiere, sullattivit economica di un territorio circoscritto. Il territorio (urbano, provinciale e regionale) circoscritto per identificare quale spesa e quale attivit economica includere nella stima. Come facilmente intuibile, pi il territorio circoscritto, pi facile calcolare limpatto di un evento poich le variazioni sono misurate registrando i mutamenti che avvengono nella spesa, nei redditi, nelle presenze turistiche e nelloccupazione. Tale stima pu essere implementata sia con rilevazioni empiriche ad hoc su un campione di attivit economiche, per poi inferire limpatto totale, sia attraverso indagini e interviste agli operatori del territorio. Alcuni recenti studi effettuati in accordo a tale metodologia hanno evidenziato risultati talvolta molto variabili con moltiplicatori sulleconomia espressi in termini di fatturati e/o spese per consumi rispetto alla spesa diretta per lorganizzazione dellevento che oscillano tra: - 4 volte per il Festival dellEconomia a Trento; - 3 volte per le Mostre a Brescia e Como1; - 7 volte per il Festival della Letteratura a Mantova. A titolo esemplificativo, nel Regno Unito lo studio effettuato con riferimento al Festival di Edimburgo ha mostrato come questultimo generi effetti di moltiplicazione indiretta e indotta della spesa per il festival compresi tra 1,39 per il settore trasporti e 1,7 per il settore cibo e bevande rispetto alla spesa diretta. Cio, per ogni Euro di spesa diretta si generano 1,39 Euro di spesa nei trasporti e 1,7 Euro di spesa nel settore cibo e bevande. Limpatto economico cos calcolato presenta tuttavia alcuni limiti metodologici. I motivi vanno ricercati nella variabilit delle metodologie adottate, nelle rilevazioni spesso soggettive e nella mancanza di una accettazione comune su quali siano gli effetti da considerare in una analisi di impatto di questo tipo. In aggiunta a ci, spesso si verificano casi di confusione degli impatti di breve, medio e lungo periodo e le valutazioni risultano spesso fatte una tantum e non in modo continuativo. Con lobiettivo di inquadrare il settore culturale a livello complessivo, ovvero su un orizzonte temporale di medio-lungo periodo, a livello di Sistema Paese, per comprenderne limportanza su un territorio pi ampio e non limitato alla dimensione locale, e analizzando i legami economici con tutti gli altri settori senza trascurarne alcuno (come invece pu capitare negli studi riportati in precedenza), abbiamo utilizzato la metodologia di stima degli impatti diretti, indiretti e indotti, al settore culturale e creativo, che utilizza le matrici delle interdipendenze settoriali, teorizzata e utilizzata da Wassily Leontief, economista russo insignito del Premio Nobel per lEconomia nel 1973.
Fonte: G. Guerzoni, Effetto Festival, Ed. Fondazioni Eventi, 2008.
119
Leconomia dei beni culturali e ambientali.
Una visione sistemica e integrata
Leontief elabor per primo gli schemi contabili e analitici che costituiscono gli elementi della moderna analisi input-output, conosciuta anche come analisi delle matrici delle interdipendenze settoriali, denominate anche matrici intersettoriali/matrici interindustriali. Analizzando la struttura delleconomia americana, nel periodo compreso tra il 1919 e il 1929, Leontief costru delle tavole per descrivere in modo numerico le relazioni che intercorrevano nel sistema economico tra produttori e consumatori: il lavoro port alla definizione di due tavole delle transazioni composte da 10 settori produttivi, quelli che allora caratterizzavano leconomia statunitense. Da allora, lelaborazione statistica dei flussi intersettoriali diventata materia di approfondimento a livello internazionale. Con riferimento allItalia, la prima tavola input-output venne costruita nel 1950 dalla Mutual Security Agency2 e successivamente venne rielaborata ed aggiornata dallISCO nel 19533. Dal 1959 ad oggi lIstituto Italiano di Statistica ha lavorato su questo tema pubblicando aggiornamenti continui delle tavole inputoutput e approfondendo lanalisi fino ad evidenziare le transazioni economiche suddivise per 77 settori produttivi. Inoltre, dal 1970, con lelaborazione del Sistema Europeo dei Conti Regionali - SEC4, la tavola delle transazioni entrata a far parte integrante della contabilit nazionale per tutti i Paesi dellUnione Europea. Col passare degli anni la sua struttura teorica stata raffinata e la sua applicazione pratica si estesa. Oggi utilizzata ampiamente nelle applicazioni di politiche economiche e sociali e in un numero vasto di campi compresi quelli della contabilit nazionale, delleconomia regionale, delleconomia ambientale, del commercio e dei trasporti, nello studio dei cambiamenti tecnologici, delloccupazione e della crescita dello sviluppo economico.
5.2. struttura e obiettivi deLLanaLisi deLLe interdipendenze settoriaLi
Linterdipendenza strutturale di un sistema economico pu essere rilevata e valutata per mezzo di una particolare tecnica dindagine economica, cio lanalisi delle matrici delle interdipendenze setto- La logica sottostante la matrice input-output riali o analisi input-output. Input-output matrix is constructed Nelle applicazioni pi recenti, limplementazione di analisi input- on the simple idea that goods and output ha lobiettivo di misurare limpatto di una variazione di do- services produced by economic secmanda in qualunque settore/branca di attivit sullintero sistema tors should be registered in a table economico. simultaneously by origin and by desPi in dettaglio, in un arco di tempo definito, tra le diverse unit in tination cui articolata leconomia, si svolge un complesso di transazioni che Fonte: OECD, 2006 determinato dalle esigenze di impiego finale e dalle caratteristiche tecnologiche del sistema economico stesso. Una schematizzazione delle relazioni che intercorrono tra i differenti settori economici rappresentata nella Figura 1. Nella situazione di partenza (tempo zero) si analizzano le relazioni o interdipendenze (fisiche o monetarie) che intercorrono tra i differenti settori economici, che assorbono risorse per produrre beni e servizi.
3 4
Agenzia creata il 31 ottobre del 1951 per rendere concreto il Mutual Security Act, cio la legge americana che rendeva concreta lattivazione del Piano Marshall. International Standard Classification of Occupations (ISCO). Eurostat, European system of accounts ESA, 1995.
120
5. La stima dellimpatto diretto, indiretto e indotto del settore culturale e creativo in Italia
Figura 1 Schema sintetico di riferimento per le relazioni economiche analizzate da Leontief: situazione iniziale Fonte: elaborazione The European House-Ambrosetti, 2010
Dopo un periodo (tempo 1) lespansione di unindustria o di un settore attiva una serie di relazioni allinterno del sistema economico che, a loro volta, attiveranno altre relazioni con altri settori industriali, in accordo con lo schema delle interdipendenze settoriali (Figura 2). Ad esempio, laumento esogeno della domanda di un dato settore economico produrr una serie di effetti, evidenziati in figura dalla linea rossa, tra cui: - laumento dellofferta di lavoro per il funzionamento del settore stesso; - laumento complessivo degli stipendi e dei salari pagati nel settore; - laumento di beni e servizi richiesti per il funzionamento del settore in espansione.
Figura 2 Schema sintetico di riferimento per le relazioni economiche analizzate da Leontief: espansione in una industria/settore economico Fonte: elaborazione The European House-Ambrosetti, 2010
121
Leconomia dei beni culturali e ambientali.
Una visione sistemica e integrata
Per il primo intervallo di tempo gli effetti saranno circoscritti al medesimo settore in cui si verifica leffetto. Negli intervalli di tempo successivi, per leffetto delle interdipendenze settoriali, altri settori economici saranno coinvolti e anche per questo si registrano incrementi nellofferta di lavoro, negli stipendi e salari e nella domanda di beni e servizi richiesti per il funzionamento dei settori (Figura 3), producendo unespansione a livello di sistema.
Figura 3 Schema sintetico di riferimento per le relazioni economiche analizzate da Leontief: attivazione completa del sistema economico Fonte: elaborazione The European House-Ambrosetti, 2010
La traduzione algebrica di tale schema di riferimento porta alla costruzione delle matrici delle interdipendenze settoriali o matrici input-output. Il sistema input-output , quindi, costruito analizzando statisticamente le interazioni tra i settori industriali di una nazione. Le matrici input-output offrono una rappresentazione statistica delle relazioni interne, determinate dalla produzione e dalla circolazione (acquisti e vendite) dei beni tra i vari settori in cui si articola un sistema economico, e dalle relazioni esterne, ossia importazioni ed esportazioni. Lelemento centrale dellanalisi input-output costituito dalla tavola intersettoriale dei flussi tra settori economici. Leconomia nazionale immaginata come un insieme di unit produttive, ciascuna delle quali realizza un duplice ordine di transazioni: - da un lato come acquirente, dalle altre unit, di beni e servizi che impiega come input nella propria attivit produttiva; - dallaltro come venditore del suo prodotto, ad altri settori economici. In altri termini, ogni impresa operante in un settore produttivo produce un output acquistando e combinando insieme alcuni input provenienti da altre industrie/settori produttivi. possibile esprimere i flussi intersettoriali sia in termini monetari, sia in termini fisici. Il sistema economico , quindi, attraversato da flussi che collegano le diverse unit produttive. Si pu cos costruire una tavola (matrice) a doppia entrata, sia per flussi monetari che fisici, dove per riga figurano le unit produttive in qualit di venditori (output) e per colonna le stesse unit figurano in qualit di acquirenti (input). Per i dettagli si rinvia alla nota metodologica in appendice. Nel box successivo, invece, si illustra con alcuni esempi il meccanismo di attivazione dei consumi interni ad un determinato settore necessari a sostenere un aumento della produzione nel settore stesso.
122
5. La stima dellimpatto diretto, indiretto e indotto del settore culturale e creativo in Italia
Esempio di consumi e utilizzi interni ai settori Settore energetico
Si ipotizzi che la domanda di petrolio aumenti di 1 milione di barili. Quanto petrolio si deve produrre per soddisfare la domanda? Per aumentare la produzione di petrolio e soddisfare cos laumento della domanda necessario, ad esempio, potenziare o utilizzare maggiormente le pompe di estrazione, il sistema di trasporto del greggio alle raffinerie, le raffinerie, ecc.. Tuttavia, il potenziamento anche di uno solo di questi elementi comporta un utilizzo maggiore di petrolio sotto forma di consumo interno allo stesso settore. Le pompe di estrazione sono alimentate da energia prodotta dal petrolio, i trasporti si basano su carburanti derivati dal petrolio e le raffinerie funzionano bruciando petrolio. Se si vuole produrre 1 milione di barili di petrolio in pi quindi necessario produrre pi di 1 milione di barili e la differenza serve per il consumo interno al settore stesso. Tale relazione vale in tutti i settori economici.
Settore culturale
Con riferimento al settore culturale un semplice esempio legato alla realizzazione di un nuovo teatro o museo. Con riferimento al teatro, la realizzazione di nuove attivit teatrali richiede, ad esempio, il potenziamento di personale operativo addetto alle rappresentazioni, di attori, registi, direttori artistici, direttori di sala, direttori di scena, coreografi, scenografi, coristi, costumisti, tecnici di luci, attrezzisti, drammaturghi, sarti e macchinisti. Con riferimento al museo, la realizzazione o il potenziamento di allestimenti museali richiede, ad esempio, il potenziamento di figure professionali relative alla cura e gestione delle collezioni quali il conservatore, il catalogatore, il registratore, il restauratore, lassistente tecnico addetto alle collezioni; figure professionali relative ai servizi e rapporti con il pubblico quali il responsabile dei servizi educativi, leducatore museale, leventuale responsabile della biblioteca, il responsabile e operatori dei servizi di accoglienza e custodia, il responsabile del centro di documentazione; figure professionali relative allamministrazione, finanza, gestione e relazioni pubbliche quali il responsabile amministrativo e finanziario, il responsabile del sito web, il responsabile per lo sviluppo, il responsabile della segreteria, il responsabile dellufficio stampa e delle relazioni pubbliche; figure professionali relative alle strutture, agli allestimenti e alla sicurezza quali il responsabile delle strutture e dellimpiantistica, il progettista degli allestimenti, il responsabile della sicurezza, il responsabile della rete informatica. Le figure professionali elencate in precedenza per musei e teatri sono risorse che lavorano gi nellinterno settore culturale. Pertanto, se si realizza un nuovo teatro o museo, si utilizzano necessariamente figure professionali che fanno gi parte del settore: di conseguenza, linvestimento nel settore culturale richiesto per lapertura di un nuovo museo o teatro maggiore del costo di realizzazione degli stessi.
La metodologia delle interdipendenze settoriali e le ipotesi elaborate da Leontief sulle relazioni tra i settori industriali portano a identificare il livello di produzione necessario per soddisfare la domanda, tenuto conto del consumo interno al settore stesso. In sintesi, lanalisi delle interdipendenze settoriali o analisi input-output serve per: - costruire una rappresentazione dei flussi in ingresso e in uscita tra i settori economici, le istituzioni e le famiglie in uneconomia di scambio; - stimare limpatto in termini monetari e di unit di lavoro sui settori/branche di attivit fornitrici rispetto a cambiamenti della produzione di uno specifico settore o branca di attivit a seguito di un incremento della domanda registrato nel medesimo settore; - stimare ex ante e valutare ex post la reattivit di un sistema economico a seguito dellimplementazione di provvedimenti di stimolo alleconomia da parte del Governo o delle amministrazioni locali.
123
Leconomia dei beni culturali e ambientali.
Una visione sistemica e integrata
Spesso le tavole input-output sono utilizzate per fare delle classifiche dimportanza circa la destinazione dinvestimenti tra differenti settori economici. Lutilizzo dei moltiplicatori come strumento di scelta per lindirizzo dei finanziamenti presenta limiti e pu portare a conclusioni fuorvianti. Ad esempio, analisi input-output effettuate in altri studi e ricerche, con riferimento al Prodotto Interno Lordo, hanno evidenziato i seguenti moltiplicatori: - Sanit circa 2; - Infrastrutture ferroviarie 2,5; - Infrastrutture autostradali da 3 a 4; - Infrastrutture aeroportuali da 4 a 5; - Universit da 5 a 8; - Scuole elementari e medie 1,5. Sulla base di questi risultati, e da una lettura dei moltiplicatori come strumento di scelta per lindirizzo dei finanziamenti, emerge una preferenza per linvestimento nel sistema universitario. Tuttavia, vien da s che a fronte di un budget ristretto, non avrebbe senso investire solamente nelle universit (e non nelle scuole elementari e medie), in quanto gli studenti che si iscrivono alluniversit devono aver frequentato le scuole elementari e medie. Un ulteriore esempio legato alla Sanit. Solitamente analisi di questo tipo sulle infrastrutture di trasporto restituiscono moltiplicatori pi elevati di investimenti nel settore sanitario (ospedali, ricerca medica, ecc.). Tuttavia, chi potrebbe sensatamente sostenere che pi importante investire nelle infrastrutture piuttosto che negli ospedali? In sintesi, i moltiplicatori e le stime servono per capire le relazioni interindustriali e intersettoriali, piuttosto che per fare classifiche dimportanza. Capendo le interrelazioni esistenti tra i settori si analizzano i legami tra di essi, e quindi sindaga la capacit concreta e reale di uneconomia di raggiungere determinati obiettivi. Ad esempio, se un investimento nel settore culturale genera effetti positivi sul settore ricettivo e si scopre, tramite lanalisi input-output, che tale politica non perseguibile a causa di uninadeguatezza del settore ricettivo stesso - che non in grado di fornire la quantit di servizi richiesta - si evidenzia come un investimento nel settore culturale debba essere fatto solamente dopo aver potenziato il settore ricettivo, che - fornendo servizi al settore culturale - consente a questultimo di produrre gli effetti benefici che si stimano con le matrici input-output.
5.3. La
vaLutazione deLLimpatto economico derivante da un potenziamento deL settore cuLturaLe e creativo
La metodologia sinteticamente illustrata stata implementata per stimare gli effetti diretti, indiretti e indotti sulleconomia nazionale a seguito di un aumento del Prodotto Interno Lordo (PIL) e delle Unit di Lavoro nel settore culturale in Italia. Si partiti dallanalisi della contabilit nazionale per ricercare quelle attivit registrate dallISTAT che rientrano nella definizione di attivit culturali fornita nei capitoli precedenti. Nella contabilit nazionale le attivit culturali - da noi individuate - sono racchiuse allinterno della branca di attivit denominata Attivit ricreative, culturali e sportive. In base al modello di riferimento che descrive il settore culturale e creativo abbiamo, quindi, isolato le seguenti voci: - produzioni e distribuzioni cinematografiche e di video e gestione di sale di proiezione cinematografiche; - attivit radiotelevisive; - attivit di biblioteche e archivi;
124
5. La stima dellimpatto diretto, indiretto e indotto del settore culturale e creativo in Italia
- gestione di musei e del patrimonio culturale; - gestione degli orti botanici, dei parchi naturali e del patrimonio naturale; - creazioni e interpretazioni artistiche e letterarie; - gestione di teatri, sale da concerto e altre sale di spettacolo e attivit connesse; - circhi e altre attivit di intrattenimento e di spettacolo; - attivit delle agenzie di stampa. In accordo con lo schema di riferimento per la definizione del settore culturale e creativo presentato nel Capitolo 2, che si riporta di seguito per completezza, esso racchiude anche la parte di editoria e stampa, cinema, software e personal computer utilizzati per le arti creative, design e la Ricerca e Sviluppo. Inoltre, rientrano nella visione sistemica anche le attivit di aggiornamento permanente e di interconnettivit digitale e fieristiche.
Figura 4 La matrice del settore culturale e creativo Fonte: elaborazione The European House-Ambrosetti, 2010
Tuttavia, lISTAT non fornisce i flussi di impieghi e utilizzi singolarmente per ogni attivit economica individuata nello schema precedentemente illustrato: questo perch le tavole input-output adottano una visione tradizionale del settore culturale, intercettando prevalentemente le attivit connesse ai musei, teatri, aree archeologiche, ecc.. Dove possibile, il raggruppamento ISTAT denominato Attivit ricreative, culturali e sportive stato integrato con le attivit economiche incluse nella visione pi ampia del settore adottata dal progetto Florens 2010, ma anche da tutta la letteratura specialistica pi recente. auspicabile che tali istanze possano essere accolte in futuro in tempi rapidi per poter consentire una lettura pi completa e integrale del fenomeno. Ad esempio, le attivit editoriali, che nel modello di riferimento utilizzato rientrano nel settore culturale, sono raggruppate allinterno della branca di attivit denominata Servizi di informazione e di comunicazione, che comprende anche le telecomunicazioni fisse, mobili e satellitari, lelaborazione dei dati, la gestione dei database, ecc.. Un secondo esempio legato alle attivit fieristiche che nella classificazione adottata dallISTAT rientrano sotto il raggruppamento denominato Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese assieme alle attivit di noleggio autoveicoli e di beni per uso personale e per la casa (CD, DVD, attrezzature
125
Leconomia dei beni culturali e ambientali.
Una visione sistemica e integrata
sportive, ecc.), allo sfruttamento dei diritti dautore, alle agenzie di collocamento, alle agenzie turistiche e ai tour operator, ai servizi di vigilanza e investigazione, alle attivit di pulizia e disinfestazione e alle attivit di supporto per le funzioni dufficio come i call center, ecc.. Lanalisi delle interdipendenze settoriali basata sulle matrici input-output , pertanto, costruita utilizzando come punto centrale i flussi in ingresso e in uscita che interessano il raggruppamento di attivit che lISTAT ha definito come Attivit ricreative, culturali e sportive. Pur avendo evidenziato questi problemi, parte di queste attivit non considerate sono comunque rilevate per effetto di meccanismi di trasmissione indiretta e indotta. Ad esempio, per le attivit editoriali il legame appare abbastanza intuitivo se si pensa che un museo ha bisogno di stampare i cataloghi, cos come un teatro ha bisogno di stampare programmi o volantini. Leditoria, dunque, attivata dallattivit culturale in senso stretto. Certamente la revisione del raggruppamento pi allargato potrebbe consentire una lettura pi completa del potenziale economico del settore culturale. Dopo questa necessaria premessa, utilizzando le matrici delle interdipendenze settoriali, abbiamo stimato gli impatti sul sistema economico derivanti da un potenziamento del settore culturale. Nello specifico, sono stati stimati gli impatti5: - diretti, cio quelli correlati direttamente al settore analizzato e relativi agli effetti prodotti allinterno della filiera produttiva del settore culturale; - indiretti, generati nel sistema economico attraverso la catena produttiva formata dai fornitori di beni e servizi esterni al settore culturale i cui output sono per input della filiera del settore culturale; - indotti, generati attraverso le spese ed i consumi indotti dallimpatto diretto ed indiretto. Sono costituiti dallaumento della spesa che si registra nellarea geografica di riferimento delle attivit culturali ed generata dalla maggiore presenza di cittadini, attivit economiche e unit di lavoro. I risultati delle analisi condotte con riferimento al settore culturale e creativo in Italia sono riportati di seguito.
5.3.1. I moltiplicatori del settore culturale sul Prodotto Interno Lordo
Data la valenza delle tavole input-output e le considerazioni di premessa, abbiamo analizzato gli impatti sul Prodotto Interno Lordo di unespansione delle attivit culturali e creative. Limpatto diretto generato dallespansione dellattivit culturale e ricreativa pari a 1,15 dove 1 rappresenta lincremento di PIL diretto e 0,15 limpatto di PIL che viene attivato internamente alla filiera stessa riconducibile ai consumi/utilizzi interni. Limpatto indiretto e indotto, invece, pari a 1,34, che si scompone in un impatto di 0,58 nei servizi, 0,75 nellindustria e 0,01 nellagricoltura.
da evidenziare come tale impianto metodologico si basi su delle ipotesi che nel medio-lungo periodo possono venire meno. Ad esempio, le stime sugli impatti diretti, indiretti e indotti si basa su coefficienti tecnici fissi (cio sulle relazioni quantitative fra output e input fisse), considera i rendimenti di scala costanti nel tempo e non prevede limiti alla capacit produttiva del sistema (offerta infinitamente elastica degli input).
126
5. La stima dellimpatto diretto, indiretto e indotto del settore culturale e creativo in Italia
Tabella 1 Moltiplicatori settoriali del settore culturale sullincremento del Prodotto Interno Lordo nel sistema economico Fonte: elaborazione The European House-Ambrosetti, 2010
Lindustria manifatturiera (0,62), i trasporti (0,16) e il commercio (0,12) sono i settori maggiormente reattivi a un aumento del PIL nel settore culturale. Per ogni unit di PIL aggiuntivo nella cultura il PIL in questi settori aumenta di 0,9 unit.
Figura 5 Scomposizione dellimpatto di un aumento del PIL nel settore culturale sul PIL complessivo del sistema economico Fonte: elaborazione The European House-Ambrosetti, 2010
In sintesi, per ogni Euro di Prodotto Interno Lordo generato nel settore culturale, limpatto diretto, indiretto e indotto sul sistema economico di 2,49 Euro di PIL, di cui 1,15 sono trattenuti allinterno dello stesso settore, 0,62 Euro vengono generati nellindustria manifatturiera, 0,16 Euro nei trasporti, 0,12 Euro nel commercio, 0,09 Euro nellindustria non manifatturiera, 0,04 Euro nel settore delle costruzioni, 0,02 Euro nel settore ricettivo (alberghi e ristoranti) e 0,01 Euro nellagricoltura.
127
Leconomia dei beni culturali e ambientali.
Una visione sistemica e integrata
Leffetto generato sul PIL negli altri servizi (attivit immobiliari, finanziarie, noleggio, informatica, servizi alle imprese, istruzione, sanit e difesa) si attesta a 0,27 Euro, per ogni Euro di incremento di PIL nel settore culturale e ricreativo.
5.3.2. I moltiplicatori del settore culturale sulle unit di lavoro
Come precedentemente fatto per il PIL, data la valenza delle tavole input-output e le considerazioni di premessa, abbiamo analizzato gli impatti sulle Unit di Lavoro6 di unespansione delle attivit culturali e creative. Limpatto diretto pari a 1,1 dove 1 rappresenta lunit di Unit di Lavoro Totali (ULA) realizzate nel settore e 0,1 limpatto diretto sulle Unit di Lavoro Totali (ULA) della filiera culturale stessa. Limpatto indiretto e indotto, invece, pari a 0,5, che si scompone in un impatto di 0,35 nei servizi, 0,16 nellindustria e 0,04 nellagricoltura.
Tabella 2 Moltiplicatori settoriali del settore culturale sullincremento delle Unit di Lavoro nel sistema economico Fonte: elaborazione The European House-Ambrosetti, 2010
Anche con riferimento alle Unit di Lavoro, lindustria manifatturiera (0,13), i trasporti (0,07) e il commercio (0,07) sono i settori maggiormente reattivi a un aumento delle Unit di Lavoro nel settore culturale. Per ogni Unit di Lavoro aggiuntiva nella cultura le Unit di Lavoro create in questi settori aumentano di 0,27 unit.
Il Sistema Europeo dei Conti Nazionali e Regionali indica come le unit di lavoro totali siano un indicatore migliore rispetto agli occupati per capire le dinamiche effettive del lavoro in una area geografica o in un territorio. Il SEC quantifica in modo omogeneo il volume di lavoro svolto da coloro che partecipano al processo di produzione realizzato sul territorio economico di un Paese a prescindere dalla loro residenza (occupati interni). Tale calcolo si reso necessario in quanto la persona pu assumere una o pi posizioni lavorative in funzione: dellattivit (unica, principale, secondaria); della posizione nella professione (dipendente, indipendente); della durata (continuativa, non continuativa); dellorario di lavoro (a tempo pieno, a tempo parziale); della posizione contributiva o fiscale (regolare, irregolare). Lunit di lavoro rappresenta la quantit di lavoro prestato nellanno da un occupato a tempo pieno, oppure la quantit di lavoro equivalente prestata da lavoratori a tempo parziale o da lavoratori che svolgono un doppio lavoro. Questo concetto non pi legato alla singola persona fisica, ma risulta ragguagliato ad un numero di ore annue corrispondenti ad unoccupazione esercitata a tempo pieno, numero che pu diversificarsi in funzione della differente attivit lavorativa. Le unit di lavoro sono dunque utilizzate come unit di misura del volume di lavoro impiegato nella produzione dei beni e servizi rientranti nelle stime del Prodotto Interno Lordo in un determinato periodo di riferimento.
128
5. La stima dellimpatto diretto, indiretto e indotto del settore culturale e creativo in Italia
Figura 6 Scomposizione dellimpatto di una unit di lavoro creata nel settore culturale sulle unit di lavoro totali nel sistema economico Fonte: elaborazione The European House-Ambrosetti, 2010
Per ogni incremento di una unit di lavoro nel settore culturale lincremento totale sulle unit di lavoro nel sistema economico di 1,65 di cui 1,10 unit trattenute allinterno dello stesso settore, 0,13 ULA generate nellindustria manifatturiera, 0,07 ULA generate nei trasporti e nel commercio, 0,04 ULA generate nellagricoltura, 0,03 ULA generate nelle costruzioni e 0,02 ULA generate nellindustria non manifatturiera e nel settore degli alberghi e della ristorazione. Leffetto generato sulle ULA negli altri servizi (attivit immobiliari, finanziarie, noleggio, informatica, servizi alle imprese, istruzione, sanit e difesa) si attesta a 0,18 unit, per ogni unit di lavoro generata nel settore culturale e ricreativo. Le analisi effettuate e i risultati ottenuti sono relativi al contesto italiano, in quanto si basano sulle matrici delle interdipendenze settoriali costruite con riferimento allItalia e alleconomia italiana. Tuttavia, pur consapevoli delle differenze esistenti, possibile ipotizzare che le relazioni economiche analizzate tra i settori siano simili anche nei principali Paesi europei come la Germania, la Francia e la Spagna. Quindi, i risultati ottenuti per lItalia possono essere considerati validi anche a livello europeo, seppur come ordine di grandezza e non come dato puntuale.
129
Leconomia dei beni culturali e ambientali.
Una visione sistemica e integrata
5.4. moLtipLicatori e FloreNs iNdex
La lettura dei risultati del Florens Index, unita a quella delle tavole delle interdipendenze settoriali, ci consente di contestualizzare lanalisi input-output su base regionale. Per loro natura le tavole sono costruite su base nazionale e i moltiplicatori di impatto sono anchessi nazionali. Tuttavia pensabile che alcune realt territoriali con una maggiore specializzazione e caratterizzazione nel settore culturale possano presentare moltiplicatori pi elevati.
Tabella 3 Stima dei moltiplicatori di impatto diretto, indiretto e indotto sul PIL su base regionale - Fonte: elaborazione The European House-Ambrosetti, 2010
Stanti tali premesse, si assume che le regioni con un Florens Index pi elevato inneschino, nei propri sistemi economici, dinamiche virtuose con conseguenti effetti positivi sui moltiplicatori. I valori del Florens Index, espressi su una scala crescente da 1 a 5, sono compresi tra 1,47 in Molise e 3,41 in Lombardia. Il valore medio del Florens Index per lItalia, calcolato come media delle Regioni italiane, 2,12. Si assume che in un intervallo di +/-10% rispetto al Florens Index medio dellItalia il moltiplicatore regionale coincida con quello nazionale. Al di fuori di tale intervallo i moltiplicatori regionali risultano pi alti o pi bassi della media italiana a seconda della distanza del Florens Index regionale dal Florens Index medio italiano. In altre parole, in proporzione alle distanze tra i valori del Florens Index registrati nelle Regioni e il valore medio dello stesso sono stati calcolati i moltiplicatori di impatto diretto, indiretto e indotto sul PIL nel sistema economico a seguito di un aumento di una unit di PIL nel settore culturale. Ad esempio, per la Regione Toscana, con un Florens Index di 2,79, che equivale al +31,6% di differenza rispetto al Florens Index medio nazionale, si stima che il suo moltiplicatore sar pari 3,03, calcolato come 2,49 pari al moltiplicatore medio nazionale e 0,54 calcolato come differenza incrementale dovuta ad un valore maggiore di Florens Index della Toscana (2,79) rispetto a quello medio nazionale (2,12).
130
5. La stima dellimpatto diretto, indiretto e indotto del settore culturale e creativo in Italia
5.5. sintesi dei principaLi risuLtati emersi
Il settore culturale e creativo sta diventando sempre pi importante nellattuale contesto economico e presenta dinamiche in controtendenza rispetto alla recente crisi economica mondiale. Limportanza delleconomia creativa legata al fatto che le attivit che la compongono si caratterizzano per essere multidisciplinari e interessano settori economici differenti e lontani tra loro considerando i processi produttivi e gli output prodotti. In conformit a questi dati che confermano limportanza del settore culturale e creativo in Italia, si proceduto ad stimare gli effetti sul sistema economico generati da un potenziamento del settore culturale e creativo. Dopo aver analizzato le metodologie di stima degli impatti economici, in accordo con le finalit del presente studio, si deciso di implementare lanalisi delle matrici delle interdipendenze settoriali, conosciuta anche come analisi input-output per studiare le relazioni tra il settore culturale e creativo e leconomia nel suo complesso. Tale metodologia si basa sullanalisi dei flussi tra i settori economici e sulle relazioni tra gli stessi. Un aumento della domanda finale delloutput di un determinato settore, infatti, genera un processo di moltiplicazione per ondate successive nel quale, per ogni fase, gli incrementi netti delloutput di ciascun settore diventano sempre pi piccoli, fino a zero. La somma degli incrementi netti delloutput sintetizzata nei moltiplicatori economici di settore. Riassumendo, i moltiplicatori del settore cultura ottenuti dallanalisi delle matrici delle interdipendenze settoriali evidenziano quanto segue: - 100 Euro di incremento di PIL nel settore culturale genera tramite le relazioni interindustriali (impatto indiretto) e laumento della domanda (impatto indotto) un aumento di 249 Euro di PIL nel sistema economico (moltiplicatore pari a 2,49); - per ogni unit di lavoro che si crea nel settore culturale si generano tramite le relazioni interindustriali (impatto indiretto) e laumento della domanda (impatto indotto) 1,65 unit di lavoro complessive nel sistema economico (moltiplicatore pari a 1,65). Altro risultato interessante lesistenza di un forte collegamento tra il settore culturale e lindustria manifatturiera. Escludendo limpatto generato sul settore culturale stesso, si evidenzia come il settore manifatturiero catturi quasi il 42% degli effetti positivi sul PIL e il 20% degli effetti positivi sul numero delle Unit di Lavoro generate dal settore culturale. Pi nello specifico, come emerso dalle elaborazioni effettuate: - per ogni 100 Euro di PIL prodotto nel settore culturale vengono generati 62 Euro di PIL nellindustria manifatturiera. Pertanto ad essa riconducibile il 41,6% dellimpatto generato nel sistema economico escludendo limpatto stesso sul settore culturale (62 euro su un totale di 149); - per ogni unit di lavoro che si crea nel settore culturale vengono generati 0,13 unit di lavoro nellindustria manifatturiera. Ad essa riconducibile il 20% dellimpatto generato nel sistema economico escludendo limpatto stesso sul settore culturale (0,13 su un totale di 0,65). Gli impatti calcolati sono relativi alleconomia italiana a livello complessivo. In altre parole, i moltiplicatori si riferiscono a un incremento di Valore Aggiunto e di occupati nel settore culturale e agli impatti prodotti a livello complessivo di sistema Paese. Aree territoriali, province e citt, con forti specializzazioni e caratterizzazioni nei confronti del settore culturale e creativo, possono registrare moltiplicatori pi elevati, proprio per la maggiore intensit e dimensione del settore culturale e creativo nel sistema economico stesso. Purtroppo non esistono matrici delle interdipendenze settoriali su base provinciale o relative alle singole citt. ipotizzabile, tuttavia, che tali moltiplicatori siano pi elevati nelle realt territoriali con una maggiore specializzazione nel settore culturale.
131
Leconomia dei beni culturali e ambientali.
Una visione sistemica e integrata
In tal senso, utilizzando il Florens Index, che misura il livello di sviluppo comparato del settore culturale e creativo territoriale in ogni Regione italiana, sono stati stimati i moltiplicatori sul PIL a livello regionale. In Toscana si stima che tale moltiplicatore si attesti intorno al valore 3: ci significa che per ogni 100 Euro di PIL generato nel settore culturale in Toscana, gli effetti diretti, indiretti e indotti sul PIL nel sistema economico della Toscana si attestano a 300 Euro. Inoltre, se si restringe maggiormente lanalisi a livello territoriale e ci si focalizza sulle realt che presentano eccellenze di tipo culturale e creativo, gli effetti risultano amplificati rispetto a quelli medi che si registrano a livello nazionale o regionale. Come gi ricordato in precedenza, studi effettuati ad hoc su realt locali hanno dimostrato come il moltiplicatore sulleconomia rispetto alla spesa diretta sia pari a: - 4 volte per il Festival dellEconomia a Trento; - 3 volte per le Mostre a Brescia e Como; - 7 volte per il Festival della letteratura a Mantova. Tali risultati si ottengono perch leffetto di un evento o manifestazione culturale su unarea geografica pi piccola (provincia o citt) risulta pi concentrato e, quindi, il moltiplicatore pi alto. Gli effetti generati tendono per a ridursi allallontanarsi dal luogo in cui avviene levento o la manifestazione culturale. Pertanto, limpatto complessivo sul sistema economico risulta inferiore. In conclusione, ai fini del presente studio e in accordo con la volont di indagare limportanza del settore culturale per il Paese, ma anche con la necessit di valutare gli effetti generati da eventi o manifestazioni culturali su un livello pi ampio rispetto alla singola citt, si ritiene che unanalisi complessiva di pi ampio respiro fornisca una migliore comprensione e valutazione dellimpatto del settore culturale sul sistema economico italiano. Analisi effettuate su un livello inferiore a quello regionale sono sicuramente utili per la valutazione delle singole iniziative/manifestazioni, ma paiono limitanti ai fini di una comprensione reale degli impatti prodotti e dei legami con gli altri settori e attivit economiche.
appendice. nota metodoLogica deLLe tavoLe iNput-output
Tabella 4 La struttura algebrica delle matrici input-output: esempio su 3 settori Fonte: elaborazione The European House-Ambrosetti, 2010
132
5. La stima dellimpatto diretto, indiretto e indotto del settore culturale e creativo in Italia
Nella Tabella 4 le righe della matrice indicano il settore che vende, le colonne il settore che acquista. A titolo esemplificativo, X12 indica i beni che lagricoltura vende allindustria e, viceversa, che lindustria acquista dallagricoltura (come ad esempio cibo, bevande, materie prime alimentari, ecc.), mentre X21 indica i beni che lindustria vende allagricoltura, ovvero che lagricoltura acquista dallindustria (come ad esempio aratri, trattori, macchinari vari per la trasformazione del cibo, attrezzature, ecc.).
Tabella 5 Come si legge la struttura algebrica delle matrici input-output Fonte: elaborazione The European House-Ambrosetti, 2010
Proseguendo nella lettura delle matrici input-output, gli impieghi intermedi presentano le transazioni interindustriali riguardanti beni e servizi intermedi affluiti dal settore di origine (riga) ai settori di impiego (colonna) e da questi utilizzati come input del loro processo produttivo. Nella sezione degli impieghi finali, invece, sono riportati i flussi di beni e servizi che dai settori di origine affluiscono agli utilizzatori finali per essere destinati al consumo (privato e della Pubblica Amministrazione) alla formazione del capitale (investimenti e scorte) e alle esportazioni. La somma per riga degli impieghi intermedi e di quelli finali rappresenta il totale degli impieghi di beni e servizi del settore considerato. Le informazioni di una matrice delle interdipendenze settoriali possono essere lette verticalmente ed orizzontalmente (Tabella 5). La lettura verticale (per colonna) indica quanto e da quali settori industriali il settore considerato acquista, mentre la lettura orizzontale (per riga) indica quanto e a quali settori industriali il settore considerato vende. In generale, la struttura algebrica delle matrici input-output, relativa agli impieghi intermedi, pu essere generalizzata nel modo seguente. X1 = X11 + X12 + + X1i + + X1n + Y1 X2 = X21 + X22 + + X2i + + X2n + Y2 Xi = Xi1 + Xi2 + + Xii + + Xin + Yi Xn = Xn1 + Xn2 + + Xni + + Xnn + Yn
133
Leconomia dei beni culturali e ambientali.
Una visione sistemica e integrata
dove: X1 Xn = produzione totale del settore Y1 Yn = domanda finale X11Xnn = impieghi intermedi tra settori Operativamente la matrice input-output viene trasformata in una matrice di coefficienti diretti, i quali indicano quante unit del bene (o servizio) i-esimo sono necessarie per produrre una unit del bene (o servizio) j-esimo. Lipotesi di Leontief che in ogni attivit produttiva la quantit di input assorbita sia proporzionale al volume delloutput conseguibile (ipotesi di tecnologia lineare). In accordo con questa ipotesi, si definiscono i coefficienti che possono essere: - tecnici se le grandezze sono espresse in unit fisiche; - di spesa se le grandezze sono espresse in unit monetarie.
Figura 7 Modello input-output scritto in accordo con le ipotesi di Leontief e con levidenziazione dei coefficienti Fonte: elaborazione The European House-Ambrosetti, 2010
La produzione dunque utilizzata in parte per soddisfare la domanda finale (Y) e in parte per garantire la sua producibilit, sotto forma di input intermedi necessari (AX). Questa espressione di fondamentale importanza perch tiene in considerazione che nelle relazioni tra i settori economici esistono anche degli utilizzi interni al settore considerato che consentono a questultimo di funzionare. La stima dellimpatto economico sulle industrie fornitrici rispetto a cambiamenti della produzione in una singola industria una delle applicazioni che maggiormente trova utilizzo negli studi di impatto economico derivante dalla realizzazione di investimenti pubblici, infrastrutture o programmi di incentivo industriale. Algebricamente, risolvendo la precedente equazione X = AX + Y rispetto a X si ottiene:
134
5. La stima dellimpatto diretto, indiretto e indotto del settore culturale e creativo in Italia
In coerenza con quanto riportato in precedenza le matrici input-output: - consentono il calcolo dei moltiplicatori settoriali che misurano limpatto complessivo sul sistema economico a fronte di un cambiamento di una unit in un singolo settore; - lungo la diagonale principale (settore*settore) si caratterizzano per la presenza di valori superiori allunit, poich tengono in considerazione gli utilizzi/consumi interni.
Le tavole delle interdipendenze settoriali fornite dallISTAT
LIstituto Nazionale di Statistica ha pubblicato nellagosto del 2009 le tavole delle risorse e degli impieghi (o tavole supply and use) e le tavole simmetriche coerenti con gli aggregati di contabilit nazionale. Tali tavole aggiornano al 2006 le serie disponibili in precedenza, che erano datate 1995 e 2000. Vi dunque un considerevole gap temporale tra la data di pubblicazione delle tavole delle interdipendenze e il periodo di riferimento delle stesse. La tavola delle risorse (supply) mostra, in particolare, la disponibilit totale della produzione classificata per tipologia di prodotto e per branca dattivit, distinguendo tra produzione interna e importata. Nella tavola delle risorse le importazioni di beni sono valutate CIF (cost insurance freight7), ossia nel valore dei beni importati sono inclusi i servizi di trasporto e di assicurazione fino alla frontiera dellimportatore. La tavola degli impieghi (use) presenta gli impieghi dei beni e servizi per prodotto e per tipo dimpiego (intermedio o finale) e illustra le componenti del Valore Aggiunto. Nella tavola degli impieghi le esportazioni di prodotti sono valutate FOB (free on board8), ossia ai valori registrati alla frontiera doganale dellesportatore. Le tavole delle risorse e degli impieghi sono matrici per branca di attivit economica e per branca di produzione omogenea che descrivono dettagliatamente i processi di produzione interni e le operazioni sui prodotti delleconomia nazionale. Le tavole sono utilizzate anche ai fini della verifica e del miglioramento della coerenza sia dei dati di base, sia delle stime finali del sistema dei conti nazionali. A partire dalle tavole delle risorse e degli impieghi lISTAT ha costruito le tavole input-output simmetriche, convertendo le informazioni contenute nelle due tavole precedenti utilizzando ulteriori informazioni sulla struttura degli input produttivi e basandosi su assunzioni a priori sulle tecnologie produttive dei medesimi settori. In generale le tavole sono fornite per due diversi livelli di dettaglio. Uno pi articolato a 59 branche di attivit economica e 59 raggruppamenti di prodotti e laltro semplificato a 30 branche di attivit economica e 30 raggruppamenti di prodotti. La tavola simmetrica compilata nello specifico per essere usata nellanalisi input-output. Esistono due tipologie di tavole simmetriche input-output che sono costruite su differenti ipotesi, la tavola simmetrica branca per branca e la tavola simmetrica prodotto per prodotto.
Con il termine Cost, Insurance and Freight, conosciuto anche con lacronimo CIF, si intende una delle clausole contrattuali in uso nelle compravendite internazionali. Questa specifica notazione, in uso nei trasporti via nave, stabilisce che a carico del venditore siano tutte le spese di trasporto fino a destinazione, compresi eventuali costi per lo scarico della nave, nonch le spese per lottenimento di licenze e documentazioni per lesportazione dalla nazione di origine e quelle per le operazioni doganali sempre di esportazione. Sempre a carico del venditore sono anche le spese di assicurazione. Dal momento in cui la merce scaricata nel porto di arrivo tutte le altre spese sono da considerarsi a carico dellacquirente, compresi i costi doganali nella nazione di arrivo. La formulazione di questo termine di resa considerata completa con lindicazione del porto di destinazione (esempio CIF Genova). Con lespressione Free On Board, conosciuta anche con lacronimo FOB, si intende una delle clausole contrattuali in uso nelle compravendite internazionali; queste clausole di resa che riguardano il campo dei trasporti. Questa specifica notazione, nata per il trasporto marittimo da qui lusuale traduzione di Franco a bordo di una nave, stabilisce che a carico del venditore siano tutte le spese di trasporto fino al porto dimbarco, compresi eventuali costi per la messa a bordo della nave, nonch le spese per lottenimento di licenze e documentazioni per lesportazione dalla nazione di origine e quelle per le operazioni doganali sempre di esportazione. Dal momento in cui la merce considerata pronta per la partenza tutte le altre spese sono da considerarsi a carico dellacquirente, compresi i costi di assicurazione. Per quanto concerne la responsabilit della merce questa passa dal venditore al compratore al momento in cui la merce stessa supera fisicamente la verticale della murata della nave.
135
Leconomia dei beni culturali e ambientali.
Una visione sistemica e integrata
La tavola branca per branca, che descrive le relazioni interindustriali, indica per ciascuna branca limpiego dei prodotti provenienti dalle altre branche (che possono essere anche prodotti secondari di tali branche). A sua volta la tavola branca per branca pu essere costruita secondo due ipotesi: - ogni branca dattivit ha la sua propria struttura di vendite, a prescindere dal mix di prodotti che produce (questa ipotesi sembra poco realistica, dato che solo in pochi casi le aziende offriranno i loro prodotti nelle stesse proporzioni ai vari utilizzatori); - ogni prodotto ha la sua specifica struttura di vendita. La tavola prodotto per prodotto che descrive le relazioni tecnologiche tra i prodotti, indica per ciascun prodotto lammontare di prodotti che sono stati usati per produrlo, a prescindere dalla loro branca di origine. A sua volta la tavola prodotto per prodotto pu essere costruita secondo due ipotesi: - esiste solo una tecnica per produrre ciascun prodotto; di conseguenza ogni prodotto ha la sua struttura tipica di input; - ogni branca ha il suo proprio modo di produrre, a prescindere dal mix di prodotti che produce. Quindi ogni branca ha la sua propria struttura di input e ad ogni branca si pu attribuire una colonna di coefficienti di input che sono tipici di quella branca. Se il mix di output di una branca cambia, le proporzioni nei quali gli input sono usati non vengono modificati. Questultima, cio la tavola prodotto per prodotto, preferita dal Sistema Europeo dei Conti Nazionali e Regionali, in quanto considerata la tavola che mostra flussi maggiormente omogenei rispetto alla tavola branca per branca. In accordo sempre con il Sistema Europeo dei Conti e con le linee guida metodologiche fornite dallISTAT9 abbiamo utilizzato la seconda ipotesi per limplementazione delle simulazioni sugli impatti economici. In conclusione, per la stima degli effetti generati dal potenziamento del settore culturale abbiamo utilizzato la tavola delle interdipendenze settoriali costruita secondo la metodologia prodotto per prodotto, che indica per ciascun prodotto lammontare di prodotti intermedi utilizzati per produrre lo stesso. Nello specifico, inoltre, abbiamo scelto nellelaborazione delle simulazioni per la tavola prodotto per prodotto lipotesi che ogni branca di attivit ha il suo modo di produrre a prescindere dal mix di prodotti che produce. In tal modo, per ogni branca di attivit (o settore economico/produttivo) si possono attribuire dei coefficienti di input e specifici per branca, attraverso i quali possibile ricavare i moltiplicatori economici di attivazione.
Si veda: ISTAT, Le tavole delle risorse e degli impieghi e la loro trasformazione in tavole simmetriche - Nota metodologica, ottobre 2006.
136
6. Le principali evidenze emerse dalla survey nazionale e internazionale sul settore culturale e creativo
6. LE PRINCIPALI EVIDENZE EMERSE DALLA SURVEY NAZIONALE E INTERNAZIONALE SUL SETTORE CULTURALE E CREATIVO 6.1. obiettivi, ambiti deLLanaLisi e paesi considerati neLLindagine suLLa cuLtura
Allinterno dello Studio Strategico sul settore culturale e creativo stato predisposto un questionario per la rilevazione empirica, su scala nazionale e internazionale, dei comportamenti e delle aspettative dei cittadini nei confronti della cultura, con lobiettivo di analizzare attitudini, esigenze, problemi attuali e aspettative future dei cittadini sui beni culturali e confrontare tra loro i diversi Paesi oggetto danalisi. Il questionario stato costruito su quattro differenti ambiti di analisi con lobiettivo di cogliere e coprire gli aspetti pi rilevanti relativi al tema della cultura. Nello specifico, lindagine stata modulata su quattro componenti: - conoscenza dellofferta culturale e interesse verso i beni culturali, con lobiettivo di capire il perimetro del concetto di cultura nellimmaginario collettivo e in che modo siano fornite le informazioni generali/specifiche su temi e iniziative culturali; - comportamenti, esigenze e scelte degli individui in relazione a temi culturali, con lobiettivo di individuare gli elementi maggiormente rilevanti che spingono i cittadini verso unofferta culturale piuttosto che unaltra e quanto lelemento cultura incide sulle relative scelte turistiche e di tempo libero; - utilizzo delle nuove tecnologie, con lobiettivo di capire quanto e come sono utilizzate le nuove tecnologie e qual la propensione al loro consumo; - finanziamento della cultura ed eventuale attitudine al mecenatismo e donazioni nei confronti di attivit culturali, con lobiettivo di analizzare e valutare la sensibilit dellopinione pubblica verso finanziamenti di tipo pubblico e privato per le attivit artistiche e culturali.
Figura 1 Ambiti di analisi della survey Fonte: elaborazione The European House-Ambrosetti, 2010
Lindagine sulla cultura stata condotta in 6 Paesi: Italia, Francia, Germania, Regno Unito, Spagna e Stati Uniti. Per ogni Paese il campione stato selezionato dal gruppo di lavoro The European House-Ambrosetti con la collaborazione di una societ di ricerche demoscopiche e di mercato1, con lobiettivo di fornire risultati statisticamente significativi.
The European House-Ambrosetti ha diretto lindagine di mercato svolta da SWG.
137
Leconomia dei beni culturali e ambientali.
Una visione sistemica e integrata
In accordo con la metodologia di indagine, i risultati ottenuti hanno i seguenti requisiti: - affidabilit: i risultati sono attendibili e statisticamente consistenti; - validit: loutput strettamente legato alloggetto di studio e fornisce una ragionevole comprensione del tema analizzato; - comprensibilit: i valori finali e le scale di valutazione sono realizzati in modo tale da essere comprensibili non solo per esperti di settore; - longitudinalit: la rilevazione costruita per consentire la ripetibilit futura e la comparabilit dei risultati. Con riferimento allItalia lindagine (metodo CAWI) stata condotta a cavallo tra il mese di maggio e il mese di giugno del 2010 su un campione di 4.000 individui, pienamente rappresentativo della popolazione italiana. Tale campione consente, con elevati livelli di significativit statistica, anche la lettura dei dati per Regione di residenza, et, livello di istruzione e sesso. In altre parole, il campione stato costruito al fine di consentire la lettura trasversale dei dati per ogni Regione italiana, suddividendo il campione in donne e uomini, in sei fasce di et (18-24 anni; 25-34 anni; 35-44 anni; 45-54 anni; 55-64 anni; oltre 64 anni) e in differenti livelli di istruzione (basso, che corrisponde a nessun titolo di studio o licenza elementare; medio, che corrisponde alla licenza media o superiore; alto, che corrisponde alla laurea, laurea magistrale, dottorato di ricerca). Con riferimento ai Paesi scelti per il confronto internazionale - Francia, Germania, Regno Unito, Spagna e Stati Uniti - le indagini sono state condotte tra il mese di maggio e il mese di luglio del 2010 su un campione di 1.000 individui che, con un elevato livello di significativit statistica, consente la lettura dei risultati per il totale della popolazione nazionale. Nel seguente capitolo si presentano i risultati delle elaborazioni effettuate con riferimento allItalia e agli altri Paesi considerati. Dato lelevato numero di elaborazioni effettuate, si presentano le evidenze principali e i risultati di maggior interesse.
6.2. i risuLtati deLLindagine suLLa cuLtura
6.2.1. Parole che si associano allidea di cultura
Prima di indagare il rapporto tra cittadini e cultura sembrato importante comprendere come sia interpretato il concetto stesso di cultura tra i cittadini. In particolare, stato chiesto agli intervistati di indicare, tra una serie di parole, le prime tre che a loro avviso si associano maggiormente al concetto di cultura. Le risposte a disposizione erano le seguenti: - museo; - biblioteca; - monumento; - parco naturale, riserva naturale; - mostra darte, galleria darte; - musica, concerto, opera; - teatro; - cinema; - moda, design; - enogastronomia, tradizione culinaria; - riti e feste tradizionali;
138
6. Le principali evidenze emerse dalla survey nazionale e internazionale sul settore culturale e creativo
- aree archeologiche; - non saprei. Quasi la met degli italiani associa al concetto di cultura la parola museo. Seguono le aree archeologiche con il 36%, le gallerie darte con il 34% circa e i monumenti con il 28% circa.
Figura 2 Parole che si associano allidea di cultura: totale popolazione Italia Fonte: elaborazione The European House-Ambrosetti, 2010
Pochi, invece, sono gli italiani che associano alla cultura le parole moda, design e cinema. Nei giovani (tra i 18 e i 24 anni) la percentuale di chi considera le parole moda e design si attesta al 7%, mentre la percentuale di giovani che associa parchi e riserve naturali alla parola cultura inferiore alla media nazionale: solo il 13,8% dei giovani (tra i 18 e i 24 anni), pensa ai parchi naturali e alle riserve naturali come cultura, contro il 24,1% a livello nazionale. Non si rilevano differenze significative nelle risposte tra differenti Regioni dItalia, livelli di educazione e sesso degli intervistati. Nel confronto internazionale emerge un quadro disomogeneo. La parola museo quella che si associa maggiormente allidea di cultura in Francia (52% circa), negli Stati Uniti (47% circa) e in Italia (46% circa). In Spagna (37% circa) e in Germania (38% circa) lassociazione pi elevata con il termine cultura attribuita a riti e feste tradizionali, mentre nel Regno Unito (48% circa) lenogastronomia la parola che pi si associa al termine cultura.
139
Leconomia dei beni culturali e ambientali.
Una visione sistemica e integrata
Figura 3 Percentuale di associazione tra le parole museo e cultura: confronto internazionale Fonte: elaborazione The European House-Ambrosetti, 2010
Con riferimento allassociazione tra le parole museo e cultura, circa un cittadino su due in Francia, Italia e Stati Uniti considera la parola museo un sinonimo di cultura, mentre nel Regno Unito, in Germania e in Spagna la parola museo viene associata al termine cultura solo da 1 cittadino su 3 circa.
Figura 4 Percentuale di associazione tra le parole mostre / gallerie darte e cultura: confronto internazionale Fonte: elaborazione The European House-Ambrosetti, 2010
Come si pu osservare dal grafico precedente, mostre e gallerie darte sono sinonimo di cultura per oltre un terzo dei cittadini italiani, per circa un quarto dei cittadini inglesi, americani, francesi e tedeschi e per un quinto dei cittadini spagnoli. Gli italiani detengono il primato anche nellassociazione tra le parole aree archeologiche e cultura. Pi nello specifico, il 37% degli italiani associa aree archeologiche e cultura, mentre ci avviene solo per il 17% circa degli spagnoli.
140
6. Le principali evidenze emerse dalla survey nazionale e internazionale sul settore culturale e creativo
Figura 5 Percentuale di associazione tra le parole aree archeologiche e cultura: confronto internazionale Fonte: elaborazione The European House-Ambrosetti, 2010
Feste, sagre e riti tradizionali si associano alla parola cultura soprattutto per gli inglesi (39,4%) e i tedeschi (38,3%). Per gli italiani, invece, le tradizioni popolari sembrano pi distanti dallidea di cultura.
Figura 6 Percentuale di associazione tra le parole riti e feste tradizionali e cultura: confronto internazionale Fonte: Elaborazione The European House-Ambrosetti, 2010
Il primato dei cittadini del Regno Unito si evidenzia anche nellassociazione tra enogastronomia e tradizione culinaria e cultura. In modo abbastanza sorprendente per quasi il 50% della popolazione britannica lenogastronomia sinonimo di cultura, mentre in Italia e Spagna (in penultima e ultima posizione), tale percentuale si attesta rispettivamente al 20% circa e al 17% circa.
141
Leconomia dei beni culturali e ambientali.
Una visione sistemica e integrata
Figura 7 Percentuale di associazione tra le parole enogastronomia e cultura: confronto internazionale Fonte: elaborazione The European House-Ambrosetti, 2010
La musica, i concerti e lopera sono sinonimi di cultura per il 35% degli americani. Tale percentuale pi che doppia rispetto agli spagnoli (15%) e doppia rispetto ai Francesi (18%).
Figura 8 Percentuale di associazione tra le parole musica, concerto, opera e cultura: confronto internazionale Fonte: elaborazione The European House-Ambrosetti, 2010
I Paesi di origine latina (Francia, Italia e Spagna) sono agli ultimi posti per lassociazione tra le parole musica, concerto, opera e cultura, mentre risultano ai primi posti nellassociazione tra le parole biblioteca e cultura. Infatti, circa 1 cittadino su 5 in Francia, Italia e Spagna considera la parola biblioteca sinonimo di cultura, mentre ci avviene solamente per 1 cittadino su 20 in Germania, Stati Uniti e Regno Unito.
142
6. Le principali evidenze emerse dalla survey nazionale e internazionale sul settore culturale e creativo
Figura 9 Percentuale di associazione tra le parole biblioteca e cultura: confronto internazionale Fonte: elaborazione The European House-Ambrosetti, 2010
In sintesi, dal confronto internazionale emergono delle differenze rilevanti. Per gli inglesi i riti, le feste tradizionali e lenogastronomia sono sinonimi di cultura. In Italia, invece, per cultura sintendono soprattutto mostre, gallerie darte e aree archeologiche. Negli USA oltre ai musei, la musica, i concerti e lopera sono ai primi posti fra le parole associate alla cultura. Nei Paesi latini si considera la parola biblioteca come sinonimo di cultura, mentre nei Paesi anglosassoni e in Germania lassociazione tra biblioteca e cultura molto debole: solo la parola museo, seppur con alcune differenze, viene associata mediamente in percentuali elevate al termine cultura in modo trasversale tra tutti i Paesi della survey.
6.2.2. La vacanza ideale e la cultura
Lassociazione tra cultura e turismo spesso automatica: si parla infatti diffusamente di citt darte e di turismo culturale in modo spesso indistinto. Si , pertanto, chiesto al campione rappresentativo dei cittadini dei 6 Paesi analizzati di indicare, tra una serie di risposte, quella che maggiormente si associava alla loro idea di vacanza ideale. Le risposte a disposizione erano: - citt darte, luoghi ricchi di storia, cultura; - localit ricca di locali, discoteche, divertimento; - luogo tranquillo, poco affollato dove riposare, rilassarsi; - luogo con paesaggi naturali attraenti; - luogo dove fare sport, attivit fisica; - non saprei. Per quanto riguarda lItalia, le citt darte o i luoghi ricchi di cultura per le proprie vacanze sono stati indicati da oltre 1 cittadino su 3. Sembra quindi particolarmente interessante capire la relazione percepita tra cultura e vacanza ideale per valutare se e quanto le citt siano un elemento decisivo nella scelta delle mete turistiche.
143
Leconomia dei beni culturali e ambientali.
Una visione sistemica e integrata
A seguire, con rispettivamente il 28% e il 27% delle risposte, si collocano i luoghi tranquilli dove potersi rilassare e i luoghi con paesaggi naturali attraenti. Solo il 7% preferisce recarsi in localit ricche di locali e discoteche, mentre il restante 3% preferisce recarsi in luoghi dove poter svolgere attivit fisica e sport.
Figura 10 Vacanza ideale e cultura: totale popolazione Italia Fonte: elaborazione The European HouseAmbrosetti, 2010
Anche lanalisi per fasce det conferma la preferenza degli italiani per le citt darte e i luoghi ricchi di cultura e tradizioni. In tale contesto, dove anche la maggioranza dei giovani (18 e 24 anni) dichiara di preferire le citt darte come meta di vacanze ideali, con una percentuale di risposta che si attesta a circa il 27%, si evidenzia una relazione positiva tra et dei cittadini e preferenza per citt darte e luoghi ricchi di cultura e tradizione come vacanza ideale. Infatti, al crescere dellet cresce lassociazione tra cultura e vacanza ideale.
Figura 11 Vacanza ideale e cultura: risultati per fasce di et, Italia Fonte: elaborazione The European HouseAmbrosetti, 2010
144
6. Le principali evidenze emerse dalla survey nazionale e internazionale sul settore culturale e creativo
Viceversa, come prevedibile, si riscontra una relazione negativa tra et dei cittadini e preferenza per localit ricche di locali e discoteche come vacanza ideale. Nello specifico, la percentuale di chi dichiara di preferire localit ricche di locali e discoteche si attesta al 25% circa degli individui in et compresa tra 18 e 24 anni, al 10% tra gli individui in et compresa tra 25 e 34 anni, per poi ridursi con laumento dellet e attestarsi all1,6% negli individui con unet superiore ai 64 anni. Piuttosto stabile risulta, invece, la percentuale di chi dichiara di preferire luoghi con paesaggi naturali attraenti, che si attesta tra il 23% degli over 64 (valore minimo) e il 30% degli individui in et compresa tra i 55 e i 64 anni (valore massimo). Analizzando le risposte per Regione emergono differenti risultati. In Sicilia, Sardegna e Toscana, pi del 40% dei cittadini associa la cultura al concetto di vacanza ideale, viceversa in Trentino Alto Adige e Valle dAosta la percentuale scende al 26% circa. Nonostante questi risultati non sembrino essere particolarmente influenzati dallappartenenza a macro aree geografiche (Nord, Centro, Sud), un fatto che le prime due Regioni in Italia, sotto questo profilo, siano le isole, cio la Sicilia e la Sardegna e le ultime due siano Regioni di montagna come il Trentino Alto Adige e la Valle DAosta.
Figura 12 Vacanza ideale e cultura: risultati per Regione di appartenenza Fonte: elaborazione The European House-Ambrosetti, 2010
Sempre con riferimento allItalia, lanalisi delle risposte per sesso e livello distruzione non fa emergere differenze significative e/o rilevanti. Al contrario, la stessa domanda rivolta al campione intervistato nei 6 Paesi oggetto dellindagine internazionale fa emergere risultati di particolare interesse. LItalia lunico Paese, tra quelli considerati, dove le citt darte e i luoghi ricchi di cultura e tradizione ottengono la maggioranza delle preferenze come mete di vacanze ideali, con una percentuale superiore al 34%. In Spagna tale percentuale si attesta al 25%, negli Stati Uniti e nel Regno Unito al 20% circa, in Francia al 14% circa e all8,5% in Germania.
145
Leconomia dei beni culturali e ambientali.
Una visione sistemica e integrata
Figura 13 Vacanza ideale e cultura: confronto internazionale Fonte: elaborazione The European HouseAmbrosetti, 2010
In Spagna, Germania e Francia i cittadini preferiscono luoghi con paesaggi naturali attraenti, rispettivamente con circa il 27%, il 37% e il 42%, mentre nel Regno Unito e negli Stati Uniti i cittadini preferiscono i posti tranquilli dove riposare e rilassarsi, rispettivamente con circa il 39% e il 45% delle preferenze. In sintesi, quasi 1 americano su 2 associa luoghi tranquilli e poco affollati dove riposare al concetto di vacanza ideale e della stessa idea sono circa il 40% degli inglesi. Le citt darte e i luoghi ricchi di cultura rappresentano le vacanze ideali per quasi il 35% degli italiani (valore massimo) e per l8% circa dei tedeschi (valore minimo). Particolarmente elevata risulta la propensione al divertimento dei tedeschi: il 14,3% di questi associa luoghi ricchi di locali e discoteche al concetto di vacanza ideale.
6.2.3.
Fattori che favoriscono linteresse per la cultura nei giovani
Comprendere quali fattori favoriscano linteresse dei giovani per la cultura stato un altro ambito di indagine approfondito nel corso del sondaggio. In particolare si chiesto di esprimere per ciascuno dei quattro fattori identificati, cio la scuola, lambiente familiare e sociale, le amicizie, i viaggi e le esperienze, una valutazione relativa alla capacit degli stessi di promuovere lo sviluppo dellinteresse per la cultura nei giovani.
146
6. Le principali evidenze emerse dalla survey nazionale e internazionale sul settore culturale e creativo
Figura 14 Aspetti che favoriscono linteresse dei giovani per la cultura: totale popolazione Italia Fonte: elaborazione The European House-Ambrosetti, 2010
Oltre il 93% degli italiani considera i viaggi e le esperienze il principale stimolo che favorisce linteresse per la cultura nei giovani. Seguono lambiente familiare e sociale con il 74% circa e le amicizie con il 70% circa. Solo il 56% circa degli italiani ritiene che la scuola abbia la capacit di favorire, in modo significativo e positivo, linteresse per la cultura nei giovani. Leggendo il dato in negativo, oltre 4 italiani su 10 non pensano che la scuola abbia un ruolo nel favorire linteresse per la cultura nei giovani. Si tratta di un dato preoccupante, in quanto la funzione stessa della scuola dovrebbe essere quella di favorire lapertura e linteresse dei giovani verso la conoscenza e, quindi, verso la cultura. Dallanalisi dei risultati per sesso, fasce di et, livelli di educazione e Regioni di residenza, non si rilevano differenze significative nelle risposte. A livello internazionale si registra, invece, come in tutti i Paesi i viaggi e le esperienze siano ritenute laspetto principale che favorisce linteresse per la cultura nei giovani. Diverso ritenuto, invece, il ruolo dellambiente familiare e sociale. I francesi (78%) e gli italiani (74%) considerano lambiente familiare e sociale un elemento che favorisce linteresse per la cultura in modo quasi doppio rispetto ai tedeschi (41%) e agli inglesi (37%). Inoltre, in Italia e Francia, lambiente familiare e sociale si colloca al secondo posto come fattore che favorisce linteresse della cultura nei giovani, mentre in Germania e Regno Unito allultimo posto. In tale contesto, i tedeschi, gli inglesi e gli americani pensano che la scuola favorisca maggiormente linteresse per la cultura, rispetto allambiente familiare e sociale. Infine, le amicizie sono considerate trasversalmente un fattore importante per lo sviluppo dellinteresse dei giovani per la cultura, con percentuali comprese tra il 54% della Germania e il 69% dellItalia e della Francia.
147
Leconomia dei beni culturali e ambientali.
Una visione sistemica e integrata
Figura 15 Aspetti che favoriscono linteresse dei giovani per la cultura: confronto internazionale Fonte: elaborazione The European House-Ambrosetti, 2010
6.2.4.
Fattori che scoraggiano la partecipazione ad attivit culturali
Sovente la partecipazione a eventi e manifestazioni culturali scoraggiata da alcuni fattori o aspetti che rendono in particolar modo difficoltosa, o meno agevole, una normale fruizione delle attivit culturali. Per comprendere meglio la natura dei fattori ostativi stato chiesto, al campione rappresentativo di ogni Paese considerato, di indicare i tre elementi ritenuti pi negativi, cio che scoraggiano maggiormente la partecipazione alle attivit culturali, tra i seguenti: - prezzo elevato; - biglietterie inefficienti; - code allingresso, affollamento; - difficolt nei trasporti o a trovare parcheggio; - orari; - giorni di apertura; - mancanza di guide adeguate o cartelli, materiale esplicativo; - mancanza di punti di riposo, di ristoro; - altro/non saprei. I risultati non sono sorprendenti, ma restano interessanti. Il fattore che scoraggia maggiormente la partecipazione ad attivit culturali il prezzo elevato. Nello specifico, oltre 6 italiani su 10 indicano il prezzo elevato come un ostacolo alla partecipazione ad attivit culturali. A seguire si collocano le code allingresso e laffollamento dei locali con il 40% circa, mentre la difficolt nei trasporti o limpossibilit a trovare un parcheggio nelle vicinanze si attesta al 37% circa.
148
6. Le principali evidenze emerse dalla survey nazionale e internazionale sul settore culturale e creativo
Figura 16 Fattori che scoraggiano la partecipazione ad attivit culturali: totale popolazione Italia Fonte: elaborazione The European House-Ambrosetti, 2010
I giorni e gli orari dapertura sono stati indicati solo dal 17-18% degli intervistati. Lanalisi regionale conferma il prezzo elevato come principale fattore ostativo, seppure con percentuali differenti tra le diverse Regioni che vanno dal 70% dei rispondenti in Piemonte al 44% dei rispondenti in Molise. In tutte le Regioni, ad eccezione del Molise, pi di un cittadino su due indica il prezzo come ostacolo alla fruizione della cultura. Analizzando il campione per sesso, fasce det e livelli di educazione non si rilevano differenze statisticamente significative.
Figura 17 Fattori che scoraggiano la partecipazione ad attivit culturali: risultati per Regione di appartenenza Fonte: elaborazione The European House-Ambrosetti, 2010
In tutte le Regioni si confermano, inoltre, al secondo e al terzo posto, le code allingresso/laffollamento e la difficolt nei trasporti come principali elementi che scoraggiano la partecipazione alle attivit culturali.
149
Leconomia dei beni culturali e ambientali.
Una visione sistemica e integrata
Anche a livello internazionale la sensibilit al prezzo il fattore ostativo principale come in Italia, ma con percentuali differenti. In Francia il prezzo elevato indicato da quasi il 90% dei cittadini, mentre in Spagna dal 68% circa del campione.
Figura 18 Fattori che scoraggiano la partecipazione ad attivit culturali: confronto internazionale Fonte: elaborazione The European House-Ambrosetti, 2010
Da questa rilevazione emerge come in Italia il fattore prezzo elevato, seppur ritenuto elemento negativo e scoraggiante nella fruizione della cultura per circa il 60% degli italiani, sia meno sentito rispetto agli altri Paesi utilizzati come benchmark. Per verificare tale risultato si proceduto ad una analisi dei prezzi di ingresso per alcuni dei pi importanti musei situati nei Paesi oggetto danalisi. Pur consapevoli della non rappresentativit statistica del campione utilizzato, il dato di proxy favorisce linterpretazione dei risultati del sondaggio. I prezzi dei biglietti di ingresso, relativi ad un ingresso standard per una giornata, sono stati rilevati attraverso i siti internet ufficiali dei musei. In genere il prezzo massimo corrisponde al prezzo pieno pagato da un adulto, mentre il prezzo minimo si riferisce alla riduzione che spetta ai bambini2. Se si esclude la Francia, dalle rilevazioni empiriche emerge come la percezione del prezzo elevato come fattore negativo negli USA e nel Regno Unito sia giustificata dalla presenza effettiva di prezzi di ingresso pi elevati rispetto a Italia, Germania e Spagna. Un caso a parte rappresentato dalla Francia, dove quasi il 90% del campione (percentuale pi elevata tra tutte quelle registrate) lamenta il prezzo elevato come un fattore negativo e che scoraggia la partecipazione a eventi culturali, ma in realt la Francia mostra, insieme allItalia e alla Germania, i prezzi pi bassi.
Le rilevazioni sono state effettuate il 14 ottobre 2010. Per il calcolo dei prezzi dei biglietti nel Regno Unito e negli USA stato utilizzato il tasso di cambio ufficiale tra lEuro e la Sterlina e lEuro e il Dollaro del 14 ottobre 2010 fornito dalla Banca Centrale Europea.
150
6. Le principali evidenze emerse dalla survey nazionale e internazionale sul settore culturale e creativo
Tabella 1 Prezzi di ingresso in alcuni musei/gallerie darte nei Paesi benchmark Fonte: elaborazione The European House-Ambrosetti sui siti web delle istituzioni museali analizzate, ottobre 2010
Nella tabella precedente sono riportati i nomi dei musei analizzati e dei prezzi di ingresso rilevati dai siti internet, mentre nella figura successiva si riporta lo schema graficamente con levidenziazione dei prezzi medi minimi e massimi registrati e della media generale.
Figura 19 Prezzi di ingresso in alcuni musei/gallerie darte nei Paesi benchmark Fonte: elaborazione The European House-Ambrosetti, 2010
151
Leconomia dei beni culturali e ambientali.
Una visione sistemica e integrata
Come si pu osservare, con un prezzo medio di 7,3 Euro, lItalia si colloca sostanzialmente in linea con la Francia e al di sotto dei prezzi registrati nel Regno Unito e soprattutto negli Stati Uniti. Fra gli altri fattori ostativi indagati a livello nazionale, le code allingresso e laffollamento sono elementi negativi percepiti da quasi la met dei francesi, da oltre il 40% dei tedeschi e dal 40% degli italiani. Nel Regno Unito la percentuale di persone che lamentano code allingresso e affollamento si attesta al 37% circa, mentre negli USA tale percentuale scende sotto il 30% e in Spagna si attesta al 25% circa. Le difficolt nei trasporti, invece, sono un elemento che scoraggia la fruizione delle attivit culturali per il 45% circa degli inglesi, il 37% degli italiani e il 35% degli americani. In Francia tale percentuale scende e si attesta al 29% circa, in Spagna al 25% e in Germania scende ancora e si attesta al 19% circa. in ogni caso evidente che lattenuazione, o rimozione, dei fattori ostativi necessiti di uno sforzo congiunto a livello di sistema che interessi sia gli amministratori pubblici territoriali, sia i gestori e gli organizzatori degli eventi e delle manifestazioni culturali.
6.2.5.
Interesse per gli eventi culturali della propria citt/area di residenza
Con lobiettivo di comprendere il livello di soddisfazione dei cittadini relativamente allofferta culturale stato chiesto di attribuire un giudizio sul livello di interesse degli eventi culturali che avvengono nella propria citt o area di residenza. Le possibili risposte erano: molto interessato, abbastanza interessato, poco interessato, per niente interessato e non saprei. Si assume che livelli di interesse molto alti costituiscano una proxy del livello di soddisfazione dei cittadini per lofferta culturale.
Figura 20 Interesse per gli eventi culturali della propria citt/area di appartenenza: totale popolazione Italia Fonte: elaborazione The European House-Ambrosetti, 2010
Dai risultati emerge con forza come quasi il 70% degli italiani dichiara di trovare interessanti (molto + abbastanza) gli eventi culturali che avvengono nella propria citt o area di residenza. Il restante 30% circa dichiara di trovare poco o per niente interessanti gli eventi culturali che avvengono nella provincia di residenza.
152
6. Le principali evidenze emerse dalla survey nazionale e internazionale sul settore culturale e creativo
Alcune differenze emergono se si considerano le fasce di et. Infatti, se si restringe lanalisi sui giovani, cio sugli individui in et compresa tra ai 18 e i 24 anni, la percentuale di chi si dichiara soddisfatto dellofferta culturale scende di circa 10 punti percentuali e si attesta al 60%. Pertanto, quasi il 40% dei giovani in et compresa tra i 18 e i 24 anni trova poco o per niente interessanti gli eventi culturali che avvengono nella propria citt o area di residenza.
Figura 21 Interesse per gli eventi culturali della propria citt/area di appartenenza: risultati per fasce di et, Italia Fonte: elaborazione The European House-Ambrosetti, 2010
Lofferta di eventi e attivit culturali sembra maggiormente in sintonia con le aspettative dei cittadini over 45. Sopra questa soglia, infatti, il livello di soddisfazione stabile e si attesta mediamente sopra il 70%. Le fasce pi giovani della popolazione esprimono minori livelli di soddisfazione dellofferta culturale del proprio territorio: dichiara, infatti, di essere soddisfatto dellofferta culturale, il 65% degli individui in et compresa tra i 35 e i 54 anni, il 63% degli individui in et compresa tra i 25 e i 34 anni, e il 58% degli individui in et compresa tra i 18 e i 24 anni. Lanalisi regionale consente di cogliere alcune prospettive differenti di lettura tra le varie aree dItalia. A livello complessivo, in tutte le Regioni italiane la percentuale di cittadini che dichiarano di essere soddisfatti dellofferta culturale del territorio stabilmente sopra il 50%. La Regione che esprime maggiore livello di soddisfazione lEmilia Romagna con l83% circa, mentre sul fronte opposto si posiziona lAbruzzo con il 53% circa. Analizzando i cittadini che si dichiarano molto soddisfatti dellofferta culturale della propria citt o territorio di appartenenza, invece, i risultati cambiano sensibilmente. La prima Regione il Lazio, con quasi il 30% dei cittadini che si dichiarano molto soddisfatti dellofferta culturale (valore doppio rispetto alla media italiana che si attesta al 15%), la seconda la Toscana con oltre il 20% e intorno al 19% si colloca la Campania al terzo posto e il Veneto al quarto posto. La Lombardia, che risulta la seconda Regione in Italia sommando le risposte molto interessato e abbastanza interessato, diventa una delle ultime regioni se si considerano solamente i cittadini che dichiarano di essere molto interessati. Nello specifico circa il 10% dei lombardi si dichiara molto soddisfatto dellofferta culturale della propria citt o area di residenza. Tale valore inferiore alla media nazionale (15%) e vale il quartultimo posto per la Lombardia, davanti solamente ad Abruzzo, Calabria e Liguria.
153
Leconomia dei beni culturali e ambientali.
Una visione sistemica e integrata
Figura 22 Interesse per gli eventi culturali della propria citt/area di appartenenza: risultati per Regione di appartenenza Fonte: elaborazione The European House-Ambrosetti, 2010
Incrociando i dati ottenuti del sondaggio con quelli del Florens Index, i cui risultati sono stati presentati nel Capitolo 3, emergono alcuni parallelismi significativi.
Figura 23 Interesse per gli eventi culturali della propria citt/area di appartenenza: confronto con il Florens Index Fonte: elaborazione The European House-Ambrosetti, 2010
I risultati mostrano come le prime tre Regioni per grado dinteresse da parte dei cittadini (Emilia Romagna, Lombardia e Veneto) circa gli eventi che avvengono nel proprio territorio di riferimento si collocano anche in alto nelle valutazioni fornite dal Florens Index che stima in via diretta, o tramite proxy, il livello di sviluppo comparato del settore culturale e creativo territoriale in ogni Regione italiana.
154
6. Le principali evidenze emerse dalla survey nazionale e internazionale sul settore culturale e creativo
A livello complessivo emerge una certa correlazione (che si pu osservare anche graficamente) tra i valori ottenuti dal Florens Index e i risultati della survey, relativi al livello di interesse per gli eventi culturali della propria citt o area di residenza. Analizzando, inoltre, le 5 Regioni con i valori di Florens Index pi contenuti, se ne trovano ben 3 (Calabria, Molise e Basilicata) che risultano anche nelle ultime 5 posizioni relativamente allinteresse dichiarato dai propri cittadini per gli eventi culturali che avvengono nel proprio territorio di riferimento. In questo contesto, anche con riferimento alla Regione Toscana si nota una certa relazione tra Florens Index e risultati della survey: la Toscana posizionata al 4 posto nel Florens Index e si colloca 7 in Italia come livello di soddisfazione dei cittadini dellofferta culturale con una percentuale che si attesta al 74,9%. Dallanalisi del livello di soddisfazione degli eventi culturali che avvengono nella propria citt o area di residenza, per sesso e livelli di educazione non si sono rilevate particolari differenze.
Figura 24 Interesse per gli eventi culturali della propria citt/area di appartenenza: confronto internazionale Fonte: elaborazione The European House-Ambrosetti, 2010
A livello internazionale, i francesi esprimono il livello di soddisfazione pi elevato con una percentuale superiore al 70%. Subito dietro si collocano i cittadini italiani, tedeschi e britannici con percentuali comprese tra il 68% e il 65%, mentre gli americani (55%) e gli spagnoli (53%) risultano i meno soddisfatti delle attivit culturali che avvengono nelle rispettive aree di residenza. Infatti, oltre il 40% degli spagnoli e degli americani dichiara di trovare poco e per niente interessanti gli eventi culturali che avvengono nella propria area di residenza, mentre negli altri Paesi tale percentuale si attesta tra il 25% della Francia e il 32% del Regno Unito. Altro tema indagato nellanalisi empirica relativo allevoluzione dellinteresse dei cittadini verso la cultura. Nella costruzione della survey si sono, quindi, inserite due domande specifiche sul tema: la prima relativa allevoluzione dellinteresse verso gli eventi culturali negli ultimi 5 anni, per avere una idea delle dinamiche passate, e la seconda relativa alla previsione di spesa per attivit e beni culturali su un orizzonte di 5 anni. In entrambe le domande il campione danalisi poteva rispondere indicando un aumento, una riduzione o una situazione stabile, relativa allinteresse negli ultimi 5 anni e alle previsioni di spesa futura a 5 anni.
155
Leconomia dei beni culturali e ambientali.
Una visione sistemica e integrata
6.2.6. Interesse verso la cultura negli ultimi 5 anni
Il 30% degli italiani afferma di aver aumentato linteresse per la cultura negli ultimi 5 anni; solo l8% dichiara di averlo diminuito, mentre il 61% dichiara di averlo mantenuto costante. In altre parole, negli ultimi 5 anni: - meno di 1 italiano su 10 dichiara di aver ridotto il proprio interesse nei confronti di attivit culturali; - 3 su 10 dichiarano di aver aumentato il proprio interesse nei confronti di attivit culturali; - 6 italiani su 10, infine, dichiarano di aver mantenuto lo stesso livello di interesse.
Figura 25 Interesse verso la cultura negli ultimi 5 anni: totale popolazione Italia Fonte: elaborazione The European House-Ambrosetti, 2010
Differenze consistenti si evidenziano analizzando le risposte per fasce di et. Oltre il 50% dei giovani (tra i 18 e i 24 anni), dichiara di aver aumentato linteresse per eventi culturali. Questa percentuale quasi doppia rispetto a chi ha unet compresa tra 35 e 64 anni (28% di media) e quasi tripla rispetto a chi ha pi di 64 anni (17%). Si tratta di un dato abbastanza logico dato il tasso di apprendimento dellet evolutiva. A livello generale, anche includendo tra i giovani la fascia di et 25-34, emerge come questi ultimi mostrino un interesse per la cultura superiore alle altre fasce di et. Raggiunti i 35 anni, invece, sembra che mediamente linteresse per la cultura si stabilizzi e tenda ad aumentare di meno. Infine, sopra i 64 anni si registra un interesse crescente per la cultura solo per il 17% circa degli intervistati. In sintesi, con gli anni della maturit anche linteresse per la cultura sembra stabilizzarsi e tende invece a diminuire negli over 64. Essendo una componente fondamentale dello sviluppo del capitale umano, linteresse per la cultura sembra seguire in modo sintotico la curva di esperienza dellessere umano.
156
6. Le principali evidenze emerse dalla survey nazionale e internazionale sul settore culturale e creativo
Figura 26 Interesse verso la cultura negli ultimi 5 anni: risultati per fasce di et, Italia Fonte: elaborazione The European House-Ambrosetti, 2010
Lanalisi per livelli di educazione evidenzia una relazione positiva tra interesse per la cultura e titolo di studio conseguito. Ci dimostra quanto sia essenziale incentivare la crescita del capitale umano innalzando il livello complessivo di accesso allistruzione terziaria, anche per alimentare il circuito virtuoso che alimenta il capitale culturale e creativo.
Figura 27 Interesse verso la cultura negli ultimi 5 anni: risultati per livelli di educazione, Italia Fonte: elaborazione The European House-Ambrosetti, 2010
Analizzando i dati per Regione di appartenenza si nota una certa diversit nelle risposte fornite.
157
Leconomia dei beni culturali e ambientali.
Una visione sistemica e integrata
Le Regioni in cui i cittadini hanno dichiarato con maggiore frequenza di aver aumentato linteresse negli ultimi 5 anni sono le Marche con il 40% circa, la Sardegna con il 39% circa e la Puglia con il 37,5%. Agli ultimi posti si colloca la Sicilia con il 21% circa, la Lombardia con il 23% circa e la Liguria con il 25% circa. Questi risultati non indicano una classifica di intensit/quantit di interesse verso la cultura negli ultimi 5 anni, ma devono essere letti in ottica dinamica e di tendenza. Infatti, nonostante solo 1/5 circa dei siciliani e dei lombardi abbiano dichiarato di aver aumentato il proprio interesse nei confronti della cultura, ci non significa che non si interessino di cultura, ma solo che tale interesse non aumentato negli ultimi 5 anni. Non si evidenziano differenze significative nellanalisi dei dati per sesso.
Figura 28 Interesse verso la cultura negli ultimi 5 anni: risultati per Regione di appartenenza Fonte: elaborazione The European House-Ambrosetti, 2010
Osservando i dati relativi al confronto internazionale lItalia si colloca al terzo posto dietro a Spagna e Regno Unito.
Figura 29 Interesse verso la cultura negli ultimi 5 anni: confronto internazionale Fonte: elaborazione The European House-Ambrosetti, 2010
158
6. Le principali evidenze emerse dalla survey nazionale e internazionale sul settore culturale e creativo
Il 45% dei cittadini spagnoli e il 38% dei cittadini britannici dichiara di aver aumentato significativamente il proprio interesse per eventi culturali. In Francia, negli USA e soprattutto in Germania, la quota di quanti dichiarano di aver diminuito il proprio interesse per eventi culturali si attesta su un valore superiore al 10%, raggiungendo quasi il 14% in Germania.
6.2.7.
Spesa verso la cultura nei prossimi 5 anni
Cos come il 30% degli italiani ha dichiarato che il proprio interesse per la cultura aumentato negli ultimi 5 anni, si attesta anche al 30% circa la percentuale di chi prevede di aumentare la spesa per i consumi culturali nei prossimi 5 anni. In tale contesto, oltre la met degli italiani prevede che la spesa per i consumi culturali rimarr uguale, mentre solo il 10% pensa che diminuir.
Figura 30 Interesse verso la cultura nei prossimi 5 anni: totale popolazione Italia Fonte: elaborazione The European House-Ambrosetti, 2010
A livello generale i dati di previsione della spesa a 5 anni mostrano percentuali di aumento, stabilit e riduzione simili a quelli registrati dallinteresse mostrato negli ultimi 5 anni dagli italiani. Con riferimento alle fasce det, si evidenzia come quasi il 50% dei giovani, in et compresa tra i 18 e i 24 anni, prevede che la propria spesa per i consumi culturali aumenter. Questa percentuale si attesta al 43% circa tra i giovani in et compresa tra i 25 e i 34 anni. Con laumentare dellet si registra una tendenza al mantenimento o alla riduzione della propria spesa in consumi culturali. Dichiarano che aumenteranno la propria spesa per i consumi culturali il 33% circa degli individui in et compresa tra 35 e 44 anni, il 30% circa degli individui in et compresa tra 45 e 64 anni e il 15% circa degli individui con unet superiore ai 64 anni. Considerando tra i giovani anche la fascia 25-34, la percentuale di coloro che dichiarano di aumentare la spesa verso i consumi culturali si attesta al 45%, rispetto al 30% circa dei cittadini in et compresa tra i 35 e i 64 anni.
159
Leconomia dei beni culturali e ambientali.
Una visione sistemica e integrata
Figura 31 Spesa verso la cultura nei prossimi 5 anni: risultati per fasce di et, Italia Fonte: elaborazione The European House-Ambrosetti, 2010
Anche i dati per fascia det, relativi alla spesa nei prossimi 5 anni per i consumi culturali, appaiono allineati allinteresse mostrato negli ultimi 5 anni verso le attivit culturali. In sintesi, circa il 50% dei giovani ha dichiarato di aver aumentato, negli ultimi 5 anni, il proprio interesse per la cultura e dichiara che aumenter, nei prossimi 5, i propri consumi culturali. Ci avviene anche per il 40% degli individui in et compresa tra i 25 e i 35 anni e il 30% degli individui in et compresa tra i 35 e i 64 anni. Situazione analoga si ottiene analizzando i risultati per titolo di studio. Come stata evidenziata una relazione positiva tra titolo di studio e aumento dellinteresse per le attivit culturali negli ultimi 5 anni, cos si registra una simile relazione positiva tra livello di educazione e previsioni sullaumento di spesa nei consumi culturali nei prossimi 5 anni.
Figura 32 Interesse verso la cultura nei prossimi 5 anni: risultati per livelli di educazione, Italia Fonte: elaborazione The European House-Ambrosetti, 2010
160
6. Le principali evidenze emerse dalla survey nazionale e internazionale sul settore culturale e creativo
Quasi il 45% degli italiani con un livello di educazione alto prevede che la propria spesa in consumi culturali aumenter, contro il 34% di chi ha un livello di educazione medio e il 22% circa di chi ha un livello di educazione basso. A livello regionale i cittadini con una maggiore propensione alla spesa futura in cultura sono residenti in Molise. Sorprende trovare a fondo classifica il Veneto, la Lombardia, Toscana e la Sicilia.
Figura 33 Interesse verso la cultura nei prossimi 5 anni: risultati per Regione di appartenenza Fonte: elaborazione The European House-Ambrosetti, 2010
da rilevare come tra le ultime quattro Regioni nella classifica del livello di interesse per eventi culturali negli ultimi 5 anni (Sicilia, Lombardia, Liguria e Toscana), ben tre sono anche negli ultimi quattro posti della classifica relativa alla previsione di aumento di spesa nei consumi culturali: Sicilia, Toscana e Lombardia. Analogamente, due delle prime quattro Regioni nella classifica del livello di interesse per eventi culturali negli ultimi 5 anni (Marche, Sardegna, Puglia, Basilicata), sono anche nelle prime posizioni della classifica di propensione allaumento della spesa in cultura, cio Sardegna e Basilicata.
Figura 34 Relazione tra interesse per la cultura nei prossimi 5 anni e PIL pro capite Fonte: elaborazione The European House-Ambrosetti, 2010
161
Leconomia dei beni culturali e ambientali.
Una visione sistemica e integrata
Contrariamente a quanto possa sembrare a livello intuitivo, la propensione verso la spesa culturale nei prossimi 5 anni non sembra essere correlata alla ricchezza prodotta. Regioni con il PIL pro capite pi elevato non mostrano una maggiore propensione alla spesa culturale. questo il caso della Lombardia, del Veneto e della Toscana. Viceversa, ci sono Regioni con PIL pro capite inferiore alla media nazionale che mostrano una maggiore propensione per la spesa culturale, come nel caso della Basilicata e della Puglia. Non si evidenziano differenze significative nellanalisi dei dati per sesso. Nellanalisi internazionale emerge una maggiore propensione alla spesa futura in cultura per Spagna (41,9%) e Regno Unito (41,3%). Seguono gli Stati Uniti (37,3%), mentre la Germania mostra la minore propensione ad un aumento della spesa futura in cultura (24,2).
Figura 35 Interesse verso la cultura nei prossimi 5 anni: confronto internazionale Fonte: elaborazione The European House-Ambrosetti, 2010
6.2.8.
Modalit di reperimento delle informazioni sulle attivit culturali
Per capire con quali modalit e come le informazioni riguardanti le attivit culturali fossero veicolate e indirizzate al pubblico, stato chiesto di indicare i mezzi utilizzati, nel corso dellultimo anno, per cercare informazioni sulle attivit culturali. Gli intervistati avevano a disposizione delle risposte chiuse ed stato chiesto loro di indicare al massimo tre risposte in base alla frequenza di utilizzo. Le risposte possibili erano le seguenti: - non mi mai capitato di dover cercare informazioni culturali nellultimo anno; - siti internet di operatori turistici; - siti internet di citt, Comuni, Regioni; - siti internet dedicati al museo, mostra, evento a cui era interessato; - blog; - brochure presso uffici turistici; - pubblicit su quotidiani e periodici; - TV, televideo, servizi in digitale;
162
6. Le principali evidenze emerse dalla survey nazionale e internazionale sul settore culturale e creativo
- direttamente presso agenzie viaggi, di prenotazioni biglietti; - direttamente nella struttura dove si svolgeva; - altro; - non saprei. Il risultato principale che emerge dallanalisi che internet il mezzo dinformazione principale per reperire informazioni sugli eventi culturali.
Figura 36 Modalit di reperimento delle informazioni: totale popolazione Italia Fonte: elaborazione The European House-Ambrosetti, 2010
Quasi il 60% degli italiani dichiara, infatti, di cercare informazioni relative a eventi culturali sui siti internet delle citt/Regioni, quasi il 55% afferma di cercarli sui siti internet dei musei, mostre o eventi a cui interessato e un ulteriore 33% circa dichiara di cercarle sui siti internet degli operatori turistici. Meno del 20% utilizza le brochure degli uffici turistici, circa il 15% cerca informazioni sulle pagine pubblicitarie dei giornali e circa il 10% le cerca in televisione e/o direttamente nella struttura dove si svolge levento culturale. Concentrando il focus esclusivamente su chi ha risposto che utilizza internet e analizzando i risultati per fasce di et si evidenzia un dato per certi versi sorprendente: internet utilizzato in modo significativo anche tra le fasce di et pi elevate. In media, infatti, il 40% dei cittadini con et superiore ai 64 anni utilizza internet per reperire informazioni culturali, contro una media del 50% dei giovani in et compresa tra i 18 e i 35 anni. I cittadini in et compresa tra i 45 e i 54 anni sono quelli che dichiarano di utilizzare maggiormente internet per ottenere informazioni sugli eventi e le manifestazioni culturali (53% in media).
163
Leconomia dei beni culturali e ambientali.
Una visione sistemica e integrata
Figura 37 Modalit di reperimento delle informazioni: risultati per fasce det, Italia Fonte: elaborazione The European House-Ambrosetti, 2010
Di rilievo appaiono anche i risultati riportati nel grafico successivo che analizza limpatto dei blog, degli uffici turistici e delle agenzie di viaggio. In questo caso lanalisi per fasce det mostra differenze significative. I blog sono utilizzati maggiormente dai giovani, mentre i cittadini con pi di 64 anni tendono a recarsi presso uffici turistici o agenzie di viaggio.
Figura 38 Modalit di reperimento delle informazioni: risultati per fasce det, Italia Fonte: elaborazione The European House-Ambrosetti, 2010
164
6. Le principali evidenze emerse dalla survey nazionale e internazionale sul settore culturale e creativo
Nello specifico, la consultazione di blog per il reperimento di informazioni culturali correlata negativamente allet (ad un aumento dellet corrisponde una minore consultazione dei blog). I blog sono utilizzati dal 15% dei giovani in et compresa tra i 18 e i 24 anni, mentre tale percentuale si attesta al 3% circa tra gli individui con oltre 64 anni. Viceversa, le brochure esposte presso gli uffici turistici e le informazioni presso le agenzie di viaggio sono utilizzate in modo maggiore dai cittadini over 64, che ne usufruiscono rispettivamente con una percentuale del 28% circa e del 15% circa. Poich internet il mezzo pi utilizzato, si indagata la relazione tra livello di educazione e utilizzo di questo strumento per la ricerca di informazioni culturali. I cittadini con livelli di educazione pi elevati utilizzano maggiormente internet come mezzo di reperimento di informazioni su eventi e manifestazioni culturali. Mediamente circa il 40% della popolazione con un livello di educazione basso utilizza internet come mezzo per reperire informazioni su eventi e manifestazioni culturali. Tale percentuale sale al 50% nei cittadini con un livello di educazione medio e al 60% circa in quelli con un livello di educazione alto.
Figura 39 Modalit di reperimento delle informazioni: risultati per livelli di educazione, Italia Fonte: elaborazione The European House-Ambrosetti, 2010
Lanalisi dei risultati relativi alle modalit di reperimento delle informazioni effettuata per sesso e Regione di appartenenza non ha riscontrato particolari evidenze. Il ruolo di internet come mezzo primario e di riferimento per reperire informazioni su eventi e attivit culturali si conferma anche dallanalisi internazionale. Internet il mezzo pi diffuso in tutti i Paesi considerati, anche se con alcune differenze. In Italia e in Spagna i cittadini tendono ad utilizzare maggiormente i siti internet degli operatori turistici e delle citt o Regioni, mentre nel Regno Unito e negli USA i cittadini tendono ad utilizzare maggiormente i siti internet dedicati alla mostra, al museo o allevento di interesse. In dettaglio, il 65% circa degli inglesi e degli americani utilizza i siti internet dedicati alla mostra, al museo o allevento dinteresse per reperire informazioni. Solo il 36% circa dei tedeschi si comporta nel medesimo modo. In Italia, Spagna e Francia il 55% circa dei cittadini utilizza i siti internet dei Comuni e delle Regioni per reperire informazioni su eventi culturali, contro il 34% degli americani e il 38% degli inglesi.
165
Leconomia dei beni culturali e ambientali.
Una visione sistemica e integrata
Altro dato interessate che oltre il 33% degli italiani utilizza i siti internet degli operatori turistici per reperire informazioni su eventi culturali, mentre tale mezzo utilizzato solamente dall11% circa degli americani.
Figura 40 Modalit di reperimento delle informazioni: confronto internazionale Fonte: elaborazione The European House-Ambrosetti, 2010
Gli spagnoli che utilizzano i blog sono circa il triplo dei tedeschi e degli inglesi. Con riferimento a brochure di uffici turistici e agenzie di viaggio le percentuali di cittadini che utilizzano questi strumenti per reperire informazioni su eventi culturali pressoch simile, ad eccezione della Francia dove marcatamente pi basso. Nel dettaglio, i blog sono utilizzati da oltre il 9% degli spagnoli, dal 7% circa degli italiani, francesi e americani. I tedeschi che utilizzano questo mezzo di reperimento delle informazioni sono solo il 3% circa. Le brochure presso gli uffici turistici sono utilizzate in percentuali simili tra i differenti stati, ad eccezione della Francia. I tedeschi utilizzano in modo maggiore rispetto agli altri le agenzie di viaggio per reperire informazioni su eventi culturali.
Figura 41 Modalit di reperimento delle informazioni: confronto internazionale Fonte: elaborazione The European House-Ambrosetti, 2010
166
6. Le principali evidenze emerse dalla survey nazionale e internazionale sul settore culturale e creativo
6.2.9.
Modalit di pagamento per eventi/attivit culturali
Un ulteriore aspetto indagato nellanalisi interessa le modalit di pagamento dei biglietti per la partecipazione a eventi o attivit culturali. stato quindi chiesto al campione di intervistati quale modalit di pagamento avessero utilizzato per la partecipazione ad uno spettacolo, concerto, opera, per lingresso ad un museo, mostra, sito archeologico, parco naturale, riserva, ecc.. Agli intervistati stato chiesto di scegliere 3 risposte, in base alla frequenza di utilizzo, da un elenco di risposte chiuse. Le risposte possibili erano le seguenti: - utilizzo internet per prenotare e pagare; - utilizzo internet per prenotare, ma pago allingresso; - telefono per prenotare e pago con bonifico bancario; - telefono per verificare la disponibilit e pago allingresso; - mi reco direttamente nel luogo e acquisto in biglietteria; - mi rivolgo allagenzia di prenotazione biglietti; - altro; - non saprei. Nonostante internet sia il mezzo pi utilizzato per reperire le informazioni, gli acquisti e i pagamenti vengono ancora effettuati presso la biglietteria. Quasi 4 italiani su 10 dichiarano di acquistare i biglietti per eventi culturali direttamente in biglietteria. Circa 1 italiano su 3, invece, dichiara di usare internet per prenotare e pagare. Rimane alta la percentuale di chi paga allingresso: il 18% utilizzare internet per prenotare, ma paga allingresso, e il 14% circa telefona per verificare la disponibilit, ma paga allingresso. Infine, il 13% circa si rivolge allagenzia di prenotazione biglietti.
Figura 42 Modalit di pagamento eventi/attivit culturali: totale nazionale Italia Fonte: elaborazione The European House-Ambrosetti, 2010
167
Leconomia dei beni culturali e ambientali.
Una visione sistemica e integrata
Analizzando i risultati per sesso emergono alcune differenze tra uomini e donne. Gli uomini utilizzano maggiormente internet per prenotare e pagare rispetto alle donne. Queste ultime, invece, si recano maggiormente in biglietteria o in agenzia viaggi. Pi precisamente, il 36% circa degli uomini dichiara di prenotare e pagare i ticket per fruire o partecipare a eventi culturali utilizzando internet, contro il 27% circa delle donne. Quasi il 39% di queste ultime si reca direttamente nel luogo di acquisto e in biglietteria, e il 15% circa in agenzia viaggi, contro rispettivamente il 36% circa e il 10% circa degli uomini.
Figura 43 Modalit di pagamento per eventi/attivit culturali: risultati per sesso, Italia Fonte: elaborazione The European House-Ambrosetti, 2010
Considerando solo chi ha risposto che utilizza internet per prenotare e pagare, e segmentando il campione per et, si evidenziano percentuali superiori al 30%, dai 18 ai 54 anni, con un picco del 38,7% nella fascia 25-34. La percentuale scende al 20% per i cittadini over 64.
Figura 44 Modalit di pagamento per eventi/attivit culturali: risultati per fasce det, Italia Fonte: elaborazione The European House-Ambrosetti, 2010
168
6. Le principali evidenze emerse dalla survey nazionale e internazionale sul settore culturale e creativo
Lanalisi per livello di educazione, sempre considerando chi ha risposto che utilizza internet per prenotare e pagare, fa emergere una correlazione positiva tra titolo di studio e modalit di pagamento e prenotazione via internet. Oltre il 42% degli italiani con un livello di educazione alto utilizza internet per prenotare e pagare la partecipazione a eventi culturali: si tratta di una percentuale doppia rispetto a chi ha un livello di educazione basso (22% circa).
Figura 45 Modalit di pagamento per eventi/attivit culturali: risultati livello di educazione, Italia Fonte: elaborazione The European House-Ambrosetti, 2010
Lanalisi regionale evidenzia, come spesso accade, alcune differenze significative nelle risposte fornite dagli intervistati. Quasi il 40% dei cittadini del Lazio dichiara di utilizzare internet per prenotare e pagare la partecipazione a un evento culturale (valore massimo a livello nazionale), contro il 24% dei cittadini della Calabria (valore minimo a livello nazionale).
Figura 46 Modalit di pagamento per eventi/attivit culturali: risultati per Regione di residenza Fonte: elaborazione The European House-Ambrosetti, 2010
169
Leconomia dei beni culturali e ambientali.
Una visione sistemica e integrata
A livello generale nelle Regioni del Sud Italia si utilizza meno internet come strumento per prenotare e pagare la partecipazione a un evento/attivit culturale. Il confronto internazionale evidenzia una maggiore propensione allacquisto tradizionale per italiani e francesi e una maggiore propensione allacquisto via internet per inglesi, spagnoli e americani. Lultimo posto dellItalia nellutilizzo di internet come strumento per prenotare e pagare la partecipazione a attivit culturali dipende, in parte, anche dalla minore diffusione delle carte di credito3 che sono necessarie per prenotare/pagare via internet.
Figura 47 Modalit di pagamento per eventi/attivit culturali: confronto internazionale Fonte: elaborazione The European House-Ambrosetti, 2010
Infine, sempre allinterno del confronto internazionale, lanalisi per sesso mostra come nei Paesi latini gli uomini utilizzino maggiormente internet per prenotare e pagare rispetto alle donne, mentre in Germania, nel Regno Unito e negli Stati Uniti il contrario; in altri termini, sono le donne ad utilizzare maggiormente internet per prenotare e pagare.
La minore diffusione delle carte di credito stata sottolineata, tra laltro, nellultimo rapporto del CRIF (Osservatorio sulle Carte di edito).
170
6. Le principali evidenze emerse dalla survey nazionale e internazionale sul settore culturale e creativo
Figura 48 Modalit di pagamento per eventi/attivit culturali: risultati per sesso, confronto internazionale Fonte: elaborazione The European House-Ambrosetti, 2010
6.2.10. Attitudine verso le nuove tecnologie
Lindagine ha affrontato anche il tema relativo allinteresse verso lutilizzo delle nuove tecnologie e in particolare dei servizi georeferenziati. stato chiesto al campione dintervistati di immaginare un servizio, attivabile a piacimento dallutente, che segnali gratuitamente sul cellulare, ad esempio tramite un sms, ogni volta che si passa nei pressi di qualcosa di interessante da visitare o che segnali eventi e manifestazioni in atto. Successivamente si chiesto di indicare il grado di interesse per un servizio di questo tipo scegliendo tra le seguenti risposte: - molto interessato; - abbastanza interessato; - poco interessato; - per niente interessato; - non saprei. I risultati mostrano come il 75% degli italiani dichiari di essere interessato ad un servizio gratuito che segnali sul telefono portatile la vicinanza di luoghi di particolare interesse culturale e/o manifestazioni in atto nel periodo. Circa 1 italiano su 4, invece, dichiara di non essere interessato.
171
Leconomia dei beni culturali e ambientali.
Una visione sistemica e integrata
Figura 49 Servizio di segnalazione gratuito sul portatile: totale popolazione Italia Fonte: elaborazione The European House-Ambrosetti, 2010
Lanalisi dei risultati per fasce det mostra che il 40% circa dei giovani, di et compresa tra i 28 e i 34 anni, si dichiara molto interessato ad un servizio di segnalazione gratuito sul telefono portatile, contro mediamente il 21% circa di chi ha pi di 55 anni. Se si somma, invece, la percentuale di cittadini che dichiarano di essere molto interessati o abbastanza interessati ad un servizio di questo tipo, si evince come in ogni fascia det chi si dichiara molto o abbastanza interessato rappresenta una ampia maggioranza.
Figura 50 Servizio di segnalazione gratuito sul portatile: risultati per fasce di et, Italia Fonte: elaborazione The European House-Ambrosetti, 2010
172
6. Le principali evidenze emerse dalla survey nazionale e internazionale sul settore culturale e creativo
Con riferimento al livello di educazione, i risultati mostrano una relazione positiva tra livello di istruzione e interesse elevato nei confronti del servizio. Si dichiara molto interessato al servizio di segnalazione gratuito sul telefono portatile il 35% circa degli italiani con un livello di educazione alto, il 32% di chi ha un livello di educazione medio e il 25% circa di chi ha un livello di educazione basso. Se si sommano le percentuali di chi ha risposto molto interessato e chi ha risposto abbastanza interessato, le differenze nelle risposte tra i livelli di educazione diminuiscono. Infatti, si dichiara molto o abbastanza interessato, quasi il 78% dei cittadini con un livello di educazione alto, quasi il 76% dei cittadini con un livello di educazione medio e il 71,5% dei cittadini con un livello di educazione basso.
Figura 51 Servizio di segnalazione gratuito sul portatile: risultati per livelli di educazione, Italia Fonte: elaborazione The European House-Ambrosetti, 2010
Dallanalisi dei risultati stratificati per sesso e Regione di residenza non sono emerse particolari evidenze. Dal confronto internazionale emergono, invece, alcuni aspetti che meritano di essere sottolineati. I cittadini italiani (75% circa), spagnoli (56% circa) e inglesi (54% circa) sembrano i pi interessati a servizi georeferenziati che segnalino la vicinanza di luoghi di particolare interesse culturale; al contrario, quelli francesi (46% circa), tedeschi (41% circa) e americani (35% circa) non sembrano particolarmente interessati ad un servizio di questo tipo. In Italia e Spagna, rispettivamente il 6% circa e il 12% dei cittadini circa non per niente interessato a un servizio di questo tipo. In Francia, Germania e Regno Unito, tale percentuale si attesta al 24% circa e negli USA raggiunge il 33% circa. Da notare che per i Paesi analizzati lItalia ha il maggiore livello di penetrazione dei telefoni cellulari: 151% secondo gli ultimi dati contro il 130% nel Regno Unito, 127% in Germania, 112% in Spagna, 95% in Francia e 92% negli USA.
173
Leconomia dei beni culturali e ambientali.
Una visione sistemica e integrata
Figura 52 Servizio di segnalazione gratuito sul portatile: confronto internazionale Fonte: elaborazione The European House-Ambrosetti, 2010
6.2.11. Il finanziamento delle attivit culturali
A completamento della survey, dopo aver indagato la conoscenza dellofferta culturale, i comportamenti dei cittadini verso la cultura e lutilizzo di nuove tecnologie per la fruizione di beni e attivit culturali, stata analizzata la componente relativa alle modalit di finanziamento della cultura. stato chiesto al campione di indicare quale sistema di finanziamento ritenesse pi appropriato. Le risposte possibili erano le seguenti: - finanziamento esclusivamente da denaro pubblico; - finanziamento sia da denaro pubblico che da privati; - finanziamento esclusivamente privato; - non saprei. Oltre il 75% degli italiani ritiene che le attivit culturali debbano essere finanziate attraverso la compartecipazione di risorse pubbliche e risorse private. Il 15% circa pensa che debbano essere finanziate solo con denaro pubblico mentre il 4% circa pensa che debbano essere finanziate esclusivamente da privati.
174
6. Le principali evidenze emerse dalla survey nazionale e internazionale sul settore culturale e creativo
Figura 53 Finanziamento delle attivit culturali: totale popolazione Fonte: elaborazione The European HouseAmbrosetti, 2010
Dallanalisi dei risultati per livello di educazione emerge che quasi l85% degli italiani con un livello di educazione alto ritiene che le attivit culturali possano essere finanziate dalla compartecipazione di denaro pubblico e privato, contro il 71% circa di chi ha un livello di educazione basso. Il 10% degli italiani con un livello di educazione elevato pensa che le attivit culturali debbano essere finanziate solo da denaro pubblico. Tale percentuale si attesta a quasi il 16% tra chi ha un livello di educazione basso. Solo il 3,8% di chi ha un livello di educazione elevato, inoltre, pensa che le attivit culturali debbano essere finanziate solo da denaro privato, contro il 4,5% di chi ha un livello di educazione basso. In sintesi, chi ha un livello di educazione elevato non pensa che la cultura debba essere finanziata solo da denaro pubblico, o solo da denaro privato, ma ritiene che le attivit debbano essere finanziate prevalentemente con la partecipazione di denaro pubblico e privato.
Figura 54 Finanziamento delle attivit culturali: risultati per livello di educazione, Italia Fonte: elaborazione The European House-Ambrosetti, 2010
175
Leconomia dei beni culturali e ambientali.
Una visione sistemica e integrata
Dallanalisi regionale non emergono particolari differenze tra Regioni, poich la gran parte dei cittadini, indipendentemente dalla residenza, pensa che le attivit culturali debbano essere finanziate dalla compartecipazione di denaro pubblico e privato. Alcune differenze si notano, invece, dallanalisi per macro area regionale, da cui emerge una leggera prevalenza per il finanziamento tramite partecipazione pubblico privato nel Nord Ovest, Nord Est e Centro, rispetto al Sud e alle Isole. Nel Sud e nelle Isole pi elevata anche la percentuale dei cittadini che pensa che le attivit culturali debbano essere finanziate solo da denaro pubblico o solo da denaro privato.
Figura 55 Finanziamento delle attivit culturali: risultati per livello di educazione, Italia Fonte: elaborazione The European House-Ambrosetti, 2010
A livello internazionale oltre 3 cittadini su 4, in tutti i Paesi analizzati, pensano che le attivit culturali debbano essere finanziate dalla compartecipazione tra denaro pubblico e privato. Alcune differenze si riscontrano, tuttora, tra i Paesi latini e gli altri. Nei Paesi latini (Italia, Francia e Spagna) il 13% circa della popolazione pensa che le attivit culturali debbano essere finanziate esclusivamente con denaro pubblico. Tale percentuale si attesta al 6% circa in Germania e Regno Unito e al 3% circa negli USA. Negli USA si registra anche la quota maggiore di cittadini che pensano che le attivit culturali debbano essere finanziate esclusivamente da privati.
176
6. Le principali evidenze emerse dalla survey nazionale e internazionale sul settore culturale e creativo
Figura 56 Finanziamento delle attivit culturali: confronto internazionale Fonte: elaborazione The European House-Ambrosetti, 2010
Infine, con specifico riferimento al contesto italiano, stata chiesta ai componenti del campione la loro opinione sullintroduzione di normative fiscali che favoriscano donazioni e sponsorizzazioni di eventi e manifestazioni culturali da parte dei privati. L85% circa degli italiani si dichiarato favorevole e solo il 10% si detto contrario, con un 5% di indecisi. In altre parole, la quasi totalit degli italiani favorevole a introdurre ulteriori forme di incentivo, a livello fiscale, per promuovere donazioni e sponsorizzazioni di attivit culturali.
6.3. considerazioni di sintesi
6.3.1. Sintesi delle principali evidenze sui giovani
Uno degli obiettivi del lavoro capire le esigenze dei giovani, i loro comportamenti e le loro aspettative in ambito culturale. Per focalizzare meglio alcuni punti, che sono emersi durante lanalisi dei risultati del sondaggio, sono state predisposte delle rappresentazioni grafiche, in grado di fornire una lettura trasversale sui temi trattati, con un focus sui cittadini in et compresa tra 18 e 24 anni. Concretamente, ponendo su base 100 il risultato medio dellItalia, si calcolato il valore relativo ai giovani su temi quali, linteresse per gli eventi culturali della propria citt, la parole che maggiormente si associano allidea di cultura, i fattori che scoraggiano la partecipazione a eventi culturali, linteresse passato e la previsione di spesa futura per la cultura, le modalit di reperimento delle informazioni culturali e linteresse nellutilizzo di nuove tecnologie georeferenziate.
177
Leconomia dei beni culturali e ambientali.
Una visione sistemica e integrata
Figura 57 Focus sui giovani (18-24 anni) e confronto con valori medi italiani Fonte: elaborazione The European House-Ambrosetti, 2010
Dallanalisi comparata tra i valori della media italiana e quelli registrati nei giovani, trasversalmente ai differenti temi oggetto dindagine, si evidenzia quanto segue: - i giovani sono meno soddisfatti dellofferta culturale della propria citt o area di residenza rispetto alla media; lattuale offerta culturale sembra pi indirizzata alle fasce adulte della popolazione; - tra i fattori che scoraggiano la partecipazione a eventi culturali, i giovani mostrano una sensibilit maggiore rispetto alle code allingresso e minore rispetto al prezzo; - i giovani associano le parole moda e design allidea di cultura in modo quasi triplo rispetto alla media italiana, mentre considerano le parole parco naturale e area archeologica meno affini allidea di cultura, sempre rispetto alla media italiana; - i giovani dichiarano di aver aumentato linteresse per la cultura negli ultimi 5 anni, e dichiarano che aumenteranno la spesa in beni culturali nei prossimi 5, in modo maggiore di 1,6 volte circa rispetto alla media italiana; - i blog sono utilizzati dai giovani per reperire informazioni culturali in modo doppio rispetto alla media italiana; - i giovani risultano anche maggiormente interessati (circa 40% in pi rispetto alla media italiana) ad un servizio di segnalazione gratuito sul telefono portatile di eventi o manifestazioni culturali.
178
6. Le principali evidenze emerse dalla survey nazionale e internazionale sul settore culturale e creativo
Figura 58 Focus sui giovani (18-24 anni) e confronto con valori medi italiani Fonte: elaborazione The European House-Ambrosetti, 2010
6.3.2. Sintesi delle principali evidenze del confronto internazionale
Analogamente a quanto fatto con riferimento ai giovani, per focalizzare meglio alcuni risultati significativi, sono state predisposte delle rappresentazioni grafiche in grado di fornire velocemente un confronto tra le risposte fornite dai cittadini nei Paesi oggetto dellindagine. Ponendo al livello 100 il risultato medio dellItalia, si calcolato il valore relativo agli altri Paesi su temi quali la vacanza ideale, la parole che maggiormente si associano allidea di cultura, linteresse per gli eventi culturali che avvengono nella propria citt o area di residenza, i fattori che scoraggiano la partecipazione a eventi culturali e le modalit di pagamento per la partecipazione a eventi o manifestazioni culturali.
Figura 59 Focus su confronto internazionale: confronto con valori medi italiani Fonte: elaborazione The European House-Ambrosetti, 2010
179
Leconomia dei beni culturali e ambientali.
Una visione sistemica e integrata
Con riferimento al luogo di vacanza ideale, in tutti i Paesi analizzati la percentuale dei cittadini che pensa ad un luogo ricco di cultura o una citt darte inferiore rispetto a quella che si registra in Italia. In Germania tale percentuale un quarto dellItalia, in Francia e Regno Unito e Stati Uniti circa la met, mentre in Spagna inferiore del 30% circa. Rispetto allItalia invece, i cittadini che dichiarano di preferire luoghi tranquilli dove riposare sono il 60% in pi in Germania, il 40% in pi circa nel Regno Unito e il 17% in pi negli USA. In Francia si riscontrano valori simili allItalia, mentre in Spagna i cittadini che dichiarano di preferire luoghi tranquilli dove risposare sono quasi il 20% in meno rispetto alla media italiana. Dal confronto sulle parole che si associano allidea di cultura, invece, si evince come i Paesi latini considerino la parola biblioteca sinonimo di cultura in modo quattro volte superiore rispetto ai Paesi anglosassoni e alla Germania. La parola museo sinonimo di cultura in modo quasi simile in Francia, Italia e Germania, mentre associata al termine cultura in modo inferiore in Spagna e nei Paesi anglosassoni. Questultimi, invece, associano il termine enogastronomia a cultura in modo doppio rispetto allItalia e quasi triplo rispetto alla Spagna. Questi risultati indicano come la percezione del concetto di cultura si sia progressivamente allargata e sia abbastanza diversa tra Paesi diversi. Per queste ragioni la scelta di puntare sul turismo culturale richiede una attenta valutazione delle reali aspettativi culturali dei potenziali turisti. Le scelte turistiche vincenti si connotano sempre pi come pacchetti dove possibile unire differenti aspetti ed esperienze. Osservando la tavola precedente, ad esempio, si nota come puntare solamente sulle citt darte e sui luoghi ricchi di storia e cultura per attirare i turisti stranieri potrebbe non essere, in assoluto, la scelta vincente. Comporre unofferta turistica in grado di far leva su differenti aspetti del territorio, come la tranquillit, le tradizioni enogastronomiche ecc. potrebbe consentire di cogliere maggiori opportunit. In Toscana possibile unire in modo vincente differenti aspetti legati alla cultura come le citt darte, i luoghi tranquilli dove riposare e rilassarsi, una eccellente tradizione enogastronomica, il mare e i paesaggi naturali attraenti. Come si visto prima, ad esempio, poich gli inglesi associano lenogastronomia alla cultura in modo pi che doppio rispetto a quello italiano, mentre dichiarano di preferire le citt darte come meta per la vacanza ideale, in misura inferiore al 40% circa, unendo in un pacchetto turistico entrambe le offerte possibile estrarre il massimo delle potenzialit dallintero settore culturale che assume connotati, perimetri e caratteristiche differenti tra i vari Paesi.
Figura 60 Focus su confronto internazionale: confronto con valori medi italiani Fonte: elaborazione The European House-Ambrosetti, 2010
180
6. Le principali evidenze emerse dalla survey nazionale e internazionale sul settore culturale e creativo
Tornando ad analizzare i dati del sondaggio, francesi, italiani, tedeschi e inglesi si dichiarano molto interessati per gli eventi culturali che avvengono nella propria citt, mentre per americani e spagnoli la soddisfazione minore. Come visto in precedenza, il prezzo elevato il fattore che trasversalmente in tutti i Paesi scoraggia maggiormente i cittadini a partecipare a eventi e/o manifestazioni culturali. In Italia, nonostante si collochi al primo posto come fattore scoraggiante, il suo impatto negativo inferiore rispetto ai Paesi benchmark. In Francia, ad esempio, la percentuale di chi afferma che il prezzo elevato un elemento che impatta negativamente superiore di quasi il 50% rispetto allItalia. Le code allingresso rappresentano un fattore ostativo soprattutto in Francia e Germania mentre nei Paesi anglosassoni e in Spagna tale fattore impatta negativamente, ma in modo inferiore allItalia. Infine, rispetto agli italiani, solo la met dei tedeschi individua nella difficolt dei trasporti un elemento negativo, mentre circa il 20% in pi degli inglesi (sempre rispetto agli italiani) attribuisce alla difficolt trasporti un impatto negativo.
6.3.3.
Focus sui risultati della survey nelle Regioni con i pi elevati punteggi nel Florens Index
In questo paragrafo si presentano i risultati della survey effettuata su base regionale, focalizzando lattenzione sulle Regioni dove si sono registrati i valori pi alti del Florens Index. Pertanto, si analizzeranno i risultati comparati, rispetto alla media italiana, di Lombardia, Lazio, Emilia Romagna e Toscana, relativamente ad alcuni aspetti particolarmente significativi. Nei grafici successivi, si confrontano alcuni risultati relativi ai differenti temi indagati nella survey e si presenta un confronto con i valori medi italiani. Lombardia Rispetto alla media italiana, in Lombardia: - i cittadini prediligono luoghi poco affollati e tranquilli quali mete per le vacanze ideali; - i cittadini sono maggiormente soddisfatti dellofferta culturale locale con un valore superiore di quasi dieci punti percentuali alla media italiana; - solo il 24,5% circa dei cittadini pensa che aumenter le proprie spese in cultura nei prossimi 5 anni, contro una media italiana di 31%.
Figura 61 Principali evidenze emerse dalla survey: focus Lombardia Fonte: elaborazione The European HouseAmbrosetti, 2010
181
Leconomia dei beni culturali e ambientali.
Una visione sistemica e integrata
Lazio Rispetto alla media italiana, i cittadini del Lazio: - prediligono citt darte e luoghi ricchi di storia e cultura come meta per le vacanze ideali; - per il 40% utilizzano internet per prenotare e pagare la partecipazione a eventi culturali, contro una media italiana di 31%. In questo ambito il Lazio la prima Regione in Italia.
Figura 62 Principali evidenze emerse dalla survey: focus Lazio Fonte: elaborazione The European House-Ambrosetti, 2010
Emilia Romagna Analizzando lEmilia Romagna, invece, le principali evidenze sono le seguenti: - l83% dei cittadini soddisfatto dellofferta culturale della propria Regione, contro il 68% circa della media nazionale; - solo il 54% circa, invece, pensa che il prezzo sia un fattore che scoraggia la partecipazione a eventi culturali, rispetto al 60% circa a livello nazionale.
182
6. Le principali evidenze emerse dalla survey nazionale e internazionale sul settore culturale e creativo
Figura 63 Principali evidenze emerse dalla survey: focus Emilia Romagna Fonte: elaborazione The European House-Ambrosetti, 2010
Toscana Infine, con riferimento alla Toscana, sempre rispetto alla media italiana, i principali risultati indicano quanto segue: - in Toscana oltre il 40% dei cittadini pensa a un luogo poco affollato e tranquillo come meta della vacanza ideale, rispetto al 34,5% della media italiana; - in Toscana quasi il 75% dei cittadini soddisfatto dellofferta culturale della propria Regione, contro il 68% circa della media nazionale; - sempre rispetto alla media italiana (31% circa), solo il 25,5% della popolazione toscana ritiene che aumenter la spesa in cultura nei prossimi 5 anni.
Figura 64 Principali evidenze emerse dalla survey: focus Toscana Fonte: elaborazione The European HouseAmbrosetti, 2010
183
Leconomia dei beni culturali e ambientali.
Una visione sistemica e integrata
A livello complessivo e di sintesi, nel grafico successivo si presentano le percentuali di risposte pi alte e pi basse, relative ad alcuni temi specifici e di particolare interesse. Sono soprattutto i cittadini siciliani ad associare arte e cultura al concetto di vacanza ideale, mentre i valdostani prediligono luoghi tranquilli e poco affollati dove rilassarsi e riposare. Quasi il 70% dei piemontesi afferma che il prezzo elevato il fattore che scoraggia maggiormente la partecipazione a eventi e manifestazioni culturali, contro il 44% circa dei cittadini del Molise che appaiono meno sensibili ai prezzi elevati. I molisani, invece, risultano primi in termini di propensione alla spesa in cultura nei prossimi 5 anni. Infatti, quasi il 41% dichiara che aumenter la spesa in consumi culturali entro i prossimi 5 anni, contro il 21% dei siciliani, ultimi in Italia. I cittadini dellEmilia Romagna sono quelli pi soddisfatti dellofferta culturale che avviene nel proprio territorio con quasi l83%, mente solo il 53% circa degli abruzzesi si dichiara interessato agli eventi culturali del proprio territorio. Infine, i cittadini del Lazio sono quelli che maggiormente prenotano e pagano i biglietti per la partecipazione a eventi o manifestazioni culturali attraverso internet (quasi il 40%) mentre in Calabria solo il 24% dichiara di utilizzare internet per prenotare e pagare i biglietti per partecipare a eventi culturali.
Figura 65 Confronto di sintesi tra le Regioni italiane: migliori e peggiori in ogni ambito analizzato Fonte: elaborazione The European House-Ambrosetti, 2010
184
6. Le principali evidenze emerse dalla survey nazionale e internazionale sul settore culturale e creativo
Infine, si presentano i profili Paese cos come sono emersi durante lanalisi dei risultati del sondaggio.
Tabella 2 Tabella comparativa delle principali evidenze emerse nellindagine sulla cultura Fonte: elaborazione The European House-Ambrosetti, 2010
185
Leconomia dei beni culturali e ambientali.
Una visione sistemica e integrata
186
7. La normativa sulla definizione dei beni culturali e paesaggistici
7. LA NORMATIVA SULLA DEFINIZIONE DEI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI 7.1. primi passi verso iL riconoscimento dei beni cuLturaLi
Secondo gli storici furono i romani i primi a dettare disposizioni per la tutela e lintangibilit dei monumenti e a considerare di pubblico servizio o di pubblico dominio le opere dellarchitettura e della scultura (queste ultime se esposte alla libera visione di tutti). Tra gli esempi pi significativi di disposizioni in materia si pu citare ladozione di provvedimenti affinch non venisse alterato laspetto dei centri urbani, il divieto di demolire anche i propri edifici per alienare le statue e i marmi, la diffusione del principio secondo cui persino una statua collocata da privati in un luogo pubblico in onore di cittadini emeriti dovesse ritenersi di propriet pubblica. Se si considera lenorme quantit di statue, bassorilievi ed architetture di pregio delle citt sottoposte al dominio romano, appare evidente come queste disposizioni normative rappresentassero un vincolo esteso e quantitativamente importante. Appare doveroso premettere, tuttavia, che lemanazione di quelle norme non era determinata da una precisa e consapevole pretesa di tutelare quei beni per la loro importanza culturale o artistica, bens per poter salvaguardare altre esigenze (viarie, di salubrit, economiche, ecc.)1. Ci non toglie, comunque, che alcuni degli istituti affermatisi nel mondo romano siano stati successivamente ripresi e rielaborati dalle prime organiche leggi di tutela degli Stati Italiani preunitari, sino a giungere ai giorni nostri. Ne sono tipici esempi la dicatio ad patriam e la deputatio ad cultum: - la prima rappresenta listituto oggi conosciuto come limitazione al diritto di propriet, ossia la facolt del proprietario di porre volontariamente un bene a disposizione di una collettivit indeterminata di cittadini, assoggettandola alluso pubblico o ammettendo il pubblico ad un particolare godimento; - la deputatio ad cultum deriva dallistituto sopra descritto: in essa luso collettivo del bene storico o artistico ha carattere esclusivamente culturale. In entrambi gli Istituti, comunque, il diritto di propriet viene solo affievolito dalla destinazione pubblica del bene, ma non viene meno la possibilit di commerciare questultimo, ovviamente nel rispetto delle norme in materia2. Al di l dellesperienza in materia dellepoca romana, la protezione del patrimonio storico, artistico ed archeologico stata oggetto dinteresse anche negli Stati Italiani preunitari. Gi alla fine del Cinquecento nel Granducato Mediceo di Toscana si tent di dar vita alla prima, anche se embrionale, forma di Ordinamento Giuridico dei Beni Culturali. Nel 1571 si viet la rimozione di insegne e iscrizioni dai palazzi antichi. Nel 1602 Ferdinando I ordin lentrata in vigore della deliberazione intitolata dipinti dei quali si proibisce lestrazione, contenente lelenco di 18 pittori, le cui opere erano considerate talmente qualificanti per lindividuazione delle radici storiche della cultura figurativa, da non poter essere esportate senza la concessione della licenza da parte del luogotenente dellAccademia del Disegno: si fissava, in tal modo, un chiaro limite alla esportabilit delle tele3. Sempre in Toscana, nel primo trentennio del Settecento, la granduchessa Anna Maria Elettrice destin le raccolte granducali degli Uffizi a funzioni museali e ordin, tramite il proprio testamento (5 aprile 1739), che le opere darte di sua propriet rimanessero a Firenze. Questa ed altre misure fecero s che la Toscana si trovasse in una posizione di avanguardia nel campo della protezione di beni di interesse artistico, storico e archeologico anche durante tutto il periodo che precedette lunificazione dItalia. La maggiore preoccupazione a quel tempo fu quella di evitare, o, al massimo, contenere, il saccheggio e la vendita allestero di opere darte italiane: il primo segno di una considerazione della esistenza di un patrimonio artistico e storico da salvaguardare.
1 2 3
A. Mansi, La tutela dei beni culturali, II ediz., Padova, Cedam, 1998. A. Ainis M. Fiorillo, I beni culturali, in Trattato di Diritto Amministrativo, tomo II (a cura di S. Cassese), Milano Giuffr editore, 2000. A. Ainis M. Fiorillo, I beni culturali, in Trattato di Diritto Amministrativo, tomo II (a cura di S. Cassese), Milano Giuffr editore, 2000.
187
Leconomia dei beni culturali e ambientali.
Una visione sistemica e integrata
7.2. verso iL riconoscimento dei beni paesaggistici
Nelle societ occidentali, con lavvento della rivoluzione industriale, cambi la consapevolezza del rapporto fra uomo e natura, generando una crescente domanda di tutela della natura per preservarla dai danni causati dal suo incondizionato sfruttamento. In Italia i primi accenni ad una legislazione attinente alle bellezze naturali risalgono ai primi del Novecento. In quegli anni la concezione della tutela paesaggistica prevalente a livello istituzionale era ancorata allessenziale compresenza, insieme al fattore estetico, di valori culturali. Di conseguenza, un passaggio apprezzabile esteticamente, ma non riconosciuto a livello storico o culturale, non risultava essere meritevole di tutela. Il primo significativo intervento a tutela di unarea naturale extraurbana fu rappresentato dalla Legge n. 411 del 16 luglio 1905, a salvaguardia della pineta di Ravenna. Lanno successivo, il Re Vittorio Emanuele III nomin una commissione per lelaborazione di un progetto di legge in materia di cose mobili ed immobili aventi interesse storico, archeologico o artistico: tale commissione produsse il progetto che divenne la Legge n. 364 del 20 giugno 1909 (nota come Legge Rosadi - Rava) nella quale, per, la protezione fu limitata alle cose mobili e immobili di interesse storico, archeologico e artistico4.
7.3. passaggi storici chiave neLLa deFinizione di bene cuLturaLe
7.3.1. Le disposizioni della Carta Costituzionale
Limportanza della tutela del patrimonio storico-artistico e ambientale ha assunto una rilevante importanza a livello normativo dopo lentrata in vigore della Costituzione. Larticolo 9, infatti, riunisce la tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico e colloca gli interessi estetici, culturali e paesaggistici tra i valori primari dellordinamento, volano di promozione della cultura e della ricerca scientifica (art. 9, comma 1), dove la cultura non si riferisce solo alle idee e ai valori delluomo, intesi come espressione di libert individuale e di autonomia delle istituzioni culturali, ma anche a ci che tali idee e valori sprigionano, cio le attivit e i beni culturali5. La Costituzione abbandona la filosofia delle precedenti leggi; infatti il bene costituzionalmente protetto non nelle singole cose, genericamente determinate, bens nella valenza culturale che si attribuisce al rapporto uomo-ambiente, nel quale si inseriscono anche gli immobili dinteresse storico-artistico. Questo significa che la considerazione del legislatore costituente non andata solo verso i beni mobili e immobili intesi esclusivamente come oggetti da conservare passivamente, bens nella direzione del territorio nella sua interezza, compresi flora, fauna e tutto quanto concorre a costituire lambiente in cui vive e agisce luomo, e di tutti i beni aventi valore storico o/e artistico. Con la Carta Costituzionale, quindi, si introdotto un concetto innovativo per lepoca: la protezione integrata e complessiva dei valori naturali insieme con quelli consolidati dalle testimonianze di civilt. Ai fini interpretativi, la norma dellart. 9 si collega con quelle degli artt. 2 e 3, comma 232 comma 1 e 42, comma 3 della Costituzione, poich la finalit della tutela del patrimonio storico e artistico consiste nellarricchire culturalmente la persona e soddisfare le attuali esigenze della societ a godere di un ambiente che garantisca una migliore qualit della vita. In tal senso un ruolo particolarmente importante assume la pianificazione del territorio, poich essa consente di intervenire sulle aree al fine di soddisfare linteresse collettivo al recupero dei valori culturali e ambientali e ad una pi estesa fruizione del bene da parte del pubblico. La protezione e la valorizzazione del patrimonio artistico e ambientale si giustificano, quindi, in quanto questultimo espressione della storicit, creativit e spiritualit di un popolo6.
4 5 6
M. Cantucci, definizione di bellezze naturali, in Novissimo Digesto Italiano II, terza edizione, Torino, UTET, 1957. F.M.Lazzaro, I beni culturali tra riforma amministrativa e nuovi principi costituzionali. N.Aicardi, Lordinamento amministrativo dei beni culturali. La sussidiariet nella tutela e nella valorizzazione , in Ambiente, beni culturali, urbanistica, collana diretta da G.Caia, B.Carovita, L. Francario, Torino, Giappichelli editore, 2002.
188
7. La normativa sulla definizione dei beni culturali e paesaggistici
7.3.2. Le disposizioni sul patrimonio culturale negli anni Sessanta
Nonostante la portata radicalmente innovativa della Carta Costituzionale, nei primi anni della Repubblica italiana non ci sono state particolari disposizioni in materia culturale. Se, infatti, si prescinde dal nuovo ordinamento degli Archivi, approvato con D.P.R. n. 1409 del 30 settembre 1963 e dalla legislazione delle Regioni a statuto speciale, che in larga parte si richiamava alle normative statali vigenti, nel settore del patrimonio storico-artistico e della protezione delle bellezze naturali si trovano solo degli interventi isolati e occasionali, generalmente sollecitati degli ambienti politico-culturali pi sensibili ai problemi di gestione pubblica del patrimonio artistico e del paesaggio. Purtroppo, proprio in questa fase della storia italiana connotata dal passaggio da una societ ancora prevalentemente agricola ad una societ industriale il patrimonio culturale ed ambientale ha subito danni ingenti, a causa dellespansione urbanistica incontrollata e del rapido moltiplicarsi degli insediamenti industriali. Uninversione di tendenza si registrata a met degli anni Sessanta, con la Legge n. 310 del 26 aprile 1964 e listituzione della commissione di indagine per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, archeologico artistico e del paesaggio, la Commissione Franceschini, che concluse la propria attivit nel 19667.
7.3.3.Recenti sviluppi normativi: il Testo Unico dei beni culturali e ambientali
In tempi molto pi recenti la chiave di volta per il rafforzamento del sistema di tutela e valorizzazione dei beni culturali rappresentata dallelaborazione del Testo Unico n. 490 del 29 ottobre 19998, i cui obiettivi primari erano la semplificazione del rapporto fra cittadini e amministrazioni pubbliche e laggiornamento e la modernizzazione della legislazione in materia di beni culturali e ambientali. Con un notevole sforzo di semplificazione, armonizzazione e coordinamento, tutta la legislazione in materia stata riesaminata, a partire dalle leggi fondamentali sulla tutela del patrimonio artistico del 1939, fino alle leggi sugli Archivi, alla Legge Ronchey9 (che esprimeva lintento statale di dar vita a forme di compartecipazione privata nellassolvimento delle funzioni istituzionali) e alla Legge Veltroni10. Questultima, pur conservando allo Stato la tutela del patrimonio culturale, prevista la possibilit di delegare a regioni, province o comuni la sua gestione e valorizzazione, e stabiliva che Stato, regioni ed enti locali concorrono allattivit di conservazione dei beni culturali. La precedente generica definizione riconosceva un bene culturale materiale come fisicamente tangibile, ad esempio unopera architettonica, un dipinto o una scultura, mentre era definito immateriale quando non fisicamente tangibile, come una lingua o un dialetto, una manifestazione di folklore o persino una ricetta culinaria. Composto di 166 articoli, il Testo Unico ha riproposto la distinzione tra beni culturali e beni paesaggistici e ambientali. I primi risultano essere quelli aventi interesse storico-artistico; inoltre il Testo Unico contiene la previsione dellallargamento della definizione di bene culturale, estendendola anche alle fotografie, agli audiovisivi, agli spartiti musicali, agli strumenti scientifici e tecnici e a tutto quanto potesse in futuro essere individuato come testimonianza avente valore di civilt, adeguandola quindi allevoluzione socio-economica e culturale della seconda met del ventesimo secolo. I beni paesaggistici e ambientali vengono cos distinti da quelli culturali e definiti come: le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale come le ville, i giardini, i parchi, i complessi di cose immobili, le bellezze panoramiche, i territori costieri, i territori vicini ai laghi, i fiumi, i torrenti, i corsi dacqua, le montagne, i ghiacciai e i circoli glaciali, i parchi e le riserve nazionali e regionali. Inoltre, tra i beni paesaggistici e ambientali si includono anche quelli di carattere prevalentemente naturale anche se modificati, trasformati o creati dallattivit delluomo.
7 8 9 10
G.Cogo, I beni culturali ed ambientali tra ordinamento e istituzioni, in I beni culturali, a cura di Mezzetti, Padova, Cedam, 1995. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 1999 supplemento ordinario numero 302. Legge n.4 del 14 gennaio 1993. R. Tamiozzo, La legislazione dei beni culturali e paesaggistici, Milano, Giuffr editore, 2004.
189
Leconomia dei beni culturali e ambientali.
Una visione sistemica e integrata
Pi in generale, infine, il Testo Unico ha dato grande risalto al ruolo di regioni ed enti locali in materia di tutela e conservazione del patrimonio culturale, potenziando la disciplina degli interventi di edilizia, e il ricorso alle convenzioni internazionali, specie con riferimento alla circolazione extra-nazionale dei beni. In definitiva, dunque, al Testo Unico, pur non risolvendo il problema relativo alla protezione dei beni culturali, si deve riconoscere il merito di aver finalmente provveduto al totale riordino della disciplina legislativa relativa ad un settore assai complicato e delicato. Vengono di seguito proposti due schemi riepilogativi degli argomenti trattati dal Testo Unico.
Figura 1 I beni culturali ed ambientali secondo i profili regolamentati dal Testo Unico - Fonte: rielaborazione The European House-Ambrosetti su F. Lanzarone, Conservazione dei beni culturali: processo conservativo e vigente normativa: il nuovo Codice Urbani, 2004
7.4. iL codice dei beni cuLturaLi e deL paesaggio
Il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 e successive modificazioni) riveste un ruolo di particolare rilievo nella definizione di bene culturale e paesaggistico. Esso rappresenta il primo Codice della legislazione italiana riguardante il settore dei beni culturali e paesaggistici, sostituendo in larga misura i decreti precedenti. Lintero testo normativo risponde alla finalit di disciplinare in modo omnicomprensivo la materia dei beni culturali ed fondato sullart. 9 della Costituzione italiana che promuove lo sviluppo della cultura, tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico dellItalia e lega a filo doppio beni culturali e paesaggio. A tale proposito il Codice, allart. 2, afferma esplicitamente il principio dellunitariet della materia dei beni culturali11. Il Codice composto di 184 articoli che: - definiscono anzitutto il concetto di patrimonio culturale nazionale: esso costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici.
11
A.Ferretti, Il Codice dei beni culturali.
190
7. La normativa sulla definizione dei beni culturali e paesaggistici
- sanciscono lobbligo per i soggetti pubblici di assicurare sempre, nello svolgimento della propria attivit istituzionale, il rispetto delle esigenze di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale, affinch esso possa essere fruito dalla collettivit, perch attraverso la fruizione si concorre allo sviluppo e alla promozione della cultura. Al contempo, il Codice conferma il dovere dei privati di garantire la conservazione dei propri beni culturali; - definiscono la tutela e la valorizzazione, confermando la preminenza della prima sulla seconda. Al Codice va riconosciuto inoltre il merito di aver considerato il paesaggio ed i beni che ne fanno parte quali componenti, insieme ai beni culturali in senso stretto, del patrimonio culturale. Di conseguenza, tutte le nuove norme che regolano i vincoli dei beni e delle aree, la pianificazione paesaggistica e le autorizzazioni ai lavori su beni o aree vincolate sono ispirate al principio che il paesaggio un bene culturale. Ci sicuramente corrisponde alla piena e concreta attuazione dellart. 9 della Costituzione italiana.12 I beni paesaggistici, parte del patrimonio culturale, vengono definiti come gli immobili costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge. Oltre alla tradizione giuridica italiana, secondo la quale il paesaggio nazionale ha unindubbia e peculiare valenza culturale, larticolo tiene conto dei contenuti della Convenzione europea del paesaggio, che, nellart. 1, comma a), definisce il paesaggio come una determinata parte di territorio, cos come percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dallazione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni. Il paesaggio quindi visto come un contesto territoriale in cui le componenti ambientali e naturali si connettono in maniera indissolubile a quelle antropiche e culturali. Dunque, la protezione della natura diventa automaticamente tutela dellessere umano e del suo bisogno di circondarsi di un ambiente che abbia valore non solo quanto al dato estetico, ma soprattutto per la qualit di vita e per il senso di appartenenza che ogni uomo avverte nei confronti del paesaggio stesso. Il paesaggio di tutti gli individui, contribuisce allo sviluppo personale e sociale di questi e ne rafforza la relazione con i luoghi di vita. Questa estensione della nozione di paesaggio, non pi limitata alla definizione classica di bellezze naturali, n sinonimo della locuzione beni paesaggistici e ambientali, ha mutato anche la prospettiva giuridica di approccio al problema della tutela e della valorizzazione dei beni paesaggistici. Unefficace salvaguardia dei valori che i beni paesaggistici esprimono non pu esaurirsi quindi con azioni conservative su circoscritte aree di particolare pregio: appare indispensabile una disciplina integrata ed estesa allintero territorio che, oltre a tutelare il paesaggio, lo valorizzi adeguatamente.
12
Ministero per i beni e le attivit culturali, l nuovo Codice dei Beni Culturali e Paesaggistici.
191
Leconomia dei beni culturali e ambientali.
Una visione sistemica e integrata
192
8. Raccomandazioni e indicazioni di policy per il rilancio del settore culturale e creativo in Italia
8. RACCOMANDAZIONI E INDICAZIONI DI POLICY PER IL RILANCIO DEL SETTORE CULTURALE E CREATIVO IN ITALIA 8.1. introduzione
Il presente capitolo illustra una serie di raccomandazioni e di indicazioni di policy attraverso le quali si desidera contribuire alla piena valorizzazione e allo sviluppo del settore culturale e creativo nel nostro Paese. Le riflessioni di seguito esposte derivano in parte dallanalisi delle principali evidenze emerse dal Florens Index calcolato a livello nazionale ed internazionale (presentate nei Capitoli 3 e 4) e dei risultati raccolti attraverso la survey sul settore culturale e creativo realizzata in Italia e allestero (di cui al Capitolo 6). Non meno importanti per lidentificazione di questi cantieri di lavoro sono stati i dibattiti che hanno animato le numerose occasioni di incontro e di lavoro dellAdvisory Board e dei Tavoli Tecnici del progetto Florens 2010, cos come le interviste ad esperti ed opinion leader del settore, nazionali ed internazionali.
8.2. Le aree-chiave dintervento per una rinascita cuLturaLe deLLitaLia e deLLa toscana
Le riflessioni emerse dal progetto Florens 2010 ruotano attorno a 13 aree dintervento: Rinnovata attenzione agli investimenti nel settore culturale come strumento strategico di politica industriale 2. Semplificazione normativa per la libera circolazione e commercializzazione delle opere darte
1. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Promozione delle eccellenze artistiche e produttive Made in Italy sui mercati esteri Evoluzione tecnologica nel settore culturale Firenze come centro di riferimento mondiale per la digitalizzazione Creazione di un database delle best practice per la gestione dei musei Misurazione della soddisfazione del cliente dellofferta culturale Iniziative a sostegno del mecenatismo nel settore artistico e culturale Sostegno alla collaborazione tra pubblico e privato nel settore culturale
10. Miglioramento della classificazione statistica per il monitoraggio delle attivit artigianali 11. Maggiore valorizzazione dei mestieri darte 12. Maggiore fruibilit della cultura per le fasce giovani della popolazione 13. Specializzazione di Firenze sul management dei beni culturali
Alcune delle azioni suggerite si indirizzano verso interventi a livello di Sistema Paese e richiedono, pertanto, azioni e/o prese di posizione da parte delle Istituzioni nazionali competenti; in altri casi, le proposte si indirizzano ad alcune specificit della Toscana o della realt culturale e industriale di Firenze. Di conseguenza, sono numerosi gli attori pubblici e privati chiamati ad agire di concerto e in sinergia per attivare un circolo virtuoso nel tradurre le proposte in iniziative concrete. Per meglio contestualizzare le diverse aree dintervento ed esemplificare possibili linee dazione, laddove possibile, si far cenno ad esperienze innovative o best practice di riferimento, sia allestero che in Italia. Si premette, infine, che le riflessioni propositive di Florens 2010 si sono concentrate sui beni culturali e sul sistema creativo. Tali aree sono infatti risultate prioritarie nel lavoro svolto in questo primo anno di attivit.
193
Leconomia dei beni culturali e ambientali.
Una visione sistemica e integrata
1. Rinnovata attenzione agli investimenti nel settore culturale come strumento strategico di politica industriale Lanalisi dei risultati del Florens Index calcolato su base internazionale (si veda il Capitolo 4) ha evidenziato una debolezza del nostro Paese in merito alla capacit di valorizzare il patrimonio culturale e ambientale di cui dispone: ad esempio, nella classifica relativa al Quadrante del Capitale Culturale e Ambientale, lItalia preceduta da Stati Uniti (in prima posizione anche per valore del Florens Index complessivo), Regno Unito e Francia. Nello specifico, gli USA distanziano il nostro Paese grazie ad una migliore capacit di gestione del proprio patrimonio culturale e ambientale. Infatti, se si limita lanalisi al Florens Performance Sub-Index1 che misura la capacit di valorizzare gli asset culturali e ambientali, gli stessi tre Paesi prima menzionati (con Francia in testa, seguita dagli USA e dal Regno Unito) si collocano alle prime posizioni in classifica. Il confronto tra il punteggio dellItalia e degli Stati Uniti fornisce unidea del gap che il nostro Paese deve colmare nella capacit di valorizzare il proprio patrimonio.
Figura 1 Florens Performance Sub-Index: confronto tra Italia e USA Fonte: elaborazione The European House-Ambrosetti, 2010
In Italia una simile riflessione appare oggi pi che mai urgente anche alla luce dei ventilati tagli dei finanziamenti statali ad alcuni tra i maggiori Istituti di cultura italiani2. Storicamente, infatti, la cultura viene considerata un centro di costo3: non sembra dunque percepita la valenza strategica che questo settore ha in termini di sviluppo potenziale a livello di PIL ed occupazione, senza considerare il connotato sociale associato al settore culturale e creativo.
1
I KPI considerati per il calcolo di questo sotto-indicatore sulla capacit di valorizzare il patrimonio culturale e ambientale sono 9: Numero di visitatori a musei, monumenti e aree archeologiche statali a pagamento, Numero di Universit presenti nei ranking internazionali, Numero di studenti universitari, Numero medio annuo di nuovi laureati, Numero medio annuo di laureati in discipline artistiche, umanistiche e musicali, Numero di Premi Nobel per la letteratura, Numero medio annuo di visitatori ai primi 25 musei mondiali, Numero di spettacoli teatrali e Numero di spettacoli concertistici. I pesi relativi sono stati mantenuti invariati rispetto al calcolo del Florens Index, tuttavia i pesi sono stati normalizzati a 100% per ciascun cluster considerato. Lart. 7, comma 22, del Decreto Legge recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivit economica prevedeva la sospensione di finanziamenti pubblici a 232 enti culturali, fondazioni e istituzioni in Italia (di cui 33 localizzate in Toscana). Il Ministro per la Cultura, Sandro Bondi, in una conferenza stampa del 4 novembre 2010 ha ricordato di aver scongiurato la soppressione di questi enti e di essere riuscito a lasciare sostanzialmente inalterato per lanno in corso il contributo statale. La scarsa attenzione destinata alla Cultura come asset strategico pu essere approssimata non solo dalle riduzioni dei fondi statali per alcune delle principali istituzioni culturali italiane o dai frequenti annunci di tagli al Fondo Unico per lo Spettacolo (FUS), ma anche dal livello degli stipendi per i Direttori dei musei: nel nostro paese i Direttori dei musei italiani di propriet pubblica scontano un basso livello di retribuzione rispetto a quanto avviene in altre realt europee e molto spesso il gap salariale rispetto ad altri dirigenti o direttori della Pubblica Amministrazione appare particolarmente pronunciato.
194
8. Raccomandazioni e indicazioni di policy per il rilancio del settore culturale e creativo in Italia
Oggi la stima complessiva del Valore Aggiunto attribuibile al settore culturale e creativo nel nostro Paese ammonta a circa 116 miliardi di Euro, pari al 9,3% del Valore Aggiunto nazionale, mentre quella delloccupazione risulta pari a quasi 2,8 milioni di addetti, cio 11,9% delloccupazione totale4.
Proposta n.1
Occorre dare priorit, sia su base nazionale che regionale, agli investimenti nel settore culturale e creativo, in modo da dotare il nostro Paese degli strumenti necessari (sviluppo delle conoscenze e delle competenze tecniche, capacit manageriali, infrastrutture, tecnologie, ecc.) per valorizzare il potenziale inespresso di questo settore: si tratta di una fondamentale leva strategica per future iniziative di politica industriale in grado di riconfigurare il tessuto produttivo del Paese.
Per comprendere il posizionamento dellItalia nel panorama europeo, si riportano di seguito alcuni dati relativi alla spesa pubblica per la cultura e le arti nelle principali economie europee. Occorre premettere che i dati statistici relativi alla spesa pubblica per il settore culturale e artistico risentono di numerosi limiti dovuti alla mancanza di omogeneit nella definizione del concetto di cultura adottata a livello nazionale o locale, alle differenti modalit di rilevazione metodologica dei dati, cos come ai frequenti ritardi nella comunicazione degli stessi5. Le fonti cui si fatto riferimento sono uno studio condotto nel novembre del 2006 dal Parlamento Europeo sul finanziamento al settore culturale negli Stati Membri dellUE6 e il Council of Europe7. Come si pu notare dalla figura sotto riportata, bench gli anni di riferimento non siano omogenei per la carenza informativa cui si accennato, la spesa pubblica in cultura dellItalia (a livello centrale e di amministrazioni locali, ovvero Regioni/Province e Comuni) in rapporto al PIL nazionale si pone ad un livello inferiore a quello di Paesi quali Francia, Regno Unito e realt del Nord Europa.
Figura 2 Spesa pubblica per cultura in % del Prodotto Interno Lordo: confronto tra Italia ed alcune realt europee, 2004 o anni precedenti Fonte: elaborazione The European House-Ambrosetti su dati Parlamento Europeo (Financing the Arts and Culture in the EU) e Council of Europe, 2006
4 5
Fonte: Libro Bianco sulla Creativit, W. Santagata, 2009. Ad esempio, molto spesso le informazioni relative alla spesa statale in cultura sono limitate ai dati del Ministero della Cultura e non tengono conto di quelli di altri Ministeri che possono accogliere centri di spesa pi o meno direttamente legati al settore culturale. Si veda: European Parliament, Policy Department Structural and Cohesion Policies (Culture and Education), Financing the arts and culture in the European Union, novembre 2006. Si veda: Council of Europe/ERICarts, Compendium of cultural policies and trends in Europe, 2009.
195
Leconomia dei beni culturali e ambientali.
Una visione sistemica e integrata
Lanalisi delle matrici delle interdipendenze settoriali (illustrata nel Capitolo 7) ha per dimostrato che linvestimento nel settore culturale in grado di determinare importanti benefici per il Paese sul fronte della ricchezza generata e delloccupazione attivata. Infatti: - 100 Euro di incremento di PIL nel settore culturale generano tramite le relazioni interindustriali (impatto indiretto) e laumento della domanda (impatto indotto) un aumento di 249 Euro di PIL nel sistema economico (moltiplicatore pari a 2,49); - per ogni unit di lavoro che si crea nel settore culturale si generano tramite le relazioni interindustriali (impatto indiretto) e laumento della domanda (impatto indotto) 1,65 unit di lavoro complessive nel sistema economico (moltiplicatore pari a 1,65). Gli effetti sono particolarmente significativi se si considera il solo settore manifatturiero: per ogni 100 Euro di PIL prodotto nel settore culturale vengono generati 62 Euro di PIL nellindustria manifatturiera e per ogni unit di lavoro che si crea nel settore culturale vengono generate 0,13 unit di lavoro nellindustria manifatturiera. Appare quindi evidente che possibili tagli alla Cultura nel nostro Paese non solo danneggiano il patrimonio artistico e culturale, indeboliscono la crescita sociale e riducono la possibilit per cittadini e turisti di usufruire di prodotti e servizi di valore, ma si ripercuotono negativamente anche sulla crescita dellintera economia: a titolo esemplificativo, applicando i moltiplicatori sopra esposti, una riduzione di 500 milioni di Euro del PIL del settore culturale, imputabile ad esempio ad un taglio dei finanziamenti, si tradurrebbe nella mancata di attivazione di 1,2 miliardi di Euro di PIL nazionale, di cui oltre 300 milioni di Euro nel solo comparto manifatturiero. Inoltre, negli ultimi 10 anni il settore culturale e creativo ha registrato elevati ritmi di crescita: - Tra il 1996 e il 2005, secondo lUNCTAD, il tasso medio annuo di crescita dellexport mondiale di beni culturali e creativi stato pari all8,7%; - Le analisi del NESTA - National Endowment for Science Technology and the Arts evidenziano che tra il 1997 e il 2007 le industrie creative del Regno Unito hanno conosciuto un tasso medio annuo di crescita pari al 5% (rispetto al 3% dellintera economia). Sempre secondo le previsioni del NESTA (elaborate nel 2009, quindi dopo la crisi), si stima che le industrie creative del Regno Unito cresceranno del 4% allanno fino al 2013. 2. Semplificazione normativa per la libera circolazione e commercializzazione delle opere darte Attualmente nel nostro Paese permangono alcune restrizioni alla libera circolazione delle opere darte provenienti dallestero. Stante lattuale situazione, si generano non solo un appesantimento burocratico e tempi lunghi per gli operatori del settore culturale e artistico, ma anche costi elevati e un aggravio dellattivit delle Sovrintendenze stesse. Infatti, da un lato, la normativa vigente prevede che il certificato di temporanea importazione abbia una validit di 5 anni, con la necessit di rinnovarlo pena la nazionalizzazione del bene; dallaltro, occorre un attestato di libera circolazione per riesportare lopera darte al di fuori dei confini nazionali.
196
8. Raccomandazioni e indicazioni di policy per il rilancio del settore culturale e creativo in Italia
Proposta n.2
Istituire un passaporto per le opere darte in entrata/uscita dal Paese, come avviene in altri Paesi europei quali Francia e Regno Unito: un simile certificato non sarebbe soggetto a vincoli temporali di sorta e consentirebbe a collezionisti e mercanti darte di poter esportare le opere senza dover ripetere procedure burocratiche o rischiare, trascorsi i 5 anni, se non rinnovata la pratica, di vedere il proprio bene nazionalizzato.
Leccessivo protezionismo previsto dalle leggi sul comparto e lassenza di un passaporto per le opere darte di privati rappresentano un vincolo sia per i mercanti, sia per i privati. I sovrintendenti negano spesso lespatrio alle opere darte perch le dichiarano parte del patrimonio collettivo, cosicch i beni acquistati all`asta da collezionisti stranieri non possono varcare i confini italiani, anche quando si tratta di opere minori. Ai sovrintendenti infatti chiesto di valutare se unopera, compiuti i 50 anni, abbia un valore minore, e dunque possa uscire dallItalia per entrare a far parte di una collezione privata allestero, o se - al contrario - non possa lasciare il Paese perch degna di far parte del patrimonio collettivo: lassenso o il dissenso sono stabiliti sulla base di parametri messi a punto nel 1974 e contenuti in una circolare del Ministero della Pubblica Istruzione (allepoca, infatti, il Ministero dei Beni Culturali non era stato ancora istituito).
3. Promozione delle eccellenze artistiche e produttive Made in Italy sui mercati esteri
Le esposizioni itineranti di opere darte come, ad esempio, il tour del David del Verrocchio negli Stati Uniti (Washington e Atlanta, tra il 2003 e il 2004) o la presentazione dellAnnunciazione di Leonardo da Vinci a Tokyo (2007) - riscuotono crescente successo di pubblico a livello internazionale. Poich tali iniziative sono occasioni eccezionali di visibilit per il nostro Paese, sarebbe importante affiancarle sempre, o comunque ogniqualvolta ci sia possibile, ad iniziative finalizzate a promuovere le eccellenze culturali, artigianali e industriali che oggi caratterizzano il Made in Italy.
Figura 3 Capolavori italiani in in tourne allestero: alcuni esempi di successo Fonte: elaborazione The European House-Ambrosetti su dati The Art Newspaper, Ministero per i Beni e le Attivit Culturali e altre fonti, 2010
197
Leconomia dei beni culturali e ambientali.
Una visione sistemica e integrata
Proposta n.3
- Promuovere maggiormente le c.d. travelling exhibition, ad esempio prestando allestero anche singole opere darte (incluse quelle meno note e stoccate nei magazzini dei musei e, di conseguenza, non fruibili al pubblico) e creando contestualizzazioni ed eventi ad hoc al di fuori dellItalia: ci consentirebbe di aumentare il cultural understanding e di far conoscere la cultura italiana anche a quanti non possono visitare il nostro Paese; inoltre, le travelling exhibition dovrebbero essere realizzate preferibilmente in condizioni di reciprocit con altri Paesi - Prevedere modalit di compensazione economica a chi concede le proprie opere darte in prestito per esposizioni allestero - Abbinare allesposizione di opere darte al di fuori dellItalia anche presentazioni di settori-chiave industriali (vi sono, ad esempio, forti sinergie con il comparto Moda ed Agroalimentare), nonch delle tecnologie per i beni culturali prodotte nel nostro Paese (Road Show, incontri business-to-business, ecc.), nellottica di favorire possibili collaborazioni commerciali: le esposizioni itineranti dovrebbero essere viste come una opportunit per far conoscere allestero la creativit e la storia italiana.
Se iniziative itineranti di capolavori permettono di far conoscere nel mondo le eccellenze artistiche dellItalia (offrendo visibilit anche ad opere minori e di nicchia, come nel caso del Trittico del Maestro di Beffi del XV secolo, proveniente dal Museo dellAquila e ammirato da 3.000 visitatori durante lesposizione a Washington nel 2009), simili occasioni dovrebbero essere maggiormente integrate con la divulgazione delle eccellenze industriali che il Paese in grado di offrire. Il concetto di Made in Italy, in particolare, dovrebbe essere interpretato in modo pi ampio, comprendendo anche larte e la cultura italiana, due elementi strettamente legati alla capacit produttiva e alle tecnologie: non a caso, la stessa impostazione del progetto Florens 2010 finalizzata ad evidenziare la stretta relazione tra economia, lavoro, arte e cultura. Oggi sembra mancare una piena consapevolezza che attraverso il concetto del Made in Italy si pu promuovere uno stile di vita che comprende anche la valorizzazione, conservazione, fruizione e generazione stessa di beni culturali. Esistono quindi ampie possibilit per raccontare litalianit dal punto di vista emotivo e commerciale: non solo esibizioni di opere o performance di Arte/Moda/Design ma veri e propri spettacoli arricchiti, ad esempio, da elaborazioni in alta definizione, applicazioni laser, soluzioni tecnologiche per il restauro ed altre applicazioni di sicuro interesse per il grande pubblico. Possibili partner per la realizzazione di simili iniziative potrebbero essere, tra gli altri, la rete degli Istituti Italiani di Cultura nel mondo o la Borsa Internazionale delle Mostre, promossa da Confindustria e operativa dal 2011.
Una fondazione per una maggiore interazione fra cultura, turismo e innovazione: la Borsa Internazionale delle Mostre
La Borsa Internazionale delle Mostre (International Art Museum Exposition Exchange) la fondazione costituita da Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici, Federturismo Confindustria e Confcultura, lassociazione confindustriale delle imprese che gestiscono i servizi per la valorizzazione, la fruizione e la promozione del patrimonio culturale. Attraverso la Borsa Internazionale delle Mostre, la pi vasta offerta al mondo di beni culturali e artistici, posseduta dallItalia, potr confrontarsi con i protagonisti della domanda a livello mondiale, espressa dagli organizzatori di mostre, di grandi manifestazioni darte e dagli operatori del turismo culturale. In considerazione dellentit del patrimonio italiano, la Borsa Internazionale delle Mostre, destinata a rappresentare il pi grande evento dedicato al settore, unico al mondo per dimensioni e capacit di offerta. La prima edizione della Borsa, che avr cadenza annuale e sar itinerante (cos da offrire alle citt darte la possibilit di ospitare un evento con importanti ricadute sul territorio), stata fissata per il 2011, mentre nel 2015 vi sar unedizione speciale a Milano in occasione dellEXPO.
198
8. Raccomandazioni e indicazioni di policy per il rilancio del settore culturale e creativo in Italia
4. Evoluzione tecnologica nel settore culturale Gli Uffizi tra tradizione e innovazione Nel mondo oltre 2 miliardi di persone sono on-line (di cui 22 Nel corso del 2010 stata varata dalla Galleria milioni in Italia). Grazie ad una rapida serie di discontinuit degli Uffizi di Firenze lapplicazione Uffizi tecnologiche, Internet diventato - in tempi relativamente Touch, la prima soluzione al mondo che brevi - uno dei principali canali di informazione, consente di ammirare in alta definizione tutte le opere del museo, in modo naturale comunicazione, distribuzione e socializzazione. e coinvolgente, allinterno di un quadro Lungi dallessere immune alla spinta innovativa che interessa digitale interattivo, realizzato dalla societ tutti i comparti industriali e agli effetti delle tendenze che Centrica di Firenze. si stanno affermando a livello globale (dallavvento dei social network allesplosione della c.d. mobile Internet), Fonte: www.uffizitouch.it il settore della cultura pu e deve cavalcare linnovazione tecnologica e disporre in questo modo di una vasta gamma di strumenti e tecnologie che aprono nuove opportunit di comunicazione e di generazione di nuovi contenuti. Nonostante alcune grandi istituzioni culturali nazionali si siano gi mosse in questa direzione, appare auspicabile che si dia maggior peso alla tecnologia e alla informatizzazione nellintero settore culturale italiano, a partire dai musei (incluse le realt di medie e piccole dimensioni). La comunicazione in chiave moderna dellofferta culturale, per risultare efficace, dovr sempre pi poggiare su tre elementi-chiave: - La distribuzione digitale degli asset, per entrare in contatto diretto con gli utenti finali; - La costruzione di relazioni attraverso meccanismi di interazione e di raccolta di feedback; - Ladozione di un atteggiamento aperto nei confronti della sperimentazione.
Proposta n.4
- Promuovere lintroduzione di tecnologie ICT nei musei italiani e stanziare incentivi per le aziende produttrici di applicazioni multimediali per il settore culturale ed i sistemi museali: ci consentirebbe di rendere pi efficaci ed attrattive la produzione dei contenuti e le iniziative di comunicazione e marketing delle strutture espositive esistenti (musei, monumenti, aree archeologiche, ecc.) - Investire nella formazione del personale del settore culturale italiano sulle nuove tecnologie per i beni culturali e ambientali attraverso la predisposizione di corsi di aggiornamento permanente.
Allestero sono numerose le realt del sistema culturale e creativo che hanno saputo cogliere al meglio le opportunit offerte dalle nuove tecnologie, creando casi di successo ed aprendo la strada agli sviluppi futuri. Ad esempio, i maggiori musei a livello internazionale hanno inaugurato profili personalizzati sui principali social network (YouTube, Facebook, ecc.) o sviluppato applicazioni mobile che contengono le riproduzioni delle principali opere darte esposte - a pagamento, come quella del museo Tate Modern di Londra, o gratuite, come nel caso del Louvre di Parigi. Inoltre, laccesso in remoto spesso affiancato da applicazioni on-site, mediante lofferta ai visitatori di mappe, programmi e audioguide in formato elettronico, che si possono scaricare sul proprio smartphone grazie a chioschi digitali e punti di accesso Wi-Fi dislocati allinterno del museo (ne un esempio il Museum of Modern Art - MoMA di New York). Nei box che seguono si presentano alcune esperienze di particolare interesse e nuove applicazioni promosse in Italia per rendere maggiormente fruibile lofferta di cultura da parte del pubblico.
199
Leconomia dei beni culturali e ambientali.
Una visione sistemica e integrata
Arte e Tecnologia: 5 esempi di relazione win-win
1. Museo del Prado di Madrid / Google Earth Il prestigioso Museo del Prado di Madrid ha realizzato 14 riproduzioni digitali ad altissima risoluzione dei suoi capolavori pi famosi, tra cui opere di Velazquez, Rembrandt, Goya, Raffaello, Tiziano, e le ha rese disponibili allinterno di Google Earth. Linterfaccia familiare del programma consente agli utenti di muoversi facilmente allinterno delle opere, e di ingrandire dettagli preziosi come le singole pennellate dellartista. 2. Natural History Museum di New York / Twitter Quasi tutte le istituzioni culturali hanno ormai colto limportanza di social media come Facebook e Twitter per creare occasioni di interazione con il proprio pubblico. Raramente per la comunicazione istituzionale lascia spazio a toni pi originali e divertenti: il caso del Museo di Storia Naturale di New York, che ha scelto come portavoce su Twitter lenorme balena che pende dal soffitto dellatrio: lirriverente cetaceo si lascia spesso scappare commenti ironici sui visitatori o sullumanit in generale. 3. Metropolitan Museum of Art di New York / Flickr Un esempio di crowd-sourcing digitale delle attivit promozionali liniziativa Its time we MET, promossa dal Metropolitan Museum of Art di New York. Nel 2009 il museo ha lanciato un concorso che invitava i visitatori a fotografare le proprie esperienze nel museo e a condividerle sul sito di photo sharing Flickr. Dopo una rigida selezione, le immagini pi significative sono state utilizzate nella nuova campagna di marketing istituzionale. 4. Brooklyn Museum di New York / Foursquare Foursquare un servizio di geolocalizzazione via smartphone che combina elementi di socializzazione e ludici: gli utenti possono effettuare check-in in determinate localit per condividere la propria posizione con gli amici e guadagnare premi virtuali. Il Brooklyn Museum sfrutta questo meccanismo per fidelizzare la clientela, offrendo sconti ed altri vantaggi agli utenti che effettuano check-in ripetuti presso il museo. 5. Muse de la Poste di Parigi / Netvibes Il Museo della Posta di Parigi ha adottato un approccio originale alla comunicazione digitale: oltre al sito tradizionale, il museo vive anche sulla piattaforma Netvibes, un servizio di homepage personalizzata molto popolare in Francia. La natura modulare delle pagine di Netvibes consente ad ogni utente di scegliere gli elementi da visualizzare o nascondere, e permette a tutti di suggerire nuovi contenuti da incorporare allinterno del sito.
Le frontiere dellinnovazione in campo culturale in Italia
Il Ministero per i Beni e le Attivit Culturali ha realizzato la mappatura dei pi importanti siti archeologici e musei statali attraverso il servizio Street View del motore di ricerca Google, che permette di passeggiare virtualmente allinterno dei principali monumenti ed aree archeologiche italiane. Prima in assoluto stata Pompei, seguita dal Colosseo, dai Fori Imperiali fino ad estendersi alle principali aree archeologiche del Paese. La tecnologia Google Earth ospita anche una ricostruzione dellantica Roma come appariva ai tempi dellimperatore Costantino: senza lasciare la propria scrivania, possibile muoversi tra oltre 6.000 riproduzioni tridimensionali di edifici storici, accompagnate da schede informative in 9 lingue. Per gli edifici pi famosi, come il Colosseo o la Basilica di Massenzio, sono disponibili anche riproduzioni dettagliate degli interni. Un altro progetto che il MiBAC sta portando avanti, il progetto di realt aumentata con Layar, il primo software per la realt aumentata che permette una personalizzazione in base al servizio che si vuole erogare: anche in questo caso il primo progetto riguarder larea archeologica di Roma (a partire dal Colosseo) con la ricostruzione di Roma antica e di tutto il complesso del Foro romano visibile. Tale tecnologia permetter ad un utilizzatore di smartphone di rivedere ricostruita lintera area archeologica nel suo antico splendore direttamente sullo schermo del proprio cellulare puntando lobbiettivo sullarea interessata. Fonte: MiBAC, 2010
200
8. Raccomandazioni e indicazioni di policy per il rilancio del settore culturale e creativo in Italia
5. Firenze come centro di riferimento mondiale per la digitalizzazione Le tecnologie digitali stanno conoscendo un crescente sviluppo nelle applicazioni per il settore culturale e creativo, determinando significativi impatti industriali ed occupazionali. La stessa Unione Europea ha avviato, nel 2010, una consultazione sul modo migliore per promuovere la digitalizzazione del patrimonio culturale, al fine di aiutare il settore ad entrare nel mondo virtuale, affinch i contenuti possano essere accessibili a tutti grazie ad Internet.
Una biblioteca completamente digitalizzata Nel novembre 2009 la Direzione Generale per lorganizzazione, gli affari generali, linnovazione, il bilancio ed il personale del Ministero per i Beni e le Attivit Culturali si proposta di portare a compimento entro il 2012 la completa digitalizzazione dei servizi e delle risorse culturali per la realizzazione di un programma dinnovazione per il patrimonio culturale. Il progetto ha portato nel 2010 allaccordo con Google per la digitalizzazione di circa un milione di volumi precedenti il 1870, liberi quindi dal diritto dautore e provenienti dalle Biblioteche nazionali di Roma e Firenze, attraverso Google Books, con la possibilit di consultarli on-line, gratuitamente da ogni parte del mondo. Fonte: MiBAC, 2010 Proposta n.5 Firenze potrebbe candidarsi a diventare la capitale mondiale della digitalizzazione (produzione multimediale, ICT, telecomunicazioni, ecc.). La citt potrebbe anche capitalizzare lesperienza derivante dalle attivit del recente Distretto Tecnologico dei Beni Culturali (focalizzato sulle aree del restauro e della conservazione, dellICT e delle tecnologie per i beni culturali e della gestione dei servizi), una delle iniziative attraverso cui Firenze intende riqualificare il tessuto urbano e imprenditoriale del proprio territorio per attrarre talenti creativi.
Lo sviluppo di questo settore nel tessuto imprenditoriale fiorentino ben si accompagna allo sviluppo di specifiche filiere legate ai beni culturali e ambientali, di cui si offre un esempio nella figura seguente.
Figura 4 Alcune attivit-tipo nella filiera dei Beni Culturali Fonte: rielaborazione The European House-Ambrosetti su dati Ministero per i Beni e le Attivit Culturali e Regione Toscana, 2010
Una ricerca condotta nel 2008 sulle imprese tecnologiche presenti nelle diverse province della Toscana8, ha mostrato che la maggiore concentrazione di tali imprese si trova nella provincia di Firenze, con la netta prevalenza di attivit specializzate nella produzione di software, consulenza e attivit connesse.
8
Lindagine ha classificato le aziende secondo i codici ATECO 2007, includendo i settori: fabbricazione di computer e prodotti di elettronica, telecomunicazioni, produzioni software, consulenza e attivit connesse, attivit dei servizi di informazione e altri servizi informatici. Il campione analizzato comprende 577 imprese toscane, di cui 203 a Firenze.
201
Leconomia dei beni culturali e ambientali.
Una visione sistemica e integrata
Allo stesso tempo, le aziende tecnologiche della provincia di Firenze generano il 40% del fatturato regionale (1,5 miliardi di Euro), seguite da Siena e Arezzo, e che le imprese della provincia di Firenze occupano il 32% degli addetti (totale 8.275), seguite da Pisa e Siena. La presenza radicata, nella provincia di Firenze, di specializzazioni nel campo dellICT pu, quindi, supportare lo sviluppo di attivit legate alla digitalizzazione dei beni culturali, favorendo lemergere in parallelo di nuove professioni creative, anche nellambito del Distretto Tecnologico dei Beni Culturali (il cui processo di costituzione attualmente in corso).
Poli creativi a Firenze LAmministrazione Comunale fiorentina ha dato vita ad una serie di iniziative di recupero delle aree dismesse, anche industriali, della citt per renderle poli di attrazione di talenti creativi. Un esempio il restauro del quartiere delle Murate, lex carcere di Firenze interessato da un progetto di recupero e trasformazione in edilizia residenziale pubblica, attivit commerciali e spazi sociali, il cui progetto iniziato nel 2004.
6. Creazione di un database delle best practice per la gestione dei musei Ad oggi si assiste alla mancanza di una ricognizione completa ed esauriente delle principali iniziative culturali di riferimento, sia a livello nazionale che estero.
Proposta n.6
Realizzare una sorta di clearing house delle best practice nel campo delle attivit culturali, ossia un database che gli addetti ai lavori possano consultare quando hanno un problema per trovare esperienze analoghe, link, contatti, ecc.
Un esempio offerto da quanto realizzato negli Stati Uniti dallInstitute of Museum & Library Services IMLS.
Lesperienza dellIMLS per la ricognizione dellofferta museale negli USA
LInstitute of Museum and Library Services (IMLS) lagenzia del governo federale statunitense che supporta lattivit di 123.000 biblioteche e 17.500 musei nazionali attraverso la concessione di finanziamenti, il coordinamento di iniziative con le organizzazioni statali e locali, la promozione dello scambio di idee, informazioni, best practice, lo sviluppo dellapprendimento e dellinnovazione, il supporto allo sviluppo professionale. Nella visione dellIMLS, musei e biblioteche rappresentano una infrastruttura tecnologica e un luogo privilegiato di formazione della coesione sociale delle comunit locali. Grazie allincrocio di queste due dimensioni lobiettivo a cui tendere consentire agli utenti modalit di accesso a informazioni, dati, esperienze, ecc. che superino i vincoli del sovraccarico cognitivo e trasformino quindi linformazione in conoscenza. Nellambito della propria missione, lIMLS ha realizzato un database delle best practice riguardanti la gestione dei musei e delle biblioteche. Al database si accede attraverso il sito dellIMLS. Il sistema di validazione delle best practice di tipo meritocratico, poich segue le stesse logiche di assegnazione dei finanziamenti. Poich tutti i finanziamenti concessi sono pubblici, il ranking dei progetti giudicati meritevoli dallIMLS trasparente, visibile e accessibile a tutti attraverso il sito internet, e la ricerca pu avvenire anche in base alla tipologia dei progetti (progetti di conservazione, progetti educativi, progetti tecnologici, ecc.). Inoltre, ad ogni progetto assegnato un program officer che pu essere contattato per approfondire aspetti specifici delle best practice di riferimento. Fonte: Intervista con Anne Radice, former Director, the Institute of Museum and Library Services (IMLS), 2010
7. Misurazione della soddisfazione del cliente dellofferta culturale Il sistema museale italiano non sembra essere allineato alle principali metriche di misurazione della soddisfazione della clientela, soprattutto a causa della scarsa diffusione di strumenti tecnologici. Ci impedisce un ottimale allineamento tra domanda e offerta nel settore culturale: appare dunque auspicabile la creazione e diffusione di uno standard semplice ed omogeneo a livello nazionale per misurare la soddisfazione del consumatore di servizi culturali.
202
8. Raccomandazioni e indicazioni di policy per il rilancio del settore culturale e creativo in Italia
Proposta n.7
Realizzare, per i musei italiani, uno standard semplice e user friendly per la valutazione della soddisfazione dei visitatori: ci consentirebbe di avere statistiche comparabili a livello nazionale e si potrebbe alimentare automaticamente il database delle best practice.
Per la realizzazione delle proposte n. 6 e 7, sono state gi avviate riflessioni preliminari con il Ministero per i Beni e le Attivit Culturali. 8. Iniziative a sostegno del mecenatismo nel settore artistico e culturale In uno scenario economico in cui la possibilit che i fondi statali a disposizione del settore culturale e artistico subiscano una contrazione appare concreta in molti Paesi europei, il ruolo del mecenatismo privato (rappresentato da imprese, imprenditori e fondazioni bancarie) pi che mai fondamentale per affiancare il tradizionale ruolo dello Stato e delle Amministrazioni Pubbliche. I risultati della survey sul settore culturale e creativo condotta a livello nazionale hanno evidenziato che pi di 8 italiani su 10 sono favorevoli allintroduzione di ulteriori forme di incentivo, a livello fiscale, per promuovere donazioni e sponsorizzazioni di eventi e manifestazioni culturali da parte dei privati9. Passando al confronto internazionale, non stupisce che in tema di provenienza dei finanziamenti per il settore culturale, i cittadini dei Paesi latini (Italia, Spagna e Francia, con circa il 13% delle risposte) si dichiarino favorevoli ad un ruolo forte dello Stato, in misura superiore rispetto a quanto si osserva in Germania e nel Regno Unito (6%) o negli USA (3% circa), dove lorientamento verso un finanziamento delle attivit culturali esclusivamente a carico di soggetti privati interessa il 13,5% degli intervistati. Tuttavia, contrariamente a quanto accade negli Stati Uniti e in molti Paesi europei, in Italia solo le imprese sono in grado di effettuare una piena deduzione delle somme versate, mentre i privati cittadini possono detrarre dallimposta lorda solo il 19% della donazione.
Proposta n.8
Prevedere una legge ad hoc che incentivi la sponsorizzazione dei restauri da parte dei privati, permettendo di dedurre dalle tasse lintero valore dellopera restaurata. In Paesi come gli USA, la defiscalizzazione utilizzata come leva per promuovere linvestimento in beni culturali (anche con lasciti testamentari a musei e fondazioni) Destinare incentivi alla valorizzazione delle opere e delle collezioni private Nel campo immobiliare introdurre agevolazioni fiscali per restauri di edifici destinati a ospitare un museo, una biblioteca, un centro culturale, ecc., permettendo il recupero di spazi dismessi/edifici storici e larricchimento del patrimonio culturale.
Tale evidenza appare coerente con unindagine sul fenomeno delle donazioni in Italia, realizzata nel 2009 dal MiBAC e dallAssociazione Civita, secondo la quale gli italiani di sesso maschile - se potessero detrarre dalle tasse la met della cifra erogata - sarebbero disposti ad aumentarne considerevolmente lentit: da un minimo di 33 Euro a un massimo di 109 Euro, circa il 50% in pi di quanto versano finora. La ricerca, condotta su un campione di 1.000 persone det compresa tra i 25 e i 64 anni, ha evidenziato anche come in favore dellarte e della cultura la quota dei donatori sia superiore rispetto a quanti privilegiano il settore ambientale (5,6% contro 5,1%). Inoltre, 1 italiano su 3 si dichiara disponibile a donare una somma di denaro in favore dei musei volendo contribuire alla conservazione del patrimonio artisticoculturale dellItalia. Fonte: Ministero per i Beni e le Attivit Culturali - Associazione Civita, Donare si pu. Gli Italiani e il mecenatismo culturale diffuso, dicembre 2009.
203
Leconomia dei beni culturali e ambientali.
Una visione sistemica e integrata
9. Sostegno alla collaborazione tra pubblico e privato nel settore culturale Anche in base alle esperienze di altri Paesi, la collaborazione tra Amministrazione Pubblica e settore privato (cittadini, aziende, organizzazioni no-profit, fondazioni bancarie e non, ecc.) nel settore dei beni culturali appare quanto mai auspicabile. Proposta n.9
Favorire iniziative di partnership pubblico-private, favorendo la donazione di opere darte o collezioni dei privati a fronte di vantaggi fiscali Valutare la possibile transizione dei grandi musei italiani in Fondazioni pubblico-private (come gi avvenuto nel caso del Museo delle Antichit Egizie di Torino, della Fondazione per la Valorizzazione Archeologica del sito di Aquileia e del Museo Maxxi a Roma) Potenziare il ruolo delle fondazioni private e del project financing in campo culturale
Nel nostro Paese vi sono numerose fondazioni private che contribuiscono alla tutela del sistema dei beni culturali e ambientali. Un primo esempio offerto dal FAI - Fondo per lAmbiente Italiano, la fondazione nazionale senza scopo di lucro che dal 1975 ha salvato, restaurato e aperto al pubblico importanti testimonianze del patrimonio artistico e naturalistico italiano: oggi si contano sul territorio nazionale 27 monumenti (ville e case darte, castelli, complessi monasteriali, giardini, ecc.) affidati al FAI per donazione o in concessione. Le attivit di conservazione e restauro realizzate dal FAI in Italia sono rese possibili grazie ai fondi raccolti da Istituzioni, cittadini ed imprese e, come viene dichiarato nel proprio Bilancio Sociale 2009, per ogni 100 Euro raccolti, circa 70 Euro sono destinati alla missione istituzionale dellente. Merita un cenno anche il caso dei comitati privati di Venezia: nella ricerca di fondi per la campagna internazionale di restauro di Venezia, 24 Comitati Privati, sia italiani che stranieri, si sono riuniti in una Associazione dei Comitati Privati Internazionali per la salvaguardia di Venezia con due finalit: promuovere, con il patrocinio dellUNESCO, il restauro e il mantenimento del patrimonio artistico e culturale di Venezia, e salvaguardare la qualit della vita della citt allinterno di uno sviluppo sostenibile. Le risorse raccolte dallassociazione sono destinate interamente agli interventi di La gestione pubblico-privata dei musei in Italia conservazione e restauro: le operazioni promosse e finanziate hanno permesso dal 1966 ad oggi circa 1.000 interventi sul La Fondazione Museo delle Antichit Egizie di Torino, costituita ufficialmente patrimonio storico-artistico di Venezia. il 6 ottobre 2004, rappresenta il primo La presente proposta non intende determinare un eccesso di esperimento di costituzione, da parte privatizzazione nel comparto dei beni culturali e ambientali, ma dello Stato, di uno strumento di piuttosto favorire una accelerazione dei rapporti tra pubblico e gestione museale a partecipazione privato in senso positivo, come sta gi avvenendo in alcuni grandi privata. musei italiani diventate Fondazioni pubblico-private. 10. Miglioramento della classificazione statistica per il monitoraggio delle attivit artigianali A livello statistico, stato sottolineato come i dati relativi allartigianato rientrino nellaggregato Industria, poich in Italia la classificazione delle imprese artigiane avviene sulla base della dimensione aziendale anzich secondo parametri qualitativi10. Lassenza di una standardizzazione nelle modalit di classificazione, e quindi di rilevazione, delle attivit economiche associate alle realt artigianali espressione del c.d. Alto Artigianato impedisce di avere una visione completa sulla reale entit di tale comparto e sul suo peso sul sistema industriale complessivo.
10
La definizione di imprenditore artigiano e di impresa artigiana sono contenute nella Legge n. 443 dell8 agosto 1985 (nota come Legge-Quadro per lartigianato). In essa sono specificati anche i limiti dimensionali (art. 4) in base ai quali unimpresa pu essere qualificata come artigiana.
204
8. Raccomandazioni e indicazioni di policy per il rilancio del settore culturale e creativo in Italia
Proposta n.10
Valutare lintroduzione, a livello di ISTAT, della separazione tra il c.d. Alto Artigianato e i settori artigianali in senso stretto, favorendo quindi un miglioramento della disciplina del settore nel nostro Paese.
11. Maggiore valorizzazione dei mestieri darte Oltre ad identificare correttamente il perimetro dazione della produzione artigianale, si dovrebbe anche prevenire o limitare la progressiva scomparsa di attivit che per natura propria o per il settore di appartenenza sono esposte a tale rischio.
Proposta n.11
Istituire un riconoscimento per i mestieri darte in via di estinzione (come stato fatto, ad esempio, in Giappone per i maestri di spada, in Corea, in Francia, ecc.) al fine di valorizzare i mestieri darte e le eccellenze che stanno scomparendo.
I risultati dellindagine condotta da The European House-Ambrosetti tra i componenti del Tavolo Tecnico degli Enti Culturali e delle Universit in merito alla scena culturale e creativa di Firenze11 evidenziano che allArtigianato dArte spetta un posto di primo piano tra le principali professioni creative che in futuro si dovrebbero sviluppare maggiormente sul territorio fiorentino. In particolare, la capacit di saper coniugare manualit, tradizione e competenze artigiane con le nuove tecnologie stata spesso sottolineata quale caratteristica fondamentale dellartigiano fiorentino di domani. In generale, emerso che sul territorio si dovrebbero formare dei professionisti in grado di sviluppare e di utilizzare le tecnologie ICT a favore del contesto culturale. Le altre professioni citate con maggior ricorrenza nel corso dellindagine empirica sono, nellordine: Manager dei beni culturali (si veda, a tale proposito, la proposta n.13), Architetti, Designer, Stilisti e Restauratori/Conservatori. La presenza del mondo dellArchitettura/Moda e della Conservazione dei beni culturali tra le prime sei professioni in cui lelite della scena culturale fiorentina individua ampie possibilit di sviluppo per il futuro del territorio appare, peraltro, coerente con lattuale specializzazione produttiva del sistema economico e imprenditoriale locale: ad esempio, alcuni di questi mestieri sono anche indicati tra le professionalit che oggi detengono il maggior grado di influenza nel panorama culturale fiorentino.
11
Lindagine stata condotta attraverso la somministrazione di un questionario quali-quantitativo ai membri del Tavolo Tecnico degli Enti Culturali e delle Universit tra il mese di maggio e il mese di settembre 2010. Il campione utilizzato (i vertici di 38 enti, sia pubblici che privati) pu considerarsi rappresentativo del settore culturale della citt di Firenze e del suo territorio.
205
Leconomia dei beni culturali e ambientali.
Una visione sistemica e integrata
Figura 5 La percezione dellinfluenza delle diverse professionalit della scena culturale fiorentina (1 = minima influenza; 10 = massima influenza) Fonte: indagine condotta da The European House-Ambrosetti tra i partecipanti al Tavolo degli Enti Culturali e delle Universit di Florens 2010, settembre 2010
Si tratta al tempo stesso, come nel caso dei restauratori, di professionalit esistenti che rischiano di scomparire a causa dellassenza di un naturale rinnovo tra le nuove e le vecchie generazioni. Di conseguenza, la trasmissione dei saperi attraverso la formazione e il dialogo con il mondo del lavoro rappresentano un elemento centrale per la sopravvivenza stessa del patrimonio culturale fiorentino.
Lipotesi di una Scuola Internazionale di Apprendistato Artigianale dEccellenza a Firenze
CNA Firenze ha recentemente proposto il progetto Imparare facendo, finalizzato a ricercare i caratteri salienti costitutivi della bottega artigianale fiorentina e a rigenerare il suo funzionamento produttivo ed economico: ci rappresenta una solida base di partenza indispensabile alla tutela attiva del patrimonio culturale dellartigianato per contrastare gli effetti della crisi economica globale dellultimo biennio. Il progetto prevede la creazione di una Scuola Internazionale di Apprendistato Artigianale dEccellenza, con sede presso CNA Firenze e sedi operative presso le Botteghe Artigiane dEccellenza o Botteghe Scuola della citt, cui saranno ammessi apprendisti comunitari e di Paesi terzi tra i 16 e i 25 anni det. Al termine del percorso formativo (ogni corso dura 16 mesi) ciascun Apprendista ricever un Certificato di Artigiano dEccellenza nel settore nel quale lapprendista si preparato, valido su tutto il territorio dellUE.
12. Maggiore fruibilit della cultura per le fasce giovani della popolazione Bambini e adolescenti sono sempre pi in grado di mobilitare la famiglia nel suo complesso, anche nei consumi in ambito culturale (si pensi, ad esempio, alle classifiche dei film pi visti12). Affinch i musei diventino sempre pi attrattivi per le famiglie, occorre offrire contenuti trasversali, che intercettino scienze, arti e lettere: in altri termini, offrire contenuti che sappiano interessare e coinvolgere simultaneamente adulti, bambini e adolescenti.
12
In Italia nel 2008 nella Top 20 dei film pi visti al cinema ben 15 pellicole sono indirizzate ad un pubblico adolescenziale o infantile (cartoni animati, c.d. teen-movies e commedie per tutta la famiglia). Fonte: rielaborazione The European House-Ambrosetti su dati SIAE, Annuario dello Spettacolo 2009.
206
8. Raccomandazioni e indicazioni di policy per il rilancio del settore culturale e creativo in Italia
Proposta n.12
Rendere i musei, le gallerie darte, le biblioteche, ecc. pi attrattivi per i bambini, al fine di attivare un potente moltiplicatore di visitatori (come testimonia lesperienza dei Childrens Museums) Potenziare la formazione nella scuola primaria italiana su materie come disegno, arte, musica, ambiente, ecc., attribuendo maggior tempo ed attenzione alla creativit ed alla capacit di fare ed investendo sulla qualit degli insegnanti: investire maggiormente sullimportanza della creativit costituisce una valida premessa per diffondere la cultura dellintraprendere e del fare
Un esempio di successo riguarda i c.d. Childrens Museums, il primo dei quali venne fondato a Brooklyn nel 1899. Quello di Indianapolis attualmente considerato il pi grande al mondo13. In Europa, la prima struttura interamente dedicata ai bambini stata la Cit des Enfants, nata a Parigi nel 1988 allinterno della Villette, la Cit des Sciences et des Industries. Il pi importante e il pi grande per il museo Eureka! (4.500 m2), sorto nel 1992 ad Halifax (Yorkshire, Regno Unito), che accoglie pi di 300.000 visitatori allanno ed ha vinto diversi premi nel Regno Unito dei settori per il Design, lArchitettura e il Turismo. In Italia i musei dei bambini sono relativamente recenti: i principali si trovano a Genova (La Citt dei Bambini), Roma (Explora-il Museo dei Bambini) e Napoli (LOfficina dei Piccoli, dentro la Citt della Scienza). Sono in fase di progettazione musei dedicati in altre citt italiane.
Un caso di successo: il Children s Museum di Indianapolis (USA)
Fondato nel 1925 e rinnovato a partire dagli anni Settanta, il Childrens Museum di Indianapolis oggi il pi grande museo al mondo dedicato alle famiglie e ai bambini (15.000 m2 di percorso museale) e rappresenta la principale attrazione turistica dello Stato dellIndiana. Con pi di un milione di visitatori ogni anno e un impatto economico di oltre 75 milioni di dollari, il Childrens Museum ha un impatto maggiore dei due principali team sportivi professionistici dello Stato (gli Indiana Pacers nella NBA e gli Indianapolis Colt nella NFL). La missione del museo ben si riassume nella capacit di creare straordinarie esperienze di apprendimento che hanno il potere di trasformare la vita dei bambini e delle famiglie, cos come la Visione dellistituto consiste nella volont di essere riconosciuti come leader mondiale tra tutti i musei e istituzioni culturali dedicati ai bambini e alle famiglie. Questo museo a misura di bambino offre un valido esempio su come sia possibile offrire contenuti trasversali, intercettando scienze, arti e lettere per riuscire ad interessare e coinvolgere simultaneamente adulti, bambini e adolescenti, oltre a cambiare nel continuo realizzando esposizioni temporanee (come, ad esempio, mostre sui dinosauri, sullantico Egitto e sulla storia dei treni a vapore): a tal fine, uno staff dedicato realizza un piano annuale di misurazione e valutazione del coinvolgimento dei visitatori e del percorso di apprendimento compiuto dalle famiglie che hanno visitato il museo. Fonte: intervista a Jeff Patchen (Chairman & CEO, Childrens Museum of Indianapolis) e www.childrensmuseum. org, 2010
13. Specializzazione di Firenze sul management dei beni culturali Il Tavolo Tecnico degli Enti Culturali e delle Universit attivato per Florens 2010 ha riconosciuto nella specializzazione formativa nel settore della gestione dei beni culturali una importante opportunit per il territorio fiorentino.
13
Negli USA, i Childrens Museums pi importanti per grandezza e per popolarit sono quelli di Indianapolis, Boston, Houston, Manhattan, Philadelphia e Seattle. Sono raggruppati dallassociazione Association of Childrens Museums (ACM), che riunisce 300 Childrens Museum e un totale di 470 membri da 49 Stati Americani e 29 Paesi. LACM stima che nei prossimi 4-6 anni apriranno 80 nuovi musei dei bambini nel mondo.
207
Leconomia dei beni culturali e ambientali.
Una visione sistemica e integrata
Proposta n.13
Istituire a Firenze una Scuola di Alta Formazione sulla Gestione dei Beni Culturali per rendere la citt un centro di riferimento in tale specializzazione.
Alla domanda Secondo Lei il management dei beni culturali pu diventare una specializzazione formativa del territorio fiorentino? il 96% degli intervistati del Tavolo Tecnico degli Enti Culturali e delle Universit ha risposto affermativamente. In generale, circa un terzo degli intervistati (32% delle risposte affermative) concorda sulla naturale predisposizione di Firenze per diventare un centro di riferimento nel campo della specializzazione nella gestione dei beni culturali grazie alla dotazione di monumenti e tradizioni concentrati a Firenze e in Toscana. Il 28% delle risposte affermative sottolinea come nella citt siano tuttora diffuse competenze professionali tali da favorire una simile transizione.
Figura 6 Ragioni a sostegno della specializzazione formativa del territorio fiorentino nel management dei beni culturali Fonte: indagine condotta da The European House-Ambrosetti tra i partecipanti al Tavolo degli Enti Culturali e delle Universit di Florens 2010, settembre 2010
8.3. considerazioni concLusive
Le analisi realizzate nellambito di Florens 2010 hanno permesso di delineare un quadro di ampio respiro sul posizionamento dellofferta culturale italiana a livello sia locale (regioni) che internazionale (le principali realt estere che competono con lItalia nellofferta di prodotti culturali), mostrando al tempo stesso limportanza che il sistema dei beni culturali e ambientali assume nelleconomia complessiva del Paese. Poich la ricchezza della dotazione di patrimonio storico-artistico e ambientale del nostro Paese da sola non sufficiente per garantire posizioni di rendita allItalia, il vero elementochiave che sempre pi far la differenza rappresentato dal continuo sviluppo di un vivace e ricco tessuto di aziende, grandi e piccole, che a vario titolo si inseriscono nel settore culturale e creativo. Gli eventi della Settimana Internazionale dei Beni Culturali e Ambientali e il dibattito alimentato dal Forum Internazionale dei Beni Culturali e Ambientali a Palazzo Vecchio di Firenze contribuiranno a diffondere presso le Istituzioni, il sistema imprenditoriale e i semplici cittadini linvito a credere e ad investire in questo asset straordinario per il Paese, poich solo attraverso una stretta e fattiva collaborazione tra Istituzioni, Industria e Privati per lItalia sar possibile attivare un circolo virtuoso in grado di determinare importanti ricadute di sviluppo per il settore manifatturiero, per lartigianato e, in generale, per i settori creativi. Se recepite dai vari attori coinvolti in tempi rapidi e in modo efficace attraverso adeguate azioni di politica industriale sul territorio, le indicazioni emerse dal progetto Florens 2010, possono costituire un primo passo verso un progressivo rafforzamento del settore culturale nel nostro Paese e nelle
208
8. Raccomandazioni e indicazioni di policy per il rilancio del settore culturale e creativo in Italia
diverse realt locali che mostrano grandi potenzialit da sfruttare in questo comparto: una necessit tanto pi urgente se si considera lattuale momento storico che lItalia sta attraversando. Lauspicio dunque che, coerentemente con la mission della manifestazione, lOsservatorio sul sistema dei Beni Culturali e Ambientali nazionale varato da Florens 2010, possa diventare permanente, al fine di continuare a svolgere la propria attivit di monitoraggio ed approfondimento delle principali tematiche e sfide legate al futuro del settore culturale in Italia e nel mondo. La futura edizione delliniziativa nel 2012 a Firenze rappresenter cos loccasione per fare il punto su quali di queste raccomandazioni di policy siano state recepite dai soggetti competenti (e con quali risultati), nonch su quali, al contrario, sia necessario intervenire con rinnovato fervore.
209
Leconomia dei beni culturali e ambientali.
Una visione sistemica e integrata
210
Principali fonti documentali di riferimento
principaLi Fonti documentaLi di riFerimento
Adorno T.W. - Horkheimer M., The Cultural Industries Model, 1947 Aicardi N., Lordinamento amministrativo dei beni culturali. La sussidiariet nella tutela e nella valorizzazione, in Ambiente, beni culturali, urbanistica, Torino, Giappichelli Editore, 2000 Ainis A. - Fiorillo M., I beni culturali, in Trattato di Diritto Amministrativo, tomo II (a cura di S. Cassese), Milano Giuffr Editore, 2000 Americans for the Arts, Arts & Economic Prosperity III. The Economic Impact of Nonprofit Arts and Culture Organizations and Their Audiences. National Report Americans for the Arts, National Arts Index 2009. An annual measure of the vitality of Arts and Culture in the United States (a cura di R.J. Kushner e R. Cohen), 2010 Associazione Esposizioni e Fiere Italiane (AEFI), Statistiche 2008. Manifestazioni fieristiche internazionali, 2009 Chicago Council on Global Affairs, The Global Cities Index 2008, 2008 Cogo G., I beni culturali ed ambientali tra ordinamento e istituzioni, in I beni culturali, Padova, Cedam, 1995 Confindustria Confcultura, La valorizzazione della cultura fra stato e mercato, febbraio 2008 Confcultura - Federturismo Confindustria, Arte, turismo culturale e indotto economico, 2009 Corriere della Sera, Lo stipendio della cultura, 14 settembre 2010 Council of Europe/ERICarts, Compendium of cultural policies and trends in Europe, 2009 European Commission, The Economy of Culture in Europe, 2006 European Commission, Design as a driver of user-centred innovation, 2009 European Commission, Green Paper Unlocking the potential of cultural and creative industries, 2010 European Parliament, Policy Department Structural and Cohesion Policies (Culture and Education), Financing the arts and culture in the European Union, novembre 2006 European Council, Convenzione europea del Paesaggio, Firenze, 20 ottobre 2000 Eurostat, Cultural Statistics 2007 edition, 2008 Eurostat, Eurostat Regional Yearbook 2008, 2008 Eurostat, Metodologia dei conti regionali. Valore Aggiunto Lordo e investimenti fissi lordi per branca di attivit economica, Lussemburgo, 1995 Eurostat, Eurostat Input Output Manual, doc. B1 B2/CN492e, 2001 Eurostat, Symmetric input-output tables, lavoro presentato al Workshop on Compilation and transmission of tables in the framework of Input-output system in ESA95, Lussemburgo, 14 e 15 novembre 2002 Federazione Italiana Editori Giornali(FIEG), La Stampa in Italia (2000 2006)
211
Leconomia dei beni culturali e ambientali.
Una visione sistemica e integrata
Federculture, Quarto rapporto annuale, 2007 Federculture, Creativit e produzione culturale. Un Paese tra declino e progresso (a cura di R. Grossi), Quinto Rapporto Annuale Federculture 2008, Allemandi & C. Ferretti A., Il Codice dei Beni Culturali, 2004 Florida R., Lascesa della nuova classe creativa, Mondadori, 2003 Fondazione di Firenze per lArtigianato Artistico - Camera di Commercio di Firenze, Artigiani dArte. Mappatura e classificazione delle attivit economiche nella provincia di Firenze (a cura di F. Vichi), 2009 Fondazione Symbola, Prodotto Interno Qualit. Misurare la qualit nelleconomia per competere e guardare al futuro. Rapporto Toscana 2009, collana I Quaderni di Symbola, 2009 Fuegi D., Jenning M., International library statistics: trends and commentary based on the LIBECON data, 2004 International Federation of the Phonographic Industry (IFPI), Top 50 Global Best Selling Albums, 2001-2008 Higher Education Evaluation & Accreditation Council of Taiwan, 2008 Performance Ranking of Scientific Papers for World Universities, 2009 Interbrand, The Leading Luxury Brands 2008 Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), La revisione dei conti nazionali e ladozione del SEC95, 1999 Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), Le tavole delle risorse e degli impieghi e la loro trasformazione in tavole simmetriche, 2006 Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), Annuario delle statistiche culturali (Anno 2006), ottobre 2008 Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), Annuario delle statistiche culturali (anno 2007), luglio 2009 Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), Il Patrimonio museale non statale (Anno 2006), novembre 2009 Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), Il sistema delle tavole input-output, 2010 KEA European Affairs, The Economy of Culture in Europe. Study prepared for the European Commission (Directorate-General for Education and Culture), ottobre 2006 Lanzarone F., Conservazione dei beni culturali: processo conservativo e vigente normativa: il nuovo Codice Urbani, 2004 Lazzaro F.M., I beni culturali tra riforma amministrativa e nuovi principi costituzionali, 2003 Leontief W., Input-output economics, Oxford University Press, New York, 1986 London Development Agency Mayor of London, London - A cultural audit, marzo 2008 Mansi A., La tutela dei beni culturali, II ediz., Padova, Cedam, 1998 Mantegazza S. - Mastrantonio l., Le matrici dirette e inverse delleconomia italiana Anno 1992, ISTAT, 2000
212
Principali fonti documentali di riferimento
Mantegazza S. - Mastrantonio l., Italian Supply and use tables: first evidences, lavoro presentato alla 14th International Conference on input-output techniques, Montreal, 1015 ottobre 2002 Mantegazza S. - Mastrantonio l., Il nuovo sistema input-output, nota metodologica introduttiva, 2004 Ministre de la Culture et de la Communication, Chiffres cls, statistiques de la culture, La Documentation Franaise, Paris, 2009 Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali Dipartimento delle politiche di sviluppo economico e rurale, Vini DOCG DOC: elenco e riferimenti normativi, dicembre 2008 Ministero dello Sviluppo Economico - DPS, Rapporto Annuale, 2007 Ministero del Turismo, Rapporto sul Turismo Italiano, 2009 Ministero per i Beni e le Attivit Culturali - Associazione Civita, Linee guida per la gestione innovativa dei beni culturali, terzo rapporto Vademecum, 2009 Ministero per i Beni e le Attivit Culturali - Associazione Civita, Donare si pu. Gli Italiani e il mecenatismo culturale diffuso, dicembre 2009 Ministero per i Beni e le Attivit Culturali - Istituto Guglielmo Tagliacarne, Le attivit economiche collegate alla valorizzazione del patrimonio culturale, novembre 2007 Nicolardi V., Un sistema di bilanciamento per matrici contabili di grandi dimensioni, ISTAT, Quaderni di Ricerca, n. 4/1998 Picozzi l., I settori di attivit economica nella nuova tavola input-output, relazione presentata al seminario ISTAT La nuova contabilit nazionale, Roma 12-13 gennaio 2000 Regione Lombardia (Assessorato delle Culture, Identit e Autonomie) The European House-Ambrosetti, Cultura e creativit per la competitivit del territorio. Il posizionamento della Lombardia, 2009 Santagata W., Libro Bianco sulla Creativit. Per un modello italiano di sviluppo, Universit Bocconi Editore, Milano, 2009 Societ Italiana degli Autori ed Editori (SIAE), Annuario dello spettacolo 2008 Societ Italiana degli Autori ed Editori (SIAE), Annuario dello Spettacolo 2009 Siemens The European House-Ambrosetti, Gli indicatori e le politiche per migliorare il Sistema Italia e la sua attrattivit positiva, 2003 Siemens The European House-Ambrosetti, Migliorare la cultura pro-business del nostro Paese per migliorarne attrattivit e competitivit, 2005 Siemens The European House-Ambrosetti, Osservatorio Siemens per migliorare lattrattivit positiva del Sistema Italia, 2007 Tamiozzo R., La legislazione dei beni culturali e paesaggistici, Milano, Giuffr Editore, 2004 The European House-Ambrosetti - ANCE, Le citt dei creativi. Le citt che attraggono creativit: quali, perch e le politiche per migliorarle, 2005 The New York Times, At Harvard, the Kitchen as Lab, 19 ottobre 2010
213
Leconomia dei beni culturali e ambientali.
Una visione sistemica e integrata
Throsby D., Assessing the Impacts of the Cultural Industry, The University of Chicago - Cultural Policy Center, 2004 Throsby D., Economics and culture, Cambridge University Press, 2001 Touring Club Italiano, Lannuario del turismo e della cultura 2009, 2009 Ufficio Centro Storico Patrimonio Mondiale UNESCO - Assessorato alla Cultura del Comune di Firenze, Piano di Gestione del Centro Storico di Firenze 2006-2008, marzo 2006 UK Department for Culture Media and Sport (DCMS), The Creative Industries Mapping Document, edizioni 1988, 1998 e 2001 UK Department for Culture Media and Sport (DCMS), Staying Ahead: The economic performance of UKs creative industries, 2007 UK Department for Culture Media and Sport (DCMS), Creative Industry Performance, 2007 UK Department for Culture, Media and Sport (DCMS), Annual Report 2008, 2009 Unioncamere Ministero per i Beni e le Attivit Culturali - Istituto Guglielmo Tagliacarne, Il Sistema Economico Integrato dei Beni Culturali, 2009 United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), Creative Economy. The Challenge of Assessing the Creative Economy: Towards Informed Policy-making, Report 2008
214
Allegato - Alcuni esempi di eccellenze del sistema culturale e creativo fiorentino
ALLEGATO - ALCUNI ESEMPI DI ECCELLENZE DEL SISTEMA CULTURALE E CREATIVO FIORENTINO indice
- Accademia delle Belle Arti di Firenze - Accademia dei Georgofili - Accademia della Crusca - Associazione Dimore Storiche Italiane Sezione Toscana - Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze (BNCF) - The British Institute of Florence - Centro per lArte Contemporanea Luigi Pecci di Prato - Conservatorio di Musica Luigi Cherubini di Firenze - Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana - Fondazione Circolo Rosselli e Circolo di Cultura Politica Fratelli Rosselli - Fondazione Palazzo Strozzi - Gabinetto scientifico letterario G.P. Vieusseux - Galleria dArte Moderna di Palazzo Pitti - Galleria dellAccademia - Galleria degli Uffizi - Istituto Italiano di Scienze Umane (SUM) - Istituto per la Conservazione e la Valorizzazione bei Beni Culturali (ICVBC) - Istituto di Fisica Applicata Nello Carrara (IFAC) - Istituto Lorenzo de Medici - Istituto Universitario Europeo - Musei Civici Fiorentini - Museo Galileo - Istituto e Museo di Storia della Scienza - Museo Nazionale del Bargello - Museo Marino Marini - Museo Stibbert - Opificio delle Pietre Dure di Firenze - Pitti Immagine - Polimoda - Syracuse University in Florence (SUF) - Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana - Soprintendenza per i Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici per le province di Firenze1, Pistoia e Prato - Targetti - Teatro del Maggio Musicale Fiorentino - Universit degli Studi di Firenze - Universit Internazionale dellArte di Firenze (UIA)
Con esclusione della citt di Firenze, per le competenze sul patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico.
215
Leconomia dei beni culturali e ambientali.
Una visione sistemica e integrata
ACCADEMIA DELLE BELLE ARTI DI FIRENZE
www.accademia.firenze.it
CENNI STORICI
Limportanza dellAccademia di Belle Arti di Firenze sottolineata dalla sua storia e dai personaggi che nel corso dei secoli hanno dato vita a questa istituzione: da Michelangelo al Vasari, dal Bronzino al Giambologna, da Benvenuto Cellini a Giovanni Fattori. Le origini dellAccademia delle Belle Arti di Firenze risalgono alle prime organizzazioni corporative dei mestieri della citt; la Compagnia di San Luca o dei pittori nata nel 1339 da considerarsi, infatti, il primo nucleo dal quale nel 1562, sotto la protezione di Cosimo I de Medici, si svilupp la Vasariana Accademia del Disegno, universalmente riconosciuta come una delle prime istituzioni europee che poneva fra i suoi compiti, accanto a quello di confraternita di eminenti artisti ai quali era demandato il governo e la tutela del patrimonio culturale della Toscana, anche quello dellinsegnamento delle arti e delle scienze, segnando cos linizio del moderno concetto di Accademia. La grande modernizzazione europea di questa istituzione fiorentina fu voluta dal Granduca di Toscana Pietro Leopoldo I di Lorena, che nel 1784 riorganizz lAccademia, dandole il carattere di istituto di istruzione artistica pubblico e gratuito che unendo i principi illuministi con i canoni della precettistica neoclassica coniug la volont di favorire la nascita di eccellenti artisti con la finalit di agevolare la rivalutazione delle manifatture artistiche toscane. A corredo della didattica furono allestite una Pinacoteca, una Raccolta di statue, gessi originali e calchi, ed una ricca Biblioteca con una vasta raccolta di edizioni e di stampe rare. Fra Settecento e Ottocento lAccademia fu guida ed esempio alle arti non solo della Toscana; nel Novecento, a lungo regolamentata da una legge del 1923 che allinterno della riforma Gentile dava nuovo ordine allistruzione artistica, lAccademia vide il distacco di Architettura nel 1927 e listituzione dei Corsi Speciali nel 1970.
PRINCIPALI ATTIVIT ED ECCELLENZE DELLENTE
Oggi, con listituzione dei Corsi di Specializzazione e la conseguente distinzione tra Diploma di I e II livello, lAccademia delle Belle Arti di Firenze si orienta secondo un percorso di studi di tipo universitario: Pittura, Decorazione, Grafica, Scultura e Scenografia.
216
Allegato - Alcuni esempi di eccellenze del sistema culturale e creativo fiorentino
ACCADEMIA DEI GEORGOFILI
www.georgofili.it
CENNI STORICI
LAccademia dei Georgofili fu fondata a Firenze nel 1753 per iniziativa di Ubaldo Montelatici, Canonico Lateranense, allo scopo di far continue e ben regolate sperienze, ed osservazioni, per condurre a perfezione lArte tanto giovevole della toscana coltivazione. Il Governo Granducale Lorenese le confer presto carattere di Istituzione pubblica (prima al mondo), affidandole importanti incarichi. Con lUnit dItalia, lAccademia dei Georgofili, che gi di fatto aveva una dimensione extra-toscana, divenne anche formalmente nazionale. Nel 1897 fu riconosciuta come Istituzione Statale. Nel 1932 fu trasformata in Ente morale, ottenendo anche la concessione in uso gratuito dellattuale sede demaniale. La parola Georgofili proviene dal greco dotto, come usava dal Cinquecento in poi: derivando dallunione dei termini georgos e filos, la parola georgofili pu significare per amor dellagricoltura o amici dellagricoltura o per il bene dellagricoltura. Nello stemma dellAccademia sono pertanto presenti i simboli dellattivit agricola dedicati alla dea Cerere (spiga di grano, ramoscello dolivo, grappolo duva) e quelli dellattivit economica e del commercio dedicati alla divinit di Mercurio (caduco: serpenti incrociati ed ali). Anche il motto Prosperitati publicae augendae evidenzia come lattivit dei Georgofili sia sempre stata rivolta allinteresse pubblico.
PRINCIPALI ATTIVIT ED ECCELLENZE DELLENTE
LAccademia dei Georgofili al mondo la pi antica Istituzione del genere ad occuparsi di agricoltura, ambiente, alimenti, e promuove il progresso delle conoscenze, lo sviluppo delle attivit tecnico-economiche e la crescita sociale. Adeguando ai tempi organizzazione, metodologia e strumenti di lavoro, ha sempre mantenuto il proprio ruolo e gli obiettivi enunciati con latto costitutivo. Il lavoro svolto dallAccademia fa emergere un richiamo alla consapevolezza della vitale importanza dellagricoltura, da sempre giustamente considerata settore primario, non solo per la priorit temporale delle sue attivit produttive, ma anche perch ha costituito e costituisce tuttora la fonte principale del nostro sostentamento alimentare. Inoltre, stata la matrice dello sviluppo manifatturiero industriale (al quale ha fornito materie prime, forza lavoro e capitali) e rappresenta il fondamentale fattore di equilibrio per la biosfera della quale luomo parte integrante e dalla quale dipende la sua stessa sopravvivenza. LAccademia ha accompagnato lo sviluppo delle scienze agrarie, nella loro accezione pi ampia. Seguendo levolversi dei tempi, continua ad affrontare le nuove problematiche che investono lagricoltura e tutti i rapporti delluomo con lambiente naturale. Conduce studi e ricerche, adottando le pi moderne metodologie, al fine di promuovere concrete iniziative. I risultati vengono esposti e discussi pubblicamente in apposite Adunanze pubbliche, poi riportate nellannuale volume degli Atti. Per affrontare lo studio di ogni singola problematica, lAccademia liberamente si avvale della collaborazione dei pi qualificati studiosi e tecnici, ovunque siano, anche se afferenti a diversi enti pubblici e privati. Per lo studio di specifici temi sono costituiti anche appositi Centri e Comitati consultivi. Inoltre, al fine di potenziare attivit e collaborazioni sullintero territorio nazionale, i Georgofili hanno realizzato sezioni geografiche. Lattivit editoriale oggi comprende anche la Rivista di storia dellagricoltura, le Informazioni dai Georgofili, monografie su specifici argomenti, pubblicazioni commentate di antichi manoscritti, vari cataloghi. La Biblioteca, la Fototeca e lArchivio offrono agli studiosi un patrimonio documentario tematico di ineguagliabile valore, oggetto continuo di indagini storiche da parte di studiosi di varie discipline. I pregi di tale patrimonio vengono messi in rilievo anche da numerosi momenti espositivi organizzati periodicamente su tematiche specifiche. Fra le attivit dellAccademia vi sono altre iniziative, quali corsi di formazione e aggiornamento. I Georgofili hanno rappresentato e rappresentano uno strumento per confrontare e far circolare le idee, collegandosi con il mondo e contribuendo a mantenere alto il prestigio della nostra cultura, sempre nel pieno rispetto del motto Prosperitati publicae augendae.
217
Leconomia dei beni culturali e ambientali.
Una visione sistemica e integrata
ACCADEMIA DELLA CRUSCA
www.accademiadellacrusca.it
CENNI STORICI
LAccademia della Crusca la pi antica accademia linguistica dEuropa; ebbe origine da un gruppo di dotti fiorentini che, tra il 1570 e il 1580, si riunivano per trattare, in riunioni conviviali e anche scherzose (dette allora cruscate) temi di letteratura e di lingua. Nel 1582 al gruppo dei fondatori (Giovan Battista Deti, Anton Francesco Grazzini, Bernardo Canigiani, Bernardo Zanchini e Bastiano de Rossi) si aggiunse Lionardo Salviati, insigne filologo e teorico della lingua, che dette un vero programma di ricerca allAccademia e ne fiss anche la simbologia, basata sullanalogia della buona lingua come fior di farina che viene separata dalla crusca: di qui lemblema del frullone o buratto, macchina che allepoca costituiva una grande innovazione tecnologica. Listituzione assunse come motto un verso tratto dal Petrarca - il pi bel fior ne coglie - e adott una ricca simbologia tutta riferita al grano, alla farina e al pane. Nel corso dei secoli lAccademia ha avuto oltre 1.200 membri italiani e stranieri, tra i quali Galileo Galilei, Redi, Muratori, Voltaire, i granduchi di Toscana Pietro Leopoldo e Leopoldo II, Metastasio, Manzoni, Capponi, Leopardi, Tommaseo, Ascoli, Carducci, De Amicis, DAnnunzio, Barbi e Luzi. Attualmente lAccademia formata da 49 accademici fra ordinari, emeriti, soci corrispondenti italiani e soci corrispondenti stranieri. Dal maggio 2008 ne presidente Nicoletta Maraschio, prima donna a ricoprire questa carica dopo oltre quattro secoli di vita dellAccademia. Impresa principale degli accademici stato il Vocabolario, pubblicato in cinque edizioni dal 1612 al 1923: lopera ha dato un contributo decisivo alla codificazione e alla diffusione della lingua italiana ed stato il primo esempio di dizionario moderno in Europa. Lattivit lessicografica, interrotta nel 1923, ripresa negli anni Sessanta, ed ora continuata, per quanto riguarda il Tesoro della Lingua Italiana delle Origini (TLIO), dallOpera del Vocabolario Italiano, Istituto del CNR che ha sede presso lAccademia (pubblicato in rete in corso dopera: www.vocabolario.org). LAccademia ha attualmente sede a Firenze nella Villa Medicea di Castello. Edificata su un antico nucleo risalente al secolo XII, divenne nel 1477 la dimora di Lorenzo e Giovanni di Pierfrancesco de Medici, cugini di Lorenzo il Magnifico, e poi dei loro discendenti, granduchi di Toscana. Passata ai Lorena, pervenne ai Savoia che nel 1919 la donarono allo Stato. Nella sua sede lAccademia conserva anche una ricca collezione di oggetti darte, tra cui le famose pale, 154 dipinti su tavola a forma di pala da mugnaio nei quali sono raffigurati gli emblemi degli accademici.
PRINCIPALI ATTIVIT ED ECCELLENZE DELLENTE
Oggi lAccademia della Crusca il pi importante centro di ricerca scientifica dedicato allo studio e alla promozione dellitaliano; si propone in particolare lobiettivo di fare acquisire e diffondere nella societ italiana e allestero la conoscenza storica della lingua nazionale (anche attraverso un servizio di consulenza linguistica) e la coscienza critica della sua evoluzione attuale nel quadro degli scambi interlinguistici del mondo contemporaneo. Intrattiene rapporti internazionali con universit e istituzioni di ricerca, organizza incontri, seminari e convegni sullitaliano, svolge un ruolo attivo nel campo della politica linguistica europea (in particolare con il progetto La Piazza delle Lingue, arrivato nel 2010 alla IV edizione, dedicata allItaliano degli altri). LAccademia della Crusca mantiene inoltre con il mondo della Scuola un rapporto costante che costituisce un legame fra il mondo della ricerca e quello della formazione. Nel corso degli ultimi anni quest attivit, gi avviata attraverso la rivista La Crusca per Voi (fondata nel 1990 da G.Nencioni e attualmente diretta da F.Sabatini), si ulteriormente strutturata, trovando validi sostegni nel Ministero della Pubblica Istruzione e nella Direzione Scolastica Regionale per la Toscana. Con questultima sono stati organizzati corsi per insegnanti, rivolti ad approfondire alcuni temi relativi allo studio delle strutture dellitaliano e allo sviluppo delle abilit linguistiche. A partire dallanno scolastico 2005-2006 stato avviato il progetto Insegnare italiano, che ha gi portato alla realizzazione di quattro cofanetti di DVD contenenti la registrazione delle lezioni e i materiali didattici elaborati nel corso degli incontri (2006-2007: Modelli per lo studio della lingua; 2007-2008: Il lessico tra grammatica e dizionari; 2008-2009: Insegnare italiano come lingua materna e come lingua seconda; 2009-2010: Insegnare italiano nelle classi multilingui). Questi ultimi due progetti sono stati costruiti nellottica dellintegrazione linguistica degli immigrati proprio a partire dalla Scuola. I materiali sono stati diffusi anche in varie altre regioni con iniziative particolari legate ad esperienze locali. LAccademia mette a disposizione del pubblico e degli studiosi il proprio Archivio Storico, intitolato allaccademica Severina Parodi che gli ha dato con importanti studi un primo ordinamento sistematico, e una biblioteca specialistica di oltre 120.000 volumi dedicati allo studio della lingua italiana e della linguistica generale, con unampia raccolta di testi classici (letterari, filosofici, giuridici, scientifici, storico-artistici), una ricchissima sezione di dizionari e di grammatiche, in gran parte digitalizzate e consultabili in rete, e di riviste specializzate italiane e straniere. Il patrimonio librario si arricchito anche attraverso lacquisizione delle biblioteche personali degli studiosi Alberto Chiari, Gabriella Giacomelli, Bruno Migliorini, Francesco Pagliai, Pietro Pancrazi e Giovanni Nencioni. La Biblioteca fa parte del Sistema Documentario Integrato dellArea Fiorentina (SDIAF) e di Libri in Rete, servizio di prestito interbibliotecario promosso dalla Regione tra le reti bibliotecarie della Toscana. LArchivio Storico raccoglie anche le carte dellAccademia (a partire dal 1582) e conserva documenti relativi alla compilazione delle cinque edizioni del Vocabolario, diari, verbali, lezioni accademiche, raccolte di carteggi, atti di concorsi letterari. Tra i manoscritti, autografi di Lionardo Salviati, Voltaire, Monti, Manzoni, Leopardi, Giusti, Tommaseo, Carducci, De Amicis. Gli si affianca lArchivio Moderno che raccoglie carte autografe e corrispondenza di letterati e linguisti del Novecento, tra i quali Flaminio Pellegrini, Giorgio Pasquali, Pietro Pancrazi, Francesco Pagliai, Bruno Migliorini, Alberto Chiari, Gianfranco Contini, Franca Brambilla Ageno e Gabriella Giacomelli. LAccademia ha una vivace attivit editoriale: cura ledizione critica di significativi testi della tradizione letteraria e linguistica italiana, pubblica i risultati di ricerche originali sulla storia e la struttura dellitaliano, e, oltre a La Crusca per voi, con la casa editrice Le Lettere tre riviste specialistiche: Studi di filologia italiana, Studi di grammatica italiana e Studi di lessicografia italiana. Il sito web dellAccademia un portale interamente dedicato alla lingua italiana: svolge la funzione di raccogliere, selezionare e rendere disponibile, sia al largo pubblico, sia agli specialisti, una grande quantit di informazione qualificata in materia linguistica. Il contenuto organizzato in varie sezioni e le informazioni sono accessibili sia nella forma della libera consultazione, sia attraverso motori di ricerca specifici che consentono il reperimento veloce di dati. Il sito ospita numerosi progetti multimediali realizzati dallAccademia negli ultimi anni, tra cui quelli che danno un completo accesso digitale ad alcune sezioni della Biblioteca, e in particolare alle cinque edizioni del Vocabolario degli Accademici (www.lessicografia.it). La sezione Lingua in rete tiene aperto un continuo dialogo con gli utenti che possono inviare quesiti linguistici e richiedere notizie sui neologismi. Una redazione di linguisti formula risposte adeguate che, a seconda della rilevanza, vengono inviate personalmente ai richiedenti o pubblicate nella sezione Consulenza linguistica che contiene attualmente pi di 250 articoli. Dalla sua apertura, nel 2002, il sito ha avuto oltre 4 milioni di visitatori per un totale di circa 100 milioni di contatti. Nel 2003, per iniziativa di alcuni esponenti del mondo della cultura e delleconomia, al fine di sostenere lattivit scientifica, culturale e formativa della Crusca, stata fondata lAssociazione Amici dellAccademia della Crusca-Onlus.
218
Allegato - Alcuni esempi di eccellenze del sistema culturale e creativo fiorentino
ASSOCIAZIONE DIMORE STORICHE ITALIANE SEZIONE TOSCANA
www.adsi.it - www.adsitoscana.it
CENNI STORICI
LAssociazione Dimore Storiche Italiane (ADSI) un sodalizio nato nel 1977, senza fini di lucro, per iniziativa di un gruppo di privati, dotati di grande entusiasmo e capacit professionali. Questi, proprietari di edifici vincolati per interesse artistico e storico, consapevoli sia dellimmenso valore che tali testimonianze del passato rappresentano per la nostra storia, sia dellonere che una solerte cura ed attenta manutenzione di tali immobili comporta, hanno dato vita ad un organismo che li rappresenti. LAssociazione si occupa di arte, di bellezze naturali, di beni ambientali e di immobili di interesse storico artistico, inclusi edifici costruiti per funzione residenziale o successivamente adibiti a residenza (come case e palazzi, ville, torri e castelli, parchi e giardini e perfino casolari): monumenti unici la cui salvaguardia costituisce elemento di interesse collettivo. Va diffondendosi la nozione che il bene culturale costituisca risorsa economica dinteresse generale e debba, quindi, essere gestita. LADSI fa parte della Union of European Historic Houses Associations (UEHHA), che raggruppa tutte le Associazioni similari europee. LAssociazione Italiana riunisce, oggi, con i suoi circa 4.600 iscritti, i proprietari di molte meraviglie architettoniche e paesaggistiche del nostro Paese. Si articola in Sezioni Regionali, costituite in 18 delle regioni italiane. La Sezione Toscana dellAssociazione (costituita nel giugno 1978) ha sede a Firenze ed annovera circa 1.000 iscritti.
PRINCIPALI ATTIVIT ED ECCELLENZE DELLENTE
LAssociazione mantiene stretti contatti con il Ministero per i Beni e le Attivit Culturali, con le Soprintendenze e con le autorit regionali e locali per facilitare e promuovere, quando possibile, difesa e valorizzazione degli immobili di privati. Al fine di illustrare in maniera pi esaustiva tali rapporti, si pu citare anzitutto la normativa contenuta nella Legge 512 dellagosto 1982, quella emanata con DPR 131 del 1986 e quella sullICI del 1993: si tratta di misure che prevedono agevolazioni fiscali per i proprietari di immobili vincolati. Tali agevolazioni facilitano, giuridicamente e fiscalmente, la conduzione dei beni vincolati in mano ai privati e testimoniano linteresse dellamministrazione pubblica e delle forze politiche di addivenire ad una considerazione del patrimonio immobiliare privato, non solo in termini di pura disciplina vincolistica, ma di tutela attiva degli interessi privati. Merito dellADSI di essersi fatta portavoce dei propri soci presso gli organi di governo. Tutti gli anni alcune Sezioni dellADSI organizzano la manifestazione Cortili e giardini aperti, in citt come Roma, Milano, Firenze, Bologna, Palermo e Lecce: migliaia di persone sono ammesse alla visita di decine di palazzi e giardini storici privati. Inoltre, numerose sono le iniziative culturali programmate dallADSI in varie parti del nostro Paese. Per la Toscana si citano i grandi convegni tenutisi rispettivamente a Lucca, Pisa, Pistoia e Siena sulle dimore storiche e sullarte dellabitare in quelle citt, con la pubblicazione di importanti volumi illustrati con le relazioni svolte da 140 studiosi.
219
Leconomia dei beni culturali e ambientali.
Una visione sistemica e integrata
BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE DI FIRENZE (BNCF)
www.bncf.firenze.sbn.it
CENNI STORICI
La Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze (BNCF) costituisce larchivio nazionale del libro italiano e ne garantisce la tutela, la valorizzazione e lincremento documentando il posseduto e assicurando la circolazione dei documenti. La Biblioteca dispone di un patrimonio di 6.000.000 volumi a stampa, 120.000 testate di periodici di cui 15.000 in corso, 4.000 incunaboli, 25.000 manoscritti, 29.000 edizioni del XVI secolo e oltre 1.000.000 di autografi. Le scaffalature dei depositi librari coprono attualmente 120 Km lineari, con un incremento annuo di circa 2 Km. Nellanno 2008 gli utenti in sede sono stati 200.680 (studiosi e visitatori), mentre gli accessi al sito sono stati 78.313.414. Questa ricchezza, che documenta lidentit nazionale, fa della BNCF una delle pi importanti biblioteche italiane, nonch lunica che possa rappresentare nella sua interezza lo svolgersi della vita culturale del Paese. La Biblioteca Nazionale di Firenze nata nel 1714 a beneficio universale della citt, grazie al lascito dellerudito Antonio Magliabechi, e ha aperto al pubblico nel 1747, nel 1861 si unificata con la grande Biblioteca Palatina dei granduchi di Lorena ed ha assunto il nome di Biblioteca Nazionale e dal 1885 lappellativo di Centrale. Dal 1870 la Biblioteca riceve per diritto di stampa una copia di tutto quello che viene pubblicato in Italia. Originariamente la Biblioteca ebbe sede in locali che facevano parte del complesso degli Uffizi; nel 1935 fu trasferita nella sua sede attuale, costruita, a partire dal 1911, su progetto dellarchitetto Cesare Bazzani e successivamente ampliata dallarchitetto V.Mazzei. Ledificio, uno dei rari esempi di edilizia bibliotecaria, fa parte dellarea monumentale del complesso di Santa Croce.
PRINCIPALI ATTIVIT ED ECCELLENZE DELLENTE
Fra i compiti istituzionali della Biblioteca Nazionale Centrale c la pubblicazione della Bibliografia Nazionale Italiana (BNI), che, come in ogni Paese del mondo, rappresenta la notizia ufficiale di quanto viene stampato in Italia e cura la produzione dei pi importanti strumenti scientifici necessari alla professione bibliotecaria. La BNCF costituisce un servizio culturale insostituibile per gli utenti locali e per gli studiosi di tutto il mondo in quanto: - sede pilota per lautomazione dei servizi bibliotecari; - promuove e coordina la definizione di standard e procedure per la catalogazione, la conservazione, il restauro e luso dei documenti.; - svolge un ruolo primario nei progetti di ricerca e di sviluppo in materia di digitalizzazione dei beni culturali. Ad esempio, il progetto Magazzini Digitali si propone di sperimentare su larga scala una infrastruttura di immagazzinamento e gestione delle risorse digitali affidabile e sicuro nel tempo. I Magazzini Digitali intendono offrire un servizio di accesso nel lungo periodo alle risorse digitali attraverso la predisposizione di una infrastruttura che possa crescere seguendo le esigenze e le risorse economiche disponibili e che possa essere riutilizzata in tutti i contesti che richiedano la conservazione di risorse digitali; - partecipa ai principali progetti nazionali ed internazionali in materia di biblioteche; - costituisce un centro di eccellenza per il restauro del libro e per lo studio e lapplicazione delle nuove tecnologie alla catalogazione libraria; - in base alla nuova legge sul deposito legale ha assunto un ruolo ancora pi importante ed impegnativo visto lobbligo di raccogliere e soprattutto conservare nel tempo anche tutte le pubblicazioni digitali; - per ottemperare al compito di fruizione e valorizzazione del suo patrimonio, organizza convegni, presentazioni di volumi e mostre bibliografiche che attirano visitatori da tutto il mondo.
220
Allegato - Alcuni esempi di eccellenze del sistema culturale e creativo fiorentino
THE BRITISH INSTITUTE OF FLORENCE
www.britishinstitute.it
CENNI STORICI
Il British Institute of Florence, fondato nel 1917 per promuovere gli scambi culturali tra lItalia e il mondo anglofono e insignito della Royal Charter nel 1923, stato il primo degli istituti culturali britannici a operare al di fuori dal Regno Unito e fu preso a modello alla nascita del British Council nel 1934. Nei primi anni dalla sua fondazione, il British Institute diede vita a una serie di conferenze, pubblic un periodico (La Vita Britannica), e avvi la formazione della propria biblioteca. Gli obiettivi dellIstituto, definiti proprio nella Charter del 1923, erano quelli di promuovere la mutua conoscenza tra i cittadini italiani e quelli dei Paesi aderenti al Commonwealth attraverso il mantenimento a Firenze di una biblioteca che illustrasse entrambe le culture e promuovesse lo studio delle due lingue. Negli anni Venti e Trenta il British Institute svilupp la sua missione didattica e, secondo un accordo con lUniversit di Firenze, divenne responsabile dellinsegnamento universitario della lingua inglese formando cos unintera generazione di futuri insegnanti nelle scuole italiane. Dopo la fine del secondo conflitto mondiale, lIstituto continu a sviluppare i suoi corsi, in particolare avviando quello di storia dellarte, e a mantenere fede ai propositi iniziali. LIstituto opera in due storiche sedi nel centro di Firenze: il Centro Linguistico si trova nel Palazzo Strozzino, mentre la Biblioteca e Centro Culturale ospitata in Palazzo Lanfredini sulla riva sud del fiume Arno.
PRINCIPALI ATTIVIT ED ECCELLENZE DELLENTE
Oggi il British Institute offre un vasto programma di corsi di lingua inglese, lingua italiana e storia dellarte e organizza numerosi eventi culturali d varia natura. LIstituto offre corsi di lingua italiana a tutti i livelli, dal principiante fino a quelli pi avanzati: gli obiettivi principali su cui si concentra linsegnamento mirano a consentire allo studente di migliorare progressivamente nella padronanza dellitaliano. I corsi di lingua inglese vanno dal livello principiante a livello avanzato, inclusi corsi di Business English, corsi di preparazione agli esami di Cambridge ESOL e corsi estivi intensivi. I corsi di storia dellarte sono tenuti in lingua inglese e si concentrano sullarte italiana del Medioevo e del Rinascimento. Le classi di disegno dal vero sono organizzate presso uno storico atelier fiorentino, la scuola di belle arti Charles H Cecil Studios. La Biblioteca Harold Acton raccoglie una delle pi ampie collezioni di libri in lingua inglese nellEuropa continentale: 50.000 volumi pubblicati tra il XVI e il XXI secolo e circa 500 nuovi titoli ogni anno. La Biblioteca ospita numerosi eventi culturali durante tutto lanno, rappresentando cos un vitale punto di contatto e scambio tra comunit inglese e italiana, sia che si tratti di residenti a lungo termine, di studenti o visitatori.
221
Leconomia dei beni culturali e ambientali.
Una visione sistemica e integrata
CENTRO PER LARTE CONTEMPORANEA LUIGI PECCI DI PRATO
www.centropecci.it
CENNI STORICI
Il Centro per larte contemporanea Luigi Pecci di Prato la prima istituzione museale italiana con una sede costruita ex novo per presentare, collezionare, documentare e promuovere gli sviluppi delle ricerche artistiche pi avanzate. Collocato sulla direttrice viaria tra Firenze e Pistoia, in prossimit dellingresso est di Prato, ne testimonia il carattere intraprendente, dinamico, proprio di una citt industriale attenta alla ricerca e allinnovazione sia in ambito economico che culturale. Donato alla citt nel 1988 dal Cavaliere del Lavoro Enrico Pecci in memoria del figlio Luigi, scomparso prematuramente, stato fondato con il contributo del Comune di Prato, di varie aziende, istituzioni pubbliche e privati cittadini.
PRINCIPALI ATTIVIT ED ECCELLENZE DELLENTE
Il Centro attivo e ha relazioni a livello internazionale attraverso unampia programmazione di mostre temporanee, attivit didattiche e di mediazione, di documentazione e informazione sullarte contemporanea, spettacoli ed eventi multimediali. Presenta, inoltre, una importante collezione permanente, composta da opere dei maggiori artisti contemporanei, a testimonianza dellattivit espositiva e di ricerca del Centro: la raccolta del museo pratese include importanti opere soprattutto dagli anni Ottanta e, nella sua complessit, presenta al meglio le tendenze e gli sviluppi del linguaggio artistico del nostro presente. La ricchezza della collezione e la carenza di un suo permanente spazio espositivo allinterno dellattuale edificio, progettato da Italo Gamberini, sono i motivi che hanno indotto il Consiglio Direttivo del Centro a promuovere la possibilit di un ampliamento delledificio esistente e la famiglia Pecci a commissionare il progetto allarchitetto Maurice Nio. La nuova sfida lanciata dal Centro e dalla famiglia Pecci stata accolta con favore dal Comune di Prato e dalla Regione Toscana che ne finanziano la realizzazione. Attraverso lesposizione continuativa della collezione e laggiornamento dei servizi, al termine dei lavori previsti dal 2010 al 2012 (senza comportare linterruzione dellattivit espositiva), si potr consolidare il ruolo di museo darte contemporanea regionale e riaffermarne il carattere di eccellenza e unicit nel panorama artistico nazionale e internazionale. Lampliamento architettonico progettato da Maurice Nio risponde ad alcuni requisiti fondamentali: raddoppiare lo spazio espositivo a disposizione e permettere unampia presentazione del patrimonio permanente accanto alle mostre temporanee, facilitare la suddivisione degli spazi interni e lalternanza dei progetti espositivi, migliorare i percorsi dei visitatori, aprire sulla citt i servizi di accoglienza, le aule didattiche, gli spazi per la vendita commerciale e la ristorazione che sono ormai parte integrante dellofferta culturale del museo contemporaneo. Disponendo simultaneamente di servizi al pubblico completamente rinnovati e di vari spazi espositivi organici fra loro, il Centro potr rafforzare limmagine di una citt e di una regione in cui, oltre a lunghe tradizioni culturali e grandi civilt artistiche del passato, hanno sede anche significativi esempi e molteplici sviluppi darte contemporanea.
222
Allegato - Alcuni esempi di eccellenze del sistema culturale e creativo fiorentino
CONSERVATORIO DI MUSICA LUIGI CHERUBINI DI FIRENZE
www.conservatorio.firenze.it
CENNI STORICI
E indubbio che Firenze, culla del melodramma e citt darte per eccellenza, abbia avuto da sempre delle scuole di musica a partire, perlomeno, dal Trecento, lepoca della fioritura dellArs Nova. Queste scuole ebbero, per, per lungo tempo, carattere privato poich sorsero grazie alliniziativa personale di taluni rinomati artisti o per linteressamento di mecenati, senza assumere carattere di funzione pubblica. Sotto il governo francese, sul finire del Settecento e ai primi dellOttocento, furono istituite le prime scuole municipali di musica, sulla consistenza e lordinamento delle quali non si hanno notizie precise. Comunque, in seno alle varie Accademie esistenti a Firenze (come lAccademia Fiorentina, lAccademia della Crusca e lAccademia degli Apatici), furono istituiti insegnamenti regolari, fra i quali non sembra, per, che figurasse quello delle discipline musicali. Si hanno notizie pi precise sullAccademia delle Belle Arti, che esisteva gi nel 1811 ed era suddivisa in tre classi, una delle quali era dedicata alla musica e alla declamazione: dalla classe di Musica e declamazione dipendevano le scuole di musica con propri insegnanti, fra le quali quelle di contrappunto, canto, pianoforte, violino, declamazione e arte teatrale. Un decreto granducale del 6 agosto 1849 convert la scuola musicale dellAccademia delle Belle Arti in Istituto musicale a s, chiamando a dirigerlo Giovanni Pacini, noto compositore dellepoca ed eccellente operista (autore di 90 opere teatrali, fra cui Saffo e Medea). Vittorio Emanuele II, con decreto del 15 marzo 1860, soppresse le vecchie scuole, distaccandole definitivamente dallAccademia delle Belle Arti e trasformandole in Regio Istituto Musicale di Firenze. Direttore ne fu Luigi Ferdinando Casamorata, una delle figure pi illustri, insieme ad Abramo Basevi, della vita musicale fiorentina dellepoca. Nel 1910 lIstituto musicale viene intitolato a Luigi Cherubini in omaggio al grande maestro di origine fiorentina. Infine, durante la direzione di Arnaldo Bonaventura, il Regio Decreto del 31 Dicembre 1923 trasform lIstituto in Regio Conservatorio di Musica. La biblioteca nata dal fondo della vecchia scuola, dallarchivio della corte granducale di Toscana (Fondo Pitti) e da varie donazioni (barone Ricasoli, Casamorata, Basevi, principe Corsini, ecc.). Particolarmente importante il fondo Basevi, composto di materiale bibliografico di varie epoche.
PRINCIPALI ATTIVIT ED ECCELLENZE DELLENTE
Lattuale offerta formativa del Conservatorio L.Cherubini, composta dai corsi tradizionali del Vecchio Ordinamento, dalle sperimentazioni di Triennio e Biennio Specialistico, dai corsi abilitanti previsti dal D.M. 137/07. Sostanzialmente tutto quanto previsto dalle attuali norme, attivato in corsi di diploma tradizionale, di diploma accademico triennale e biennale e biennio abilitante. La funzione del L.Cherubini, unico conservatorio della Regione Toscana, quella di offrire un servizio pubblico di alta qualit e con la pi ampia offerta formativa possibile. Oltre alla completa offerta formativa di tutti gli strumenti dellorchestra sinfonica, sono attivati corsi di musica e nuove tecnologie, Jazz, Fisarmonica, Sassofono e musica antica (flauto dolce, clavicembalo, viola da gamba), oltre ai corsi di canto, musica vocale da camera, composizione, direzione dorchestra, musica vocale e direzione di coro e di strumentazione per banda, accompagnatore al pianoforte e didattica della musica, con un organico di 107 docenti. I corsi di diploma accademico triennale e biennale, attivati nel Conservatorio di Firenze dallanno accademico 2003-2004, hanno prodotto 273 diplomati dal 2006 ad oggi, di cui 60 al triennio e 213 al biennio (escluse 39 prove finali che si terranno nel mese di febbraio 2010, ultima sessione della.a. 2008-2009), con il rapporto pi elevato, tra i conservatori italiani, tra numero discritti e diplomati. Altro dato importante che il numero discritti allAlta Formazione per la.a. 2009-2010 di 239 studenti, di cui 124 al triennio e 115 al biennio. Tutto ci a fronte di un numero di 552 studenti iscritti al Vecchio Ordinamento con una media di 40-60 diplomati ogni anno. La qualit della formazione anche confermata dai numerosissimi concorsi vinti dagli studenti, tra i quali i due prestigiosi Premio delle Arti, vinti nel 2009 da studenti del L.Cherubini, sui 16 previsti dal MIUR. Le attivit di produzione delle tre orchestre impegnano tutte le scuole del Conservatorio, coinvolgendo studenti di tutti i livelli, in collaborazione con il coro e le scuole di canto per decine di concerti in un repertorio vastissimo, dalla musica barocca a quella contemporanea, compresi brani scritti dagli studenti della scuola di composizione, cos come produzioni dei dipartimenti di Musica e Nuove Tecnologie, Jazz e Musica Antica. Vengono eseguiti concerti, solistici e con formazioni cameristiche nelle rassegne interne ed esterne, nelle scuole, nei musei, in altri conservatori e in festival prestigiosi. Vengono effettuate numerose presentazioni di libri di carattere musicale, e organizzati decine di seminari con ospiti prestigiosi. Al Conservatorio di Firenze esiste anche uno dei centri pi importanti in Italia di ricerca sul restauro dei supporti audio, MARTLAB, che opera allinterno della Struttura Multimediale e che gode di finanziamenti dell Ente Cassa di Risparmio di Firenze e altri sponsor. Anche la Biblioteca del Conservatorio, vero tesoro composto di circa 100.000 volumi antichi di musica, ha ormai conosciuto la propria rinascita, con il restauro e la riapertura della sala di lettura, con la digitalizzazione, sin dal 2005, di opere importantissime i cui dati sono disponibili in SBN Musica, e lattuale integrale catalogazione digitale, finanziata da Ente Cassa di Risparmio di Firenze, dalla Regione Toscana, dalla Galleria dellAccademia e da Villa I Tatti - Harvard University. I progetti MARTLAB e Firenze Biblioteca Digitale Musicale per il Mondo sono stati ammessi al cofinanziamento nazionale per lAnno Europeo della Creativit e dellInnovazione 2009. E stato rinnovato il comodato con la Galleria dellAccademia, che della prestigiosa collezione degli strumenti antichi del Conservatorio ha fatto un museo di rilevanza internazionale. In questi anni, il Conservatorio ha stipulato decine di convenzioni e collaborazioni a tutti i livelli istituzionali e, citandone solo alcuni: con il MIUR, la Regione Toscana, la Provincia e il Comune di Firenze, con lUniversit degli Studi di Firenze e di Pisa, con lAccademia di Belle Arti e ISIA di Firenze, con il Maggio Musicale Fiorentino, Galleria dellAccademia e Villa I Tatti-Harvard University, oltre ai 18 accordi bilaterali Erasmus con prestigiosi conservatori europei. Con ISIA e Accademia di Belle Arti, il Conservatorio ha stipulato una convenzione per La Citt delle Arti, primo passo verso il Politecnico delle Arti, contemplato dalle leggi di riforma, inoltre socio fondatore dellOrchestra Nazionale dei Conservatori, di cui diversi studenti del Conservatorio fanno parte. Il 2010, per il Conservatorio L.Cherubini, un anno particolare: ricorre infatti il 250 dalla nascita del grande compositore a cui intitolato, e per loccasione il Consiglio Accademico ha approvato una serie di concerti, con esecuzione di musiche inedite del Maestro conservate presso la Biblioteca e un importante convegno internazionale (ottobre 2010) con il patrocinio dellUniversit di Firenze. Il Conservatorio di Firenze, oltre ad essere accreditato presso la Regione Toscana, unico in Italia ad essere certificato ISO 9001 2008.
223
Leconomia dei beni culturali e ambientali.
Una visione sistemica e integrata
DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELLA TOSCANA
www.toscana.beniculturali.it
CENNI STORICI
Il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali fu istituito da Giovanni Spadolini (con D.L. 14 dicembre 1974, n. 657, convertito nella Legge 29 gennaio 1975, n. 5), con il compito di affidare alla specifica competenza di un Ministero appositamente costituito sia la gestione del patrimonio culturale che quella dellambiente, al fine di assicurare una tutela coordinata sul piano interno e nazionale. Raccolse le competenze e le funzioni in materia che prima spettavano al Ministero della Pubblica Istruzione (Antichit e Belle Arti, Accademie e Biblioteche), al Ministero degli Interni (Archivi di Stato) e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Discoteca di Stato, editoria libraria e diffusione della cultura). Nel 1998 con Decreto Legislativo n. 368 del 20 ottobre, venne istituito il nuovo Ministero per i Beni e le Attivit Culturali (MiBAC), alle cui attribuzioni si aggiunsero la promozione dello sport (rassegnate nel 2006 al nuovo Ministero per le Politiche Giovanili e Attivit sportive) e di impiantistica sportiva e la promozione delle attivit dello spettacolo in tutte le sue espressioni: dal cinema al teatro, alla danza, alla musica, agli spettacoli viaggianti. La struttura organizzativa del Ministero, regolata con Decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 26 novembre 2007 - modificato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 91 del 2 luglio 2009 - suddivisa in quattro ripartizioni tra: - Amministrazione Centrale (Segretariato Generale; 8 Direzioni Generali, ciascuna competente su specifiche materie di settore); - Organi consultivi centrali (Consiglio Superiore per i Beni Culturali e Paesaggistici; Comitati tecnico-scientifici); - Istituti Centrali (Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione; Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle Biblioteche Italiane e per le Informazioni Bibliografiche; Opificio delle Pietre Dure; Istituto Centrale per la Demoetnoantropologia; Istituto Centrale per il Restauro e la Conservazione del Patrimonio Archivistico e Librario; Istituto Centrale per gli Archivi; Istituto Centrale per i Beni Sonori ed Audiovisivi); - Istituti dotati di autonomia speciale (la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei; le Soprintendenze speciali per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale delle citt di Venezia, Napoli, Roma, Firenze; lIstituto superiore per la conservazione ed il restauro; le Biblioteche Nazionali Centrali di Firenze e Roma; il Centro per il libro e la lettura; lArchivio Centrale dello Stato). LAmministrazione Periferica si articola in Direzioni Regionali per i Beni Culturali e Paesaggistici, Soprintendenze (per i beni archeologici; per i beni architettonici e paesaggistici; per i beni storici, artistici ed etnoantropologici), Soprintendenze archivistiche, Archivi di Stato, Biblioteche statali, Musei. La riorganizzazione del MiBAC attuata nel 2009 improntata a misure di maggiore razionalizzazione, efficienza ed economicit della Pubblica Amministrazione, e introduce significative innovazioni mirate a esaltare lazione di tutela, valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale pubblico e al contempo restituisce centralit alla salvaguardia del paesaggio nel contesto pi generale delle belle arti. Tra le principali novit, infatti, vi listituzione della Direzione Generale per la valorizzazione del Patrimonio Culturale, per consentire maggiore incisivit nella promozione e nello sviluppo di questo settore, diffondere la conoscenza della cultura in campo nazionale ed internazionale, assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio da parte di tutti i cittadini. Il Segretario Generale del Ministero esercita il coordinamento delle Direzioni Regionali per i Beni Culturali e Paesaggistici, uffici di livello dirigenziale generale presenti nel territorio regionale, istituite in tutte le Regioni a statuto ordinario, in Friuli-Venezia Giulia e in Sardegna, con Decreto Legislativo n. 3 dell8 gennaio 2004, e che hanno sede nel capoluogo della rispettiva regione.
PRINCIPALI ATTIVIT ED ECCELLENZE DELLENTE
Le Direzioni Regionali esercitano poteri di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo sullattivit delle strutture periferiche del Ministero presenti nel territorio regionale (soprintendenze, archivi, biblioteche, musei) e costituiscono un punto di riferimento istituzionale per i rapporti fra il Ministero, le strutture periferiche, le regioni, gli enti locali e le altre istituzioni operanti nel territorio. Il Direttore Regionale si occupa di tre ambiti fondamentali: la tutela e la promozione del patrimonio culturale, la gestione economicofinanziaria, il coordinamento organizzativo. In particolare, tra le competenze del Direttore Regionale, si segnalano: - la promozione e lorganizzazione - anche in collaborazione con le regioni, le universit e le istituzioni culturali - di attivit di studio, di ricerca, di iniziative culturali e per la formazione in materia di tutela del paesaggio, della cultura e della qualit architettonica e urbanistica; - il coordinamento dellattivit di catalogazione dei beni culturali; - la promozione presso le scuole, in accordo con il Ministero dellIstruzione, dellUniversit e della Ricerca (MIUR), della conoscenza del patrimonio culturale; - la vigilanza sulla realizzazione delle opere darte negli edifici pubblici; - laffidamento diretto o in concessione delle attivit e dei servizi pubblici di valorizzazione dei beni culturali; - lo svolgimento della funzione di stazione appaltante per interventi conservativi con fondi statali su beni culturali esistenti nel territorio regionale; - lemanazione di provvedimenti di verifica e di dichiarazione dellinteresse volti a individuare i beni, di propriet sia pubblica che privata, che, presentando interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico, costituiscono il patrimonio culturale che, se di propriet pubblica, destinato alla fruizione della collettivit; - lautorizzazione degli interventi di rimozione, demolizione, spostamento, smembramento di beni culturali; - limposizione di misure a salvaguardia dellintegrit dei beni culturali immobili; - lautorizzazione al trasferimento a titolo oneroso di beni culturali; - la dichiarazione di notevole interesse pubblico relativamente ai beni paesaggistici e, in accordo con la regione, la definizione delle modalit di elaborazione congiunta dei piani paesaggistici; - la proposta degli interventi da inserire nella programmazione Lavori Pubblici e nei piani di spesa; - lespressione del parere di competenza del Ministero nelle conferenze di servizi per gli interventi in ambito regionale e intersettoriale; - la gestione delle risorse umane e strumentali degli uffici del Ministero nellambito della regione; - la cura delle relazioni sindacali e della contrattazione collettiva a livello regionale. Lo sviluppo della cultura, la ricerca scientifica, la tutela del paesaggio e del patrimonio storico ed artistico della nazione costituiscono principi fondamentali della Costituzione italiana.
224
Allegato - Alcuni esempi di eccellenze del sistema culturale e creativo fiorentino
FONDAZIONE CIRCOLO ROSSELLI E CIRCOLO DI CULTURA POLITICA FRATELLI ROSSELLI
www.rosselli.org
CENNI STORICI
La Fondazione Circolo Rosselli e il Circolo di Cultura Politica Fratelli Rosselli sono fra le istituzioni culturali pi antiche e insieme pi vitali dItalia. Il loro nome inestricabilmente legato alla citt di Firenze. Le loro origini risalgono al 1920, quando alcuni giovani, tra cui i fratelli Carlo e Nello Rosselli, Piero Calamandrei, Ernesto Rossi e i fratelli Alfredo e Nello Niccoli, sotto il magistero di Gaetano Salvemini, fondarono a Firenze il Circolo di Cultura (1920-1924). Nella fase di violenza fascista che segu il delitto Matteotti, anche il Circolo di Cultura, il 31 dicembre del 1924 fu oggetto di devastazione ed il materiale distrutto. Pochi giorni dopo, con decreto prefettizio del 5 gennaio 1925, il Circolo di Cultura fu chiuso. Cominci la lunga lotta antifascista che vide in prima fila i giovani del Circolo di Cultura, dalla pubblicazione del primo giornale clandestino antifascista Non Mollare alla fondazione del movimento di Giustizia e Libert, per opera di Carlo Rosselli, teorico del Socialismo Liberale, alluccisione dei due fratelli Carlo e Nello il 9 giugno 1937, alla costituzione del Partito dAzione. Fu proprio il Partito dAzione fiorentino, guidato da Tristano Codignola, a rifondare nellottobre del 1944, subito dopo la liberazione della citt, il Circolo di Cultura come Circolo di Cultura Politica Fratelli Rosselli (CFR). II Circolo Rosselli fu tenuto a battesimo da Piero Calamandrei, che ne era stato uno dei fondatori del Circolo di Cultura. Da allora stato ininterrottamente attivo con coerenza e continuit, e si pi volte rinnovato con lafflusso di qualificate energie giovanili. Le sue iniziative hanno vasto respiro ed interesse a livello non solo cittadino e regionale, ma anche nazionale e internazionale. Nel 1989 il Circolo Rosselli ha organizzato una conferenza di Giovanni Falcone sulla lotta alla criminalit organizzata. Oggi il Circolo presieduto dal prof. Riccardo Pratesi e conta alcune centinaia di soci.
PRINCIPALI ATTIVIT ED ECCELLENZE DELLENTE
Nel 1990 stata costituita la Fondazione Circolo Rosselli (eretta in Ente Morale con D.P.R.), oggi presieduta da Valdo Spini, che ha affiancato, irrobustito ed ampliato la tradizionale attivit convegnistica e culturale del Circolo con numerose iniziative e con la rivista Quaderni del Circolo Rosselli: una collana di fascicoli con cadenza trimestrale, a carattere monotematico e molto qualificati, iniziata nel 1981, strumento prezioso di diffusione dei temi di dibattito propri della Fondazione e del Circolo. I Quaderni hanno compiuto trentanni e sono arrivati a pubblicare 107 fascicoli e 3 supplementi. I fini sociali della Fondazione sono quelli di promuovere riunioni, conferenze, letture, conversazioni e discussioni sui problemi fondamentali che si presentano oggi al nostro interesse. A tale scopo la Fondazione collabora con altri circoli e fondazioni in tutta Italia e allestero. La Fondazione organizza anche mostre darte e ha effettuato sondaggi sociologici. Recentemente il direttore dei Quaderni del Circolo Rosselli, Valdo Spini, stato eletto presidente de Coordinamento Riviste Italiane di Cultura (CRIC). Ogni due anni il Circolo e la Fondazione organizzano un colloquio sulla Ricerca Scientifica intitolato a Luigi Amaducci, un grande scienziato, scomparso alcuni anni fa, che era stato tra i dirigenti del Circolo. La Fondazione Circolo Rosselli ha avuto tra i suoi conferenzieri importanti rappresentanti della politica, delleconomia e della cultura, oltre a numerosi docenti e studiosi italiani e stranieri. Il Presidente Emerito della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi ha concesso che fossero presentati in anteprima alla Fondazione Rosselli, accompagnandoli con un suo messaggio televisivo registrato, i Dialoghi con il Presidente, il volume dedicatogli da allievi ed ex allievi delle scuole universitarie di eccellenza di Pisa. Solo fra il 2008 e il 2009 la Fondazione ha svolto oltre 40 tra conferenze e convegni.
225
Leconomia dei beni culturali e ambientali.
Una visione sistemica e integrata
FONDAZIONE PALAZZO STROZZI
www.palazzostrozzi.org
CENNI STORICI
La Fondazione Palazzo Strozzi, istituita nel luglio 2006, nata per trasformare il quattrocentesco palazzo, situato nel cuore di Firenze, in una moderna piattaforma culturale di sperimentazione: lo scopo quello di creare un luogo di dibattito e discussione, avere un approccio internazionale nella produzione culturale e aprire il palazzo alla citt, ai residenti e a tutti coloro che amano Firenze. La Fondazione Palazzo Strozzi rappresenta uninnovazione nella governance delle istituzioni culturali italiane. Guidata da un autorevole Consiglio di Amministrazione, nata dalla collaborazione tra pubblico e privato: tre enti pubblici e unAssociazione di partner privati nella quale figurano alcune delle pi importanti realt imprenditoriali italiane.
PRINCIPALI ATTIVIT ED ECCELLENZE DELLENTE
Oggi Palazzo Strozzi, diretto da James Bradburne, un luogo di ritrovo attraente e frequentato, nonch un attivo centro culturale, aperto tutto lanno. Palazzo Strozzi non ospita solo due grandi mostre annuali, ma anche il dinamico Centro di Cultura Contemporanea Strozzina (CCCS) e unesposizione permanente sulla storia del Palazzo. Il Palazzo sempre aperto con un bar/caff gestito da Caff Giacosa e con Agora|z Mandragora design e bookshop e il magnifico cortile accoglie regolarmente concerti, sfilate e installazioni dei maggiori artisti contemporanei. Le mostre organizzate a Palazzo Strozzi intendono offrire unampia gamma di attivit, con didascalie speciali per famiglie e bambini, esperienze interattive, laboratori e pubblicazioni dedicate (in italiano e in inglese). Grande attenzione data all ascolto visibile, cio al riconoscimento che la cultura fatta di molte voci e limportanza di renderle visibili: questapproccio riconoscibile ovunque, dalla segnaletica alle informazioni video nel cortile, fino alle didascalie allinterno della mostra. Sin dallinizio, la Fondazione ha deciso che le cantine del palazzo, recentemente restaurate e note storicamente come la Strozzina, divenissero la principale piattaforma di Palazzo Strozzi per la cultura contemporanea, con lobiettivo di attirare pubblico pi giovane e ospitare tutta una serie di eventi, attivit e mostre in rappresentanza dellintero spettro dellattivit creativa contemporanea. I progetti relativi alla Strozzina hanno posto laccento su quattro strategie: favorire luso ripetuto anzich la concentrazione su singole visite, sviluppare un mix di attivit che riflettano la realt contemporanea, puntare a un pubblico pi giovane e definire una piattaforma di collaborazione. A partire dal novembre 2007, il Centro di Cultura Contemporanea Strozzina (CCCS), sotto la direzione generale di Franziska Nori, ha formulato un programma pluriennale, basato su network locali e internazionali, che sviluppa mostre tematiche ed eventi interdisciplinari su aspetti diversi della cultura contemporanea. Curatori indipendenti e istituzioni internazionali sono invitati a proporre mostre, cicli di video e film, workshop, performance e conferenze con lobiettivo di approfondire i temi prescelti. Il CCCS realizza progetti culturali relativi a questioni socialmente rilevanti che stanno alla base della nostra realt contemporanea. Il pubblico diviene protagonista attraverso un rapporto diretto e continuo con il Centro. Il biglietto multiplo da 5 Euro, valido un mese, incoraggia a ripetere la visita alle mostre e a partecipare alle conferenze settimanali, alle performance e ai workshop offerti nellarco di tutto lanno. Collocare larte contemporanea in una cornice architettonica rinascimentale come quella di Palazzo Strozzi pone una sfida che la Fondazione interpreta come stimolo ad allestire ogni nuovo evento o progetto alla costante ricerca di nuove possibilit di comunicazione e presentazione artistica: lesigenza di identificare Palazzo Strozzi come meta culturale autonoma pu essere dunque sintetizzata dalla formula non solo mostre.
226
Allegato - Alcuni esempi di eccellenze del sistema culturale e creativo fiorentino
GABINETTO SCIENTIFICO LETTERARIO G.P. VIEUSSEUX
www.vieusseux.fi.it
CENNI STORICI
Fondato a Firenze nel 1819 da Giovan Pietro Vieusseux, mercante di origine ginevrina, il Gabinetto Scientifico Letterario G.P. Vieusseux stato nellOttocento uno dei principali tramiti tra la cultura italiana e quella europea, centro fra i pi attivi per il Risorgimento dItalia. Nasce come gabinetto di lettura, dove vengono messe a disposizione del pubblico cittadino e straniero le pi importanti riviste dEuropa, in sale aperte alla conversazione e allo scambio di idee. A fianco del Gabinetto viene allestita una biblioteca circolante, presso la quale possibile prendere in prestito le novit librarie in italiano, in francese, in inglese. Giacomo Leopardi e Alessandro Manzoni furono frequentatori del Gabinetto Vieusseux durante i loro soggiorni fiorentini; tra i soci stranieri che vi si abbonarono, figurano Stendhal, Arthur Schopenhauer, James F. Cooper, William M. Thackeray, Fdor Dostoevskij, Mark Twain, Emile Zola, Andr Gide, Rudyard Kipling, Aldous Huxley e David H. Lawrence. Retto fino al 1919 dagli eredi di Vieusseux come esercizio privato, il Gabinetto diventa nel 1925 Ente Morale, con un Consiglio dAmministrazione presieduto, tramite un suo delegato, dal Sindaco di Firenze.
PRINCIPALI ATTIVIT ED ECCELLENZE DELLENTE
LIstituto con sede legale a Palazzo Strozzi promuove, nel corso dellanno, convegni, conferenze, mostre, ricerche, pubblicazioni (dal 1995 ripresa la pubblicazione della rivista quadrimestrale Antologia Vieusseux, fondata da Bonsanti nel 1966). Lattivit del Gabinetto Vieusseux si esplica attraverso il lavoro dei sei settori (oltre il settore amministrativo), costituiti nel corso del tempo per venire incontro alle esigenze di gestione e di sviluppo del patrimonio materiale e ideale dellIstituto. In particolare: - la Biblioteca, che costituisce il pi antico tra i sei settori, ha il compito di salvaguardare e rendere accessibile a un pubblico eterogeneo per interessi e grado di specializzazione, un patrimonio di 460.000 libri e periodici in pi lingue che per la sua costituzione ha pochi equivalenti in Europa, svolgendo anche un lavoro di indagine sulle caratteristiche della raccolta e sul suo utilizzo da parte dei frequentatori nel corso dellOttocento e del Novecento. Lattivit della biblioteca, per esperienza e per competenza scientifica e tecnica, costituisce inoltre un riferimento prezioso in ambito biblioteconomico e bibliografico; - il Centro Romantico promuove, a partire dalla documentazione conservata presso lIstituto, ricerche e iniziative (convegni, seminari, mostre, pubblicazioni) sulla civilt europea dellOttocento, soprattutto per quanto riguarda lacquisizione e la diffusione di conoscenze e il confronto tra le diverse esperienze che caratterizzarono il Gabinetto di Vieusseux. Lattivit di ricerca e di divulgazione si estende per molteplici aspetti alle problematiche della civilt odierna relative allincontro tra differenti culture; in tale ambito fa capo al Centro Romantico il Programma Vieusseux-Asia, nato dopo lacquisizione della Biblioteca Orientale (8.000 volumi) e dellArchivio Fotografico (100.000 immagini) di Fosco Maraini. Sono parte dei compiti del Centro la consulenza e il sostegno alla ricerca; - lArchivio Contemporaneo Alessandro Bonsanti, accoglie e preserva documenti rilevanti del Novecento, costituiti soprattutto da archivi e biblioteche di autori e personalit tra le pi rappresentative della cultura italiana. Con gli oltre 150 fondi che attualmente conserva costituisce al riguardo il maggior centro italiano di conservazione e consultazione. Vista la mole dei documenti (oltre 5.000.000 di carte e 90.000 volumi), allArchivio Contemporaneo dedicata una sede specifica in Palazzo Corsini Suarez; - lArchivio Storico raccoglie le carte istituzionali dellIstituto dalla nascita, nel 1819, ai nostri giorni: dai primi Copialettere e Libri dei Soci alle documentazioni delle direzioni di Eugenio Montale ed Alessandro Bonsanti; conserva inoltre alcuni nuclei ottocenteschi aggregati; - il settore delle Manifestazioni Culturali valorizza le tradizioni e le potenzialit del Gabinetto Vieusseux come luogo di incontro e di discussione, sia promuovendo convegni, tavole rotonde, mostre, spesso in collaborazione con altri soggetti, sia favorendo la comunicazione dei risultati dei lavori degli altri settori del Gabinetto e curando la rivista dellIstituto. Particolare attenzione attualmente dedicata alladozione dei nuovi sistemi e delle nuove tecniche di comunicazione e divulgazione; - il Servizio di Conservazione e Restauro, nato in seguito allalluvione del 1966 che danneggi grande parte, e in particolare la pi antica, del patrimonio librario e archivistico del Gabinetto Vieusseux, opera per il recupero e il ripristino dei volumi, secondo priorit di intervento determinate dal loro valore intrinseco, dalle strategie di intervento della Biblioteca e dai programmi di studio e ricerca dell Istituto. suo compito predisporre gli atti necessari alla tutela fisica del patrimonio del Gabinetto Vieusseux. Lesperienza acquisita lo ha reso negli anni uno dei pi accreditati laboratori in ambito internazionale. Limpegno di questi settori, nelle loro diverse specializzazioni di lavoro, si articola intorno al comune scopo di garantire la fruizione da parte del pubblico dei libri, dei documenti e della tradizione che rendono il Gabinetto Vieusseux uno dei luoghi pi significativi, per le sue caratteristiche di interdisciplinarit e di apertura internazionale, della cultura italiana ed europea.
227
Leconomia dei beni culturali e ambientali.
Una visione sistemica e integrata
GALLERIA DARTE MODERNA DI PALAZZO PITTI
www.polomuseale.firenze.it/gam/
CENNI STORICI
La Galleria dArte Moderna (GAM) fa parte del complesso museale di Palazzo Pitti dal 1924, quando trov posto al secondo piano, dove tuttora collocata, negli ambienti lasciati liberi dalla famiglia reale che li aveva abitati fino al 1922. Si concretizzava cos un progetto accarezzato gi agli albori dell unit dItalia: quello di dotare la citt, solitamente proiettata verso la tradizione artistica del suo passato glorioso, di un museo che raccogliesse la produzione artistica pi recente e al contempo fosse di stimolo per mantenere viva la creativit in ambito fiorentino e toscano. Dieci anni prima che la Galleria potesse trovare il luogo adatto alla sua esistenza, lo Stato e il Comune firmarono una convenzione, tuttora valida, per far confluire in un unico organismo museale le collezioni di rispettiva propriet, affidate alla gestione di un direttore di appartenenza statale, affiancato da una commissione paritetica Stato-Comune per quanto riguarda la politica dei nuovi acquisti ed acquisizioni.
PRINCIPALI ATTIVIT ED ECCELLENZE DELLENTE
Il nuovo museo, forte di questa ben strutturata e lungimirante identit, pot trovare sistemazione e crescere nelle 30 sale che ne costituiscono lattuale itinerario espositivo, che si sviluppa negli ambienti ristrutturati dai Granduchi lorenesi, secondo la misurata eleganza del Neoclassicismo e il decoro appena pi eloquente del primo Romanticismo. Il visitatore che, approdato in quelli che furono gli appartamenti privati dei Lorena, percorre le sale visitando il museo e godendo dei duplici affacci sul giardino di Boboli e su Firenze, si sente introdotto a corte, nelleleganza di una reggia che fa Settecento e Ottocento fu appartata ma mai provinciale. Contribuiscono a questo effetto gli arredi, tutti di provenienza granducale, ben ambientati nelle diverse sale, che rispondono alla funzione primaria di esporre le raccolte di pittura e scultura, formatesi dalla fine del Settecento in poi. Il percorso si sviluppa secondo una sequenza cronologica e tematica, che illumina suggestivamente gli aspetti del Neoclassicismo in Toscana, specialmente internazionale al tempo dei Napoleonidi; la pittura romantica di genere storico, con temi dedicati alla storia patria, spesso visti in funzione di exempla per il riscatto del Risorgimento; i soggetti risorgimentali in senso stretto, cui aderirono pittori di diverso credo stilistico, concordi nel cogliere limportanza e novit di quel momento storico; la ritrattistica celebrativa della societ borghese, in ascesa nel corso dell Ottocento; la pittura di paesaggio, declinata su diversi registri dalla sensibilit alla Natura comune al Romanticismo; la pittura di genere, di grande successo verso il declinare di un Ottocento che aveva esaurito la sua fase eroica. In qualche modo trasversale ai diversi generi, ma segnata da una propria, inconfondibile sigla innovativa, la pittura dei Macchiaioli il nucleo pi cospicuo, per numero e qualit, della Galleria, che ad esso lega in particolare la propria notoriet e storia. Ma le raccolte della Galleria si spingono ben oltre, fino a dopo la met del XX secolo, quando la politica del museo e la mutata situazione artistica in sede locale hanno concluso la fase promotrice del museo di Pitti, storicizzandone le raccolte e la fisionomia. La carenza attuale di spazi fa s che solo nelle ultime sale si esponga una selezione antologica, ma comunque rappresentativa, dellambito artistico toscano nei primi due decenni del Novecento. Lauspicato recupero, si spera a breve termine, di 15 sale al piano superiore, consentir di ampliare e rendere pi esaustivo litinerario novecentesco. Ma gi oggi la Galleria dArte Moderna, con i suoi capolavori inseriti nel tessuto di una storia figurativa sfaccettata, complessa eppure di seducente eloquenza, invita il visitatore, fiorentino e non, a passare un podi tempo in un luogo dove pu trovare luxe, calme, volupt.
228
Allegato - Alcuni esempi di eccellenze del sistema culturale e creativo fiorentino
GALLERIA DEGLI UFFIZI
www.polomuseale.firenze.it/musei/uffizi/
CENNI STORICI
uno dei musei pi famosi al mondo per le sue straordinarie collezioni di dipinti e di statue antiche; le sue raccolte di dipinti del Trecento e del Rinascimento, infatti, contengono alcuni capolavori assoluti dellarte di tutti i tempi. La Galleria degli Uffizi nasce allinterno di un edificio voluto da Cosimo I de Medici e posto accanto alla sua residenza di Palazzo Vecchio per ospitare le Magistrature delle Arti fiorentine. Qui allultimo piano, a partire dagli anni Ottanta del Cinquecento, il suo erede, Francesco I, colloc una serie di ritratti di uomini illustri antichi e contemporanei e cre il primo nucleo dellattuale museo, situato nella Tribuna ottagonale cui si accede dal primo corridoio. In Tribuna, Francesco conservava le opere darte e le rarit naturali pi preziose e stupefacenti. Accanto ad essa sorsero, pi tardi, ambienti destinati alla raccolta di strumenti scientifici e allarmeria medicea.
PRINCIPALI ATTIVIT ED ECCELLENZE DELLENTE
Nei secoli successivi i Medici e, in seguito, i Lorena incrementarono le raccolte darte che vi si conservavano fino a farne uno dei pi importanti musei del mondo per le sue collezioni di statue antiche, disegni e di dipinti, tra i quali si annoverano opere di Giotto, Simone Martini, Piero della Francesca, Beato Angelico, Filippo Lippi, Sandro Botticelli, Mantegna, Correggio, Leonardo da Vinci, Raffaello, Michelangelo, Caravaggio. Significative anche le raccolte di pittori tedeschi, olandesi e fiamminghi, tra i quali: Drer, Rembrandt e Rubens. La Sala del Botticelli una delle pi famose della Galleria degli Uffizi perch ospita alcuni tra i capolavori del Rinascimento eseguiti negli ultimi decenni del Quattrocento: tra le 15 opere di Sandro Botticelli le pi famose sono La Primavera e La Nascita di Venere, i primi dipinti di soggetto profano di grandi dimensioni del Rinascimento italiano, che testimoniano il clima culturale di Firenze al tempo di Lorenzo il Magnifico. Pur nella consapevolezza della ricchezza di numerosi altri capolavori appartenenti alle collezioni degli Uffizi, si possono ricordare anche le sale del Duecento e di Giotto, dei Lippi (dove si pu ammirare il famoso Doppio ritratto dei duchi di Urbino di Piero della Francesca), di Leonardo da Vinci (Il battesimo di Cristo, LAnnunciazione, Ladorazione dei Magi), di Michelangelo e dei fiorentini (dove collocato il Tondo Doni, uno dei dipinti pi famosi della Galleria, opera giovanile di Michelangelo). Nel complesso vasariano sono ospitate anche la Collezione Contini Bonacossi e il celebre Gabinetto Disegni e Stampe degli Uffizi. Il Corridoio Vasariano (1565) collega ledificio degli Uffizi con Palazzo Vecchio e con Palazzo Pitti. Vi sono esposte importanti raccolte di dipinti del Seicento e la famosa collezione degli Autoritratti di pittori.
229
Leconomia dei beni culturali e ambientali.
Una visione sistemica e integrata
GALLERIA DELLACCADEMIA
www.uffizi.firenze.it/musei/accademia/
CENNI STORICI
Nel 1784 il Granduca di Toscana Pietro Leopoldo fond lAccademia di Belle Arti, una scuola destinata allinsegnamento dellarte che, riunendo prestigiose istituzioni quale lAccademia delle Arti del Disegno, trov sede negli antichi edifici dellOspedale di San Matteo e del Convento di San Niccol di Cafaggio. Con lAccademia di Belle Arti fu fondata anche la Galleria dellAccademia, un museo destinato ad accogliere le opere darte di propriet della scuola darte che servisse al contempo da esempio per la formazione degli artisti. La Galleria and progressivamente ad arricchirsi di numerosi antichi dipinti provenienti dalle chiese e dai conventi soppressi dal granduca Pietro Leopoldo alla fine del Settecento e poi da Napoleone nel 1810, oltre che di una sezione di arte moderna. Nel 1873 fu trasferito nella Galleria, dalla Piazza della Signoria, la statua del David di Michelangelo Buonarroti, per la quale fu realizzato un apposito ambiente espositivo progettato da Emilio De Fabris, detto la Tribuna. Fra la fine del XIX secolo e i primi anni del Novecento la Galleria, ormai separata nellamministrazione dallAccademia di Belle Arti, fu soggetta a un riordinamento che vide il trasferimento in altri musei cittadini di una parte dei dipinti antichi, mentre la sezione di arte moderna trov una nuova sede a Palazzo Pitti.
PRINCIPALI ATTIVIT ED ECCELLENZE DELLENTE
Oltre alla famosissima statua del David, nel corso degli anni la Galleria dellAccademia si arricchita di altri capolavori di Michelangelo, come la statua del San Matteo (acquisito dal museo nel 1906), e, dal 1909, le quattro grandi sculture dei Prigioni, provenienti dalla grotta del Buontalenti nel Giardino di Boboli. Fra le opere presenti nella Galleria fin dalla fondazione si ricorda il gesso del gruppo scultoreo del Ratto delle Sabine del Giambologna, oggi esposto nella Sala del Colosso. In anni pi recenti si cercato di ricostituire loriginario legame con lAccademia di Belle Arti esponendo una cospicua raccolta di gessi di Lorenzo Bartolini e di altri artisti del XIX secolo legati alla scuola darte, ed stato allestito allinterno della Galleria il Museo degli strumenti musicali, una raccolta dei pi importanti strumenti musicali appartenenti al Conservatorio Luigi Cherubini di Firenze, inizialmente nato anchesso come una sezione dellantica Accademia di Belle Arti. stata, inoltre, ampliata la raccolta dei fondi oro, dipinti su tavola risalenti al XIII, XIV e XV secolo, che hanno trovato spazio in nuove sale espositive dove stato possibile esibire polittici e tavole daltare di grandi dimensioni.
230
Allegato - Alcuni esempi di eccellenze del sistema culturale e creativo fiorentino
ISTITUTO ITALIANO DI SCIENZE UMANE (SUM)
www.sumitalia.it
CENNI STORICI
LIstituto Italiano di Scienze Umane (SUM) una Universit pubblica dedicata allalta formazione e alla ricerca nelle scienze umane e sociali. Ha sede a Firenze (Palazzo Strozzi) e a Napoli (Palazzo Cavalcanti). costituito con una struttura a rete cui partecipano le Scuole di alta formazione delle Universit di Bologna, Firenze, Roma La Sapienza, Milano-Bicocca, Napoli Federico II, Napoli LOrientale, Napoli Suor Orsola Benincasa, Siena. Listituto sede di corsi di dottorato di ricerca con caratteristiche di qualit avanzate, e di programmi di formazione di post-dottorato. I corsi di dottorato sono gestiti in collaborazione con le universit della rete. Oltre ai Professori Ordinari del SUM, collaborano con lIstituto numerosi docenti di universit italiane, europee e americane impegnati a contratto nelle diverse attivit didattiche. LIstituto retto dal Direttore (Aldo Schiavone), dal Consiglio Direttivo, dal Consiglio dei Docenti e dal Consiglio di Garanzia composto dai Rettori delle otto Universit della Rete, presieduto da Umberto Eco. Il SUM opera con finanziamenti del Ministero, e con il supporto di enti pubblici e privati. Per il sostegno delle sue attivit, il SUM affiancato da una fondazione privata (con sede a Milano) che ha lo scopo di raccogliere fondi e di promuovere il dibattito culturale nel campo delle scienze umane e sociali e di definire un innovativo sistema di relazioni tra pubblico e privato, tra ricerca e impresa.
PRINCIPALI ATTIVIT ED ECCELLENZE DELLENTE
Il SUM gestisce attualmente 22 corsi triennali di dottorato, attivati presso le diverse Scuole delle Universit della rete. La formazione improntata alla pi ampia apertura interdisciplinare e alla cooperazione tra diversi ambiti di studio e diverse metodologie di ricerca. LIstituto ha, dunque, oggi in totale circa 200 allievi, di cui 134 con borsa. Il dimensionamento a regime di oltre 300 allievi, di cui oltre 200 con borsa. Dei 16 dottorati banditi nel 2008, 3 sono a Firenze, 7 a Napoli, 2 a Bologna, 1 a Roma, 1 a Milano e 2 a Siena. Le attivit formative, particolarmente intense nei primi due anni, sono distribuite su due semestri. I seminari vengono affidati agli specialisti ritenuti i pi idonei nel panorama internazionale: i docenti sono tenuti a svolgere ampie discussioni con gli allievi sui contenuti delle loro lezioni. I seminari si svolgono in italiano, in inglese, in francese, e sono ammessi anche allievi di altri dottorati italiani o stranieri. Agli allievi, sia che fruiscano sia che non fruiscano di borsa di studio, viene offerta la residenzialit nella sede del corso per tutta la durata delle attivit formative, cos da consentire una frequenza piena e in modo da creare un ambiente di studio e di lavoro nel quale le diverse esperienze culturali e di ricerca degli allievi possano positivamente interagire. Vengono inoltre ampiamente finanziate le spese di ricerca degli allievi, e periodi di studio allestero (in tempi in cui non si svolgono le attivit formative ordinarie in sede). Lanno accademico si apre con una settimana di attivit comune a tutti i dottorati, che rappresenta una riflessione sulla nozione e sul significato di scienze umane e sociali - epistemologia, percorsi, metodi - e specificit: unoccasione pensata anche come unopportunit per i nuovi allievi di conoscere i professori e i coordinatori del SUM, insieme con i propri compagni. Ogni allievo viene affidato a un tutore, scelto tra specialisti di riconosciuta competenza in campo internazionale. Gli allievi presentano periodicamente relazioni sullo stato di avanzamento delle loro ricerche e relazioni scritte sulle attivit didattiche frequentate. Il SUM bandisce borse di studio biennali destinate a giovani studiosi gi in possesso del dottorato, per consentire loro di portare a termine un programma di ricerca. Gli allievi lavorano a tempo pieno sul proprio programma di ricerca, che si prevede debba concludersi con la pubblicazione di una monografia originale. La loro attivit, guidata da tutori di alta qualificazione internazionale, seguita da una commissione dellIstituto, con relazioni e incontri periodici. LIstituto, in collaborazione con lUniversit di Firenze, con la Regione Toscana, e con il contributo dellEnte Cassa di Risparmio di Firenze e della Confindustria, gestisce un Master dedicato alla gestione dei processi partecipativi nellambito delle politiche territoriali locali. Il corso rivolto principalmente a dirigenti e funzionari delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali e ad esponenti delle realt associative locali. Liniziativa nasce dalla consapevolezza che intorno alle politiche di governo del territorio si esprime una crescente attenzione dellopinione pubblica e una domanda di partecipazione delle comunit locali e che pertanto occorre costruire le condizioni che permettano forme innovative di coinvolgimento dei cittadini. Inoltre, lIstituto sviluppa con i suoi docenti, e con il coinvolgimento di quipe internazionali, alcuni programmi di ricerca di particolare impegno. Tra i pi significativi ricordiamo: il progetto sulla Qualit della democrazia, diretto da Leonardo Morlino, che sviluppa un quadro teorico e metodologico per la rilevazione della qualit democratica nei suoi aspetti generali e nelle sue dimensioni specifiche, con lobiettivo di creare un Osservatorio permanente sulla qualit delle democrazie europee, e il progetto Corpus Scriptorum Iuris Romani, diretto da Aldo Schiavone, cui cooperano storici del diritto e filologi, con lobiettivo di pubblicare i testi dei giuristi romani, cos da ricomporre, per quanto possibile, il profilo originario di ciascuna opera e la personalit di ciascun autore. LIstituto si dotato di una collana presso Il Mulino come sede privilegiata, ma non unica, per pubblicare i risultati delle ricerche di allievi e docenti; volumi derivati da convegni e iniziative culturali. La collana si articola per ora in tre diverse sezioni: Studi, Dialoghi, Lezioni di Palazzo Strozzi. Altre sezioni sono in programma. Sono stati finora pubblicati 10 volumi ed altri 7 sono attualmente in preparazione. Infine, lIstituto svolge numerose attivit in cooperazione con Universit e istituzioni europee e americane, tra cui la New York University e la Georgetown University. Partecipa a un programma di mobilit comunitario (Marie Curie) in Storia giuridica insieme allcole des Hautes tudes en Sciences Sociales, la London School of Economics e il Max Planck Institut. LIstituto ha promosso la costituzione di una Programma Dottorale Europeo in Scienze Umane e Sociali, cui partecipano la Central European University di Budapest, lcole des Hautes tudes en Sciences Sociales e lcole Pratique des Hautes tudes di Parigi e la Humboldt Universitt di Berlino. La nomina a Direttore del programma dottorale europeo, che viene fatta a rotazione fra i presidenti delle istituzioni aderenti, stata assegnata al Direttore dellIstituto Italiano di Scienze Umane, per gli anni 2009-2011. In collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri ha realizzato un corso di formazione in cultura italiana per studenti e docenti dellUniversit di Baghdad e sostiene iniziative di formazione in Iraq.
231
Leconomia dei beni culturali e ambientali.
Una visione sistemica e integrata
ISTITUTO PER LA CONSERVAZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI (ICVBC)
www.icvbc.cnr.it
CENNI STORICI
Sorto nel Luglio del 2001, lIstituto per la Conservazione e la Valorizzazione dei Beni Culturali (ICVBC) nasce dallaccorpamento dei tre Centri di Studio sulle Cause di Deperimento e Metodi di Conservazione delle Opere dArte del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), creati a partire dal 1971. Poich la maggioranza dei suoi attuali ricercatori appartiene agli ex Centri che avevano sede a Milano (ex Centro Gino Bozza diretto da Giovanna Alessandrini), a Firenze (ex Centro diretto da Franco Piacenti) e a Roma (ex Centro Marcello Paribeni diretto da Gino Moncada Lo Giudice), lattuale profilo dellICVBC ha ereditato la tradizione operativa e di studio che ha caratterizzato i Centri. Questi ultimi si sono interessati prevalentemente della conservazione del patrimonio allaperto, soprattutto di tipo architettonico (Firenze, Milano) e archeologico (Roma), affrontandone le problematiche sotto il profilo scientifico e proponendone e sperimentando nuove soluzioni tecnologiche. Lattivit prevalente di ricerca stata quella della sintesi, dello studio e della sperimentazione di nuovi prodotti per la conservazione dei manufatti lapidei (Firenze e Milano), degli studi diagnostici sullo stato di conservazione dei monumenti (Milano), delle ricerche inerenti gli scavi archeologici (Roma) e degli studi sullambiente e sul controllo del microclima allinterno di zone espositive (Roma). Gli ex Centri di studio sono divenuti oggi la Sede dellIstituto (Firenze), la Unit Operativa Staccata di Roma e la Unit Operativa Staccata di Milano. Gli obiettivi istituzionali dellIstituto per la Conservazione e la Valorizzazione dei Beni Culturali sono i seguenti: - Caratterizzazione dei materiali costituenti le opere darte e delle loro alterazioni e degradazioni; - Sperimentazione di nuove tecnologie e materiali per la conservazione dei beni culturali; - Sviluppo di criteri innovativi di progettazione e realizzazione dinterventi conservativi; - Sviluppo di progetti innovativi di valorizzazione dei beni culturali.
PRINCIPALI ATTIVIT ED ECCELLENZE DELLENTE
LICVBC ha un proprio profilo distintivo nel panorama degli istituti italiani operanti nellambito dei Beni Culturali ed appartenenti sia al CNR che al Ministero per i Beni e le Attivit Culturali. Ci importante al fine di evitare inutili duplicazioni o sterili sovrapposizioni e per sviluppare unattivit dintegrazione con quelle delle altre realt istituzionali nel settore. Gli Istituti del CNR nellarea dei beni culturali sono tre: in ordine storico di creazione citiamo lITABC - Istituto Tecnologie Applicate ai Beni Culturali (operativo dal 1998) diretto da Salvatore Garaffo con sede a Roma, lICVBC - Istituto per la Conservazione e la Valorizzazione de Beni Culturali (operativo dal 2001) diretto da Piero Frediani con sede a Firenze e due sezioni staccate a Milano e a Roma, lIBAM - Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali (operativo dal 2003) diretto da Francesco DAndria, con sede a Lecce e due sezioni staccate a Potenza e a Catania. LICVBC ha una propria linea caratteristica nel privilegiare laspetto della conservazione dei beni culturali (pur mantenendo la finalit della valorizzazione) affrontando tematiche di ricerca relative alla conservazione di beni culturali esposti allaperto agli aspetti scientifico-tecnologici dei problemi conservativi, alla sintesi di prodotti per la protezione e conservazione dei Beni Culturali, alla valorizzazione dei siti culturali. I grandi Istituti del Ministero per i Beni e le Attivit Culturali, lIstituto Centrale Superiore del Restauro di Roma (ICR) e lOpificio delle Pietre Dure di Firenze (OPD), hanno finalit istituzionali ben distinte da quelle dellICVBC, privilegiando lattivit diretta o di coordinamento degli interventi di restauro veri e propri. Laddove anche questi istituti effettuino ricerca scientifico-tecnologica, gli ottimi rapporti di collaborazione con lICVBC assicurano lo sviluppo di azioni concertate con ruoli di reciproca integrazione. Stabilita lattivit primaria dellIstituto (ricerca eminentemente rivolta allapprofondimento degli aspetti scientifico-tecnologici della conservazione), unattivit distintiva stata rivolta alla messa a punto di protocolli e strumentazioni per la valutazione dello stato di conservazione dei Beni Culturali. Tale attivit svolta sia direttamente attraverso i propri ricercatori nella sede e nelle due sezioni staccate, sia coordinando gruppi di studio di altri istituti CNR e di Universit italiane, che condividano linteresse verso questa tematica e ne riconoscano limportanza e la priorit. Lattenzione rivolta soprattutto al patrimonio sito allesterno, particolarmente quello costituito da materiali lapidei naturali e artificiali, ma anche metallici (bronzi), intonaci decorati, vetrate, ecc.. Per la loro stessa collocazione ed esposizione diretta allambiente contaminato e aggressivo dei siti urbani, questo patrimonio quello soggetto al massimo rischio di degrado. LICVBC collabora alla messa a punto di protocolli al fine di monitorare in situ lo stato di conservazione e di conseguenza la progressione del degrado di manufatti e monumenti e per valutare lo stato di efficienza dei trattamenti conservativi utilizzati. Quanto sopra risponde a unesigenza prioritaria degli organi di tutela del patrimonio, le Soprintendenze, che, sulla base dei dati rilevati nelle campagne di monitoraggio, hanno la possibilit di elaborare piani funzionali di manutenzione programmata. Lo sviluppo di un tale programma prevede linterazione tra istituti di ricerca del CNR e dellUniversit insieme a istituti per la tutela dei Beni Culturali, nellottica di una politica programmatica comune, con un dichiarato orientamento verso una conservazione dei Beni Culturali.
232
Allegato - Alcuni esempi di eccellenze del sistema culturale e creativo fiorentino
ISTITUTO DI FISICA APPLICATA NELLO CARRARA (IFAC)
www.ifac.cnr.it
CENNI STORICI
LIstituto di Fisica Applicata Nello Carrara parte del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), il principale ente pubblico che persegua in Italia obiettivi di ricerca ed innovazione. La fondazione dellIFAC avviene nel 2002, ma le sue origini risalgono a molto prima, datate al 1946 con il nome di Centro Microonde e furono dovute a Nello Carrara, un pioniere nella scienza delle microonde. In questo periodo linteresse scientifico dellIstituto crebbe verso varie branche delle scienze fisiche, per il contributo scientifico di altri scienziati, come Giuliano Toraldo di Francia, includendo loptoelettronica, lelettronica quantistica, le scienze della Terra e le scienze dellinformazione. Una riforma del CNR pose nel 2002 le condizioni per laggregazione dellIstituto di Ricerca sulle Onde Elettromagnetiche Nello Carrara con lIstituto di Elettronica Quantistica, entrambi provenienti dal precedente Centro Microonde, nellattuale Istituto di Fisica Applicata Nello Carrara. Lo scopo primario dellIstituto la conduzione di ricerche di frontiera a livello internazionale e, nello stesso tempo, lo sviluppo di nuove tecnologie e metodologie da trasferire efficacemente al sistema economico.
PRINCIPALI ATTIVIT ED ECCELLENZE DELLENTE
Gli approcci perseguiti sono di ricerca teorica, sperimentale e applicata, con una forte attitudine allo sviluppo di nuove tecniche ed alla costruzione di prototipi di strumenti. Le principali linee di ricerca ruotano intorno ad un centro comune di metodi fisici per lindagine scientifica. Essi si basano essenzialmente sulle metodologie generali delloptoelettronica, della spettroscopia e dellICT. Le linee principali di ricerca riguardano Laser, Microottiche, Sensori, Telerilevamento, Microonde e ICT. Questi metodi fisici vengono impiegati per indagare nuove applicazioni in varie branche di scienze interdisciplinari, come i dispositivi fotonici per telecomunicazioni, la strumentazione aerotrasportata su satelliti, palloni ed aerei per losservazione della Terra, le soluzioni digitali per laccesso allinformazione, la biofotonica per terapie e chirurgie, le lavorazioni laser per lindustria, i sensori ottici per il controllo ambientale, le tecniche laser ed altre diagnostiche per larcheometria e la conservazione dei beni culturali. LIFAC contribuisce anche a studi cosmologici con lIstituto Nazionale di Fisica Nucleare Italiano con progetti sulla radiazione cosmica di fondo alle microonde, ed alle ricerche astrofisiche sullantimateria e sulla materia oscura: lIFAC stato coinvolto in vari progetti dellAgenzia Spaziale Italiana e dellAgenzia Spaziale Europea, nei progetti FLEX, KLIMA, CAMELOT, MARSCHALS dei Programmi Quadro della Comunit Europea focalizzati sui problemi climatici, con lo sviluppo di payloads, analisi ed elaborazione dei dati. In FP6 ha contribuito a vari progetti come NEMO, ENOC ed EFONGA sullo sviluppo di microottiche, CLINICIP e CAREMAN su biosensori per la cura della salute, DfA@einclusion sullaccesso per tutti alle ICT; in FP7 sta coordinando la rete E-Dean riguardante laccesso allinformazione, e sta contribuendo a progetti come Photonics4Life sulla biofotonica. LIFAC sta anche contribuendo a programmi di ricerca ed innovazione a livello nazionale e della Regione Toscana, con il coordinamento di molti progetti riguardanti le tecnologie optoelettroniche e fotoniche trasferite ad industrie e piccole e medie imprese attive nei settori dei prodotti biomedicali, della strumentazione aerospaziale, delle produzioni manifatturiere, della conservazione del patrimonio culturale. Con questo, lIstituto adempie agli obiettivi di contribuire efficacemente alle necessit della societ basata sulla conoscenza, sviluppando inoltre una significativa innovazione in vari settori tecnologici. Fra questi, lIFAC ha dato importanti contributi nella scienza e tecnologia per i Beni Culturali. Dai primi anni Novanta, lIstituto ha svolto ricerche sugli effetti dei fattori ambientali nel deterioramento dei materiali: - nel periodo 1994-1998 ha partecipato alla rete Europea ERA (Environmental Research for Art Conservation); - dal 1995 al 2002 ha svolto ricerche nel Progetto Finalizzato Beni Culturali del CNR, sviluppando diagnostiche ottiche e tecnologie Laser; - dal 2001 al 2004 ha partecipato al progetto Europeo FP5 LiDo Light Dosimeter sugli effetti dellilluminazione sul degrado dei dipinti; - dal 2002 al 2004 ha coordinato il progetto Regionale Optocantieri, una rete con 23 fra istituti, universit ed imprese high-tech e di servizi; - dal 2003 al 2006 ha coordinato COST G7 Artworks Conservation by Laser, una rete europea di cooperazione con 36 organizzazioni di 24 Paesi; - dal 2007 al 2010 ha collaborato con COST D42 Chemical interactions artefacts & environment, sugli effetti climatici; - dal 2007 al 2009 ha partecipato al progetto Europeo FP6 AUTHENTICO (Authentication methodologies of metal artefacts), per lautentica oggettiva anticontraffazione; - dal 2008 al 2010 ha partecipato al progetto Europeo FP6 POP ART (Preservation of Plastic Artefacts) sui problemi di conservazione dellarte moderna; - dal 2010 al 2013 partner di CHARISMA, unica infrastruttura europea per il settore dei beni culturali, con la responsabilit delle tecnologie di pulitura laser; - a livello regionale, nel 2010 coordina il rapporto con le imprese nel progetto START, una rete di Istituti, Universit e Soprintendenze, partecipa al progetto TDT Bio Art sullanalisi dei biodeteriogeni ed coordinatore di TEMART, una rete con INFN, UNIFI, Opificio delle Pietre Dure con imprese high-tech e di servizi che mira allo sviluppo integrato di prodotti e servizi innovativi per la caratterizzazione e la conservazione di beni culturali. Fra i successi riconosciuti in campo internazionale, lIFAC pu vantare lo sviluppo di sensori ottici per analisi dei pigmenti, soluzioni digitali per larchivistica, immagini iperspettrali di dipinti, varie diagnostiche ottiche e a radiofrequenza per la conservazione, strumenti LIDAR per lanalisi remota, strumenti Laser per lautentica di metalli e nuovi metodi e sistemi Laser per la pulitura di lapidei, metalli e pitture murali, che sono diventati prodotti (EL.EN. Spa) apprezzati in tutto il mondo, usati nel restauro di capolavori di altissimo pregio storico e artistico.
233
Leconomia dei beni culturali e ambientali.
Una visione sistemica e integrata
ISTITUTO LORENZO DE MEDICI
www.lorenzodemedici.it
CENNI STORICI
LIstituto Lorenzo de Medici, nato nel 1973, una delle prime istituzioni accademiche internazionali in Europa. Con il passare degli anni ha esteso i suoi programmi teorico-pratici a molte discipline artistiche, umanistiche ed economiche, diventando uno dei maggiori riferimenti per studenti internazionali in Italia, contando 2.300/2.500 presenze annue. Dopo lampliamento della sua sede a Firenze, ha aperto tre sedi a Roma, a Tuscania e a Venezia. Dal 2006, lIstituto, insieme a Marist College di New York, offre B.A., B.S. e Master riconosciuti dal sistema statunitense di accreditamento di Middle States. La missione dellIstituto Lorenzo de Medici di aiutare gli studenti di tutto il mondo a realizzare il proprio potenziale creativo attraverso uneducazione connessa ad esperienze dirette nel mondo della loro futura professione. LIstituto stimola i propri studenti a sperimentare lEmpowerment come possibilit parallela per organizzarsi ed inserirsi nel sistema.
PRINCIPALI ATTIVIT ED ECCELLENZE DELLENTE
LIstituto attualmente conta pi di 200 docenti qualificati per 450 corsi in belle arti, discipline umanistiche, design, archeologia, restauro, grafica, cinematografia, moda, arti applicate e dello spettacolo, scienze politiche e sociali. LIstituto diviso in quattro dipartimenti: Scuola di Arti e Scienze (Storia dellArte, Comunicazione, Cinema e TV, International Business, Scienze Politiche e Studi Internazionali), Scuola delle Arti Applicate (Pittura, Disegno e Mixed Media, Fotografia, Scultura e Ceramica, Grafica, Danza, Musica e Teatro, Restauro e Conservazione, Archeologia), Scuola di Design (Design di Interni, Graphic Design, Design di Moda, Design di Gioielleria) e Scuola di Lingua Italiana (Corsi collettivi e individuali, Corsi per insegnanti, Certificazioni CILS e CELI). LIstituto affiliato con il DAMS dellUniversit di Firenze, il Dipartimento di Scienze Antiche, il Dipartimento di Scienze Sociali e con oltre 200 Universit in tutto il mondo. LIstituto progetta, insieme agli studenti, eventi, convegni e seminari che riguardano il loro percorso didattico: - Conferenze: Sciences and Consciousness, Empowerment, The Source of Creativity, Tax Credit and Tax Shelter, New Way for Art Distribution, ecc.; - Esposizioni annuali: The Art is in the street, The Art of Recycling, Second End Second Life, Fashion Shows, Biennale di Venezia; - Festival Musicali annuali: Paesaggi e Suoni Tuscania - Festival cinematografici annuali: Segno dargento, FilmSpray; - Restauri pittorici e plastici: attivit in Italia (varie esperienze, sia nel pubblico che nel privato, tra i quali: Casa di Giotto a Vicchio del Mugello, Museo degli Uffizi, Tabernacoli, Cappelle Medicee, Palazzo Martelli, Cappella Poccetti, Scuola di Sanit Militare, Castello di Rocca Imperiale in Calabria, ecc.) e allestero (affresco nella chiesa di San Francesco a Nuova Delhi, vari templi in Nepal, casa di Pablo Neruda a Santiago del Cile, varie chiese in Sudamerica, Mohai dellIsola di Pasqua questultima esperienza allIsola di Pasqua non riguarda soltanto il restauro, ma anche laddestramento dei restauratori locali); - Archeologia: in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Antiche dellUniversit di Firenze: Parco Archeologico del lago dellAccesa (Massa Marittima), varie necropoli di Tuscania (VT).
234
Allegato - Alcuni esempi di eccellenze del sistema culturale e creativo fiorentino
ISTITUTO UNIVERSITARIO EUROPEO
www.eui.eu
CENNI STORICI
LIstituto Universitario Europeo (IUE - European University Institute) unistituzione internazionale di ricerca e di insegnamento a livello post-laurea creata nel 1972 dai sei Stati Membri fondatori della Comunit Europea con lo scopo di promuovere lo sviluppo culturale e scientifico nellambito delle scienze sociali, giuridiche e umanistiche, in unottica europea. Fu nel 1955, durante i lavori della Conferenza di Messina, che per la prima volta venne prospettata lidea di dar vita ad unistituzione che avrebbe contribuito alla costruzione dellEuropa nellarea dellinsegnamento e della ricerca. Solo diciassette anni dopo, con la firma della Convenzione che sanciva la creazione dellIstituto Universitario Europeo, lidea prese forma e Firenze venne scelta come sede del nuovo istituto europeo di studi post-universitari. Al momento, 19 dei 27 Stati Membri dellUnione Europea hanno firmato la Convenzione relativa alla creazione di un Istituto Universitario Europeo, e sono in corso trattative per ladesione degli altri 8 Paesi Membri. Secondo la Convenzione istitutiva, solo gli Stati Membri dellUE possono diventare formalmente membri dellIUE; gli altri Paesi europei e i Paesi in via dadesione allUE possono firmare, rispettivamente, accordi di associazione e accordi di preadesione. Ad oggi, lIUE ha sottoscritto accordi di preadesione con lUngheria e la Turchia, e accordi di associazione con la Svizzera e la Norvegia. LIUE ha forti rapporti con la Commissione dellUnione Europea. Una parte dei finanziamenti dellIstituto proviene dallUE, bench la gestione sia di totale competenza degli Stati aderenti alla Convenzione. Lorgano principale dellIUE il Consiglio Superiore, in cui siedono i rappresentanti degli Stati Membri. Spetta al Consiglio Superiore nominare il Presidente dellIUE ed il Segretario Generale. Il Presidente dirige lIstituto e presiede il Consiglio Accademico, organo composto dai docenti e responsabile della gestione delle attivit di insegnamento e ricerca. LIUE occupa una dozzina di edifici storici che si trovano sulla collina di Fiesole, alle porte di Firenze.
PRINCIPALI ATTIVIT ED ECCELLENZE DELLENTE
Attualmente lIstituto riunisce 1.000 persone e offre uno dei pi ampi programmi del mondo di dottorato e post-dottorato in scienze sociali. I ricercatori sono ammessi in seguito ad una rigorosa selezione, e seguono il proprio programma di dottorato presso i quattro Dipartimenti dellIstituto (Scienze economiche, Storia e civilizzazione, Scienze giuridiche, Scienze politiche e sociali). Dagli anni Ottanta sono state istituite alcune borse di studio per i ricercatori di postdottorato. Agli inizi degli anni Novanta stato creato il Centro di Studi Avanzati Robert Schuman, che si occupa di ricerca post-dottorale orientata a sostenere la formulazione delle politiche, con unimpostazione interdisciplinare ed europea. Nel 2006, in collaborazione con la Commissione Europea, stato varato il Programma Max Weber, volto a rafforzare la dimensione postdottorale dellIUE. Inoltre, in seguito alla firma dellAccordo di deposito nel 1984, le istituzioni comunitarie hanno affidato allIUE la gestione degli Archivi Storici dellUnione Europea, la cui missione raccogliere, archiviare e rendere accessibili al pubblico i documenti storici dellUE.
235
Leconomia dei beni culturali e ambientali.
Una visione sistemica e integrata
MUSEI CIVICI FIORENTINI
www.museicivicifiorentini.it
CENNI STORICI
I Musei Civici Fiorentini sono costituiti da una ricchezza e da una variet articolata di collezioni custodite per la maggior parte in edifici antichi: il Museo di Palazzo Vecchio, il Museo di Santa Maria Novella, la Fondazione Salvatore Romano presso il Cenacolo di Santo Spirito, il Museo Stefano Bardini (riaperto in Oltrarno nellaprile 2009 dopo 10 anni di lavori di restauro e riallestimento). A questi Musei oggi aperti al pubblico, si affiancano il Forte Belvedere che custodisce la raccolta Alberto Della Ragione e le Collezioni del Novecento (attualmente inaccessibile al pubblico), la Galleria Rinaldo Carnielo (chiusa e in attesa dellavvio di un nuovo progetto di allestimento) e il Museo Firenze comera, che confluir nel futuro Museo della Citt, il cui nucleo fondativo trover sede in Palazzo Vecchio. Ai Musei si aggiungono le Chiese coi quadri, con le statue, coi mobili di chiesa, e tutti gli oggetti darte e gli arredi sacri che vi si trovano acquisite in concessione duso con quanto disposto dal Rogito Guerri del 29 aprile 1868 a seguito della legge di soppressione degli Enti religiosi sottoscritta dal ministro Siccardi nel 1866. Tra queste si ricordano: Santa Maria Novella con i suoi chiostri monumentali, Santa Maria del Carmine con la Cappella Brancacci, San Firenze, Santissima Annunziata e Santo Spirito. Vi poi una serie di altri edifici religiosi per i quali i Musei Civici Fiorentini hanno in vario modo acquisito competenze nel corso del tempo relativamente al patrimonio di oggetti darte mobili, come San Salvatore al Monte, San Giovannino degli Scolopi, la Cappella di San Romano a Settignano, Santa Maria del Pellegrino, San Giuseppino. Contribuiscono a formare il patrimonio di opere darte di cui i Musei Civici Fiorentini curano la gestione, conservazione e valorizzazione anche le numerose raccolte che il Comune ha ricevuto in dono da collezionisti, artisti e istituzioni cittadine, in parte confluite nei Musei esistenti e in parte in deposito presso altri Enti.
PRINCIPALI ATTIVIT ED ECCELLENZE DELLENTE
I Musei Civici Fiorentini hanno il compito di conservare e valorizzare il patrimonio darte civico mettendolo a disposizione della fruizione pubblica nel senso pi ampio e democratico possibile; essi sono un servizio pubblico, con funzioni culturali e sociali, un diritto dei cittadini.
236
Allegato - Alcuni esempi di eccellenze del sistema culturale e creativo fiorentino
MUSEO GALILEO - ISTITUTO E MUSEO DI STORIA DELLA SCIENZA
www.museogalileo.it
CENNI STORICI
Museo Galileo la nuova denominazione dellIstituto e Museo di Storia della Scienza fondato nel 1927. Sede del Museo Palazzo Castellani, edificio medievale situato nel cuore di Firenze, sullArno, accanto alla Galleria degli Uffizi e vicino ai principali monumenti storici ed artistici della citt. Il Museo Galileo rappresenta una delle principali istituzioni a scala internazionale attive nella museografia scientifica, nella produzione di iniziative per la diffusione della cultura scientifica e nelle attivit di documentazione e di ricerca, grazie anche alla collaborazione con i maggiori istituti internazionali. Lo staff del Museo Galileo composto da 25 dipendenti e da altrettante persone con contratti a progetto.
PRINCIPALI ATTIVIT ED ECCELLENZE DELLENTE
Il primo e secondo piano, totalmente rinnovati, ospitano lesposizione permanente del Museo Galileo: una collezione di bellissimi strumenti scientifici estremamente importanti e conosciuti in tutto il mondo, appartenuti alle famiglie dei Medici e dei Lorena. Il patrimonio del museo si compone di oltre 5.000 oggetti, tra i quali spiccato gli unici due telescopi originali di Galileo che siano pervenuti fino ai giorni nostri. Il terzo e quarto piano sono occupati, oltre che dagli uffici, da unimportante biblioteca di ricerca che conserva circa 130.000 opere di interesse storico-scientifico. Alle 5.000 opere dei fondi antichi si affiancano i cospicui fondi otto-novecenteschi e il fondo contemporaneo, arricchito ogni anno di circa 1.800 nuove acquisizioni. Sono, inoltre, presenti diversi fondi archivistici dei secoli XVIII-XX e un interessante archivio di foto depoca. La biblioteca, conosciuta a livello internazionale, offre fondamentale supporto a studiosi di storia della scienza provenienti da tutto il mondo. Il piano terra occupato dalla biglietteria, dal bookshop, da stanze per i laboratori didattici e da locali tecnici; mentre i magnifici spazi del piano seminterrato, attrezzati con i pi moderni equipaggiamenti informatici, sono dedicati ad ospitare convegni e mostre temporanee. Nei locali situati in Piazza Mentana si trova il Laboratorio Multimediale responsabile della produzione dei filmati, delle applicazioni interattive per le attivit divulgative e di documentazione del Museo Galileo. Tali attivit riguardano sia la collezione del Museo stesso, sia mostre o altri eventi speciali. Il laboratorio ha realizzato e continuamente aggiorna un gigantesco sito web visitato ogni anno da milioni di utenti che ne utilizzano i molteplici servizi. Tra le attivit dellEnte si segnalano lideazione di numerose mostre, di notevole successo a livello mondiale tra cui Gli Ingegneri del Rinascimento (allestita a Parigi, Firenze, New York, Londra, Tokyo e Taranto), La mente di Leonardo (primo allestimento a Firenze e poi a Tokyo, Debrecen, San Jos e Roma), Galileo. Immagini delluniverso dallantichit al telescopio (Firenze, 2009). Negli ultimi 20 anni, infine, listituto ha pubblicato oltre 200 volumi di argomento scientifico e due collane di riviste: Nuncius e Galilaeana.
237
Leconomia dei beni culturali e ambientali.
Una visione sistemica e integrata
MUSEI MARINO MARINI
www.museomarinomarini.it
CENNI STORICI
Il Museo Marino Marini nato dalla volont congiunta di Marino e Marina Marini, che alla fine degli anni Settanta individuarono la Chiesa di San Pancrazio di Firenze come luogo ideale al quale legare la cospicua donazione di opere che lartista, poco prima di morire, aveva fatto alla citt di Firenze. La ristrutturazione della chiesa, recuperata dopo secoli e ridestinata ad una funzione pubblica, fu ad opera degli architetti Lorenzo Papi e Bruno Sacchi che hanno saputo interpretare magistralmente le idee di Marina, come lei stessa ha pi volte sottolineato, creando un allestimento pensato a immagine e somiglianza di quel mondo cos affascinante di Marino Marini, uno dei personaggi pi significativi della cultura figurativa del Novecento. Spazi ampi e luminosi, punti di vista molteplici consentono una lettura completa del lavoro dellartista, evidenziando i temi a lui pi cari, dai Cavalieri alle Pomone, dai Miracoli ai Giocolieri, ai Danzatori e naturalmente ai ritratti. Vi sono conservate 183 opere fra sculture, dipinti, disegni e incisioni, realizzate tra il 1916 e 1977, e donate in momenti diversi da Marino Marini e dalla moglie. Nel 1980 fu donato dallartista al Comune di Firenze il primo nucleo di opere, costituito da 22 sculture, 31 dipinti, 30 disegni e 30 incisioni. Successivamente, nel 1988, la vedova Marini don al Comune di Firenze altre 42 opere al fine di rendere pi completa ed approfondita la collezione del museo. Nel frattempo il patrimonio museale si arricchito di ulteriori 26 opere donate dalla signora Marini, dalla signora Del Vecchio, dal lascito testamentario Jesi e recentemente dalla donazione della signora Freccia. Il museo contiene esclusivamente opere di Marino Marini tutte esposte sui quattro livelli delledificio di San Pancrazio.
PRINCIPALI ATTIVIT ED ECCELLENZE DELLENTE
Dal 1988 ad oggi, il Museo ha ospitato mostre, incontri, concerti e attivit culturali legate alla vita pubblica e artistica della citt e alle opere di Marino Marini. Con la presidenza di Carlo Sisi, iniziata nel 1999, lattivit del museo si intensificata. Negli ultimi tre anni, sotto la direzione artistica di Alberto Salvadori, lattenzione dedicata alla ricerca contemporanea, assieme al costante lavoro di divulgazione e valorizzazione dellopera di Marino Marini, hanno fatto s che la fondazione abbia continuato a mettere al servizio della citt di Firenze sia la significativa presenza di uno dei maestri del Novecento sia una piattaforma votata alle tematiche della contemporaneit. In generale, lo spazio espositivo del Museo Marino Marini stato pensato, fin dalla sua apertura, per offrire al pubblico una vasta gamma di servizi: bookshop, dipartimento di didattica. Unidea che gi allepoca era perfettamente in linea con ci che altrove museograficamente veniva regolarmente praticato.
238
Allegato - Alcuni esempi di eccellenze del sistema culturale e creativo fiorentino
MUSEO NAZIONALE DEL BARGELLO
www.firenzemusei.it/bargello
CENNI STORICI
Il Museo Nazionale del Bargello si trova in quello che fu il Palazzo del Capitano del Popolo. Il nucleo originale, risalente al 1255, stato costruito, secondo il Vasari, su disegno di un certo Lapo, padre di Arnolfo di Cambio, e corrisponde al blocco che si affaccia su via del Proconsole: la pi antica sede del governo della citt. Dalla fine del XIII sec. fino al 1502 il Palazzo fu residenza ufficiale del Podest, il magistrato che governava la citt e che doveva essere, secondo la tradizione, un forestiero. Intorno al 1287 fu costruito il verone, la bellissima loggia affacciata sul cortile dove spesso il Podest adunava i rappresentanti delle arti e delle corporazioni. Il torrione, preesistente a tutto ledificio, conteneva la campana detta La Montanina, che suonava quando si dovevano chiamare a raccolta i cittadini fiorentini in caso di guerra o di assedio. Nel 1502 il palazzo divenne sede del Consiglio di Giustizia e della polizia, il cui capo era detto, appunto, il Bargello. Nel 1786, quando il granduca Pietro Leopoldo abol la pena di morte, gli strumenti di tortura furono bruciati nel cortile. Le prigioni rimasero in uso fino al 1857, quando furono trasferite nellex convento delle Murate; a partire da questa data, cominci il completo restauro delledificio, compiuto dallarchitetto Francesco Mazzei.
PRINCIPALI ATTIVIT ED ECCELLENZE DELLENTE
La scoperta, nel luglio del 1840, del pi antico ritratto di Dante Alighieri su una parete della Cappella del Bargello fu decisiva per il recupero del Bargello e la sua destinazione. Nel 1865, ricorrendo il sesto centenario della nascita del poeta, il nuovo Museo Nazionale fu inaugurato con unesposizione dedicata a Dante e unaltra sulla storia delle arti applicate a partire dal Medioevo: ambedue gli eventi fornirono al museo loccasione di acquisire il deposito di straordinarie opere provenienti dagli Uffizi (armi, bronzi, maioliche, sculture rinascimentali e medaglie), da Palazzo Vecchio (armi e statue del Salone dei Cinquecento), dallArchivio di Stato (sigilli), dalla Zecca (monete), da conventi soppressi (sculture, oreficerie e terrecotte robbiane). Ma la definitiva destinazione del Bargello a museo della scultura del 1886, quando si celebr il quinto centenario della nascita di Donatello, consacrandolo come il pi importante museo di scultura italiana del Rinascimento. Due anni pi tardi il museo fu destinatario della generosa donazione di oggetti gotici e rinascimentali dellantiquario francese Louis Carrand (bronzi, smalti, maioliche, oreficeria, avori, armi, stoffe), alla quale segu quella del 1894 di Costantino Ressman, ambasciatore e collezionista di armi. Giulio Franchetti don, invece, nel 1907 la sua collezione di tessuti, con esemplari che vanno dal VI al XVIII secolo. Seguirono altre donazioni e ancora oggi, insieme agli acquisti dello Stato, il contributo di privati e associazioni consente il continuo accrescimento delle raccolte. Tra le opere conservate al Museo Nazionale del Bargello vi sono sculture di Michelangelo (come il Bacco ebbro e il tondo marmoreo raffigurante la Madonna col bambino e San Giovannino), di Jacopo Sansovino, di Benvenuto Cellini, del Giambologna, di Andrea Verrocchio e, soprattutto, di Donatello (come il famoso bronzo del David e il Marzocco, emblema della citt di Firenze). La collezione di maioliche del Bargello che copre quasi lintera storia della maiolica italiana deve molto al collezionismo dei Medici, in particolare a quello di Cosimo I, che apprezzava particolarmente larte della ceramica e della porcellana. Infine, ben rappresentata la raccolta di terre invetriate di Giovanni e Andrea della Robbia.
239
Leconomia dei beni culturali e ambientali.
Una visione sistemica e integrata
MUSEO STIBBERT
www.museostibbert.it
CENNI STORICI
Il Museo Stibbert uno dei luoghi pi affascinanti e inaspettati di Firenze. In una casa-museo progettata dal suo proprietario, il collezionista e mecenate Frederick Stibbert (1838-1906), sono raccolte e disposte secondo un allestimento emozionante e ricco di scena, le eccezionali collezioni che egli ha lasciato, alla sua morte, alla citt: in particolare la famosa collezione di armi, ma anche oggetti darte e di vita quotidiana della civilt europea, islamica ed estremo orientale, in particolare giapponese. Il Museo Stibbert la testimonianza del gusto e dellintelligenza di un individuo e insieme rappresenta la sintesi dei pi alti valori culturali del secolo XIX: interesse per il passato, esaltazione dellarte e passione per lesotico. Nato nel 1838 da un alto ufficiale inglese e da madre fiorentina, erede di una grande fortuna, Frederick Stibbert dedica il suo tempo e le sue cospicue sostanze a studiare e raccogliere gli oggetti significativi del divenire storico, primi fra tutti le armi, sulla cui forma, innovazione ed efficienza si sono costruiti i miti degli eroi, ma soprattutto le vittorie degli eserciti, la potenza degli stati e, quindi, la civilt. Il clima culturale di Firenze, tutto rivolto alla celebrazione dei fasti antichi e in cui attiva una numerosa colonia inglese, particolarmente consono agli interessi di Stibbert, alle cui rievocazioni storiche non manca di partecipare. Ma i suoi interessi vanno ben oltre i limiti della cultura cittadina: affascinato dalle culture diverse e lontane, dal Medio Oriente allallora misterioso Giappone, mette a confronto i nostri con i loro diversi modi di combattere e di vivere, con intuizioni moderne e tuttora valide. Agenti che operano in tutto il mondo gli permettono di scegliere gli oggetti pi belli, curiosi o interessanti; uno stuolo di artigiani fiorentini al suo servizio sincarica di restaurare e ridare vita ai pezzi pi significativi. Nel 1906, alla sua morte, vengono lasciati alla citt di Firenze pi di 36.000 pezzi, quasi tutti di eccellente qualit, gi disposti secondo percorsi didattici ed evocativi nella casa da lui disegnata e strutturata per questo scopo.
PRINCIPALI ATTIVIT ED ECCELLENZE DELLENTE
La villa che Stibbert possiede alle pendici dei colli fiorentini viene da lui trasformata in castello neogotico, con ampi ambienti a piano terreno pensati per ospitare le collezioni nella successione e nella forma scenografica da lui ideata. Questi confluiscono negli sfarzosi appartamenti privati, arredati e decorati secondo i criteri ottocenteschi, che assegnavano ad ogni ambiente uno stile preciso: neorinascimentale per il salone da ballo, rococ per i salottini, impero per le camere da letto. Lo stesso gusto eclettico, la stessa curiosit per il passato e lesotico caratterizza il parco che circonda la villa. Boschetti, padiglioni, statue, false rovine e un piccolo tempio egiziano scandiscono o sono la meta di percorsi naturalistico-evocativi apparentemente casuali: una visione romantica del giardino che rappresenta unulteriore novit portata da Stibbert nellambiente culturale fiorentino del tempo. La casa-museo Stibbert nota particolarmente per la sua Armeria, per i costumi e le altre collezioni in essa custodite. Il tipo di collezionismo e soprattutto di armeria, da cui F.Stibbert prende ispirazione, quello inglese, in una visione che spazia dallOriente allOccidente, dallIndia al Giappone, dal mondo islamico allEuropa. Il suo scopo didattico: le collezioni devono raccontare la storia delle armi e soprattutto del costume, inteso nellaccezione pi vasta. In un grande salone di gusto gotico, costruito appositamente, i cavalieri cinquecenteschi, chiusi nelle loro armature danno vita ad una imponente cavalcata, in cui le pose dei guerrieri e dei cavalli si ispirano ai grandi monumenti equestri di veri personaggi storici, come Emanuele Filiberto di Savoia o lImperatore Massimiliano dAustria. In una sala con decorazioni moresche un altro piccolo esercito, ricoperto di pregiati tessuti e maglie metalliche, testimonia la diversa concezione dellarmamento propria del mondo islamico, che va dallAfrica settentrionale, allAsia centrale fino allIndia. Non meno suggestiva la sezione dedicata al Giappone, con i suoi guerrieri colorati e fantastici e lestrema eleganza delle vesti e degli arredi. Oltre alle armature, armi e bardature di cavalli, la collezione comprende bronzi, costumi, lacche: per la sua ricchezza e qualit dei pezzi una delle pi importanti al mondo fuori dal Giappone. Se le armature dei diversi popoli servono a testimoniare le vittorie e le sconfitte che segnano e determinano la storia, gli oggetti quotidiani o artistici che le accompagnano servono a restituirne il senso e la vita. Stibbert colleziona tutto, ma soprattutto ci che attinente alla persona e ne forma limmagine, ne svela i valori, come le vesti. Acquista pitture importanti, ma preferisce i dipinti, anche di artisti sconosciuti, che illustrano la storia del costume, delle armi indossate e degli abiti concepiti come corazze. Gli arazzi che decorano le pareti della villa sono scelti per il loro soggetto con lo stesso criterio illustrativo. Tra i pezzi di abbigliamento se ne contano alcuni addirittura eccezionali, come indumenti e accessori del Cinquecento e labito completo indossato da Napoleone per lincoronazione a re dItalia. Fra le pi ricche al mondo la raccolta di cuoi seicenteschi impressi e dipinti, che Stibbert usa alle pareti della sua casa museo, ma soprattutto negli appartamenti privati. Mobili, maioliche, stoffe, parati sacri ed infine libri: la sua biblioteca certo, per i soggetti armi e costume, una delle pi vaste del tempo, cui F.Stibbert aggiunse la sua personale Storia del Costume civile e militare, sintesi del suo lavoro collezionistico e del senso di tutta una vita.
240
Allegato - Alcuni esempi di eccellenze del sistema culturale e creativo fiorentino
OPIFICIO DELLE PIETRE DURE DI FIRENZE
www.opificiodellepietredure.it
CENNI STORICI
LOpificio delle Pietre Dure (OPD) nasce come Istituto a competenza nazionale nel 1975, dallunione di due diverse realt attive da tempo nel campo della produzione artistica e della conservazione delle opere darte a Firenze: lantico e rinomato Opificio, fondato nel 1588 come manifattura di corte e trasformato in istituto di restauro verso la fine dellOttocento, e il Gabinetto Restauri fondato da Ugo Procacci allinterno della Soprintendenza nel 1932, grandemente poi sviluppatosi nella nuova sede della Fortezza da Basso in seguito allalluvione di Firenze del 1966. Attualmente lOpificio uno degli Istituti centrali del Ministero per i Beni e le Attivit Culturali.
PRINCIPALI ATTIVIT ED ECCELLENZE DELLENTE
Lattivit dellOpificio si esplica in tre branche principali: la conservazione propriamente detta, tramite gli 11 settori specialistici di restauro ed i circa 60 restauratori, eseguita in forma diretta o indiretta, cio con consulenze, progettazioni e direzioni dei lavori; la ricerca, sia pura sia applicata ai casi in corso di restauro, spesso anche svolta attraverso collaborazioni e consulenze in sedi nazionali e internazionali; la didattica tramite la Scuola di Alta Formazione e unintensa attivit di stage in rapporto con analoghi istituti italiani e internazionali. Nel dettaglio: - Laboratori di restauro: lattivit di restauro, conservazione e consulenza sui beni culturali si struttura in 11 laboratori di restauro dislocati in 3 sedi operative: la sede storica di Via degli Alfani (bronzi e armi antiche; materiali ceramici e plastici; materiali lapidei; oreficerie; mosaico e commesso in pietre dure), la sede della Fortezza da Basso (dipinti su tela e tavola; materiali cartacei e membranacei; pitture murali; sculture lignee policrome; materiali tessili) e il salone delle bandiere di Palazzo Vecchio (arazzi e tappeti); - Diagnostica, analisi e ricerca: lattivit connessa alle discipline scientifiche applicate allo studio e alla conservazione dei beni culturali rappresenta una rilevante e ben consolidata realt allinterno dellIstituto e si concretizza nel Laboratorio Scientifico e nel servizio di Climatologia e conservazione preventiva; - Scuola di Alta Formazione: lattuale scuola di restauro attiva presso lOpificio delle Pietre Dure di Firenze ha avviati i propri corsi nel 1978 ricevendo un riconoscimento giuridico ufficiale nel 1992. Dal 1996 ha durata quinquennale ed parificata ad un corso di laurea magistrale; - Documentazione e archivi: lattivit di documentazione dellIstituto comprende la Biblioteca, lArchivio dei restauri e lArchivio storico, con sede in Via degli Alfani e il Laboratorio fotografico con sede nella Fortezza da Basso; - Servizio di promozione culturale: cura la comunicazione istituzionale dellIstituto; - Servizio di informatica applicata: svolge attivit di consulenza, progettazione, gestione, manutenzione e didattica inerente linformatica e le sue applicazioni nel campo della conservazione dei Beni Culturali e delle attivit amministrative correlate. Infine, il Museo dellOpificio diretta filiazione della manifattura artistica antica, caratterizzata dalla lavorazione delle pietre dure, che fu ufficialmente fondata nel 1588 da Ferdinando I de Medici. La fisionomia del Museo non corrisponde ad una precisa volont collezionistica, ma piuttosto riflesso della vita e delle vicende della secolare attivit produttiva. Le creazioni pi prestigiose, oggetto sovente di dono da parte dei granduchi fiorentini, sono conservate nelle regge e nei musei di tutta Europa, mentre nei laboratori di produzione sono rimaste opere incompiute o risultato di modifiche e smontaggi successivi, e quanto sopravvissuto alle dispersioni ottocentesche, che ebbero termine nel 1882 con la musealizzazione della raccolta. La raccolta, che comprende esemplari di grande suggestione e raffinatezza, comunque sufficiente a delineare un percorso storico della manifattura che si snoda attraverso tre secoli. Resta inoltre una importante riserva di marmi antichi e di pietre dure raccolte in funzione della tecnica del commesso. Il museo stato ristrutturato, su progetto di Adolfo Natalini, nel 1995.
241
Leconomia dei beni culturali e ambientali.
Una visione sistemica e integrata
PITTI IMMAGINE
www.pittiimmagine.com
CENNI STORICI
Pitti Immagine una delle societ leader nel mondo per lorganizzazione di fiere ed eventi nel settore della moda. E una societ di capitali con sede a Firenze, partecipata dai principali organismi dellindustria italiana del tessile e dellabbigliamento e dai principali soggetti collettivi, pubblici e privati, a livello locale e regionale. Per statuto gli utili prodotti non vengono distribuiti ai soci, bens reinvestiti nelle attivit promozionali e di comunicazione. La missione della societ, che opera dalla met degli anni Cinquanta, consiste nel creare fiere ed eventi per la moda intesa come fatto produttivo e di consumo, di progettazione, estetico e culturale: un ponte tra il mondo dellindustria e quello del fashion design. Fondata su solide basi commerciali grazie a unaccurata selezione dei partecipanti e a una costante opera di scouting delle migliori novit internazionali la specificit del servizio di Pitti Immagine la forte interazione fra le strategie di marketing, la cura degli allestimenti e i programmi di promozione e comunicazione, con una forte vocazione alla ricerca e alla promozione dei giovani talenti (attraverso concorsi, eventi speciali e sezioni espositive).
PRINCIPALI ATTIVIT ED ECCELLENZE DELLENTE
Pitti Immagine attualmente organizza: - Pitti Immagine Uomo (abbigliamento maschile e accessori); - Pitti W_ pre.collections (womens prt a portr); - Pitti Immagine Bimbo (abbigliamento e accessori per bambini e ragazzi, prmaman e articoli per la prima infanzia); - Pitti Immagine Filati (filati per maglieria, collezioni di accessori per maglieria, uffici stile, librerie specializzate; macchinari e sistemi informatizzati); - Touch+Neozone+Cloudine (abbigliamento e accessori di prt-a-portr femminile); - Taste (eccellenze eno-gastronomiche italiane); - ModaPrima (collezioni moda per la grande distribuzione); - Fragranze (profumi ed essenze per il corpo e la casa). Nel panorama fieristico internazionale, le rassegne di Pitti Immagine rappresentano il quadro pi aggiornato e completo della produzione italiana ed estera di fascia alta. Gli espositori (oltre 2.500 imprese) sono, infatti, selezionati da appositi comitati tecnici (formati da esperti dei rispettivi settori, produttori e commercianti), che passano a un severo vaglio le richieste di ammissione delle aziende, garantendo cos alle manifestazioni il massimo livello qualitativo e offrendo un prezioso know-how per le fiere e per le iniziative che vengono proposte e intraprese. Le rassegne vengono visitate ogni anno da circa 120.000 operatori internazionali del settore: la parte del leone spetta a Pitti Uomo, con le sue oltre 60.000 presenze. Si tratta della distribuzione qualificata e specializzata (boutique, department e specialty store, gruppi dacquisto, buying office, importatori, distributori), dellintermediazione commerciale (agenti e rappresentanti), del mondo della progettazione (consulenti, studi stilistici) e della comunicazione (giornalisti, agenzie di pubblicit e di pubbliche relazioni). Dopo lItalia, le maggiori affluenze provengono dai paesi dellUE, dagli Stati Uniti e dal Sud-Est asiatico; negli ultimi anni si sono registrati grandi aumenti dallest europeo, dalla Cina e dal Sud America. Nel lavoro di promozione allestero, la societ collabora a stretto contatto con lagenzia promozionale del governo, lICE (Istituto Nazionale per il Commercio Estero, ente che opera sotto legida del Ministero delle Attivit Produttive) e con i governi regionali. Sfilate e fashion project, mostre e installazioni, performance e spettacoli si affiancano alle fiere, ampliandone la funzione tradizionale. La manifestazione cos, oltre ad essere il luogo privilegiato a livello internazionale dincontro tra addetti ai lavori, assume un nuovo ruolo: essa promuove, infatti, una cultura della moda contemporanea. Le rassegne e gli eventi speciali diventano momenti di ricerca e di analisi delle diverse tematiche culturali, estetiche e di costume che il prodotto moda continuamente crea e sollecita, mettendo in evidenza le interconnessioni esistenti tra la moda e le altre forme di creativit contemporanea: arti visive, architettura e design, fotografia, musica, comunicazione, ecc.. Pitti Immagine Discovery nasce nel 1999 con lobiettivo di focalizzare lattenzione sui pi interessanti e stimolanti linguaggi creativi contemporanei. Si tratta di unesperienza assolutamente originale: un laboratorio dove si sperimenta la capacit di unazienda di intervenire su una citt e la sua vita culturale. Nel 2002 Pitti Immagine Discovery diventa fondazione, partecipata da Pitti Immagine e dalla capogruppo Centro di Firenze per la Moda Italiana. Il compito quello di mettere in evidenza i fenomeni artistici pi innovativi dai quali la moda trae materia di progettazione e per i quali essa stessa sempre pi spesso motivo e fonte di riflessione e di produzione. La Fondazione si caratterizza anche per unintesa attivit editoriale. In questa direzione si collocano le collaborazioni con alcune delle pi importanti istituzionali culturali e artistiche internazionali. Pitti Immagine, insieme alla Fondazione Pitti Discovery, contribuisce al progetto European Fashion con una parte consistente del suo archivio digitale, costituito in questi anni con materiali fotografici e video relativi alle fiere (collezioni, allestimenti, concorsi per giovani talenti, visitatori e personaggi emblematici della moda), ai fashion project e fashion show (collezioni, allestimenti, fashion designer, collaborazioni artistiche, inviti e materiale di comunicazione), alle mostre e alle installazioni di arte e moda contemporanee (opere darte e abiti, architetture e allestimenti), ai libri (copertine, immagini, estratti dai testi, ecc.).
242
Allegato - Alcuni esempi di eccellenze del sistema culturale e creativo fiorentino
POLIMODA
www.polimoda.com
CENNI STORICI
Polimoda un centro di formazione per il settore Moda, riconosciuto tra le migliori Fashion School europee. Con sede a Firenze presso Villa Strozzi, Polimoda nato nel 1986 da uniniziativa progettata e finanziata dai Comuni di Firenze e Prato, dalle associazioni imprenditoriali e in collaborazione con il Fashion Institute of Technology (FIT) di New York. Dal marzo 2006 ne Presidente Ferruccio Ferragamo, presidente dellomonima multinazionale, e il progetto di sviluppo dellIstituto stato affidato, dal gennaio 2007, al Direttore Linda Loppa, gi fondatrice della celebre Scuola di Anversa.
PRINCIPALI ATTIVIT ED ECCELLENZE DELLENTE
LIstituto offre unampia offerta formativa che, attraverso corsi preparatori, post diploma e master, copre tutti i profili del settore moda, dal design, al marketing, al management, alla comunicazione. Il confronto con le aziende permette di rispondere prontamente ed efficacemente alle esigenze professionali del mercato e, di conseguenza, di creare professionisti pronti per linserimento nel mondo del lavoro. Radicato nel cuore della produzione moda italiana, infatti, Polimoda in costante contatto con il mondo delle imprese e, anche grazie allorganizzazione di stage a completamento dei percorsi di formazione, al termine degli studi gli studenti trovano facilmente impiego in aziende di chiaro prestigio internazionale, quali per esempio Ferragamo, Gucci, La Perla, La Rinascente, Patrizia Pepe, Tods, e molte altre. Oltre 1.000 studenti ogni anno (50% dei quali stranieri provenienti da tutto il mondo) e il 90% di studenti che trovano lavoro entro 6 mesi: sono i numeri dellIstituto, che sottolineano il successo di una formula didattica che permette di formare tutti i profili di cui il sistema moda ha bisogno, grazie anche ad un corpo docenti dalle prestigiose esperienze aziendali ed alla flessibilit dellofferta formativa per rispondere efficacemente alle evoluzioni del mercato.
243
Leconomia dei beni culturali e ambientali.
Una visione sistemica e integrata
SYRACUSE UNIVERSITY IN FLORENCE (SUF)
www.syr.fi.it
CENNI STORICI
La Syracuse University stata una delle prime universit americane ad avere un programma di studi allestero. Leducazione allestero rappresenta per questuniversit una tradizione di lunga data: era il 1959 quando i primi 30 studenti della Syracuse University giunsero da New York in nave per studiare a Firenze presso la palazzina di Villa Rossa, acquistata dallateneo statunitense come sede del programma fiorentino dellistituto. Linnovativo programma di studio presso la Syracuse University in Florence (SUF) funzion: gli studenti imparavano il linguaggio in loco e il programma divenne il modello di riferimento per le altre filiali estere dellateneo. Oltre a Firenze, le altri sedi dei programmi internazionali della Syracuse University si trovano a Hong Kong, Londra, Madrid, Pechino, Santiago del Cile e Strasburgo. Nuovi centri in Africa sono in fase di sviluppo. Inoltre, attraverso partnership internazionali, programmi estivi o corsi intensivi, gli studenti hanno la possibilit di studiare allestero in altri 20 Paesi.
PRINCIPALI ATTIVIT ED ECCELLENZE DELLENTE
Nel corso degli ultimi cinquantanni, il SUF cresciuto e si evoluto mantenendo per gli stessi obiettivi degli inizi: lapprofondimento da parte dei suoi studenti dellarte e della societ italiana e la creazione di un solido rapporto interculturale con la citt che lo ospita. Oggi la Syracuse University in Florence conta circa 300 studenti per semestre provenienti da pi di 80 universit e ha cinque dipartimenti: Storia dellArte, Architettura, Lettere, Scienze politiche ed economiche, Italiano. Oltre ai corsi regolari, agli studenti viene offerta unampia variet di visite guidate - a Firenze e nel resto dItalia - e lopportunit di lavorare e studiare fuori dal campus per ampliare la conoscenza della nostra cultura e i contatti con gli italiani. La Villa Rossa, che sempre stata ledificio principale del campus fiorentino, oggi ospita gli uffici amministrativi, alcune aule, un bar e un computer lab. Negli anni Ottanta si sono aggiunti gli studi di architettura ed arte di Piazzale Donatello e, nel 2006, il Villino, che accoglie la biblioteca, il media lab, alcune aule e gli uffici di facolt.
244
Allegato - Alcuni esempi di eccellenze del sistema culturale e creativo fiorentino
SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHEOLOGICI DELLA TOSCANA
www.archeotoscana.beniculturali.it
CENNI STORICI
La Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana, stata istituita, insieme alle altre principali soprintendenze, con legge n. 386 del 27 giugno 1907, come Soprintendenza alle Antichit dellEtruria e dellUmbria, nellambito di una vasta opera di razionalizzazione della tutela del patrimonio dei beni culturali e ambientali che nel 1939 port alla promulgazione delle due fondamentali leggi di tutela, la n.1089 Tutela delle cose dinteresse Artistico o Storico per i beni archeologici e storico-artistici e la n.1497 Protezione delle bellezze naturali per i beni architettonici e paesaggistici. Oggi, il compito istituzionale della Soprintendenza concerne tutta la regione Toscana, a differenza delle altre Soprintendenze ai Beni Artistici e Storici nella regione, che hanno competenze provinciali e, in alcuni casi, miste. La Soprintendenza ha competenza diretta nella gestione di quattro Musei Archeologici Nazionali, quello di Firenze (le cui collezioni, sia etrusca, greca e italica, che egiziana, iniziarono per volont dei Granduchi di Toscana), quello di Chiusi (con splendide raccolte etrusche), quello di Arezzo (ospitato nellAnfiteatro Romano) e lAntiquarium di Cosa (attiguo allarea archeologica), oltre alla titolarit con conseguente competenza scientifica del Museo Archeologico Nazionale di Siena. Lattivit istituzionale prioritaria quella di effettuare direttamente o sovrintendere a tutti gli scavi archeologici e programmare o autorizzare tutte le ricerche archeologiche sul terreno, nonch controllare tutte le scoperte pianificate o fortuite sul territorio. Avendo, dunque, competenza sul Patrimonio Archeologico di propriet dello Stato - cio tutto quanto stato rinvenuto a partire dallistituzione delle prime leggi di tutela (1909) ad oggi - la Soprintendenza tenuta a vigilare sullistituzione e sulla gestione di musei provinciali, civici o privati che espongano o richiedano di acquisire, per mostre permanenti o temporanee, materiale proveniente da scavi recenti. Fra i principali si ricordano il Museo Guarnacci di Volterra, il Museo Etrusco di Cortona, il Museo Civico di Grosseto, il Museo Civico di Fiesole.
PRINCIPALI ATTIVIT ED ECCELLENZE DELLENTE
Lampiezza dei compiti istituzionali della Sovrintendenza ingente, sia per la vastit del territorio regionale che per lestensione cronologica e tipologica del patrimonio da tutelare, che va dalla paleontologia allarcheologia tradizionalmente la competenza specifica viene fatta terminare con la caduta dellImpero Romano dOccidente ma, in realt, non vi sono limiti cronologici allattivit prioritaria di scavo, in quanto implica la tutela di quanto si trovi sotto terra, che di propriet dello Stato. Dunque, la prassi prevede che la Soprintendenza sia responsabile degli scavi e del corretto recupero dei materiali rinvenuti, che vengono poi, di comune accordo con le altre Soprintendenze eventualmente competenti per epoca, restaurati e destinati allesposizione o al deposito qualora si tratti di Medioevo o Et Moderna e Contemporanea. Se invece si tratta di reperti archeologici, la Soprintendenza direttamente responsabile di un grande Centro di Restauro Archeologico, ampliatosi a livello internazionale per le imprese di altissimo livello realizzate successivamente allalluvione di Firenze nel 1966: il restauro del Bronzi di Riace, dei Bronzi di Cartoceto, del Sarcofago degli Sposi al Louvre e, recentemente, del Sarcofago delle Amazzoni, della Minerva dArezzo, dellArringatore, ecc.. Collegato al Centro di Restauro il Laboratorio di Bioarcheologia, che si occupa del recupero sul terreno, del restauro e dello studio di reperti osteologici umani ed animali di tutte le epoche. Altro importantissimo settore afferente al restauro il Centro di Restauro del Legno Bagnato, sorto in funzione del Cantiere delle Navi di Pisa e sviluppatosi ora con vita propria nellambito delle sperimentazioni ed applicazioni delle pi avanzate tecniche di restauro di reperti rimasti a lungo sommersi ed attaccati da microrganismi e salsedine. Al Cantiere delle Navi di Pisa affidato il compito dellallestimento del Museo delle Navi di Pisa che in corso di sistemazione negli antichi Arsenali Medicei pisani. La funzione di tutela del territorio non si limita, naturalmente, allarcheologia preventiva, ma anche alla cura di aree e monumenti archeologici scavati da tempo e continuamente sorvegliati per una corretta apertura al pubblico. Fra le principali si ricordano le grandi citt e necropoli etrusche di Roselle, Vetulonia, Populonia, i tumuli di Montefortini e la Montagnola di Sesto Fiorentino, il Melone del Sodo 1 e 2 a Cortona, il Lago dellAccesa a Massa Marittima, ecc.. La maggior parte di questi siti curata direttamente dalla Soprintendenza che vi effettua scavi, restauri e manutenzioni stagionali, in altri la collaborazione con gli Enti Locali ha portato ad affidamenti ai fini di una gestione ed una valorizzazione sempre pi efficaci e proiettati verso la migliore conservazione delle strutture coniugata con il godimento del pubblico. La competenza della Soprintendenza si estende alle aree subacquee marine e alle acque interne, dove un gruppo specializzato, diretto da un archeologo e di cui fanno parte tecnici subacquei di varia specializzazione, effettua e controlla scavi e recuperi subacquei, recentemente anche sperimentando anche parchi e luoghi di visita subacquei; in questa attivit da sottolineare la collaborazione dei corpi specializzati delle Forze dellOrdine (Carabinieri, Vigili del Fuoco, Capitanerie di Porto, Guardia di Finanza, ecc.).
245
Leconomia dei beni culturali e ambientali.
Una visione sistemica e integrata
SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI, PAESAGGISTICI, STORICI, ARTISTICI ED ETNOANTROPOLOGICI PER LE PROVINCE DI FIRENZE, PISTOIA E PRATO
www.sbap-fi.beniculturali.it
CENNI STORICI
La Soprintendenza per i Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici per le province di Firenze (con esclusione della citt, per le competenze sul patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico), Pistoia e Prato un organo periferico del Ministero per i Beni e le Attivit Culturali (MiBAC), che ha il compito istituzionale di tutelare il patrimonio nellambito del territorio di competenza e di cooperare con la Regione e gli enti territoriali per la sua valorizzazione. Tale attivit esercitata ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 42/2004) sul patrimonio dichiarato dinteresse culturale (cio vincolato, compresi i parchi e i giardini storici) di propriet dello Stato, delle regioni, di enti e distituti pubblici, nonch di persone giuridiche private senza fine di lucro. Nellambito di quanto previsto dallo stesso Codice, la Soprintendenza svolge, inoltre, attivit di controllo e vigilanza sui beni culturali di propriet privata riconosciuti dinteresse artistico o storico, realizzati da oltre 50 anni appartenenti a privati, se dichiarati di interesse culturale e, pertanto, notificati in forma amministrativa ai proprietari tramite Decreto del Direttore Regionale. In quanto istituzione periferica del Ministero, la Soprintendenza ununit radicata nel territorio ed esplica la propria azione di tutela sul bene culturale attraverso ladozione di misure atte ad evitarne il degrado, nonch mediante lattivit di ricerca scientifica e lindividuazione e catalogazione di beni. Essa articolata in una serie di uffici che costituiscono i settori chiave dellattivit scientifica finalizzata, oltre che a specifiche azioni di tutela, anche a soddisfare le richieste dellutenza esterna e a favorire la fruizione del bene pubblico.
PRINCIPALI ATTIVIT ED ECCELLENZE DELLENTE
La gamma di attivit della Soprintendenza abbraccia svariati aspetti: dallapprovazione di progetti di restauro, agli interventi conservativi effettuati con fondi statali, allalta sorveglianza su interventi di conservazione e di restauro di beni mobili e immobili di propriet privata dichiarati dinteresse culturale, alla catalogazione, quale strumento di tutela basilare per la conoscenza e la conservazione del patrimonio, alla notifica di dichiarazione dinteresse culturale. Rientra tra i compiti della Soprintendenza, ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, anche la valorizzazione, effettuata sia attraverso la promozione di iniziative espositive, pubblicazioni, presentazione di restauri, convegni ed eventi culturali, sia tramite lattivit del Servizio Educativo con interventi rivolti alla valorizzazione del bene culturale come fattore di crescita del Paese, e alleducazione al patrimonio artistico come momento formativo nella crescita dellindividuo. Linserimento dellaspetto etnoantropologico nelle competenze della Soprintendenza, inoltre, indicativo di una rinnovata attenzione al valore storico di manufatti artistici ed artigianali, ma anche alle tradizioni popolari, significativi, entrambi, per la documentazione della vita e dellidentit della collettivit, in quanto espressione dellevolvere delle capacit umane e dei traguardi raggiunti nelle varie espressioni etnoantropologiche. Il territorio tutelato dalla Soprintendenza presenta, nelle citt capoluogo di provincia, una straordinaria concentrazione di testimonianze storiche e artistiche, in modo particolare a Firenze, il cui centro storico, segnato dalle presenze della cattedrale di Santa Maria del Fiore, di Palazzo Vecchio, delle basiliche di Santa Croce e di Santa Maria Novella, cos come dai non meno importanti Palazzo Pitti (sede della Soprintendenza), Palazzo Medici Riccardi e degli Uffizi, stato dal 1982 dichiarato dallUNESCO patrimonio dellUmanit. Tuttavia, nonostante la grandiosit dei monumenti fondati da Arnolfo e la misura delle architetture brunelleschiane e albertiane, molte altre citt italiane potrebbero essere citate per contesti urbani di uguale importanza e per la ricchezza delle tipologie esemplificate. Ci che in realt rende unico il territorio il paesaggio antropizzato e stratificato che si estende oltre questi centri. Pur in assenza di eccezionali bellezze naturali, ci che qui colpisce , infatti, lintreccio, fitto e singolare, della campagna e della montagna con le colture, la viabilit e gli edifici che la costellano, tanto che non fosse per alcuni casi in cui il disordinato crescere delle citt nel corso del Novecento ha provocato irreparabili fratture le citt sembrano proseguire senza soluzione di continuit nel contado, e viceversa. Analogamente, per quanto concerne laspetto storico-artistico, la prolungata diffusione di documenti darte figurativa dallAlto Medioevo ai giorni nostri, soprattutto nellambito religioso, ha permesso in ogni centro del territorio lo stratificarsi di documenti darte di notevole rilevanza. Si estende, infatti, in queste zone, una rete di piccoli musei darte sacra che raccolgono comunque esempi anche di vertice dellespressione artistica, sia nella provincia del capoluogo, sia in quelle di Pistoia e Prato. Il museo darte sacra , in realt, una necessit per la difesa di opere darte a rischio di dispersione o perdita, ma anche lo specchio di una rete fittissima di produzione figurativa di carattere religioso che identifica la totalit del nostro territorio. Ognuno di questi musei, nel suo specifico carattere, testimonianza di storie locali che esigono di essere preservate come segno distintivo di ogni comunit e la Soprintendenza, consapevole della straordinaria ricchezza del territorio di competenza, impegnata a salvaguardarne lidentit, sollecitando e incoraggiando ogni forma di utile collaborazione con le realt amministrative locali.
246
Allegato - Alcuni esempi di eccellenze del sistema culturale e creativo fiorentino
TARGETTI
www.targetti.it
CENNI STORICI
Il Cenacolo di Leonardo da Vinci, il David e i Prigioni di Michelangelo, la cattedrale di Ntre Dame a Parigi e quella di Reims, il Duomo di Catania e quello di Pisa, la Cappella Bardi di Vernio a Firenze, i chiostri di Santa Chiara a Napoli, piazza San Marco a Venezia, il Palazzo delle Papesse a Siena, lAccademia di Francia a Roma, lOpera di Vienna e quella di Singapore, la Domus Aurea, la National Gallery di Lubiana, il Museo del Cinema di Torino, il Museo Nazionale Romano: sono solo alcuni dei moltissimi interventi di eccellenza nellambito del patrimonio culturale firmati da TARGETTI, lazienda fiorentina nata nel 1928 da un piccolo negozio di lampadari e cresciuta fino a diventare il terzo player europeo nel settore dellilluminazione architettonica di interni ed esterni.
PRINCIPALI ATTIVIT ED ECCELLENZE DELLAZIENDA
Grazie a un costante investimento in ricerca e sviluppo, a una connaturata passione per larte e a un profondo senso di responsabilit sociale dellimpresa, TARGETTI impegnata da oltre trentanni nellideazione di soluzioni estremamente innovative destinate ad assicurare ai beni di pregio storico e artistico una regia illuminotecnica che coniughi in una sintesi efficace le esigenze della conservazione e quelle della fruizione. Spostando lattenzione dal prodotto illuminante al progetto della luce, i tecnici dellazienda affrontano le sfide spesso complicatissime che lilluminazione dei capolavori (e, in generale, quella del mondo dei beni culturali e del patrimonio paesaggistico) impone lavorando sempre in stretta sinergia con i professionisti preposti alla tutela dei beni artistici: si stabiliscono in tal modo fitte reti di conoscenze e competenze che tengono conto di una molteplicit di discipline. Proprio partendo dalla consapevolezza di questa complessit e della necessit di sviluppare una profonda cultura della luce, nel 1998 TARGETTI ha creato una fondazione (la Fondazione Targetti), che opera come una vera e propria factory della luce in cui si opera allinsegna della sperimentazione interdisciplinare di impronta marcatamente culturale. Cuore delle attivit della Fondazione il programma didattico Lighting Academy, nato per fornire conoscenze specialistiche in ambito illuminotecnico (con corsi dedicati in particolare allilluminazione del patrimonio storico-artistico) e divenuto il punto di riferimento a livello internazionale per i nuovi professionisti del mondo della luce. Affiancano le attivit formative due iniziative orientate alla ricerca: la Targetti Light Art Collection (una collezione di opere darte contemporanea realizzate da artisti affermati e giovani talenti emergenti per indagare il potenziale emotivo del fattore-luce) e lOsservatorio sullArchitettura (un ciclo di incontri e dibattiti con i pi autorevoli protagonisti del pensiero architettonico contemporaneo a cui hanno partecipato, tra gli altri, Yona Friedman, Norman Foster, Bernard Tschumi, Peter Eisenman, Vito Acconti e Alvaro Siza). Questo continuo aggiornamento culturale, unito a un rilevante investimento legato allinnovazione tecnologica e dei processi produttivi, ha permesso allazienda di proporsi come un interlocutore qualificato, capace di condividere con i responsabili del patrimonio storico-artistico un linguaggio comune che si traduce non soltanto nella soddisfazione dellesigenza di una buona illuminazione in termini funzionali, ma anche nello sviluppo di progetti integrati e in partnership di lunga durata. Due esempi significativi di questo approccio sono costituiti dallilluminazione realizzata nel 1985 per il David di Michelangelo (continuamente rinnovata e adeguata sulla base delle nuove tecnologie di progettazione e gestione della luce) e dal pi recente intervento realizzato, quello sulla Cappella di Eleonora di Agnolo Bronzino a Palazzo Vecchio, a cui nuovissimi apparecchi appena sviluppati dal Dipartimento Ricerca e Sviluppo dellazienda assicurano una resa del colore dei dipinti assolutamente straordinaria.
247
Leconomia dei beni culturali e ambientali.
Una visione sistemica e integrata
TEATRO DEL MAGGIO MUSICALE FIORENTINO
www.maggiofiorentino.com
CENNI STORICI
Il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino una delle pi prestigiose Fondazioni lirico-sinfoniche in Italia e fra i pi importanti teatri dEuropa. Sede principale il Teatro Comunale (oltre 2000 posti), cui si affiancano il Piccolo Teatro, posto allinterno dello stesso edificio, e il Teatro Goldoni, gioiello lorenese nei pressi di Palazzo Pitti recentemente restaurato; attualmente in costruzione sulla riva dellArno, nel secolare Parco delle Cascine, il Nuovo Teatro Parco della Musica, con due sale da 1.800 e 1.200 posti, e una cavea allaperto da 2.000 posti, che verr inaugurato il 21 dicembre 2011 in occasione delle celebrazioni per il 150 anniversario dellUnit dItalia, e che diverr certamente la pi attraente novit culturale della Firenze contemporanea. La sua natura giuridica oggi quella di una Fondazione di diritto privato, cui partecipano e contribuiscono sia soggetti pubblici come lo Stato Italiano, il Comune di Firenze e la Regione Toscana, che soggetti privati, dalle principali istituzioni bancarie e gruppi economici alle pi celebri griffe della moda italiana, ma anche centinaia di semplici cittadini e appassionati (fra cui, caso unico in Italia, gli stessi dipendenti), che sostengono il loro Teatro per garantirsi non solo benefit ma, soprattutto, la certezza di applaudire ogni volta gli spettacoli e le interpretazioni migliori della scena internazionale.
PRINCIPALI ATTIVIT ED ECCELLENZE DELLENTE
Lattivit del Teatro si articola durante tutto larco dellanno in una lunga ed intensa Stagione di opere, balletti e concerti. Nellambito dellattivit del Teatro, si inserisce il Festival del Maggio Musicale Fiorentino, il pi antico festival musicale italiano, fondato nel 1933, punto di riferimento internazionale sia per il grande repertorio sia per la produzione contemporanea, che ha luogo ogni anno nei mesi di maggio e giugno. Da venticinque anni la Direzione Principale affidata a Zubin Mehta, Maestro di fama mondiale che ha plasmato lOrchestra, fondata nel 1928 da Vittorio Gui, siglando molte fra le pi importanti produzioni e guidando il Teatro con i suoi complessi in tutte le principali tourne allestero, come la straordinaria impresa della Turandot nella Citt Proibita a Pechino nel 1998 e quelle che, nel 2011, la vedranno nuovamente protagonista in Oriente, in Cina come in Giappone e in India. Con la sua grande Orchestra sinfonica, il Coro lodato dai pi insigni Maestri protagonisti di esecuzioni ed incisioni discografiche anche insieme ad altri complessi italiani e stranieri, la Compagnia stabile di Ballo MaggioDanza, presente in sede come negli altri Teatri italiani, e con addetti allorganizzazione altamente specializzati, il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino una delle maggiori imprese di Firenze e una delle pi grandi aziende culturali dItalia e dEuropa, che cura inoltre progetti formativi di alto perfezionamento rivolti a giovani cantanti e musicisti di diverse nazionalit. I suoi laboratori di scenografia, officine in grado di realizzare le idee pi stupefacenti e visionarie che fanno la magia dello spettacolo, lavorano anche per conto terzi; gli allestimenti che vi si producono sono richiesti dai teatri di tutto il mondo, e frequenti sono le coproduzioni con lestero.
248
Allegato - Alcuni esempi di eccellenze del sistema culturale e creativo fiorentino
UNIVERSIT DEGLI STUDI DI FIRENZE
www.unifi.it
CENNI STORICI
LUniversit di Firenze ha le sue origini nello Studium Generale che la repubblica fiorentina vuole far nascere nel 1321. Vi si insegnano il Diritto (civile e canonico), le Lettere e la Medicina. Nel 1364 lo Studium diventa universit imperiale. Con lavvento dei Medici al potere in Toscana, viene esiliato a Pisa. Dal XVI secolo a Firenze ricerche e insegnamenti rimangono vivi nelle numerose Accademie fiorite nel frattempo. Nel 1859 rinasce una struttura unica, lIstituto Superiore di Studi Pratici e di Perfezionamento, che, nello Stato Italiano, avr riconosciuto il carattere universitario. Nel 1923 allIstituto ufficialmente conferita la denominazione di Universit. Oggi lUniversit degli Studi di Firenze una delle pi grandi organizzazioni per la ricerca e la formazione superiore in Italia, con 2.300 docenti e ricercatori strutturati, oltre 1.400 dottorandi di ricerca, 750 assegnisti, quasi 100 ricercatori a tempo determinato, 1.700 tecnici e amministrativi e 60.000 studenti (un quarto dei quali proviene da fuori regione). Sono quasi 9.000 i laureati ogni anno a Firenze ed, inoltre, la percentuale dei laureati fiorentini che lavora, dopo un anno dal conseguimento del titolo triennale, pi alta della media nazionale. A Firenze lUniversit non ha un solo indirizzo: a partire dal centro storico, che fino a pochi decenni fa racchiudeva tutte le sue attivit, oggi lateneo ha presocasa in vari punti della citt, fino a superare il limite dellarea urbana con linsediamento scientifico di Sesto Fiorentino, con le sedi di Scandicci, Empoli e Calenzano, fino ad arrivare alle province di Prato e Pistoia.
PRINCIPALI ATTIVIT ED ECCELLENZE DELLENTE
Lofferta formativa dellUniversit degli Studi di Firenze prevede pi di 150 corsi di laurea (di primo e secondo livello) nelle 12 Facolt dellateneo: Agraria, Architettura, Economia, Farmacia, Giurisprudenza, Ingegneria, Lettere e Filosofia, Medicina e Chirurgia, Psicologia, Scienze della Formazione, Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali e Scienze Politiche. Tra le numerose attivit dei 70 Dipartimenti, delle circa 60 strutture di ricerca tra centri interdipartimentali e interuniversitari e dei 10 centri di ricerca, trasferimento e alta formazione, si possono ricordare, ad esempio, il Master in Multimedia (un corso post-laurea della durata di un anno, che fornisce le conoscenze e gli strumenti necessari per lavorare nel settore dei media digitali con specializzazioni su Interactive Environments - applicazioni per Internet, installazioni multimediali per larte e i beni culturali - e Video post production - computer graphic, effetti speciali e post produzione video) e le attivit del Laboratorio Ultrasuoni e Controlli non distruttivi del Dipartimento di Elettronica e Telecomunicazioni. Lo stesso Dipartimento organizza lannuale Workshop EVA (Electronic Imaging & The Visual Arts), dedicato a tecnologie dellinformazione e arte. Appartiene allUniversit anche il prestigioso Museo di Storia Naturale che, fondato nel 1775 dal Granduca Pietro Leopoldo ma con il nucleo dellOrto Botanico risalente addirittura al 1545, attualmente, con i suoi 8 milioni di esemplari, il pi importante museo naturalistico italiano ed uno dei maggiori a livello internazionale. Articolato in sei sezioni, il Museo ospita reperti di straordinario valore scientifico e naturalistico, coniugando, in maniera mirabile, natura, storia, scienza ed arte. In particolare, La Specola il pi antico museo scientifico dEuropa e contiene la pi grande collezione al mondo di cere anatomiche (eseguite tra il 1770 ed il 1850) ed oltre 3.500.000 di animali (di cui circa 5.000 esposti al pubblico).
249
Leconomia dei beni culturali e ambientali.
Una visione sistemica e integrata
UNIVERSIT INTERNAZIONALE DELLARTE DI FIRENZE (UIA)
www.uiafirenze.com
CENNI STORICI
LUniversit Internazionale dellArte (UIA) opera a Firenze dal 1968 quando Carlo L.Ragghianti, rispondendo con lazione agli effetti della disastrosa alluvione del 1966, volle creare una scuola speciale di levatura universitaria e a vocazione internazionale. LUIA si present subito come un centro propulsivo di incontri sui metodi di ricerca che si sono mantenuti costanti nel tempo contribuendo in modo significativo alla discussione su problemi e prospettive di conservazione e valorizzazione del patrimonio artistico italiano. Attraverso i Centri di Studio, i Laboratori ed i Corsi, lUIA svolge attivit di formazione e di specializzazione di esperti e tecnici che intendono dedicarsi alle funzioni e ai compiti necessari, in ogni Paese, alla conservazione e alla trasmissione dei beni artistici, in un contesto di consapevolezza culturale e sociale. Oggi lUniversit Internazionale dellArte di Firenze conta 120 studenti, di cui il 30% straniero, e 150 docenti. La dimensione delle classi di 10-15 studenti, con una prevalenza femminile e unet media tra i 18 e i 25 anni. Ogni anno si diplomano circa 100-120 studenti. LUIA di Firenze, con Decreto del Presidente della Repubblica n.137 del 29 gennaio 1982, stata riconosciuta come Ente Morale dotato di personalit giuridica. Fa parte, inoltre, delle Istituzioni abilitate a svolgere la formazione professionale ed certificata ai sensi della norma UNI ENI ISO 9001:2008 per la progettazione ed erogazione di servizi di formazione professionale nellambito dei beni culturali e del restauro. Paolo Giannarelli e Francesco Gurrieri sono rispettivamente il Presidente e il Preside dellUIA. Il Comitato Scientifico dellIstituto riunisce alcune tra le migliori personalit del settore culturale ed accademico toscano ed italiano.
PRINCIPALI ATTIVIT ED ECCELLENZE DELLENTE
LUIA ha promosso, partecipandovi, programmi europei sulla costituzione di metodi e piani-pilota sulla salvaguardia dei beni culturali. Su queste linee, fedele ai principi e agli scopi per i quali fu fondata, lUIA continua il proprio lavoro. Si sono programmati centri di studio, laboratori, corsi, seminari specialistici e realizzati congressi nazionali e internazionali. Fra gli eventi pi rilevanti di questo quadro si ricorda fra le numerose iniziative il restauro del Giardino Dipinto della Casa del Bracciale dOro a Pompei, il restauro delle Cappelle affrescate nella Basilica della SS.Annunziata a Firenze, le indagini diagnostiche e conoscitive sui dipinti di Leonardo alla Galleria degli Uffizi a Firenze. Le lezioni si svolgono nei termini di un dialogo personale e continuo fra docenti e studenti. Alle lezioni teoriche, inoltre, si avvicendano sopralluoghi, visite tecniche, esercitazioni, seminari e lezioni operative in laboratori e cantieri specializzati per il restauro di dipinti e delle pitture murali, in accordo con gli Enti e le Soprintendenza fiorentine. LUIA dotata di una Biblioteca che contiene 10.000 libri, cataloghi e giornali.
250
Allegato - Alcuni esempi di eccellenze del sistema culturale e creativo fiorentino
251
Potrebbero piacerti anche
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeDa EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeValutazione: 4.5 su 5 stelle4.5/5 (20001)
- Pride and Prejudice: Bestsellers and famous BooksDa EverandPride and Prejudice: Bestsellers and famous BooksValutazione: 4.5 su 5 stelle4.5/5 (19653)
- American Gods: The Tenth Anniversary EditionDa EverandAmerican Gods: The Tenth Anniversary EditionValutazione: 4 su 5 stelle4/5 (12942)
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeDa EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeValutazione: 4 su 5 stelle4/5 (5794)
- The 7 Habits of Highly Effective People: The Infographics EditionDa EverandThe 7 Habits of Highly Effective People: The Infographics EditionValutazione: 4 su 5 stelle4/5 (2475)
- Art of War: The Definitive Interpretation of Sun Tzu's Classic Book of StrategyDa EverandArt of War: The Definitive Interpretation of Sun Tzu's Classic Book of StrategyValutazione: 4 su 5 stelle4/5 (3321)
- Habit 6 Synergize: The Habit of Creative CooperationDa EverandHabit 6 Synergize: The Habit of Creative CooperationValutazione: 4 su 5 stelle4/5 (2499)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItDa EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItValutazione: 4.5 su 5 stelle4.5/5 (3269)
- Habit 3 Put First Things First: The Habit of Integrity and ExecutionDa EverandHabit 3 Put First Things First: The Habit of Integrity and ExecutionValutazione: 4 su 5 stelle4/5 (2506)
- How To Win Friends And Influence PeopleDa EverandHow To Win Friends And Influence PeopleValutazione: 4.5 su 5 stelle4.5/5 (6508)
- The 7 Habits of Highly Effective PeopleDa EverandThe 7 Habits of Highly Effective PeopleValutazione: 4 su 5 stelle4/5 (2564)
- The 7 Habits of Highly Effective PeopleDa EverandThe 7 Habits of Highly Effective PeopleValutazione: 4 su 5 stelle4/5 (353)
- Wuthering Heights (Seasons Edition -- Winter)Da EverandWuthering Heights (Seasons Edition -- Winter)Valutazione: 4 su 5 stelle4/5 (9486)
- The Covenant of Water (Oprah's Book Club)Da EverandThe Covenant of Water (Oprah's Book Club)Valutazione: 4.5 su 5 stelle4.5/5 (517)
- The Iliad: A New Translation by Caroline AlexanderDa EverandThe Iliad: A New Translation by Caroline AlexanderValutazione: 4 su 5 stelle4/5 (5700)
- The Perfect Marriage: A Completely Gripping Psychological SuspenseDa EverandThe Perfect Marriage: A Completely Gripping Psychological SuspenseValutazione: 4 su 5 stelle4/5 (1105)
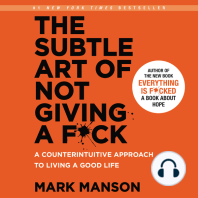

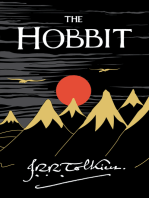










![American Gods [TV Tie-In]: A Novel](https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/audiobook_square_badge/626321117/198x198/22ab6b48b6/1712683119?v=1)











