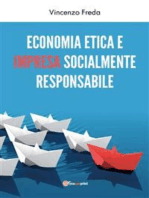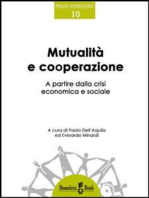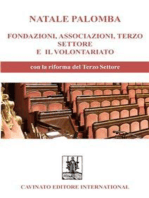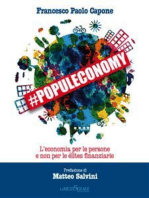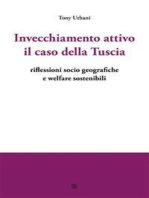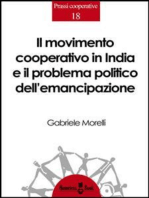Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
Riassunto Cap 18 Economia e Societa Corso Di Sociologia III Organizzazione Sociale Popolazione e Territorio
Caricato da
maria verliniTitolo originale
Copyright
Formati disponibili
Condividi questo documento
Condividi o incorpora il documento
Hai trovato utile questo documento?
Questo contenuto è inappropriato?
Segnala questo documentoCopyright:
Formati disponibili
Riassunto Cap 18 Economia e Societa Corso Di Sociologia III Organizzazione Sociale Popolazione e Territorio
Caricato da
maria verliniCopyright:
Formati disponibili
lOMoARcPSD|2185348
Riassunto Cap. 18 - Economia e Società - Corso di
Sociologia III Organizzazione sociale popolazione e territorio
L'agire economico in rete (Università degli Studi di Napoli Federico II)
StuDocu non è sponsorizzato o supportato da nessuna università o ateneo.
Scaricato da maria verlini (maria.verlini@studenti.unisob.na.it)
lOMoARcPSD|2185348
C orso d iS ociolog ia
O rg anizzazione sociale,p op olazione e territorio
C ap itolo 1
Econom ia e società
Q uesto capitolo analizza ilposto della attività econom iche nella società.Passando perle
econom ie pre-industriali,siarriverà a parlare delm ondo contem poraneo in cuil’econom ia è un
sistem a specializzato,autoregolato dalm ercato.N on tutta l’econom ia però è regolata dal
m ercato,e a volte richiede condizioniculturalie politiche.
L’uom o ha deibisognida soddisfare pervivere e spesso distinguiam o le società in base a com e
affrontano questiproblem i.A ndrem o ad analizzare lo studio sistem atico delle attività
econom iche,scoprendo com e trovano un posto all’interno della società e trovando una
definizione dieconom ia adatta all’analisisociologica.N eicapitolisuccessiviandrem o nello
specifico analizzando lavoro,produzione e consum o,con riferim ento alle società sviluppate.
1.In cerca d iuna d efinizione d ieconom ia
Potrem m o intendere con econom ia l’insiem e delle attività orientate alla produzione,alla
distribuzione dibenio serviziperla sussistenza dell’uom o,m a non è così.O ggile cose che
consideriam o necessarie perla vita sono cam biate,e variano in base alpaese e alla cultura.N on
siparla più solo dicibo,m a anche diabiti,attività e necessità dispostarsie sussistenza diventa
una parola che viene usata perlo più perindicare condizionim inim e disopravvivenza in paesi
sottosviluppati.Ilfatto che ibisognicam biano cipone nella giusta prospettiva perprecisare in
significato dieconom ia.A d esem pio,vestirsinon è solo un bisogno fisico peraffrontare ilfreddo
m a rappresenta anche una funzione sociale,com e nelcaso dim ilitari.In sostanza,ilvero bisogno
divestirsirisulta solo un lato delfenom eno che ha altriscopie funzioni.
Inoltre,osserviam o che non solo le attività orientate alla sussistenza hanno aspettinon
econom ici,m a che anche nelle azioninon econom iche sideve tener conto deim ezzim ateriali
necessariperrealizzarle.A d esem pio,un gioco fra ragazziha com unque un aspetto econom ico,
ovvero l’acquisto delpallone.
Q uindicos’è l’econom ia? A bbiam o d ue definizioni:
U na definizione sostanziale,che definisce q uell’aspetto d iog niattività,
org anizzazione o istituzione che rig uard a p rocurare m ezzim aterialiper ifiniche ci
siprop one.
U na definizione form ale che considera l’econom ia un insiem e diattività e organizzazioni
che producono benie servizie lidistribuiscono aiconsum atoriattraverso scam bidi
m ercato (denaro com e m ezzo).In questa concezione sicom prendono infinite attività
purché abbiano a che fare con ilm ercato.
Q uest’ultim o punto divista è quello adottato daglieconom isti,che individuano anche un m odo
tipico dicom portam ento delm ercato,delineando ilcom portam ento razionale:im piego di
risorse solitam ente scarse,orientate alla m assim izzazione dell’utilità individuale.
M a esistono anche società che non conoscono ilm ercato,che non agiscono in term inidi
razionalità econom ica m a secondo tradizione,senza porsiilproblem a ditrovare m odim eno
costosio distribuire m eglio le risorse perm igliorare le proprie condizioni.
Scaricato da maria verlini (maria.verlini@studenti.unisob.na.it)
lOMoARcPSD|2185348
N on potendo applicare la razionalità econom ica in questicasisiricorre ad un punto divista
sostanziale.Le ricerche m ostrano infatticom portam entieconom iciche possono apparire strani
dalnostro punto divista.A d esem pio la pratica delp otlach praticata da una tribù diindiani
d’am erica,che consiste nell’accum ulare con sacrificio grandiquantità dibenicolsolo scopo di
donarliad altre fam iglie,che dovranno poiricam biare in quantità m aggiore.Q uello che cipuò
sem brare un com portam ento irrazionale acquista senso se consideriam o che questa pratica era
una specie digara dove chinon riusciva a ricam biare ildono riconosceva a chiglielo aveva
offerto una posizione sociale superiore.
Ilpunto divista form ale sipresta dunque a definire l’econom ia contem poranea,m a risulta inutile
percom prendere econom ie precedenti.S ideve però considerare che nelle società
contem poranee la produzione dicertibenio servizipuò avvenire anche non in riferim ento al
m ercato,ad esem pio preferendo dim angiare da un am ico piuttosto che pagare un pasto al
ristorante,e in questo caso citorna dinuovo utile ilpunto divista sostanziale.
In conclusione,oltre che facendo attenzione a definire l’econom ia in base a questicasisopra
elencati,ilnostro fine in quanto sociologisarà quello divedere com e l’econom ia e la sua
organizzazione sono com patibili,accettatio m eno all’interno della società.
2 .Ilp osto d ell’econom ia nella società
N el18 ° S ecolo parte in Inghilterra e sisviluppa in tutta Europa la rivoluzione industriale,un evento
cosìim portante da farconsiderare tutte le econom ie precedentipreindustriali,una
sem plificazione che ha un suo significato poiché la produttività era ridotta e una parte del
prodotto era destinata all’autoconsum o.U n'agricoltura efficiente e che produce un surplus perla
sussistenza dichinon lavora neicam piè la condizione fondam entale peruna società più
com plessa con istituzionie ruolispecializzati.A nche la com parsa diistituzionie organizzazioni
econom iche è un aspetto delprocesso did ifferenziazione strutturale.S ignifica che nelle
econom ie preindustrialinon sono m aideltutto distinguibilida altritipidirelazionisociali.
Le società hanno affrontato in m odo diverso iloro bisognie organizzato in altrettantim odile loro
risorse,m a sipossono individuare solo 3 m odidiintegrazione dell'econom ia,ovvero sistem idi
regole secondo cuinella società conosciute illavoro,le risorse e iprodottisono distribuitie
destinatiad attività diproduzione e consum o:recip rocità,red istrib uzione e scam b io d i
m ercato [Polanyi].A ll'interno diuna società com plessa la com binazione diquestim odiè da
considerare norm a.
R ecip rocità
Per reciprocità siintende la prestazione diservizio la cessione dibenicon la previsione di
riceverliin cam bio in quantità,m odie tem pifissatida norm e culturali.A bbiam o due tipidi
reciprocità.
La recip rocità generalizzata non ha contenutiprecisi,lim itiditem po e non richiede che ciò che
viene restituito abbia lo stesso valore.A d esem pio,diquesto tipo sono irapportiall'interno della
fam iglia,dove sida e siriceve in m odo com pletam ente disinteressato.
La recip rocità b ilanciata riguarda relazioniall'esterno della fam iglia,ad esem pio tra la parentela
o altre fam iglia della stessa com unità.Q uilo scam bio prevede una restituzione equivalente in
valore e in tem pidefiniti.A d esem pio,una festa alla quale siinvitano iviciniin occasione
dell'uccisione dianim alio lo scam bio dilavoro fra fam iglie contadine.
Scaricato da maria verlini (maria.verlini@studenti.unisob.na.it)
lOMoARcPSD|2185348
Q uestidue tipidireciprocità sono accom unatidalfatto che sitratta direlazioniregolate da norm e
m orali,che hanno sìun contenuto econom ico m a è incap sulato all'interno direlazionisociali
dalle qualinon può essere separato.Inoltre,l'attesa della restituzione e l'essere tenuto a
restituire m antiene aperta la relazione fra le persone,creando aspettative e rafforzando le
relazionisociali.
A lcontrario,chinon rispetta la reciprocità nella fam iglia è disprezzato e ilnon rispetto della
reciprocità bilanciata produce la rottura della relazione.N ella società a econom ia d irecip rocità
non esistono organizzazionieconom iche separate dalla fam iglia e la posizione all'interno di
quest'ultim a definisce anche la posizione nelprocesso produttivo,regolato dalcapofam iglia.G li
scam bie la cooperazione avvengono all'interno dilegam istabilineltem po e m aisolo econom ici.
A d esem pio,ilterm ine trescare,deriva dall'antico tedesco dove significava “battere ilgrano”,
poiché in tale occasione igiovanisiincontravano e sicom binavano m atrim oni.Fino alla
com parsa disocietà agrarie com plesse e differenziate,la reciprocità è stato ilm etodo di
integrazione dell'econom ia,poisiè conservato com binato aglialtri,cosa che possiam o
constatare tutt'oggiosservando la fam iglia.Icasidipura econom ia direciprocità sono rarie
presentisono ilalcune tribù,questo è ilm otivo percuisono m aggiorm ente gliantropologiad
occuparsene,com e nelcaso dell'A nello d iK ula:un rituale m illenario che avviene in alcune isole
della N uova G uinea basato sullo scam bio dim onilidiconchiglie.Q uesta pratica consente di
avere benipregiati,m a principalm ente attraverso ilK ula sim antengono irapportifra le
popolazionie sicreano legam idifiducia perilcom m ercio vero e proprio dialtribeni.Le regole
della reciprocità quindicam biano passando da relazionistrette a relazionifra fam iglie o villaggi,
fino ad arrivare a tipidirecip rocità neg ativa,dove atticom e guerra e furtineiconfrontidi
società esterne sono am m essie conferiscono onore.
R ed istrib uzione
La redistribuzione è uno schem a diintegrazione dell'econom ia nella società più com plesso che
prevede un trasferim ento dirisorse e dibenia un centro gestito da un capo tribù o un signore
aiutato da un apparato am m inistrativo che successivam ente esegue una ripartizione fra im em bri
della società.Ilsignore dispone della terra che assegna,esige tributie im pone lavoriperiodici.
M entre ilcontenuto econom ico della reciprocità è incapsulato all'interno dirapportisociali,in
questo caso l'econom ia è regolata da un potere politico centrale,a cuiisudditisono legati,e che
in cam bio offre protezione,servizie organizzazione della società.S pesso,sia in passato che in
epoca m oderna,questo sistem a è legato con altre form e diintegrazione,com e ilm ercato.A l
giorno d'oggipotrem m o dire che riguarda im odiin cuiuno stato regola l'econom ia.L'antico
Egitto rim ane uno degliesem pidieconom ia diredistribuzione,dove parte dellavoro era però
destinato aglischiavi.Ilavoratoriliberiversavano icontributie ricevevano un salario,dicui
spesso barattavano una parte.Inoltre,la redistribuzione richiede una contabilità scritta e precisa,
ed è perquesto che ciè stato possibile ricostruire questim eccanism i.
S cam b io d im ercato
M ercato:un luogo dove sivende e sicom pra.La com pravendita è la cessione diun bene con
valore econom ico (quindiutile e non disponibile liberam ente) da un venditore a un com pratore,in
cam bio didenaro.U n bene com prato e venduto è detto m erce.C hivende non può rim ettercie
chicom pra non può spendere più diquello che ha.A d esem pio,un com m erciante ha com prato la
frutta aim ercatigenerali,rifornitida im prese agricole dove bracciantil'hanno raccolta e hanno
ricevuto un salario e dove le piante erano state fertilizzate con prodotticom pratida un'im presa
Scaricato da maria verlini (maria.verlini@studenti.unisob.na.it)
lOMoARcPSD|2185348
che ha acquistato le m aterie prim e all'estero e cosìvia.Q uindi,l'espressione m ercato,in un
senso più astratto,viene usata anche perindicare l'insiem e diquestirapportie perdefinire un
particolare m eccanism o diregolazione dell'econom ia basato sulla form azione dip rezzivariabilia
seconda della dom anda o dell'offerta.M oneta e prezziperò possono essercianche senza
scam bio dim ercato:un'econom ia diredistribuzione non com binata con lo scam bio dim ercato
può prevedere ilpagam ento delsalario in natura o in denaro,con cuiacquistare benia prezzi
fissatidalsignore e quindinon dalla fluttuazione delm ercato.A nche le econom ie odierne
prevedono benicon prezzifissatidallo stato,dettip rezziam m inistrati,ad esem pio le tariffe per
un servizio pubblico.Lo scam bio dim ercato siè diffuso fino a diventare ilm odo dom inante di
integrazione dell'econom ia nella società sviluppate.V iviam o lavorando in cam bio diun salario
con cuicom priam o ciò dicuiabbiam o bisogno.C on l'afferm azione delm ercato sicom pie la
differenziazione strutturale dell'econom ia:non è più incapsulata nella società m a è autoregolata.
S copriam o com e ilm ercato funziona da m eccanism o regolatore dell'econom ia e qualisono i
caratterigeneraliche ha assunto l'econom ia regolata dalm ercato.
3 .Ilm ercato com e m eccanism o regolatore d ell'econom ia
G lieconom istispiegano con un m odello form ale sem plificato ilm eccanism o attraverso cui
l'econom ia è autoregolata attraverso la form azione diprezzi.Le quantità diuna m erce che
vengono offerte e dom andate sulm ercato variano alvariare delloro prezzo poiché com pratori,
che sicom portano com e attorirazionali,cercheranno dispendere in m odo calcolato.S e una
m erce è cara una persona ne com prerà una piccola quantità e saranno pochia com prarla.A l
contrario se costa poco,una persona sarà disposta a com prarne dipiù,e la dom anda aum enterà.
Possiam o rappresentare questa relazione con una linea d ecrescente in un grafico che porta
sull'asse verticale iprezzie su quella orizzontale le quantità.
D alpunto divista dichivende,è da dire che pochipossono vendere ad un prezzo basso,poiché
ilricavo della vendita deve coprire alm eno le spese diproduzione e non tuttiriescono ad
ottim izzare le proprie risorse alm eglio.G lialtri,che producono a costiprogressivam ente
m aggiori,non possono vendere sotto un certo prezzo che è via via più elevato.L'offerta aum enta
dunque all'aum entare delprezzo e possiam o indicare questa relazione con una linea
ascend ente.
Ilpunto nelquale siincontrano questidue valori(dom anda e offerta) è chiam ato p rezzo d i
eq uilib rio.Ilprezzo diuna m erce tende a fissarsia un livello in cuiquantità prodotta e quantità
richiesta coincidono.S e ilprezzo fosse superiore,una parte dim erce rim arrebbe invenduta
Scaricato da maria verlini (maria.verlini@studenti.unisob.na.it)
lOMoARcPSD|2185348
producendo un calo diprezzo.S e fosse inferiore invece,la m erce disponibile sarebbe venduta a
chipuò pagare dipiù,e ilprezzo salirebbe.S e neltem po la dom anda cresce,iprezzitendono a
salire e ilm ercato suggerirebbe aiproduttoridiprodurre dipiù.A lcontrario,se la dom anda
scende iproduttorisisposteranno su altre m erci.Inoltre,chiproduce deve stare attento a non
fare sprechie ottim izzare le sue risorse.S e non fa cosìilcosto delsuo prodotto sarà superiore a
quello dialtriche invece producono in m odo più efficiente,con iqualinon potrà concorrere.In
questo caso sidice che la concorrenza d im ercato garantisce efficienza econom ica.Il
m ercato è quindiun calcolatore che tram ite iprezzida inform azioniaglioperatorieconom icie
regola l'econom ia.
Per quanto lo schem a sopra riportato rappresentiun m odello ideale e puram ente logico di
m ercato,c'è da tenere presente che purché funzioniperfettam ente devono essere soddisfatte
alcune condizioni:m oltivenditorie com pratori,conoscenza delm ercato da parte ditutti,m erci
equivalenti.Ilm ercato reale spesso siallontana da questirequisitidiventando più com plesso e
richiedendo quindiuno schem a diverso.Tutto questo è stato scoperto nel18 ° secolo,
provocando la m eraviglia distudiosicom e A dam S m ith e la nascita dell'econom ia p olitica
(studio della natura e delle cause della ricchezza delle nazioni) dato che ilm ercato non era
diventato m aicosìgrande da diventare ilregolatore dell'econom ia.
4 .L'econom ia reg olata d alm ercato
Ilcom m ercio regolato dalm ercato ha originiantiche,m entre è più recente la produzione regolata
dalm ercato.Ilcom m ercio ha avuto ruoliim portantinegliim pericentralizzatia econom ia di
distribuzione m a perquanto im portante sia stata questa diffusione,è solo quando anche la
produzione viene organizzata su grande scala in riferm ento alle regole dim ercato che possiam o
parlare dieconom ia regolata dalm ercato.
Q uest'ultim a sibasa sulla proprietà privata deim ezzidiproduzione e sulfatto che illavoro è
fornito perun com penso fissato con una contrattazione dim ercato.Ilcap itale è una som m a di
denaro investita perprodurre o com m erciare,in vista diun p rofitto,calcolato in base alla
tendenza deiprezzidim ercato.S e poichiha realizzato ilprofitto decide direinvestirlo inizia un
processo diaccum ulazione delcapitale e l'econom ia sisviluppa.L'im p rend itore diventa quindi
una fig ura sociale specializzata la cuifunzione è produrre e vendere,m otivata dalprofitto e
indirizzata dalm eccanism o dim ercato.La stessa econom ia lo controlla:a seconda deisuoi
com portam entipuò guadagnare,perdere o fallire.
L'istituzione fondam entale della produzione e delcom m ercio è l'im p resa,distinta dalla fam iglia e
dalla politica:le m ercinon sono prodotte su ordine delle autorità e le quantità e iprezzinon sono
fissati.Le b anche invece sono organizzazioniche operano sulm ercato deldenaro,che un suo
prezzo e può essere prestato a costidiversi.Ilm ercato regola anche la distribuzione dellavoro:
un settore che non trova operaipuò aum entare la paga e l'alto prezzo diun lavoro specializzato
deriva dalbasso num ero dispecialisti,stim olandone la form azione.
L'estensione delm ercato a questiaspettidell'organizzazione della produzione ha influito sulla
società.Le diverse risorse che una persona può offrire alprocesso diproduzione (capitale,
specialità) definiscono la posizione nella società,che nell'econom ia dim ercato è strutturata in
classi.U n sistem a econom ico basato sulla proprietà deim ezzi,la concorrenza fra im prese e sul
lavoro pagato a prezzo dim ercato sichiam a cap italism o.
Scaricato da maria verlini (maria.verlini@studenti.unisob.na.it)
lOMoARcPSD|2185348
In regim e capitalistico,l'econom ia non solo è autoregolata m a rappresenta anche una parte della
società specializzata,con figure sociali,istituzionie form e dicontrollo delle attività.
5 .Ilraccord o fra econom ia d im ercato e società
L'econom ia è diventata un insiem e specializzato diattività e regole dicom portam ento,quindisi
pone ilproblem a delsuo raccordo con ilresto della società. Q uesto può essere considerato in
relazione alrap p orto fra istituzionieconom iche e un sistem a istituzionale com p lessivo
d ella società e agliinterventip oliticid ireg olazione d ell'econom ia.
Econom ia e sistem a istituzionale
D etto in term inisociologici,ilm ercato e l'econom ia sono statiistituzionalizzati.M a i
com portam entiche oggiconsideriam o norm alinon sono da considerare naturali:sono em ersie
statiaccettatilentam ente nelcorso deisecolicom e risultato diuna com plessa elaborazione
culturale e sociale.A questo proposito possiam o ripercorrere la storia dell'istituzionalizzazione
d elcom m ercio.
A ll'epoca della civiltà cretese (20 0 0 – 120 0 A .C .) ilcom m ercio diprodotticom e vino,olio e vasi
era afferm ato,m a nell'Iliade e nell'O dissea possiam o trovare giudizim olto negativisulcom m ercio
e suicom m ercianti.A llora,ilsaccheggio e la guerra erano consideratim odigiustidiarricchirsi.La
professione delm ercante è rim asta a lungo non m olto definita.Perm olto tem po ilcom m ercio non
è stato distinto dalla rapina e dalfurto anche perché chiandava perm are o scam biava m ercio
rubava.N on a caso nella m itologia greca e in quella rom ana,rispettivam ente Erm es e M ercurio
sono protettoridiladrie com m ercianti.Ildisprezzo però sitrasform o in sospetto,cautela e infatti
nella città greche accettarono ilcom m ercio,orm aiindispensabile,m a ad A tene im ercanti
venivano chiam atim eteci,un gradino prim a deglischiavi.N on avevano dirittipolitici,non
potevano possedere terra e subivano altre privazioni.C ontem poraneam ente nascevano le prim e
regole perilcom m ercio.In tuttiipopolitroviam o sim iliprocessi.S ecolidopo,dall'altra parte del
m ondo,ilcom m erciantiaztechifurono descrittidaiconquistatoricom e uom iniobbligatiad
essere um ilie con ricchezze confiscabilinelcaso fossero aum entate troppo.In Europa,verso la
fine delM edioevo icentripiù sviluppatisono le città Italiane e itre più fam osiscrittoridella nostra
letteratura m ostrano com e cam biano gliatteggiam entiverso ilcom m ercio:D ante disprezza i
com m ercianti,Petrarca liignora,B occaccio liconsidera eroialparidicavalieri.È con ilprim o
capitalism o delle città Italiane,all'inizio delR inascim ento,che in Europa ilcom m ercio trova un
posto riconosciuto nella società.Tutte queste resistenze sono da attribuire alfatto che lo
sviluppo delm ercato è parte delp rocesso d im od ernizzazione.Ilm ercato spinge a com binare
le risorse e le relazionifra le persone,in contrapposizione alla staticità deilegam icom unitari.
Inoltre diffonde la razionalità,e chiciopera non sicom porta in m odo diverso in base a chiha
davanti,m a agisce secondo calcoliprecisi.Ilcontratto,ad esem pio,è una tipica relazione di
m ercato.Q uest'ultim o può quindiessere considerato istituzionalizzato e utilizzato com e
regolatore dell'econom ia quando sono istituzionalizzatiivaloridella società m oderna.I
cam biam entihanno trovato resistenza perché siopponevano alle tradizioni,m a non solo,poiché
anche iconflittifra cetie classisocialirappresentavano un ostacolo.A d A tene im ercantierano
rilegatisulfondo della società perché avrebbero potuto accum ulare più ricchezze deipoliticie
com prom etterne la stabilità.M a ilnuovo potere basato sulm ercato m ostro la sua forza quando a
com m erciantie banchierisiaggiunse l'industriale,m ostrano l'apice delcapitalism o e possibilità di
sviluppo m aiviste.
Scaricato da maria verlini (maria.verlini@studenti.unisob.na.it)
lOMoARcPSD|2185348
Ilm ercato ha quindivinto gliostacolicom piendo la sua istituzionalizzazione,m a la resistenza
culturale è perenne,in quanto puressendo riconosciuto utile è considerato altem po stesso
invadente.D a quideriva la nostra cautela perla salvaguardia divaloriche siritiene non debbano
essere com prom essi.U n bam bino può essere adottato,m a non com prato.S angue e organi,non
sono m ercatilegali.La reazione all'invadenza è istintiva ed è riconducibile aivalorisocializzati
nella nostra educazione dibase.M edicina,arte,tem po libero,editoria,ricerca,sono cam piin cui
ilm ercato agisce abbassando icostim a rischiando diappiattirne l'espressione o la funzionalità.
In sintesipossiam o dire che da un punto divista culturale le reazionisono resistenze alla
possibilità che ilm ercato e l'econom ia da m ezzidiventino fini:ilm ercato è istituzionalizzato com e
m ezzo,in continua tensione con ivaloridiuna società.S enza sostegno culturale ilm ercato però
non può funzionare.Lo scam bio dim ercato non siinnesca se non esiste fiducia reciproca,che
viene costruita continuam ente neiprocessidisocializzazione.In un'econom ia arretrata essa
rappresenta un requisito,m entre in un'econom ia avanzata un clim a scorretto può portare a
controllicostosie quindidiconseguenza inefficienza.
S tato e m ercato:la reg olazione p olitica d ell'econo m ia
Ilrapporto tra regolazione dim ercato e azione politica nell'econom ia cam bia quando siparla di
econom ia capitalistica,ovvero quando ilm ercato siautoregola.Lo stato,con la sua autorità e la
possibilità diallocare risorse,definisce condizioniaicom portam entidim ercato.Perindicare
questiinterventipubblicinell'econom ia dim ercato parliam o diregolazione p olitica
d ell'econom ia.M ercato e S tato possono essere visticom e d ue p olidiun continuum su cui
posizioniam o le varie econom ie,a seconda dell'influenza che lo stato ha su diesse.La
regolazione politica inoltre a volte favorisce lo sviluppo delm ercato,ad esem pio attraverso
accordifra S tatiperilcom m ercio estero.
A lpolo delpuro m ercato troviam o l'econom ia d ellaissez-faire (lasciate fare),dove perquanto
l'intervento dello S tato sia m inim o,c'è bisogno dielem entidiregolazione definitida quest'ultim o:
una legislazione com m erciale e ilrispetto delle leggialfine dipunire chinon rispetta icontratti.
O gniS tato definisce quindiregole didiritto com m erciale,fiscale e dellavoro.Ilm assim o
avvicinam ento a questa econom ia lo abbiam o nell'Inghilterra dal18 20 al18 8 0 .
A lpolo opposto troviam o l'econom ia p ianificata,espressione con cuisiindica un'econom ia di
redistribuzione m oderna.U n esem pio concreto diquesta organizzazione sono statiipaesiad
econom ia socialista,com e la C ina e l'U nione S ovietica con la proprietà statale deim ezzidi
produzione e le risorse allocate tram ite decisionipolitiche.
D opo il18 8 0 praticam ente ovunque abbiam o una cosiddetta econom ia m ista,posizionata al
centro fra ipoli,non più autoregolata nelsenso stretto delterm ine.O gnistato ha un suo m odo di
intervenire sull'econom ia m a sipossono individuare tendenze com uni:la produzione dibeni
pubblici,le politiche che regolano la libera concorrenza evitando ilm onopolio,vantaggifiscalie
finanziam enti.Ilm ercato però è tanto efficiente quanto im perfetto.Le decisione dubbie e cattive
valutazioniportano a erroriche cum ulandosiportano aiciclid im ercato,la successione difasidi
crescita e recessione,perstabilizzare le qualiilgoverno interviene frenando o stim olando
l'econom ia (costo deldenaro,tasse) ad esem pio com e dopo la crisideglianni3 0 .Q ueste
com binazionidim ercato e intervento politico sono chiam ate assettikeynesiani,dalnom e
dell'econom ista Inglese K eynes,ilcuipensiero ne ha influenzato la realizzazione.
Scaricato da maria verlini (maria.verlini@studenti.unisob.na.it)
lOMoARcPSD|2185348
G liassettikeynesianie id ifferenticap italism in azionali
Ilm ercato,lasciato a se stesso,non raggiunge m assim a efficienza e non è in grado dirisolvere
problem idiequità.L'offerta è orientata alla dom anda,m a cisono persone che non possono
com prare ciò dicuihanno bisogno la cuidom anda non com pare sulm ercato.
La regolazione della politica keynesiana ha due aspettifondam entali.
• G overno dell'econom ia con interventidistabilizzazione deicicliorientatiall'idea che il
m ercato tende a trovare un equilibrio che non im plica ilpieno im piego deim ezzie del
lavoro.Per vincere la disoccupazione quindilo S tato deve stim olare l'econom ia con la
spesa pubblica.
• S viluppo disistem idisicurezza socialicom e pensionie sussidiin caso dim alattia,
invalidità,disoccupazione,sistem isanitarinazionalie m iglioram ento dell'istruzione.
Q uestiprincipisono seguitiin m odo diverso da ognipaese e sono solo una parte dell'insiem e di
caratteristiche che distinguono ivaricapitalism inazionali.S ipossono distinguere due tendenze
principalidiassettiistituzionali:quella ang losassone (m aggiore regolazione delm ercato) e
quella europ ea continentale (e giapponese) dove siha più intervento pubblico (ad esem pio
l'istruzione professionale altam ente sviluppata in G erm ania) e dove siprevedono vastisistem idi
w elfare.O sservando la crescita delPIL perun periodo dicirca un secolo notiam o una fase di
crescita tra il'50 e il'73 ,seguito da un rallentam ento dell'econom ia.G liannisuccessivialla
seconda guerra m ondiale sono statiquellipiù vicinialla politica keynesiana e irisultatidell'europa
continentale sirivelano m iglioridiquellianglosassoni.D aglianni70 le politiche nazionalidi
controllo dell'econom ia funzionano m eno e l'inflazione crea disordine e m alcontento nella
società,perché riduce ilpotere d'acquisto dichiha un reddito fisso.S iridefiniscono quindii
sistem idiassistenza pubblica e la piena occupazione passa in secondo piano,allontanandosi
dagliassettikeynesianiperdarspazio alla regolazione dim ercato.N eglianni9 0 l'econom ia degli
U S A cresce più diquella europea,e cisichiede dunque perché le politiche keynesiane oggi
funzionino m eno bene.U na delle regioniè la crisifiscale d ello stato ,ovvero quelfenom eno che
accade quando la spesa pubblica costa m olto,sottraendo risorse agliinvestim enti.M a se
l'econom ia è regolata dalm ercato e dalla politica allora quest'ultim a ha le sue responsabilità.
Interventicoordinatiche agiscono fu salari,servizioffertie incentivipossono m antenere
l'equilibrio fra consum i,stipendi,spese,investim enti.E questo è ciò che accadeva in passato.G li
assettikeynesianisisono infattiafferm atidove erano possibiliaccordipoliticiche non
com prom ettevano la salute dell'econom ia.M a ilpunto è che non esistono interpretazionisicure
deim otividella crisi.S ullo sfondo,abbiam o sicuram ente ilprocesso diglobalizzazione.G listati
vanno quindiincontro a m aggioridifficoltà a stabilire politiche interne.L'econom ia è diventata più
grande della politica,quindipiù propensa all'autoregolazione.C ercare diregolarla o dare spazio
alla non equità dell'econom ia dim ercato? Ildibattito scientifico è ancora aperto a proposito,
analizzando le possibiliconseguenze.
Scaricato da maria verlini (maria.verlini@studenti.unisob.na.it)
lOMoARcPSD|2185348
6 .Econom ia form ale e inform ale:uno schem a riassun tivo
Possiam o riassum ere in tre puntiicaratterifondam entaliche l'econom ia ha assunto nelle società
sviluppate.
1. La differenziazione dalresto della società,con la costruzione diun sistem a diazione
specializzato,regolato dalm ercato,nelquale le scelte diproduzione e diconsum o sono
orientate da prezziform atiin libere contrattazioni
2. Lo sviluppo dispecifiche organizzazioni,le im prese,orientate alprofitto e che utilizzano
dipendentistipendiati
3 . Lo stabilirsidiaccordifra econom ia e resto delsistem a tram ite norm e,più specificam ente
giuridiche.
Q uestielem entidefiniscono l'econom ia in senso form ale,ovvero iprocessidiproduzione e
scam bio dibenie serviziregolatidalm ercato e realizzatida im prese orientate alprofitto,che
agiscono rispettando regole con cuilo stato organizza l'azione econom ica.A bbiam o visto inoltre
che puressendo ilm ercato dom inante,reciprocità e redistribuzione visiaffiancano e convivono.
La definizione data quindinon copre le diverse form e in cuiognuno siprocura im ezziperipropri
fini.C hiam iam o quindieconom ia inform ale l'insiem e deiprocessidiproduzione e scam bio che
sisottraggono aicaratterisopra delineati.
Tipi di economia formale e informale
1. Econom ia form ale:lavoro pagato a prezzo dim ercato,benie servizivendutisulm ercato.
2 . Econom ia dom estica:lavoro non pagato (cucinare per la fam iglia) e non venduto.
3 . D iretto intervento dello S tato:pagam ento deidipendentistatalia prezzo dim ercato,beni
e servizipubblicigratuitio pagatia prezzinon dim ercato.
4 . Form a antica che unisce reciprocità e m ercato:beniprodottida fam iglie,lavoro non
pagato,benivendutisulm ercato fuoridalla fam iglia.
5 . M ercatiparalleli:econom ia dim ercato m a con evasione dinorm e,ad esem pio illavoro in
nero,la produzione non denunciata,droga o contrabbando.
6 . A ttività dibeneficenza:volontariato,associazioni.
7. B eniacquistatisulm ercato perun lavoro fuorim ercato,ad esem pio ilfaida te.
Scaricato da maria verlini (maria.verlini@studenti.unisob.na.it)
lOMoARcPSD|2185348
Q uesto schem a è utile a distinguere ivaritipidim ercato e glispostam entifra un m ercato e l'altro,
dato che neltem po le attività tendono a spostarsi,perm ettendocidianalizzare anche
cam biam entisociali.Esem pio:la biancheria prim a era lavata a m ano,poinelle grandilavanderie,
infine con la m odalità faida te attraverso la lavatrice.In ognicaso,asp ettiform alie inform ali
sp esso coesistono e risultano intrecciatinella vita d ituttiig iorni,com e ad esem pio un
lavoro a nero svolto la sera dopo ilregolare turno dilavoro contrattuale.
7.Ilprob lem a d ello svilup p o
S ipuò paragonare lo sviluppo didiversipaesiparagonando ilprodotto nazionale lordo,ovvero il
PIL a cuiperò aggiungiam o iredditiprodottiall'estero e sottraiam o quelliprodottinelpaese da
stranieri.Idatim ostrano grandidifferenze diprodurre ricchezza e m entre ipaesisviluppatisi
devono preoccupare dim antenere elevatiiconsum iproseguendo la crescita ipaesi
sottosviluppatihanno ilproblem a diinnescarla vincendo fam e e povertà.N essuna econom ia ha
però m aipercorso lo stesso cam m ino diun'altra e lo sviluppo industriale deipaesieuropeilo
m ostra chiaram ente.In Inghilterra l'attivatore dello sviluppo sono state le im prese,in Francia e in
G erm ania le banche,e in altripaesicom e l'Italia c'è stato un grande sostegno dallo S tato.
A ttivatoridiversi,m odidiintegrare l'econom ia nella società diversi.Ilproblem a sipone cercando
una soluzione peripaesiarretrati,intorno alla questione se ilcontatto fra econom ie sviluppate e
sottosviluppate possa giovare a queste ultim e.A d esem pio,l'A m erica Latina ha avuto un forte
sviluppo proprio nelperiodo in cuinon era in forte contatto con l'Europa.Ilcontatto con
un'econom ia più forte è utile alla crescita m a potrebbe distruggere le econom ie disussistenza
tradizionalie creare un'econom ia basatisu interessiesterniinvece che sullo sviluppo interno.Le
vecchie idee sulla crescita vengono continuam ente stravolte da casicom e C orea,Taiw an,H ong
K ong,S ingapore che hanno ritm idicrescita im pressionantipursenza grandirisorse naturali,
basando lo sviluppo sull'esportazione e su com binazionidiazionipolitiche com e la dim inuzione
delrischio diinvestim enti,garanzia diservizi,burocrazie efficientie rigido controllo sociale.
Isociologihanno studiato icaratterisocialiche favoriscono o ostacolano lo sviluppo ad esem pio
com e nascono gliim prenditorio l'influenza della religione e sono statiindividuatideterm inati
problem icom e l'esplosione dem ografica,la concentrazione urbana,la crescita delle attività
terziarie.
Ilim itid ello svilup p o è iltitolo diun rapporto presentato da una com unità discienziatia R om a.
M ostrava che la crescita rischia diandare oltre le capacità fisiche della terra.Ilconsum o dirisorse
non rinnovabili,l'inquinam ento,la crescita della popolazione.Ilrapporto è stato giudicato
allarm ante m a ha avuto ilm erito dim ettere in luce ilproblem a dellim ite fisico della crescita e la
necessità diun equilibrio fra attività econom iche e am biente.N on sitratta diferm are lo sviluppo
m a pensare a uno svilup p o sostenib ile.C iò richiede m odifiche nelm odo in cuiintegriam o
l'econom ia nella società e delle nostre abitudini.B isogna considerare conseguenze che il
m ercato non può considerare in autonom ia.Iproblem iam bientalicispostano quindiverso
com plessiequilibrifra m ercato e regolazione politica dell'econom ia.
Scaricato da maria verlini (maria.verlini@studenti.unisob.na.it)
Potrebbero piacerti anche
- La Società Dei ConsumiDocumento19 pagineLa Società Dei ConsumiFilippo LandiNessuna valutazione finora
- Monitoraggio e Valutazione dei Processi di Inserimento in Agricoltura SocialeDa EverandMonitoraggio e Valutazione dei Processi di Inserimento in Agricoltura SocialeNessuna valutazione finora
- Riassunto Cap 19 Il Lavoro Corso Di Sociologia III Organizzazione Sociale Popolazione e TerritorioDocumento8 pagineRiassunto Cap 19 Il Lavoro Corso Di Sociologia III Organizzazione Sociale Popolazione e Territoriomaria verliniNessuna valutazione finora
- Airoldi Brunetti Coda Economia Aziendale RiassuntiDocumento22 pagineAiroldi Brunetti Coda Economia Aziendale RiassuntiMatteo Brivio100% (3)
- Adriano PropersiDocumento90 pagineAdriano PropersicronosNessuna valutazione finora
- 1) RiassuntoDocumento57 pagine1) Riassuntofrancepila06Nessuna valutazione finora
- Riassunti Economia e Gestione Delle ImpreseDocumento61 pagineRiassunti Economia e Gestione Delle ImpreseVeronica Gianni90% (10)
- Come comunicare tra imprese cooperative e comunità locale: Il bilancio socialeDa EverandCome comunicare tra imprese cooperative e comunità locale: Il bilancio socialeNessuna valutazione finora
- Responsabilità Dimpresa - White Paper 2018 - Il Quinto AmpliamentoDocumento84 pagineResponsabilità Dimpresa - White Paper 2018 - Il Quinto Ampliamentovigajiv832Nessuna valutazione finora
- Elementi Di Economia AziendaleDocumento33 pagineElementi Di Economia AziendaleDavid Ricardo100% (1)
- Assgaia Piccola Guida Al Consumo Critico e SolidaleDocumento64 pagineAssgaia Piccola Guida Al Consumo Critico e SolidaleChiara LunaNessuna valutazione finora
- Economia Politica 1Documento70 pagineEconomia Politica 1Giulia CaputoNessuna valutazione finora
- Fondamenti Di ManagementDocumento89 pagineFondamenti Di ManagementFederico FontanaNessuna valutazione finora
- Riassunto Un Mondo A Tre ZeriDocumento7 pagineRiassunto Un Mondo A Tre ZeriAngela LiistroNessuna valutazione finora
- Baudrillard Per Una Critica Dell Economia Politica Del SegnoDocumento202 pagineBaudrillard Per Una Critica Dell Economia Politica Del SegnoFrancesco OliverioNessuna valutazione finora
- Economia Aziendale Lucianetti RiassuntoDocumento11 pagineEconomia Aziendale Lucianetti RiassuntoGabriele Valentini100% (1)
- Trattato di Sociologia: Critica Economica. Volume 3/4Da EverandTrattato di Sociologia: Critica Economica. Volume 3/4Nessuna valutazione finora
- Mutualità e cooperazione: A partire dalla crisi economica e socialeDa EverandMutualità e cooperazione: A partire dalla crisi economica e socialeNessuna valutazione finora
- (Luigino Bruni and Stefano Zamagni) Dizionario DiDocumento505 pagine(Luigino Bruni and Stefano Zamagni) Dizionario DiAngeloMichele MazzaNessuna valutazione finora
- Elementi Di EconomiaDocumento42 pagineElementi Di EconomiaMarco LebiNessuna valutazione finora
- Ec. Aziendale Per Le Istit. Culturali 2021 (Libro Slides Appunti) LusianiDocumento55 pagineEc. Aziendale Per Le Istit. Culturali 2021 (Libro Slides Appunti) Lusiani901243Nessuna valutazione finora
- L'impresa sociale nel sistema di Welfare: Il "modello" del Circolo cooperativoDa EverandL'impresa sociale nel sistema di Welfare: Il "modello" del Circolo cooperativoNessuna valutazione finora
- Tesina Anticorruzione Parte PrimaDocumento16 pagineTesina Anticorruzione Parte PrimaPatrizia Di RenzoNessuna valutazione finora
- GLI IMPATTI DI UN MODELLO DI RIDUZIONE DELLO SPRECO ALIMENTARE UNA LOGICA WIN-WIN PER LE PERSONE, LE AZIENDE E L'AMBIENTEDocumento92 pagineGLI IMPATTI DI UN MODELLO DI RIDUZIONE DELLO SPRECO ALIMENTARE UNA LOGICA WIN-WIN PER LE PERSONE, LE AZIENDE E L'AMBIENTEArabella PaoloneNessuna valutazione finora
- Storia EconomicaDocumento137 pagineStoria Economicamariagreta.denotarpietro01Nessuna valutazione finora
- Finanza EticaDocumento17 pagineFinanza EticabestgianduiaNessuna valutazione finora
- Economia e Gestione Parte 1-6Documento22 pagineEconomia e Gestione Parte 1-6pollohjNessuna valutazione finora
- Corso Di Economia Aziendale Di AiroldiDocumento32 pagineCorso Di Economia Aziendale Di AiroldidavideNessuna valutazione finora
- CCA Semana 14 Dic 2017Documento6 pagineCCA Semana 14 Dic 2017Matias Cruz NorambuenaNessuna valutazione finora
- Workers buyout: imprese in crisi “rigenerate” dai lavoratori: Casi di studio sulla sostenibilità delle esperienze vissute nel sistema cooperativo della RomagnaDa EverandWorkers buyout: imprese in crisi “rigenerate” dai lavoratori: Casi di studio sulla sostenibilità delle esperienze vissute nel sistema cooperativo della RomagnaNessuna valutazione finora
- Problemi, cause e rimedi dell’attuale crisi economica italianaDa EverandProblemi, cause e rimedi dell’attuale crisi economica italianaNessuna valutazione finora
- Fondazioni, Associazioni, Terzo Settore e il VolontariatoDa EverandFondazioni, Associazioni, Terzo Settore e il VolontariatoNessuna valutazione finora
- Agri3 00Documento36 pagineAgri3 00brujieNessuna valutazione finora
- ConsumismoDocumento3 pagineConsumismoEleonora ColomboNessuna valutazione finora
- Riassunto Sciarelli La Gestione Dell Impresa Tra Teoria e Pratica Aziendale Parte 1Documento45 pagineRiassunto Sciarelli La Gestione Dell Impresa Tra Teoria e Pratica Aziendale Parte 1Danila MancinoNessuna valutazione finora
- Antologia Carlos 2.0Documento46 pagineAntologia Carlos 2.0Carlos AlcantarNessuna valutazione finora
- Manifesto Green MarketingDocumento32 pagineManifesto Green MarketingmarketpointerNessuna valutazione finora
- #Populeconomy: L’economia per le persone e non per le élites finanziarieDa Everand#Populeconomy: L’economia per le persone e non per le élites finanziarieNessuna valutazione finora
- Invecchiamento attivo il caso della Tuscia: riflessioni socio geografiche e welfare sostenibiliDa EverandInvecchiamento attivo il caso della Tuscia: riflessioni socio geografiche e welfare sostenibiliNessuna valutazione finora
- Bambini, Adolescenti e Famiglie VulnerabiliDocumento42 pagineBambini, Adolescenti e Famiglie VulnerabiliNicoleNessuna valutazione finora
- Economia-Samuelson RiassuntiDocumento79 pagineEconomia-Samuelson RiassuntiLuca Di BariNessuna valutazione finora
- Non profit: Fisco, tecnologie, alleanze per entrare nel terzo settoreDa EverandNon profit: Fisco, tecnologie, alleanze per entrare nel terzo settoreNessuna valutazione finora
- SOCIOLOGIADocumento6 pagineSOCIOLOGIAlaura.penello05Nessuna valutazione finora
- Economia PDF CompletoDocumento22 pagineEconomia PDF CompletoAlessia MattucciNessuna valutazione finora
- Sociologia AppuntiDocumento22 pagineSociologia AppunticristinaNessuna valutazione finora
- Rcs S.340.TRA - SGU.0001V1K2 PreviewDocumento8 pagineRcs S.340.TRA - SGU.0001V1K2 PreviewGiulia DanziNessuna valutazione finora
- La Rete Dei Servizi Alla PersonaDocumento44 pagineLa Rete Dei Servizi Alla PersonaGeorgia Ciaschetti100% (1)
- Il movimento cooperativo in India e il problema politico dell’emancipazione: Spunti di riflessione per una teoria politica della cooperazioneDa EverandIl movimento cooperativo in India e il problema politico dell’emancipazione: Spunti di riflessione per una teoria politica della cooperazioneNessuna valutazione finora
- Lezioni Di Economia AziendaleDocumento81 pagineLezioni Di Economia AziendaleDalila SartorNessuna valutazione finora
- AppuntiDocumento9 pagineAppuntiNunzio GuarracinoNessuna valutazione finora
- Traccia Economia Sostenibile e Questione AmbientaleDocumento3 pagineTraccia Economia Sostenibile e Questione AmbientaleAGNESE MARAGNANessuna valutazione finora
- Dispense Sciarelli Economia e Gestione Delle Imprese by FuturaDocumento64 pagineDispense Sciarelli Economia e Gestione Delle Imprese by FuturaAngela PerrettaNessuna valutazione finora
- Riassunto Di Diritto Ed Economia Dei MercatiDocumento173 pagineRiassunto Di Diritto Ed Economia Dei MercatiDANIELA ALEXANDRA POHNessuna valutazione finora
- Regolamento 7th Sea GDR ItaliaDocumento2 pagineRegolamento 7th Sea GDR Italiamaria verliniNessuna valutazione finora
- Scheda Nave EditabileDocumento1 paginaScheda Nave Editabilemaria verliniNessuna valutazione finora
- 7th Sea - Guida Informativa ImbarcazioniDocumento5 pagine7th Sea - Guida Informativa Imbarcazionimaria verliniNessuna valutazione finora
- Scheda 7th Sea V0.3.prova LayoutDocumento3 pagineScheda 7th Sea V0.3.prova Layoutmaria verliniNessuna valutazione finora