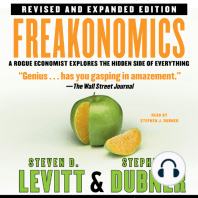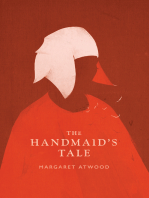Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
DP
Caricato da
Matteo LipoTitolo originale
Copyright
Formati disponibili
Condividi questo documento
Condividi o incorpora il documento
Hai trovato utile questo documento?
Questo contenuto è inappropriato?
Segnala questo documentoCopyright:
Formati disponibili
DP
Caricato da
Matteo LipoCopyright:
Formati disponibili
lOMoARcPSD|7648598
Paradiso Diritto privato MOD 1 by zziopippo
CAP 1 SOCIETA' E DIRITTO (pagg 1-11)
Una delle caratteristiche fondamentali dell'individuo è la sua capacità, anzi la sua necessità di porsi
in relazione con gli altri: occorrono quindi delle norme di comportamento ben precise che regolino i
rapporti tra gli individui,determinando ciò che è consentito e ciò che non lo è.
L'insieme di queste norme prende il nome di DIRITTO.
Il diritto è dunque la base di ogni società: non esiste società senza diritto né diritto senza società
ubi societas ibi ius, ubi ius ibi societas
Bisogna rilevare che accanto alle norme che fanno parte del diritto, dette NORME GIURIDICHE,
ci sono norme che non fanno parte di esso ad es norme di natura morale, religiosa, di costume ecc.
Ciò che distingue le une dalle altre sta nel fatto che la non osservanza delle norme giuridiche
comporta una SANZIONE: anche la violazione di norme non giuridiche comporta una reazione
negativa della collettività ad es sparlare di una persona PUO' comportare ( ma non è una cosa certa)
la riprovazione della società, ma la sanzione della giustizia cioè risarcimento per diffamazione è una
cosa certa e predeterminata.
Caratteristiche fondamentali di un ordinamento giuridico sono dunque:
...presenza di regole
...presenza di sanzioni
...presenza di organismi che applicano le sanzioni.
Si può dire che ogni società ha un suo ordinamento giuridico per cui è prevedibile che possano
sorgere problemi di compatibilità tra ordinamenti diversi: ad es in alcuni stati è ammessa la
bigamia, in Italia la Federazione Calcistica ha i suoi giudici e i suoi regolamenti; la regola in questi
casi è dettata dall'art 31 delle disposizioni preliminari del codice civile:
“ le leggi di uno stato estero, gli ordinamenti di qualsiasi istituzione non possono avere effetto nel
territorio dello Stato,quando siano contrari all'ordine pubblico e al buon costume”: ciò sancisce la
prevalenza dell'ordinamento giuridico dello Stato su tutti gli altri.
Le differenze tra i vari ordinamenti giuridici sono in gran parte dovuti alle differenti strutture delle
società, tuttavia esiste un elemento comune ed è quello della equità e giustizia delle norme.
Equità e giustizia sono garantite, almeno nella maggior parte degli ordinamenti, dal consenso
popolare.
www.unictblog.com 5
Scaricato da Giovanni Porta (portagiovanni358@gmail.com)
lOMoARcPSD|7648598
CAP 2 FONTI DEL DIRITTO POSITIVO (pagg 12-23)
Premesso che esiste un DIRITTO NATURALE cioè un insieme di leggi non scritte, connesse alla
natura e razionalità umana e come tali valide per ogni uomo, in ogni luogo e in qualunque epoca
storica ( ad es la salvaguardia della vita umana), si definisce DIRITTO POSITIVO l'insieme delle
norme che costituiscono l'ordinamento giuridico di una data collettività in un dato momento storico.
Il termine “positivo” deriva dal latino “ius in civitatem positum”.
La norma è caratterizzata da 3 aspetti:
1--- GENERALITA' perchè non si rivolge al singolo ma a tutti
2---ASTRATTEZZA perchè non si limita a una singola situazione ma a una pluralità di situazioni
3---IMPERATIVITA' perchè DEVE essere osservata
Questi aspetti sono tipici ma non necessari, ad es una legge che crea un ente pubblico non è né
generale né astratta.
Per GIURISPRUDENZA si intende l'attività di interpretazione e applicazione delle norme
giuridiche, compito svolto istituzionalmente dai giudici.
Da dove traggono origine le norme giuridiche?
Originano da fonti NON scritte (usi e costumi) e da fonti scritte (leggi e regolamenti)
Tradizionalmente si distinguono:
FONTI DI PRODUZIONE :la legge, quale atto emanato dal parlamento e dagli organi competenti
FONTI DI COGNIZIONE :è il testo scritto
Per chiarire il concetto si pensi al segnale di sosta vietata: esso è l'espressione grafica (la fonte di
cognizione) di una legge del codice stradale (fonte di produzione).
A proposito delle fonti di produzione, poiché esse sono numerose, sorge il problema di quale di esse
prevalga sulle altre ossia quale sia la GERARCHIA delle fonti: esse viene indicata nell'art 1 delle
“disposizioni sulla legge in generale”,una serie di disposizioni preliminari del cc dette PRELEGGI .
L'ordine gerarchico é il seguente:
1 Costituzione e altre leggi costituzionali 4 Leggi regionali
2 Regolamenti comunitari 5 Regolamenti
3 Leggi ordinarie dello Stato 6 Usi e consuetudini
LE LEGGI COSTITUZIONALI dettano le regole fondamentali dell'assetto politico e istituzionale
del nostro Paese: tutte le leggi devono conformarsi ai principi costituzionali pena la loro nullità per
ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE: sono leggi rigide e possono essere modificate solo con
altre leggi costituzionali tramite procedura complesse e rigorose
I REGOLAMENTI COMUNITARI sono atti normativi della UE che hanno diretta efficacia per tutti
i cittadini della comunità, prerogativa che non hanno invece le DIRETTIVE comunitarie che
devono essere recepite dal parlamento prima di entrare in vigore.
Le LEGGI ORDINARIE sono atti normativi emanati dal Parlamento; ad esse si equiparano anche i
decreti legge emanati dal governo in caso di necessità che devono essere approvati dal parlamento
entro 60 gg pena la decadenza e le leggi DELEGATE o DECRETI LEGISLATIVI emanati dal
governo su precisa delega del parlamento.
I REGOLAMENTI sono atti normativi emanati da autorità amministrative (stato, comuni, prefetti)
che regolano l'applicazione pratica delle leggi.
L'USO O CONSUETUDINE è quella norma NON SCRITTA che nasce dal protrarsi nel tempo di
un certo comportamento: perchè una consuetudine abbia la forza di una norma occorre un
REQUISITO OGGETTIVO ,cioè che si ripeta nel tempo, e uno SOGGETTIVO o psicologico nel
senso che se ne deve sentire l'obbligatorietà: nessuno si sente obbligato a versare la mancia, essa
quindi è un uso di fatto ma privo di forza normativa ( insomma se non do la mancia non mi
possono denunciare)
www.unictblog.com 6
Scaricato da Giovanni Porta (portagiovanni358@gmail.com)
lOMoARcPSD|7648598
CAP 3 APPLICAZIONE DELLA LEGGE (pagg 24-34)
L'applicazione della legge consiste nell'assegnare a un caso concreto la disciplina che gli compete.
Essa può essere paragonata al sillogismo, procedimento logico mediante il quale da determinate
premesse si ricava una conseguenza cioè da una norma generale e astratta si ricava la regola
applicata al caso singolo. Ad es per l'affitto di una casa si parte dalla categoria generale “negozio”,
si passa poi alla categoria “contratti” e infine si arriva alla categoria “affitti”.
L'applicazione della legge consta di due momenti:
1 ---individuazione delle norme pertinenti al caso
2 ---interpretazione, cioè precisazione del suo significato.
Poiché si tratta di norme scritte, l'interpretazione consiste nel chiarire il senso delle parole scritte
seguendo i dettami dell'art 12 delle dispos. prelim. c.c. che prevede:
--un criterio LETTERALE cioè dare alle parole il significato che hanno nell'uso comune
--un criterio di GLOBALITA' cioè considerare la parola singola nel contesto del discorso
--un criterio di SISTEMATICITA' cioè considerare la norma non isolatamente ma come parte di un
sistema di norme e tra queste particolare importanza assume la Costituzione.
--un criterio di FUNZIONALITA' cioè interpretare le intenzioni del legislatore
L'interpretazione inoltre può essere ESTENSIVA quando si fanno rientrare nella norma ipotesi non
previste ma coerenti con la norma e viceversa RESTRITTIVA quando vengono escluse ipotesi che
rientrerebbero nella norma ma che in realtà esulano dall'intenzione del legislatore.
Quando si presentano casi che nonostante la completezza del sistema non siano previsti
dall'ordinamento giuridico si usa il criterio dell' ANALOGIA cioè ad essi si applicano le regole che
si usano in casi previsti che abbiano una certa somiglianza ad es un interesse comune( ANALOGIA
LEGIS); si parla invece di ANALOGIA IURIS quando la regola da applicare si ricava dai principi
generali dell'ordinamento: l'analogia NON si applica alle norme penali e a quelle eccezionali.
Una legge entra in vigore 15 gg dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (art 73 Cost) per
permettere ai destinatari di prendere conoscenza delle norme.(questo periodo di 15 giorni è
chiamato VACATIO LEGIS) :una legge non ha valore retroattivo (art 11 disp preliminari).Tuttavia
si precisa che le disposizioni sulla vacatio e sulla retroattività non sono assolute poiché lo stesso art
73 recita “salvo che sia altrimenti disposto”; in ogni caso la retroattività di una legge PENALE è
vietata dall'art 25 della Costituzione.
Una norma cessa di avere efficacia per vari motivi:o perchè ABROGATA da una legge o da un
referendum o perchè incostituzionale o perchè sostituita da un'altra.
Nel caso una legge sia sostituita con un'altra si provvede a emanare delle norme TRANSITORIE
che disciplinano il passaggio dall'una all'altra, generalmente sulla base che gli effetti già prodotti
rimangono validi: es il caso in cui una legge cambi il numero degli anni di un corso di laurea, per
un certo periodo ci saranno in vigore due ordinamenti.
Vediamo ora di chiarire il problema della legge italiana di fronte a un cittadino straniero:
In primo luogo allo straniero regolarmente soggiornante in Italia vengono garantiti ,oltre ai diritti
fondamentali della persona umana, anche i diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano
riguardanti la tutela giurisdizionale, l'accesso ai pubblici servizi, i rapporti con l'amministrazione
pubblica.
In secondo luogo bisogna distinguere tra cittadini comunitari ed extracomunitari: i primi in base al
trattato di Maastricht hanno la cittadinanza europea che assicura loro i diritti civili spettanti ai
cittadini dello stato ospite più alcuni diritti politici come il voto nelle elezioni amministrative locali.
Per gli extracomunitari, pur in presenza di norme di diritto privato internazionale, la legge 218 del
1995 dispone che bisogna tener conto:
1---della cittadinanza per le questioni relative a stato della persona, rapporti familiari, successioni
(ad es a un Saudita cosa dico, di lasciare le sue 99 mogli e tenersene una sola perchè in Italia non è
ammessa la poligamia?)
2---del luogo in cui si trova la cosa o in cui è stato compiuto l'atto per le questioni riguardanti
proprietà, diritti reali, fatti illeciti (se compra una casa in Italia sottostà alle leggi italiane)
www.unictblog.com 7
Scaricato da Giovanni Porta (portagiovanni358@gmail.com)
lOMoARcPSD|7648598
3---scelta degli interessati per quanto concerne le obbligazioni contrattuali.
NOTA:
L'interpretazione in base ai soggetti che la compiono, si distingue in
1) interpretazione giurisprudenziale = fatta dai giudici
2) “ dottrinale = fatta dagli studiosi
3) “ autentica = fatta dallo stesso legislatore che per chiarire una legge nuova,
emana un'altra norma detta interpretativa.
CAP 4 IL DIRITTO PRIVATO ( pagg 35-40)
Tradizionalmente il diritto viene distinto in diritto pubblico e diritto privato:
il diritto privato tutela gli interessi dei singoli cittadini, il diritto pubblico quelli pubblici o collettivi.
Il diritto privato regola i rapporti tra due soggetti in posizione di eguaglianza reciproca, siano essi
privati cittadini o enti pubblici; il diritto pubblico regola i rapporti tra due soggetti che non sono
eguali in quanto uno dei due ,cioè il soggetto pubblico, ha poteri autoritativi che esercita sull'altro.
Se il Comune mi chiede di prendere in affitto un mio terreno, siamo nel diritto privato,facciamo un
contratto esattamente come due soggetti qualunque; altra cosa se il Comune viene da me con i
poteri autoritativi di un ente pubblico e mi espropria il terreno per costruire ad es un parco giochi.
Nell'ambito del diritto privato si distinguono
NORME DISPOSITIVE o DEROGABILI che consentono agli interessati di stabilire essi stessi le
regole: es la legge dispone che il pagamento di un debito avvenga al domicilio del creditore ma le
due parti possono benissimo accordarsi diversamente.
NORME IMPERATIVE o INDEROGABILI che non possono essere eluse neanche con il consenso
di entrambi i contraenti.( es la forma scritta della compravendita è obbligatoria)
Si parla inoltre di funzione INTEGRATIVA O SUPPLETIVA della legge quando essa interviene a
integrare quanto previsto dai soggetti: ad es. nella compravendita , il compratore ha diritto a
risarcimento se la merce risulta difettosa anche se nel contratto non c'è nulla al riguardo.
Infine il diritto privato comprende varie branche caratterizzate da regole specifiche:
diritto CIVILE disciplina rapporti personali,familiari,beni ecc.
diritto COMMERCIALE disciplina le attività di impresa,società,fallimenti
diritto del LAVORO regola le prestazioni di lavoro dipendente,attività sindacale
diritto della NAVIGAZIONE disciplina i rapporti connessi all'esercizio della navigazione.
www.unictblog.com 8
Scaricato da Giovanni Porta (portagiovanni358@gmail.com)
lOMoARcPSD|7648598
CAP 5 IL RAPPORTO GIURIDICO IN GENERALE ( pagg 41-50 )
Si definisce rapporto giuridico ogni relazione tra individui disciplinata dal diritto.
Nel rapporto giuridico quindi si individuano:
1) l'oggetto cioè il bene in senso ampio (beni materiali,immateriali,servizi)
2) i soggetti :(possono essere persone fisiche oppure enti o società) sono gli “attori”
3) le situazioni giuridiche soggettive cioè in che posizione giuridica si trovano i soggetti ,cioè se
sono in posizione di
VANTAGGIO ovvero godono di diritti ( diritti soggettivi,potestà, interessi legittimi )
o SVANTAGGIO ovvero sono soggetti a obblighi, doveri,oneri
Il DIRITTO SOGGETTIVO è il diritto di un soggetto a tutelare il proprio interesse (facultas
agendi) :è una facoltà nel senso che il soggetto può scegliere se agire o no
la POTESTA' è il diritto di un soggetto a tutelare l'interesse altrui (genitori vs figli)
l'INTERESSE LEGITTIMO è il diritto di un soggetto a tutelare sia l'interesse individuale che
collettivo: se vedo irregolarità in un concorso pubblico, ho il diritto di farlo annullare nell'interesse
mio e degli altri concorrenti
I diritti soggettivi possono essere esercitati nei confronti di tutti e sono detti ASSOLUTI ad es i
diritti della persona (diritto alla vita,all'integrità fisica,al nome ecc) oppure possono essere esercitati
nei confronti di un soggetto determinato e sono detti RELATIVI: se ho un debito devo rendere
conto solo al mio creditore.
La posizione di svantaggio comporta obblighi (correlati a un diritto relativo di tipo personale es a
fronte di un credito, un debitore ha l'obbligo di pagare), oneri (cose da fare per realizzare un proprio
interesse es per la garanzia su un oggetto, il compratore ha l'onere di farne denunzia entro 8 gg)
doveri (causati da un diritto assoluto); la SOGGEZIONE si ha quando un soggetto deve subire
unilateralmente da un altro soggetto che ha un DIRITTO POTESTATIVO ( es il Comune che
espropria un terreno).
La PUBBLICITA' dei fatti giuridici consiste nel rendere agevole la conoscenza dei fatti stessi
Abbiamo 3 tipi di pubblicità
NOTIFICATIVA serve solo a dare notizia del fatto ma la sua omissione non incide sulla validità del
fatto es la pubblicazione matrimoniale :in sua assenza il matrimonio è valido ugualmente.
DICHIARATIVA serve a rendere opponibili a terzi determinati atti: la sua omissione non incide
sulla validità ma sulla efficacia dell'atto es se compro una casa e non trascrivo l'acquisto nei registri
immobiliari l'atto sarà valido ma non potrò far valere l'acquisto contro chi, pur acquistando
successivamente, trascriva il suo acquisto.
COSTITUTIVA condiziona validità ed efficacia dell'atto es l'iscrizione dell'ipoteca nei registri
immobiliari è necessaria per la nascita dell'ipoteca stessa.
www.unictblog.com 9
Scaricato da Giovanni Porta (portagiovanni358@gmail.com)
lOMoARcPSD|7648598
CAP 6 I SOGGETTI DEL RAPPORTO GIURIDICO : PERSONE FISICHE ( pagg 51-71 )
Con il termine SOGGETTO si indica il titolare delle posizioni giuridiche soggettive: da rilevare che
soggetto non vuol dire solo una persona fisica ma anche gli Enti Giuridici (un'associazione, una
spa) in quanto portatori di interessi distinti da quelli delle persone che ne fanno parte.
L'attitudine a essere titolari di posizioni giuridiche (ovvero avere diritti o doveri) viene detta
CAPACITA' GIURIDICA e può essere :
GENERALE se attribuita a persone fisiche e agli enti giuridici “dotati di personalità” cioè
associazioni riconosciute,fondazioni,regioni,province,comuni.
PARZIALE se attribuita a enti pubblici che non hanno “personalità giuridica”( es associazioni non
riconosciute).
La capacità giuridica si acquisisce al momento della nascita (art 1 cc) cioè da questo momento si
acquistano una serie di diritti es il nome,il mantenimento ,l'acquisizione di eredità ecc. Alcuni di
questi diritti vengono riconosciuti anche al nascituro concepito e avranno effetto alla nascita, così il
nascituro concepito ha la capacità di succedere per causa di morte, di ricevere donazioni ecc; inoltre
il nascituro concepito gode di specifiche leggi di tutela : sono infatti vietate sperimentazioni non
aventi fini terapeutici,clonazione e ibridazione, commercializzazione, modifiche del patrimonio
genetico (art 13 ss e legge 40 del 2004).La legge prevede anche la figura del nascituro non ancora
concepito cioè di colui che si prevede o si spera che nascerà:anch'egli infatti ha alcuni diritti come
la possibilità di essere beneficiario in una donazione o in un testamento purchè sia figlio di persona
vivente al momento della donazione o della morte del testatore(art 784, 462).
La capacità giuridica può avere delle limitazioni giustificate dall'esigenza di tutelare gli interessi del
soggetto stesso o quelli della collettività. Queste limitazioni sono ben specificate e non sono
suscettibili di interpretazioni estensive, per questo si parla di INCAPACITA' SPECIALI
Esse sono determinate dall' ETA' (divieto di lavoro per i minori di anni 15 art 3 leg.977 del 1967)
dallo STATO DELLE PERSONE (divieto di matrimonio tra persone con stretti vincoli di parentela)
dall'UFFICIO RICOPERTO ( i pubblici amministratori non possono essere acquirenti dei beni degli
enti da essi amministrati)
Diversa dalla capacità giuridica è la CAPACITA' DI AGIRE è l'idoneità a esercitare i propri diritti e
si acquisisce al raggiungimento della maggiore età: un minore ha capacità giuridica (diritto alla
vita,al mantenimento ecc) ma non capacità di agire, non può ad es decidere del suo patrimonio,
questo spetta ai genitori.
Può accadere che anche in maggiore età il soggetto sia incapace di agire del tutto o parzialmente
avendosi così incapacità assoluta o relativa.
La legge n.6 /2004 ha introdotto la figura dell'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO al fine di
tutelare le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita
quotidiana: si tratta quindi non solo di disabili o alcoolisti e tossicodipendenti ma anche di anziani,
carcerati e in genere soggetti per i quali appare eccessiva l'interdizione o l'inabilitazione
INCAPACITA' RELATIVA DI AGIRE
Si ha nei casi in cui una persona è affetta da turbe mentali non particolarmente gravi o chi abusando
di alcool o stupefacenti espone sé e la famiglia a gravi danni economici o anche ciechi e sordomuti
non addestrati
Nei casi meno gravi il giudice tutelare nomina l'amministratore di sostegno con un decreto nel quale
sono specificati gli atti che l'amministratore compierà da solo e quelli che il beneficiario può
compiere solo con l'assistenza dell'amministratore: questo comporta che il beneficiario può
compiere liberamente da solo tutti gli altri atti non specificatamente vietati nel decreto:
l'amministratore viene scelto di solito tra i congiunti. Nei casi in cui tutto questo risulti insufficiente
si procede,dopo accertamento,alla INABILITAZIONE dell'incapace; l'inabilitato ha la capacità di
agire riguardo agli atti di ordinaria amministrazione del suo patrimonio ma gli atti di
amministrazione straordinaria necessitano di un CURATORE che si consulta con il giudice.
Si può avere anche una situazione contraria cioè concedere una parziale capacità di agire a un
soggetto che non ne avrebbe diritto, tipico l'esempio del diritto di matrimonio concesso a un
www.unictblog.com 10
Scaricato da Giovanni Porta (portagiovanni358@gmail.com)
lOMoARcPSD|7648598
minorenne: si parla allora di EMANCIPAZIONE.
INCAPACITA' GENERALE DI AGIRE
Si riferisce a 3 condizioni : minore età, interdizione e incapacità naturale.
MINORE ETA'
Al di fuori di atti per i quali sia stabilita un'età diversa (vedi matrimonio) il minore si trova in uno
stato di incapacità generale di agire, cioè tutte le decisioni personali e patrimoniali che lo riguardano
sono di competenza del suo legale rappresentante e cioè i suoi genitori o il tutore: fanno eccezione
le libertà civili cioè libertà religiosa ,di pensiero, di iscrizione a un partito politico ecc.
INTERDIZIONE:
---L'INTERDIZIONE GIUDIZIALE si riferisce a quei soggetti che per insufficiente sviluppo o per
gravi infermità mentali, vengono dichiarati interdetti con apposito provvedimento giudiziale; essi si
trovano nella stessa situazione di un minore ( ma oggi alcuni atti di ordinaria amministrazione sono
concessi , non comunque il matrimonio). Gli atti dell'interdetto possono essere, per ciò solo,
annullati.
---L'INTERDIZIONE LEGALE è una pena accessoria che discende da una condanna all'ergastolo o
alla reclusione superiore ai 5 anni e che prevede il divieto di disporre e amministrare i propri beni,
ma è libero di compiere gli atti che rientrano nella sfera personale (matrimonio,testamento ecc).
---L'INCAPACITA' NATURALE è quella attribuita a chi , seppure ordinariamente capace, si trova
momentaneamente incapace al momento in cui compie un atto, es per ubriachezza, uso di
stupefacenti, in stato di ipnosi: gli atti compiuti da questi soggetti sono suscettibili di annullamento
ma occorrerà dare la prova dello stato di alterazione delle sue facoltà mentali: si possono così
annullare matrimonio, testamento, donazione; per gli altri atti, quelli unilaterali sono annullabili se
da essi deriva un danno al soggetto (ad es donare il proprio patrimonio) nel caso di un contratto se
l'altro contraente risulta in malafede.
La RAPPRESENTANZA LEGALE E LA TUTELA
Come abbiamo visto, nel caso di incapacità relativa, al soggetto viene AFFIANCATO un curatore :
nel caso di incapacità assoluta invece il soggetto è SOSTITUITO dal RAPPRESENTANTE
LEGALE o TUTORE, figura disciplinata dalla legge in maniera molto rigorosa : il rappresentante
legale infatti può compiere solo atti di ordinaria amministrazione (es spese correnti come vestiario o
iscrizione a scuola); per gli atti di straordinaria amministrazione che incidono sul patrimonio
dell'incapace (es vendita di un bene) occorre l'autorizzazione del giudice o del tribunale pena
l'annullabilità degli atti compiuti: a garanzia dell'incapace, il rappresentante legale è obbligato a
presentare un accurato rendiconto periodico e a evitare ogni conflitto di interesse.
Per i minori i genitori possono essere i rappresentanti e in caso di mancanza dei genitori viene
nominato un tutore
SEDE DELLA PERSONA:
---DOMICILIO è il luogo in cui la persona ha stabilito la sede dei suoi affari (es studio privato)
---RESIDENZA è il luogo in cui la persona vive abitualmente
---DIMORA è un'abitazione transitoria ma non occasionale (es casa di villeggiatura)
---DOMICILIO ELETTIVO è un luogo scelto per determinati affari ( es ricevere comunicazioni)
MORTE, SCOMPARSA, ASSENZA E MORTE PRESUNTA
Con la morte cessa la capacità giuridica e si estinguono i diritti della persona (non quello dell'onore)
L'accertamento della morte compete agli uffici dello stato civile e risulta dal certificato di morte con
luogo, data e ora del decesso; l'ora del decesso può essere essenziale ad es se moglie e marito
muoiono in un incidente e la moglie muore qualche istante dopo ,sarà lei a ereditare e di
conseguenza i suoi parenti; se non è possibile stabilire l'ora si presume che la morte sia avvenuta
nello stesso istante(presunzione di commorienza) e ci saranno eredi del marito e eredi della moglie.
Poniamo ora il caso classico del marito che va a comprare le sigarette e non torna più:
su istanza degli interessati il tribunale ne dichiara la SCOMPARSA e nomina un curatore del suo
www.unictblog.com 11
Scaricato da Giovanni Porta (portagiovanni358@gmail.com)
lOMoARcPSD|7648598
patrimonio: in questo stadio si presume che il soggetto sia vivo.
Passati 2 anni se ne dichiara l'ASSENZA: a questo stadio si presume che il soggetto possa essere
morto, si apre il testamento e si può prendere possesso temporaneo dei suoi beni che gli saranno
restituiti nel caso ritorni. Passati 10 anni dalla scomparsa (o di meno per es in caso di scomparsa in
guerra) il tribunale dichiara la MORTE PRESUNTA che equivale a una morte reale: si apre la
successione ereditaria, la moglie può contrarre un nuovo matrimonio, ma se un bel giorno il
“morto” torna ,ha diritto alla restituzione dei beni così come sono, il matrimonio della moglie viene
annullato ma i figli avuti dalla moglie nel secondo matrimonio avranno lo stato di figli legittimi e
pertanto se li dovrà cuccare lui.
www.unictblog.com 12
Scaricato da Giovanni Porta (portagiovanni358@gmail.com)
lOMoARcPSD|7648598
CAP 7 I SOGGETTI DEL RAPPORTO GIURIDICO : GLI ENTI GIURIDICI (pagg 72-85)
Soggetti del rapporto giuridico possono essere, oltre le persone fisiche, anche gli ENTI GIURIDICI
Essi sono distinti in:
---ENTI DOTATI DI PERSONALITA' GIURIDICA es stato,comuni,regioni considerate persone
giuridiche in senso proprio;hanno autonomia patrimoniale perfetta cioè c'è una netta distinzione tra
il patrimonio dell'ente e il patrimonio dei soci
---ENTI NON PERSONIFICATI associazioni non riconosciute,comitati, società di persone:
hanno autonomia patrimoniale imperfetta perchè manca questa distinzione
L'acquisizione della personalità giuridica avviene per legge (es Istituzione di un nuovo Comune)
oppure tramite l'iscrizione in un apposito registro delle persone giuridiche depositato in prefettura:
tocca al prefetto decidere sul riconoscimento o meno: requisiti richiesti sono la liceità dello scopo e
un adeguato patrimonio (una volta non si concedeva il riconoscimento a quegli enti che
presentavano futili scopi o erano doppioni di alti enti).
la vita dell'ente è regolata da uno statuto che deve contenere notizie essenziali come denominazione,
scopi,sede, patrimonio ; l'ente opera a mezzo di organi cui sono affidate le decisioni e la loro
attuazione. L'Ente risponde dell'operato dei suoi organi (se un segretario di partito commette brogli
elettorali ne risponde il partito stesso)
In base alla natura abbiamo:
---ENTI PUBBLICI disciplinati da apposite norme di diritto pubblico che ne regolano la
costituzione e il funzionamento es stato,regioni (enti territoriali) INPS ASL (non territoriali)
---ENTI PRIVATI sono costituiti da persone che vogliono perseguire uno scopo
se questo scopo è il lucro si parla di SOCIETA'
se lo scopo non è lucrativo si parla di ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI,COMITATI
Si ricorda che l'art 18 della Costituzione dice “I cittadini hanno il diritto di associarsi liberamente
per fini non vietati dalle leggi penali”
Le ASSOCIAZIONI possono essere
--RICONOSCIUTE , sono organizzazioni di persone, stabili, dotate di personalità giuridica che
perseguono fini non lucrativi (culturale,ricreativo, assistenziale): sorgono con atto costitutivo
pubblico, hanno uno statuto che delinea diritti e doveri degli associati, sono aperte ad altri,sono
governate da un'assemblea dei soci cui spetta il compito di indirizzo generale, e da amministratori
eletti dall'assemblea alla quale rispondono e che rappresentano l'organo esecutivo; hanno autonomia
patrimoniale perfetta
--NON RICONOSCIUTE , sono organizzazioni di persone, stabili, prive di personalità giuridica,
perseguono fini non lucrativi. hanno autonomia patrimoniale imperfetta e questo vuol dire che un
creditore dell'ente può rifarsi sul patrimonio dei soci; hanno uno statuto e un presidente; dal 1997
anche questi enti possono acquistare immobili o donazioni.
NOTA: il cosiddetto “riconoscimento” può avvenire per legge o per iscrizione in appositi registri:
la scelta di effettuare o meno il riconoscimento dipende per lo più da ragioni di praticità: una
associazione non riconosciuta infatti presenta una maggiore snellezza di gestione essendo priva di
controlli pubblici.
FONDAZIONI sono istituzioni dotate di capacità giuridica con un patrimonio vincolato a uno
scopo scientifico,assistenziale o culturale;hanno solo gli amministratori su cui si esercita un rigido
controllo pubblico
COMITATI sono gruppi che sorgono di solito per la raccolta di fondi destinati a uno scopo ben
definito; vengono assimilati alle fondazioni in quanto anche qui abbiamo un fondo, proveniente
dalla raccolta, destinato ad uno scopo es un comitato di festeggiamento per il santo patrono: da
rilevare che, se non è stato chiesto il riconoscimento, i componenti del comitato ( ma non i
sottoscrittori cioè quelli che offrono l'oblazione) rispondono con il loro patrimonio degli obblighi
assunti.
www.unictblog.com 13
Scaricato da Giovanni Porta (portagiovanni358@gmail.com)
lOMoARcPSD|7648598
CAP 8 L'OGGETTO DEL RAPPORTO GIURIDICO (pagg 86-88)
E' il bene cioè tutto ciò che è in grado di soddisfare un bisogno umano sia economico che spirituale.
L'uomo per natura tende a tali beni, cioè ha INTERESSE per questi beni e la legge tende a tutelare
questo interesse, assicurando a ciascuno i beni necessari a soddisfare i propri bisogni.
CAP 9 FATTI ATTI E NEGOZI GIURIDICI (pagg 89-100 )
I fatti giuridici sono quell'insieme di fatti umani o naturali che producono effetti giuridici: dormire o
leggere sono fatti umani che non possono produrre effetti giuridici, a meno che tu, addetto alla
sorveglianza della Bank of America, non lo faccia in servizio e avvenga una rapina: si tratta quindi
di distinguere i fatti giuridici da quelli che non lo sono e inquadrarli in una sottocategoria
Infatti la categoria generale dei fatti giuridici viene distinta in sottocategorie a seconda della
rilevanza che ,per ciascuna di esse, assumono la coscienza e la volontà:
La COSCIENZA è la consapevolezza di sé e del mondo esterno, capire quello che si sta facendo:
giuridicamente si definisce come CAPACITA' DI INTENDERE;
la VOLONTA' è la capacità di autodeterminarsi cioè di decidere liberamente il proprio
comportamento : CAPACITA' DI VOLERE
In mancanza anche di uno solo di questi requisiti si avrà un atto irriflesso:il demente non ha
capacità di intendere e volere, il cleptomane ha capacità di intendere ma non ha capacità di volere
Le sottocategorie sono:
1)..MERI FATTI GIURIDICI: si riferiscono a accadimenti naturali o cmq fatti indipendenti dalla
volontà umana; qui ciò che conta è l'accadimento es alla morte di una persona si apre la
successione:l'effetto, cioè la successione, si collega all'accadimento,cioè alla morte della persona, a
prescindere dal fatto che la morte sia dovuta a cause naturali (morte per vecchiaia) o all'azione
umana (morte per omicidio)
2)..ATTI GIURIDICI: in cui rientrano gli eventi derivati da un'azione umana che richiedono la
capacità di intendere e volere; gli atti giuridici si distinguono, a loro volta in
-ATTI GIURIDICI IN SENSO STRETTO azione umana che richiede capacità di intendere e
volere non importa se il soggetto non voleva o ignorava gli effetti: se tu hai “riconosciuto” un figlio
naturale non puoi dopo piagnucolare che non sapevi o non credevi che ti toccasse anche mantenerlo.
-NEGOZI GIURIDICI: sono azioni non solo volontarie ma anche intenzionali:
il negozio è la possibilità di decidere in piena autonomia ciò che è conveniente ai propri interessi.
Se faccio un contratto di vendita, non solo decido il quanto e il come, ma esprimo anche la volontà
di avvalermi delle disposizioni di legge sui contratti.
Negozio giuridico, pertanto, può essere definito come ogni manifestazione di volontà dell'uomo
finalizzata ad avvalersi degli effetti previsti dalla legge e tutto questo per regolare i propri interessi.
Questa manifestazione di volontà può essere una dichiarazione scritta o orale ma anche
un'operazione materiale: salire su un autobus,secondo la giurisprudenza, equivarrebbe a esprimere
la volontà di stipulare un contratto di trasporto con la ditta.
Se la volontà si manifesta da una sola parte si parla di negozio giuridico unilaterale(es testamento);
se invece viene da due parti si parla di negozio bilaterale (un contratto di compravendita ad es).
Altre classificazioni sono:negozi tra vivi (inter vivos) e mortis causa che hanno effetti dopo la morte
(testamento), negozi familiari (matrimoni,adozioni),negozi patrimoniali (compravendite) che
possono essere a titolo oneroso,quando prevedono un corrispettivo oppure a titolo gratuito.
La RINUNZIA è l'atto unilaterale con cui un soggetto dismette un suo diritto es rinuncia a beni
mobili o immobili.
www.unictblog.com 14
Scaricato da Giovanni Porta (portagiovanni358@gmail.com)
lOMoARcPSD|7648598
CAP 14 I BENI (pagg 128-135)
Nel linguaggio comune BENE è tutto ciò che arreca utilità all'uomo in quanto soddisfa un suo
bisogno; in senso giuridico invece bene è ciò che forma oggetto di diritti (art 810): l'aria ad es che è
un bene comune,non è un bene giuridico perchè nessuno può vantare diritti su di essa cioè nessuno
può appropriarsene a meno che non sia racchiusa in bombole.
Costituiscono beni le cose materiali ma anche onore, rispetto cioè cose immateriali
Si distinguono beni mobili e immobili:
BENE IMMOBILE è il suolo e tutto ciò che, per natura o artificialmente, è incorporato ad esso
BENE MOBILE è tutto ciò che non è immobile (art 812)
Questa distinzione non è solo didattica : la compravendita di un bene immobile richiede infatti la
forma scritta e la registrazione; quella di un bene mobile no. Fa eccezione a questa regola una
particolare categoria, i cosiddetti BENI MOBILI REGISTRATI (auto,navi,aerei)
Si parla di UNIVERSALITA' di mobili quando ci si riferisce a una pluralità di cose appartenenti
alla stessa persona che le ha riunite e destinate a una funzione unitaria es biblioteca o collezione: il
carattere peculiare è che il valore del complesso è superiore alla somma dei componenti:questa
universalità,nata per volontà di chi ad es ha raccolto i libri, viene definita UNIVERSALITA' DI
FATTO; si parla di UNIVERSALITA' DI DIRITTO quando nasce per volontà della legge, la quale
per es ha stabilito che l'azienda è un'universalità perchè è “un insieme di rapporti giuridici
disciplinati in modo unitario.
Non costituisce universalità invece il PATRIMONIO, inteso come insieme dei rapporti attivi e
passivi facenti capo a uno stesso soggetto (quindi comprende debiti e crediti)
COSA SEMPLICE è costituita da elementi connessi tra loro e non separabili senza portare alla
distruzione della cosa es un tavolo
COSA COMPOSTA è costituita da elementi di per sé distinti e autonomi es automobile: la
differenza con l'universalità sta proprio nella fisicità dell'unione dei componenti
Sono DIVISIBILI i beni il cui frazionamento non altera la funzione economica delle parti risultanti
e ne mantiene il valore es edificio e appartamenti
PERTINENZE:sono beni destinati a servizio o ornamento di un altro, non costituiscono parte
dell'elemento principale ma ne accrescono il valore o l'utilità es area a parcheggio:la regola è
accessorium sequitur principale cioè la vendita dell'immobile comprende anche l'area parcheggio.
FRUTTI:sono beni che provengono da altri beni es prodotti agricoli (FRUTTI NATURALI) o
interessi che provengono da capitali (FRUTTI CIVILI):ne beneficia il titolare del bene originario.
BENI FUNGIBILI :beni sostituibili con altri dello stesso genere es denaro con denaro
BENI INFUNGIBILI beni con caratteristiche proprie e uniche es immobili, opere d'arte (anche
denaro es una moneta con un particolare anno di conio)
BENI CONSUMABILI si consumano con l'uso tutte in una volta,si usano una sola volta, non si può
concedere ad altri il godimento es derrate alimentari
BENI INCONSUMABILI è concessa l'utilizzazione a terzi
BENI DETERIORABILI si consumano poco a poco es automobile
BENI PUBBLICI:appartengono a un Ente pubblico: ad es un comune può possedere un locale
esattamente come un privato; ma ci sono beni pubblici di interesse collettivo e cioè:
--1) BENI DEMANIALI che possono appartenere
--allo stato es: la spiaggia appartiene al demanio marittimo, un fiume a quello idrico,una
. caserma a quello militare
--a un ente pubblico territoriale es un cimitero appartiene al demanio comunale
--2) BENI PATRIMONIALI INDISPONIBILI foreste, miniere,reperti archeologici,fauna selvatica.
--3) BENI PATRIMONIALI DISPONIBILI es i beni ecclesiastici (le chiese però sono intoccabili
fino al momento in cui sono sconsacrate)
www.unictblog.com 15
Scaricato da Giovanni Porta (portagiovanni358@gmail.com)
lOMoARcPSD|7648598
CAP 43 LA TRASCRIZIONE ( pagg452-461)
E' una forma di pubblicità dichiarativa che riguarda beni immobili e beni mobili registrati.
Essa si attua riportando su un pubblico registro (Ufficio dei registri immobiliari)gli atti ad es. una
vendita, in modo di consentire a tutti gli interessati di prenderne conoscenza: è necessario allegare
l'atto pubblico o la sentenza o la scrittura privata autenticata e i dati identificativi delle due parti.
La pubblicità dichiarativa non condiziona la validità o l'efficacia degli atti ma solo l'opponibilità ai
terzi, cioè la possibilità di far valere gli atti contro alcune categorie di persone; in altre parole chi
compra un immobile diviene proprietario per effetto del contratto anche se non trascrive il proprio
acquisto.
Il problema potrebbe nascere se il proprietario di un bene lo vende a più persone:in tal caso vale
l'acquisto di data anteriore se non c'è stata nessuna trascrizione; se invece la trascrizione c'è stata,
tra i diversi acquirenti è preferito quello che per primo ha trascritto l'atto, anche se l'acquisto è di
data posteriore e anche se il secondo acquirente è in malafede cioè sapeva: naturalmente tocca poi al
primo acquirente dimostrare di essere il vero proprietario e cioè che la seconda vendita è nulla:
infatti la trascrizione non sana gli eventuali vizi dell'atto di acquisto: per cui nel nostro caso il
venditore disonesto che ha venduto una seconda volta, non poteva farlo perchè a quel punto non era
più il proprietario e quindi il secondo atto di vendita è nullo.
Gli atti soggetti a trascrizione sono (art 2643)
1--- I contratti che trasferiscono la proprietà o che costituiscono o modificano o estinguono diritti
reali di godimento ultranovennale su beni immobili e mobili registrati:ad es
vendita,permuta,donazione,locazione oltre i 9 anni, usufrutto ecc.
2--- Gli atti unilaterali che provocano i medesimi effetti es atti di rinunzia a tali diritti
3--- Le sentenze che provocano gli stessi effetti
Da notare che la trascrizione viene fatta non in base al bene ma in base ai soggetti (doppia
trascrizione :venditore e compratore) per cui nel caso che io volessi sapere se il tizio che mi vuole
vendere un immobile è effettivamente il proprietario, non devo ricercare l'immobile ma il nome del
tizio: di nome in nome si potrebbe arrivare all'acquisto a titolo originario ( di solito per usucapione)
ma se manca uno dei passaggi anteriori le successive trascrizioni non hanno effetto perchè non sono
in grado di rendere note tutte le vicende del bene (viene a mancare il cd Processo di continuità delle
trascrizioni) ma hanno valore cd PRENOTATIVO. Vediamo di spiegare questa complicata faccenda.
A vende a B un terreno ma NON effettua la trascrizione quindi nei registri non c'è nulla.
B vende a sua volta a C ed effettua la trascrizione il 30 giugno
A questo punto sembrerebbe che il terreno sia di C
Ma l'1 luglio A vende a X : X va a guardare il registro delle trascrizioni e, non vedendo nulla a
carico di A, conclude che A è il proprietario e quindi compra tranquillamente e registra in data 2
luglio. Ora la situazione è questa: il terreno è di X perchè l'atto è stato registrato e risulta che X ha
comprato dal legittimo proprietario A mentre della vendita di A a B nei registri non c'è nulla ( e di
conseguenza non vale la vendita di B a C). E' una situazione paradossale perchè C che ha comprato
per primo non ne è proprietario; ma la soluzione c'è: B procede alla trascrizione del suo acquisto da
A: automaticamente le successive trascrizioni hanno effetto e in particolare ha effetto la trascrizione
fatta il 30 giugno tra B e C: a questo punto il proprietario è C (trascrizione 30 giugno) e non X
(trascrizione 2 luglio) perchè la sua trascrizione è ANTERIORE a quella di X
Analoga funzione prenotativa ha la trascrizione delle domande giudiziali e dei contratti preliminari:
la domanda giudiziale è l'inizio di un procedimento giudiziario: se ad es mio fratello si è
appropriato di un immobile che io ritengo sia mio ,avvio il procedimento cioè chiedo a un giudice
di pronunciarsi sulla questione: è opportuno allora trascrivere nei registri immobiliari accanto al
nome di mio fratello, che c'è una causa in corso in modo tale da 1) impedire che nel frattempo mio
fratello venda 2) portare a conoscenza del problema l'eventuale compratore che si renderà conto di
correre il rischio che il suo acquisto venga meno se la sentenza sarà a me favorevole 3) darmi la
possibilità di oppormi all'eventuale compratore. Lo stesso dicasi per il contratto preliminare di
www.unictblog.com 16
Scaricato da Giovanni Porta (portagiovanni358@gmail.com)
lOMoARcPSD|7648598
vendita immobiliare: prometto a Tizio con un contratto preliminare la vendita di un immobile a un
determinato prezzo e successivamente ne sottoscrivo un altro con un acquirente che mi offre di più.
Tizio non può opporsi perchè io furbo posso mettere sul secondo contratto una data antecedente a
quella del primo; ma non potrò usare questo trucco se Tizio ha provveduto alla trascrizione del suo
contratto e ha quindi l'opportunità di opporsi a terzi.
NOTA: latrascrizione ha funzione costitutiva nel caso dell'ipoteca(vedi pag 5) e nell'usucapione (per
impedire l'usucapione non basta l'atto di intimazione ma occorre anche la trascrizione dell'atto)
CAP 45 PRESCRIZIONE E DECADENZA (pagg 470-476)
La PRESCRIZIONE è l'estinzione dei diritti dovuta all'inerzia del titolare che non li esercita nei
tempi previsti dalla legge (art 2934)es se smarrisco una cambiale a mio favore e la ritrovo dopo 10
anni non posso pretenderne il pagamento; sono soggetti a prescrizione tutti i diritti assoluti e relativi
con esclusione di quelli indicati dalla legge e in particolare le azioni volte a far dichiarare la nullità
di un atto e la proprietà ad es se vendo un fondo e il contratto per qualche motivo è nullo, posso
fare dichiarare la nullità della vendita in qualsiasi momento (certo se passano più di 20 anni scatta
l'usucapione e il fondo non mi sarà restituito).La prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può
essere fatto valere e finisce allo spirare dell'ultimo giorno del termine.
La prescrizione è una norma inderogabile, non si può escluderla o modificarla e vi si può rinunciare
solo dopo che essa si sia compiuta. Sono previsti gli istituti della INTERRUZIONE E
SOSPENSIONE che interrompono e sospendono il decorso del tempo richiesto per la prescrizione:
--Interruzione è causata da domande giudiziali e atti di costituzione in mora: se, nel caso della
cambiale, entro i 10 anni intimo al debitore di restituire il denaro, la prescrizione viene interrotta e
ricomincia cioè devono passare altri 10 anni
--Sospensione se durante i 10 anni, io creditore sono stato impossibilitato a esercitare il mio diritto
perchè ad es sono stato per 2 anni in ospedale, per questi 2 anni la prescrizione è sospesa cioè non si
contano.
In base alla durata possiamo distinguere:
1---PRESCRIZIONE ORDINARIA: 10 anni, vale per tutti i diritti per i quali non sia disposto
diversamente
2---PRESCRIZIONE BREVE varia da 5 anni (risarcimenti da danni, pigioni) a 2 (risarcimento da
sinistri stradali)
Si prescrivono invece in 20 anni i diritti reali di godimento su beni altrui.
PRESCRIZIONE PRESUNTIVA è un istituto per il quale ,trascorso un certo periodo di tempo,un
diritto si PRESUME estinto: es passo una settimana di ferie a Rimini;certo la ricevuta dell'hotel non
la conserverò per molto e l'albergatore dopo 1 anno potrebbe accusarmi di non aver pagato; la legge
tutela il debitore in quei casi in cui il pagamento avviene senza rilascio di quietanza (medico-
paziente) o nei casi in cui, data l'esiguità del valore,il debitore non conserva a lungo la quietanza
( oste-cliente): la legge prevede che ,passato un breve lasso di tempo, il debito possa presumersi
estinto. La durata è varia: sei mesi (osti e albergatori),1 anno (lezioni private inferiori a 1
mese,convitti,farmacisti,commercianti al dettaglio) 3 anni (professionisti,notai ecc)
L'unica arma che il creditore ha per dimostrare il suo credito è il giuramento decisorio del debitore o
la sua confessione.
DECADENZA: a volte la legge impone a chi voglia conservare un diritto, di compiere uno
specifico atto che rappresenta la volontà del soggetto che lo compie di avvalersi del diritto:questo
atto specifico ha un termine di tempo, trascorso il quale si ha la decadenza cioè il soggetto non può
più esercitare quel diritto; decadenza è dunque l'estinzione di un diritto dovuta all'oggettivo
decorrere del tempo fissato dalla legge.
La decorrenza non può essere né interrotta né sospesa ma solo impedita: se il compratore riscontra
vizi nella cosa venduta è tenuto a farne denunzia entro 8 gg dalla scoperta, pena la decadenza del
suo diritto al rimborso o alla sostituzione: fatta la denuncia, la decadenza viene impedita: dopodichè
ho 1 anno per agire eventualmente in giudizio (prescrizione)
www.unictblog.com 17
Scaricato da Giovanni Porta (portagiovanni358@gmail.com)
lOMoARcPSD|7648598
Sono previsti due tipi di decadenza:
LEGALE prevista nell'interesse generale o di uno dei soggetti; è irrinunciabile
CONVENZIONALE le parti possono determinare i termini temporali però entro certi limiti: ad es
non si possono stabilire 3 gg anziché 30 per l'impugnazione delle delibere dell'assemblea
condominiale perchè ciò renderebbe difficoltoso l'esercizio del diritto.
CAP 11 e 12 I DIRITTI : GENERALITA' (pagg 105-122)
I diritti soggettivi si distinguono in ASSOLUTI e RELATIVI
Quelli relativi si possono far valere solo nei confronti di determinate persone: ad es se ho un credito
verso una persona il mio diritto di essere pagato vale solo per quella persona e per poterlo esercitare
ho bisogno dell'intervento attivo di quella persona (cioè che mi paghi)
I diritti assoluti si possono far valere nei confronti di tutti e per poterli esercitare non ho bisogno di
alcun intervento attivo da parte di altri i quali si devono semplicemente astenere dal violare i miei
diritti.
I diritti assoluti si distinguono in
--- diritti assoluti che si riferiscono a interessi NON patrimoniali e sono i DIRITTI DELLA
PERSONA come il diritto alla vita, alla integrità fisica,all'onore, al nome,alla identità sessuale
all'immagine, alla riservatezza. Sono inviolabili,inalienabili e garantiti dalla Costituzione(art 2 e ss).
--- diritti assoluti che si riferiscono a interessi patrimoniali : sono la proprietà, l' usufrutto ecc.e
vengono definiti DIRITTI REALI.
CAP 13 CARATTERI DEI DIRITTI REALI (pagg 123-127)
Diritti reali sono i diritti su una cosa e infatti “reale” deriva da “res” cioè “cosa”
Si distinguono in 2 categorie:
1)Diritti riguardanti una cosa propria : PROPRIETA'
2)Diritti riguardanti una cosa altrui : DIRITTI REALI MINORI es servitù,usufrutto ecc.
Caratteri dei diritti reali sono:
1---IMMEDIATEZZA: il rapporto tra soggetto e cosa è diretto, non mediato da alcuno,pertanto il
diritto si realizza immediatamente
2---INERENZA ALLA COSA: si traduce nell'opponibilità erga omnes cioè nella possibilità di farlo
valere verso chiunque
3---FACOLTA' DI SEGUITO o SEQUELA: tali diritti possono farsi valere anche nei confronti di
chi venga ad acquistare uno specifico diritto sullo stesso bene: se sono titolare di una servitù, cioè
ho il diritto di passaggio attraverso un fondo altrui, conserverò tale diritto anche se il fondo cambia
proprietà
4---ELASTICITA': il diritto può espandersi: se su un fondo mio è costruito un edificio questo è mio,
cioè la proprietà del suolo si estende all'edificio
5---TIPICITA':non è consentito ai privati di creare nuove categorie o tipi di diritti reali (numerus
clausus)
6---ASSOLUTEZZA: in contrapposizione alla RELATIVITA' dei diritti di credito: ad es una cosa è
concedere il passaggio al vicino Tizio per permettergli di raggiungere il suo fondo, instaurando una
servitù (in tal caso la servitù si mantiene anche se cambiano i proprietari: assolutezza), altra cosa è
se questa concessione viene fatta a titolo personale cioè solo a Tizio e a nessun altro (relatività)
7---IMPRESCRITTIBILITA':sono soggetti a prescrizione solo diritti reali minori
www.unictblog.com 18
Scaricato da Giovanni Porta (portagiovanni358@gmail.com)
lOMoARcPSD|7648598
CAP 15 LA PROPRIETA' (pagg136-156)
La proprietà è il primo e fondamentale fra i diritti reali e l'art 832 cc ne descrive il contenuto:
“è il diritto di GODERE e DISPORRE delle cose in modo PIENO ed ESCLUSIVO, entro i limiti
stabiliti dall'ordinamento giuridico.
Il diritto di GODERE delle cose consiste nella facoltà di utilizzare il bene perseguendo interessi e
fini liberamente scelti: il proprietario può quindi decidere come e quando utilizzare la cosa,
trasformarla o lasciarla inutilizzata.
Il diritto di DISPORRE consiste nella facoltà di alienare un bene o di costituire su di esso diritti
reali in favore di terzi: il proprietario può quindi vendere o donare, dare in pegno ecc.;
la PIENEZZA sta nel fatto che il proprietario può fare tutto ciò che non è espressamente vietato;
l'ESCLUSIVITA' consiste nella facoltà di escludere tutti coloro che non abbiano un diritto
concorrente per poter esercitare poteri o facoltà sulla cosa.
La costituzione (art 42) riconosce e garantisce la proprietà privata e ,subito dopo, parla di una sua
FUNZIONE SOCIALE :come è possibile che una proprietà privata possa avere una qualche
importanza per la collettività se privato e pubblico sono due cose opposte?
Il fatto è che, se fino al periodo della rivoluzione industriale la proprietà, intesa prevalentemente
come proprietà terriera, era il fondamento dell'economia, successivamente questa importanza è via
via diminuita a favore dell'industria e dell'impresa: la conseguenza è che oggi la legge non vede più
la proprietà come un FINE da raggiungere ma un MEZZO per la promozione umana e in tal senso
l'interesse generale va prevalendo su quello privato: questo concetto diventa chiaro se andiamo a
vedere le limitazioni sempre più numerose che la legge stabilisce nei confronti del diritto di
proprietà e questo sia nell'interesse pubblico (espropriazione per motivi di interesse generale, i
vincoli legati a beni culturali o ai parchi naturali o cmq connessi alla salvaguardia dell'ambiente),
sia nell'interesse privato ( distanze, luci e vedute).
Sono tali e tanti questi limiti che non si può + parlare di un istituto unitario, cioè di UNA disciplina
che regola la proprietà, ma di TANTE discipline che regolano altrettanti tipi di proprietà ognuna
delle quali ha i suoi limiti, basti pensare ad es che terreni agricoli e terreni edificabili sono regolati
da norme diversissime tra di loro.
Quindi l'interpretazione delle leggi esistenti (e di quelle future) si basa sull'equilibrio tra funzione
sociale e interesse privato inteso come interesse concreto non generico: ad es scavare a grande
profondità una miniera sotto un fondo, non è che lede l'interesse concreto del proprietario del fondo,
per cui si può fare anche se in linea di massima il sottosuolo è di sua proprietà.
Il codice civile si occupa innanzitutto della proprietà fondiaria, distinguendola in proprietà agricola
o rurale e proprietà edilizia.
Alla proprietà fondiaria in generale sono dedicati gli art 840-845 che stabiliscono norme generiche:
----l'estensione verticale: parte dal sottosuolo e si estende in altezza ma non come dicevano i romani
dagli inferi agli astri: il proprietario non si può opporre né alle miniere né alle teleferiche.
----L'estensione orizzontale con i CONFINI che impediscono agli estranei di accedere al fondo
Limiti e obblighi specifici sono dettati per i rapporti di vicinato cioè tra proprietà vicine: questi
vincoli sono RECIPROCI in quanto il sacrificio di ciascuno è compensato dal vantaggio derivante
dall'analogo limite in capo al vicino; sono AUTOMATICI in quanto nascono direttamente dalla
legge; infine sono GRATUITI perchè non richiedono il pagamento di alcuna indennità.
Importanti sono le regole in tema di IMMISSIONI cioè le propagazioni derivanti a un fondo dalla
attività svolta in un altro: propagazione di fumo, rumori, calore, scuotimenti.: la regola generale è
che il proprietario non può impedire le propagazioni derivanti dal fondo vicino se non superano la
normale tollerabilità: si tratta quindi di ripercussioni indirette ,involontarie cioè non conseguenze di
attività voluta.
Un ulteriore criterio è dato dalla necessità di contemperare le esigenze di produzione con le ragioni
della proprietà: questo vuol dire che sono in qualche modo autorizzate immissioni tollerabili
www.unictblog.com 19
Scaricato da Giovanni Porta (portagiovanni358@gmail.com)
lOMoARcPSD|7648598
derivanti da attività produttive anche se di recente si è consolidato l'orientamento per cui il giudice
deve previamente accertare se queste immissioni siano riducibili con l'adozione di idonei
accorgimenti tecnici.
La PROPRIETA' AGRICOLA, una volta importante tanto da essere contemplata dalla Costituzione,
è regolata dagli art 849-868 con riferimento a bonifiche, vincoli idrogeologici, vincoli boschivi e
,art 909-911, disciplina delle acque private(oggi tutte le acque superficiali e sotterranee sono
pubbliche)
La PROPRIETA' EDILIZIA, non contemplata dalla Costituzione,è regolata dall'art 869 e ss:
regolamentazione per le distanze da osservarsi fra gli edifici e fra altri manufatti
DISTANZA TRA EDIFICI art 873 :le costruzioni su fondi vicini devono essere realizzate in
aderenza ovvero tenute a una distanza non inferiore a 3 metri (una distanza maggiore è ormai quasi
ovunque stabilita dagli strumenti urbanistici) :la scelta fra le due è affidata al criterio della
prevenzione temporale: chi costruisce per primo può scegliere se edificare al confine o ritirarsi a
una distanza di un metro e mezzo.
DISTANZE PER ALTRI MANUFATTI E IMPIANTI: una regola analoga vale anche per altri
manufatti che devono essere tenuti a distanza dal confine per preservare i fondi vicini da ogni danno
pozzi, alberi ecc.
LUCI E VEDUTE:riguarda l'apertura di finestre negli edifici:
LUCI sono aperture che danno passaggio a luce e aria ma non permettono di affacciarsi sul fondo
del vicino e possono essere aperte liberamente anche nel caso di muro contiguo, ma il vicino potrà
chiudere ove costruisca in aderenza al muro stesso
VEDUTE sono aperture che consentono di affacciarsi e poter guardare, quindi hanno
l'inconveniente di esporre il vicino alla curiosità altrui e perciò devono essere tenute a una certa
distanza dal confine: 1,5 m per le vedute dirette, 0,75 m per le vedute laterali e oblique
Per la proprietà edilizia vale più che mai il concetto di funzione sociale: il proprietario non ha più
un totale ius aedificandi: può costruire solo nei limiti del piano regolatore (previo rilascio di un
permesso) e delle disposizioni di salvaguardia dei beni ambientali,storici, artistici ecc.
MODI DI ACQUISTO DELLA PROPRIETA' (art 922 e ss)
--- a titolo derivativo presuppongono un precedente titolare del diritto da cui è derivato l'acquisto
stesso tramite un titolo (ad es un atto di vendita) che trasferisce il diritto con gli stessi caratteri: es se
c'era un'ipoteca questa rimane (SUCCESSIONE NELLO STESSO DIRITTO)
---a titolo originario: acquisti che non presuppongono un precedente diritto di altri (es una casa che
ho costruito io sul mio terreno):la proprietà quindi si acquista libera da diritti altrui sulla cosa e si
parla di DIRITTO NUOVO
I modi di acquisto a titolo originario sono (oltre all'usucapione e al possesso titolato):
1--- OCCUPAZIONE: è la presa di possesso di cose mobili non appartenenti ad alcuno (RES
NULLIUS) o di cose abbandonate dal proprietario (RES DERELICTAE). Anche le RES
COMMUNES OMNIUM sono suscettibili di occupazione(es aria in bombole). Funghi e tartufi
appartengono a questa categoria
2---INVENZIONE è il ritrovamento di cose mobili smarrite dal proprietario. Il ritrovatore ne
acquisisce la proprietà se, dopo la consegna al Sindaco, il proprietario non le reclami entro 1 anno
(e darà in tal caso al ritrovatore un premio proporzionato). Nel caso di un tesoro, salvi i diritti dello
stato sulle cose di interesse artistico e archeologico, si considera di proprietà di chi ha il fondo se lo
trova lui, se lo trova un altro a questi spetterà la metà.
3---ACCESSIONE è l'acquisizione della proprietà di un bene per effetto della sua congiunzione con
un altro considerato principale: a seconda se la cosa è mobile o immobile si hanno:
A)—accessione DA MOBILE A MOBILE
-prende il nome di UNIONE quando più cose appartenenti a proprietari diversi vengono unite o
mescolate a formare un sol tutto: in tal caso la proprietà diventa comune in proporzione al valore;
www.unictblog.com 20
Scaricato da Giovanni Porta (portagiovanni358@gmail.com)
lOMoARcPSD|7648598
ma se una di queste appare principale, il suo possessore diventa proprietario del tutto con obbligo di
rimborso per gli altri(es uso di pezzi di ricambio per l'auto).
-prende il nome di SPECIFICAZIONE quando + cose formano una cosa NUOVA ad es con
legname altrui un artigiano costruisce un tavolo: il tavolo è suo (con il pagamento del legname
ovviamente)
B)---accessioni DA IMMOBILE A IMMOBILE dette INCREMENTI FLUVIALI caratterizzate dal
fatto che in seguito a modificazioni del regime o del corso delle acque, si verificano mutamenti
nell'assetto di fondi confinanti: oggi tali incrementi sono attribuiti al demanio pubblico per motivi di
salvaguardia ambientale;
AVULSIONE è l'unica ipotesi di accessione a una proprietà privata art 944 e si ha quando una parte
di un fondo viene staccata dalle acque e portata a valle dove si unisce a un altro fondo.
C)---accessione da MOBILE A IMMOBILE cd ACCESSIONE AL SUOLO : qualsiasi piantagione
o opera realizzata sopra o sotto il suolo ,appartiene al proprietario del fondo anche se l'opera è stata
realizzata da terzi : in tal caso il proprietario del suolo può richiederne la rimozione o , se preferisce
tenerla, dovrà pagare la minor somma tra lo speso e il migliorato. Ipotesi particolare è
l'ACCESSIONE INVERTITA : se una costruzione occupa parte del suolo del vicino e il costruttore
sia in buona fede ,egli può chiedere al giudice di attribuirgli anche la proprietà del suolo occupato,
previo pagamento del doppio del valore del suolo.
TUTELA DELLA PROPRIETA' artt 948-951
La legge tutela la proprietà permettendo di reagire alla violazione del diritto tramite:
1)---la RIVENDICAZIONE : il legittimo proprietario può rivendicare la cosa da chiunque la
possiede o detiene: qui i soggetti sono 2 cioè il legittimato attivo ( chi sostiene di essere il
proprietario e dovrà dimostrare tale qualità ma è necessario il titolo originario di acquisto,non basta
il titolo derivativo) e il legittimato passivo (chi possiede o detiene la cosa ed è tenuto alla
restituzione o ,in mancanza, a pagarne il valore oltre al risarcimento danni); da rilevare che il
legittimato passivo non è tenuto a dimostrare a quale titolo possiede o detiene la cosa;tale prova
tocca al legittimato attivo; non c'è prescrizione. La rivendicazione ha due funzioni: la restituzione e
l'accertamento della titolarità del diritto di cui la prima è la principale (carattere petitorio)
2)---AZIONE NEGATORIA è concessa al legittimo proprietario per far negare l'esistenza di diritti
parziari altrui sulla sua cosa: al legittimato attivo ( proprietario) basterà presentare un titolo
derivativo di acquisto e toccherà al legittimato passivo (chi pretende di avere diritti sulla cosa )
presentare le sue prove
3)---AZIONE DI REGOLAMENTO DEI CONFINI suppone un'incertezza sulla posizione dei
confini tra due fondi che bisogna accertare: l'azione pertanto ha solo scopo di accertamento e si
distingue dalla rivendicazione in quanto è ammessa ogni tipo di prova che incombe ad ambedue le
parti: in mancanza di prove ci si affida alle mappe catastali
4)---AZIONE PER APPOSIZIONE DI TERMINI presuppone la certezza o comunque la non
contestazione dei confini e ha lo scopo di far apporre a spese comuni, i termini cioè i segnali di
riconoscimento.
www.unictblog.com 21
Scaricato da Giovanni Porta (portagiovanni358@gmail.com)
lOMoARcPSD|7648598
CAP 16 I DIRITTI REALI DI GODIMENTO ( pagg157-172)
Attribuiscono un potere su una cosa altrui. In quanto appartenenti alla categoria dei diritti reali
godono di tutte le caratteristiche, inerenza, assolutezza,elasticità,tipicità ecc.
Si dicono minori o parziari per il loro contenuto ristretto che talvolta si riduce a una sola facoltà ad
es solo il passaggio sul fondo altrui e d'altra parte su uno stesso bene possono coesistere più diritti
reali minori purchè di contenuto diverso es servitù e usufrutto.
Inoltre gravano su cosa altrui perchè si tratta di beni di proprietà di altri e limitano le facoltà di altri
e il contenuto del loro diritto, riducendo pienezza ed esclusività.
L'altruità della cosa è essenziale in quanto se il proprietario e il titolare del diritto coincidono nella
stessa persona , il diritto minore si estingue cd CONSOLIDAZIONE.
In ogni caso i diritti minori si estinguono dopo 20 anni di non uso.
La tutela di questi diritti è erga omnes in quanto il titolare del diritto può agire direttamente contro
chiunque si trovi in possesso del bene, al fine della restituzione del diritto o del suo accertamento
(cd confessoria che è il contrario delle negatoria con la quale si NEGA l'esistenza dell'altrui diritto)
I diritti reali di godimento sono: la superficie, l'usufrutto, l'enfiteusi,l'uso, l'abitazione e le servitù.
La SUPERFICIE
Come sappiamo dall'art 934 cc, ogni opera esistente sopra e sotto il suolo appartiene al proprietario
del suolo: nulla vieta però che questo può dare a un altro il diritto di costruire sul proprio terreno
oppure di vendere una casa riservandosi la proprietà del suolo su cui essa è costruita.
La superficie quindi consiste nel diritto di fare una costruzione sopra o sotto il suolo altrui ( IUS
AEDIFICANDI ),oppure separare la proprietà di una costruzione già esistente dalla proprietà del
suolo ( PROPRIETA' SUPERFICIARIA ); si sottolinea che nel caso dello ius aedificandi quello che
si concede è il diritto di costruire ( che dura 20 anni poi si estingue), non la proprietà della
costruzione che appartiene al proprietario del suolo previo indennizzo. In ogni caso si realizza così
una separazione tra proprietà del suolo e proprietà delle opere fatte sopra di esso.
La proprietà superficiaria in quanto proprietà non si prescrive; è molto frequente, basti pensare alle
edicole, alle stazioni di servizio, alle cappelle cimiteriali, ai terreni comunali adibiti a parcheggio.
La costituzione della superficie può avvenire :
---per contratto scritto
---per legge ad es quando ho il diritto di passaggio e per usufruirne devo costruire un terrapieno sul
fondo servente, il terrapieno è mio
---per usucapione
l'estinzione avviene :
---per scadenza del termine se previsto nel contratto
---per consolidazione ( cioè riunione in capo allo stesso soggetto delle qualità di proprietario del
suolo e del superficiario)
---per prescrizione del diritto di costruire (20 anni)
In ogni caso l'estinzione della superficie comporta l'acquisto della costruzione a titolo originario in
capo al proprietario del fondo per accessione senza necessità di accettazione.
L'USUFRUTTO è il diritto di godere di una cosa entro i limiti segnati dal rispetto della sua
destinazione economica (artt 981 e ss)
Attribuisce al titolare ampio potere di godere della cosa altrui traendone ogni utilità che questa può
dare e in questo si avvicina alle situazioni proprietarie ma se ne discosta in quanto vi sono 2
limitazioni una è la durata temporale e l'altra la destinazione economica.
La destinazione economica della cosa rappresenta un limite al potere di godimento ed è tipico
dell'usufrutto: es se è oggetto di usufrutto un appartamento questo non può essere adibito a deposito
( questo non c'è ad es nell'enfiteusi ). Per quanto riguarda la durata temporale questa non può
eccedere la vita dell'usufruttuario e se questi è un ente non oltrepasserà i 30 anni.
www.unictblog.com 22
Scaricato da Giovanni Porta (portagiovanni358@gmail.com)
lOMoARcPSD|7648598
Oggetto dell'usufrutto non è solo il bene materiale ma anche i crediti,i titoli di credito,le azioni.
E' possibile anche che l'usufrutto sia costituito su una cosa consumabile; è evidente che l'utilizzo ne
comporta la perdita e quindi l'impossibilità di restituirla al termine dell'usufrutto: è stabilito in
questo caso che l'usufruttuario potrà servirsi liberamente del bene per poi pagarne il valore di stima
o restituirne un altro dello stesso genere: in questo caso particolare possiamo dire che la proprietà
delle cose passa all'usufruttuario e si parla di “quasi usufrutto”.
Nel caso invece di cose deteriorabili, l'usufruttuario può servirsene secondo l'uso ordinario,pur se
ciò comporti l'usura, e le restituirà nello stato in cui si trovano.
Ampi sono i POTERI dell'usufruttuario:
Può utilizzare la cosa direttamente o indirettamente traendone i frutti naturali e civili che gli
spettano per la durata del suo usufrutto.
Può realizzare miglioramenti e addizioni, cioè incrementi qualitativi (spietratura) e quantitativi (una
vasca per l'acqua): in entrambi i casi l'usufruttuario ha diritto a un'indennità nella misura della
minor somma tra la spesa e il migliorato alla cessazione dell'usufrutto.
Gli OBBLIGHI invece sono connessi alla restituzione della cosa al termine dell'usufrutto oltre che
alle spese di ordinaria manutenzione (le straordinarie e le imposte dominicali toccano al
proprietario) .
L'usufrutto si costituisce per legge (usufrutto dei genitori sui beni dei figli minori), per volontà
privata tramite testamento o contratto o donazione con riserva di usufrutto, oppure si acquisisce per
usucapione.
L'usufruttuario può anche cedere il proprio diritto a terzi mediante atto tra vivi ma non è ammesso il
passaggio da una persona a un'altra al momento della morte in quanto si estingue alla morte del ecc)
titolare; la trasmissione per successione ereditaria è ammessa solo in un caso, quando l'usufrutto sia
stato ceduto a un terzo e questo muoia prima del cedente: in tal caso gli eredi del cessionario
proseguiranno nel godimento del diritto per il periodo restante.
L'estinzione si verifica per scadenza del termine , alla morte dell'usufruttuario,per prescrizione
ventennale, per abuso che l'usufruttuario può fare del suo diritto (ad es se deteriora il bene), per
perimento totale della cosa e per consolidazione.
La SERVITU' ( art 1027 e segg) consiste in un “peso” posto sopra un fondo (detto servente) per
l'utilità di un altro fondo (detto dominante)appartenente a un diverso proprietario. Esso consente
l'utilizzo specifico e circoscritto della cosa altrui ( cd SPECIALITA' della servitù: se la servitù è
quella del passaggio non posso anche attingere acqua) ma in particolare si caratterizza perchè dà
origine a una oggettiva relazione di servitù tra due fondi in virtù della quale la limitazione imposta
al primo fondo avvantaggia il secondo( cd predialità della servitù); inoltre ha carattere di
accessorietà alla proprietà di un immobile nel senso che è legata inscindibilmente ad esso e si
trasferisce automaticamente col trasferimento di proprietà del fondo, sia il servente sia il dominante
( in altre parole si mantiene anche se cambiano i proprietari dei due fondi).
Gli elementi costituenti la servitù sono dunque:
1)---Il PESO sul servente che costituisce una limitazione della facoltà di godimento del bene e può
consistere nel permettere (il passaggio sul fondo o l'attingere acqua) o nel non permettere (ad es non
costruire o non piantare alberi di alto fusto): l'azione del servente si esaurisce qui, non deve FARE
nulla: se per contratto è tenuto ad es a spurgare l'acquedotto che passa sul suo terreno, questo esula
dalla servitù; si tratterebbe di un'OBBLIGAZIONE PROPTER REM
2)---L'UTILITA' del fondo dominante che può consistere in qualsiasi vantaggio ,economico o
no,purchè stabile e oggettivo cioè non deve riguardare personalmente il titolare del diritto (non è
ammessa una servitù del tipo entro nel tuo fondo per cacciare o pescare; se hai il diritto di attingere
acqua è per irrigare il tuo terreno non per venderla)
3)---DIVERSITA' DEI PROPRIETARI DEI DUE FONDI
Le servitù possono essere, riguardo il contenuto, negative (se vietano) o positive (se
permettono);discontinue se richiedono l'azione dell'uomo(es passaggio) o continue se non lo
richiedono es un acquedotto sta lì e basta.
www.unictblog.com 23
Scaricato da Giovanni Porta (portagiovanni358@gmail.com)
lOMoARcPSD|7648598
Riguardo il modo di costitursi, si distinguono:
---le servitù coattive: sono quelle che si costituiscono forzosamente con sentenza del giudice per
assicurare un servizio di interesse generale (es acquedotto o elettrodotto) o perchè non c'è accordo
tra le parti (ad es. si rifiuta il passaggio a un fondo che altrimenti resterebbe isolato)
---servitù volontarie: sono quelle che si costituiscono per atto negoziale, usucapione e destinazione
del padre di famiglia: esse dipendono dalla volontà delle parti che sono libere di determinarne il
contenuto: servitù di vedute,diritti di passaggio anche se vi sono altri accessi al fondo ecc.
In via negoziale possono costituirsi per testamento o per contratto
Possono anche costituirsi per usucapione o per destinazione del padre di famiglia che è un modo
peculiare di acquisto ( a titolo originario) della servitù e ha luogo quando i due fondi divisi sono
appartenuti allo stesso proprietario il quale ha realizzato opere tali da asservire un fondo all'altro: se
la proprietà viene successivamente divisa, la servitù si costituisce automaticamente, ma si deve
trattare di opere tangibili ( si parla in tali casi di SERVITU' APPARENTI).
Una servitù si estingue:
per rinuncia scritta
per confusione quando il proprietario dei fondi diventa unico,
per prescrizione cioè per mancato uso per 20 anni,ad es. a partire dall'ultimo passaggio (per le
servitù discontinue) o dal giorno in cui l'acquedotto ha cessato di funzionare perchè il pozzo si è
esaurito ( per le discontinue).
ENFITEUSI
Attribuisce al titolare (enfiteuta) lo stesso potere di godimento che spetta al proprietario, salvo
l'obbligo di migliorare il fondo e di pagare un canone periodico (art 959).
E' una figura di antica tradizione ma oggi molto meno diffusa: una volta infatti rispondeva
all'esigenza di favorire la coltivazione del latifondo e dei terreni abbandonati: il proprietario aveva
una rendita assicurata, l'enfiteuta aveva i suoi vantaggi per la tendenziale perpetuità del rapporto e
per la possibilità di acquistare la piena proprietà tramite l'affrancazione.
L'enfiteuta ha pieni poteri simili a quelli del proprietario (può cambiare la destinazione economica
del fondo, può costruire,può costituire diritti di servitù) mentre gli obblighi riguardano i
miglioramenti e il pagamento di un canone che ,per le enfiteusi rustiche, non può superare il reddito
dominicale; di rilievo la possibilità da parte dell'enfiteuta di ottenere l'affrancazione, cioè diventare
proprietario a pieno titolo, pagando una somma pari a 15 volte il canone annuo ( è un diritto
POTESTATIVO); d'altra parte il concedente ha il diritto di ottenere la devoluzione ( per la
mancanza di miglioramenti o per ritardato pagamento di 2 anni di canone) che comporta l'estinzione
dell'enfiteusi.
Prescrizione estintiva di 20 anni di non uso.
USO E ABITAZIONE
Si considerano sottospecie di usufrutto caratterizzate da una facoltà di godimento limitata ai bisogni
del titolare e della sua famiglia; sono personali e non possono essere ceduti.
L'uso è il diritto di servirsi di una cosa e di raccoglierne i frutti per bisogni personali e familiari
L'abitazione è il diritto di abitare una casa per bisogni familiari.
Hanno scarso riscontro nella pratica, però l'art 540 cc prevede a favore del coniuge superstite il
diritto di abitazione della casa familiare e di uso dei mobili che la corredano.
www.unictblog.com 24
Scaricato da Giovanni Porta (portagiovanni358@gmail.com)
lOMoARcPSD|7648598
CAP 18 IL POSSESSO ART 1140 e segg (pagg181-194 )
Il possesso NON è un diritto (la proprietà si), ma una situazione di fatto per cui un soggetto gode di
un bene a prescindere dalla circostanza che ne abbia o meno il diritto; la legge infatti ha la tendenza
a tutelare, immediatamente e senza alcuna preventiva indagine, la situazione possessoria di fatto: il
possessore ad es un ladro non deve giustificare i suoi poteri sulla cosa (possideo quia possideo) e
nel caso in cui sia privato del possesso può ottenere un'immediata reintegrazione, anche contro lo
stesso proprietario legittimo.
Questa situazione pazzesca è giustificata dalla giurisprudenza con la necessità di garantire la pace
sociale e cioè il proprietario che si vede spogliato del suo bene può resistere all'altrui violenza solo
mentre essa è in atto (legittima difesa); passato questo momento,non può riprendersi il bene con la
forza ma può tutelarsi con le azioni a difesa del possesso perduto.
Un'altra ragione della tutela del possesso in capo a chi non avrebbe diritto è l'intento di premiare
chi, a differenza del proprietario assenteista, utilizza il bene e lo mette a frutto (ad es chi coltiva un
fondo lasciato incolto dal proprietario).
La situazione possessoria può anche presentarsi come una situazione di esercizio solo INDIRETTO
del potere sulla cosa, realizzato tramite un'altra cosa;es quando il possessore lascia la cosa in
custodia a un'altra persona: in questo caso il possessore non perde il controllo sulla cosa ma
continua a esercitare un potere su di essa tramite un altro soggetto che ne ha la detenzione cioè la
materiale disponibilità.
Possiamo quindi distinguere:
1) il possesso vero e proprio che consiste nell'esercizio diretto dei poteri sulla cosa
2) il possesso mediato tramite un terzo che ne ha la detenzione cioè la materiale disponibilità
Il possesso è formato quindi da due elementi:
1) un elemento oggettivo: la materiale disponibilità della cosa ( corpus )
2) un elemento soggettivo: l'intenzione di tenere la cosa per sé ( animus )
La detenzione è invece formata solo dall'elemento oggettivo e implica l'obbligo della restituzione.
Inoltre il possessore esercita i poteri sempre nel proprio interesse e non per conto di altri, mentre
i poteri che il detentore può esercitare dipendono dallo scopo particolare per il quale il bene è stato
consegnato (affido un bene al detentore affinchè lo custodisca o lo amministri o lo affitti ecc)
Mentre la detenzione può acquistarsi solo in modo derivativo presupponendo quindi un possessore
dal quale si riceve la cosa, il possesso può acquistarsi anche in modo originario:
1) nell'ipotesi di acquisto della proprietà a titolo originario(accessione,occupazione,invenzione)
2) nell'ipotesi di mutamento della detenzione in possesso
3) quando il possesso sia conseguito con la materiale apprensione del bene altrui (es furto).
Parliamo invece di acquisto derivativo quando il possesso viene trasmesso dal precedente
possessore tramite la consegna della cosa sia essa materiale o simbolica (es consegna chiavi di un
immobile).
Il MUTAMENTO della detenzione in possesso può avvenire solo per una delle seguenti ragioni:
1)..CAUSA PROVENIENTE DA UN TERZO il quale afferma di essere proprietario e trasferisce il
diritto di proprietà al detentore
2)..ad opera del detentore (OPPOSIZIONE) che rende noto al possessore in qualunque modo ( sia
con atti giudiziari e extragiudiziari che con atti univoci) la sua intenzione di detenere la cosa non
più in nome del possessore ma in nome e per conto proprio.
Le circostanze che qualificano il possesso sono:
1)lo stato psicologico del soggetto al momento dell'acquisto: buona o mala fede: possessore in
buona fede è quello che possiede ignorando di ledere l'altrui diritto
2)le modalità di acquisto:viziato o non viziato: si definisce viziato quando sia stato acquistato in
modo violento (con la forza o la minaccia) o clandestino (tenerlo nascosto alla pubblica
conoscenza)
3)le modalità di esercizio : continuo o discontinuo:si definisce continuo quando non siano
www.unictblog.com 25
Scaricato da Giovanni Porta (portagiovanni358@gmail.com)
lOMoARcPSD|7648598
sopravvenute interruzioni civili ( una chiamata in giudizio) o naturali (se si è perduto il possesso per
oltre 1 anno)
4)durata del possesso: il possesso attuale non fa presumere il possesso anteriore: tuttavia se il
possessore attuale dimostra di aver posseduto il bene in un tempo anteriore si presume che abbia
avuto il possesso anche nel tempo intermedio.
Il possesso quindi si qualifica in base alle circostanze che accompagnano l'acquisto:
nel caso di acquisto a titolo originario del possesso, il soggetto se è in buona fede non sarà
pregiudicato dalla eventuale malafede dei possessori precedenti.
Nel caso di acquisto a titolo derivativo occorre fare una distinzione:
1) successione a titolo universale es eredità: in questo caso il possesso continua nell'erede con
gli stessi caratteri e qualificazioni che esso aveva presso l'ereditando, quindi se il possesso
era viziato continuerà ad esserlo anche in capo all'erede
2) successione a titolo particolare es la consegna del bene a seguito di vendita o donazione: in
questo caso torna ad applicarsi la regola generale, quindi colui che subentra nel possesso
non sarà pregiudicato dall'eventuale malafede del suo dante causa e inoltre potrà sommare al
periodo in cui egli stesso ha posseduto, il periodo durante il quale hanno posseduto i suoi
danti causa, elemento questo importante per definire i tempi di usucapione .
La TUTELA del possesso è solo provvisoria e , in seguito al vittorioso esperimento dell'azione di
rivendicazione da parte del titolare, il possessore dovrà restituire la cosa.
In particolare se il possessore è in buona fede e si tratta di una cosa fruttifera, potrà fare suoi i frutti
percepiti fino al giorno della domanda giudiziale; andranno quindi restituiti i frutti percepiti dopo
tale data.
Il possessore in mala fede invece deve restituire insieme alla cosa tutti i frutti dal giorno dell'inizio
del suo possesso.
Secondo la regola generale il possessore ha diritto al rimborso delle spese necessarie per la
produzione; quanto alle altre spese il possessore ha diritto al rimborso di quelle effettuate per
riparazioni straordinarie mentre per le riparazioni ordinarie si segue il regime dei frutti nel senso
che vanno rimborsate quelle relative alla restituzione dei frutti.
Infine i miglioramenti vanno rimborsati nella misura dell'aumento del valore della cosa (se il
possessore è in buona fede) oppure nella minor somma tra spese e migliorato (se il possessore è in
malafede)
A tutela delle situazioni possessorie sono previste alcune specifiche azioni con lo scopo di
mantenere o ripristinare lo stato di fatto alterato dall'altrui intromissione , senza tener conto del
diritto; il possessore molestato o spogliato della cosa può far ripristinare lo stato anteriore e in
questi casi sarà chi pretende di avere un diritto sulla cosa a dover agire POI in giudizio.
Le azioni a difesa della situazione possessoria sono:
1) manutenzione
2) reintegrazione
3) denunzia di nuova opera
4) denunzia del danno temuto
1---l'azione di MANUTENZIONE è concessa a chi è stato molestato nel possesso di un immobile o
di una universalità di mobili; legittimato attivo è solo il possessore di diritti reali sui beni immobili.
Requisiti specifici sono il possesso non viziato, continuo e non interrotto da oltre un anno;
legittimato passivo è chiunque compia atti di turbativa o molestia: l'azione mira a ottenere la
cessazione della molestia e a consentire la continuazione del libero esercizio sul potere della cosa:
2---l'azione di REINTEGRAZIONE o spoglio è concessa a chi è spogliato violentemente od
occultamente del possesso e mira a ottenere la reintegrazione nella situazione possessoria anche qui
restando insoluta la questione relativa al diritto.
Legittimato attivo è sia il possessore che il detentore di beni mobili o immobili.
Legittimato passivo è colui che ha commesso lo spoglio violento o clandestino.
Si definisce violento ogni spoglio attuato contro la volontà del possessore, clandestino lo spoglio
che di fatto sia rimasto celato. L'azione è soggetta a decadenza dopo 1 anno dal giorno dello spoglio
www.unictblog.com 26
Scaricato da Giovanni Porta (portagiovanni358@gmail.com)
lOMoARcPSD|7648598
o se clandestino dal momento in cui è stato scoperto. Conclusione: un ladro mi ruba qualcosa e se la
porta a casa: io vado da lui e mi riprendo la mia cosa : il ladro può rivolgersi al giudice che
immediatamente mi ordinerà di restituirla,basandosi semplicemente sul fatto. Solo in seguito posso
agire in giudizio per stabilire che io sono il legittimo proprietario.
3---la denunzia di nuova opera e la denunzia di danno temuto sono azioni cautelari, mirano cioè a
preservare il bene da un danno che possa derivare da una cosa del vicino o da una nuova opera da
lui intrapresa:
-- la denunzia di nuova opera può essere esercitata quando si abbia ragione di temere un danno da
una NUOVA opera intrapresa da altri da non oltre un anno: i giudici potranno vietare o permettere
la prosecuzione delle opere imponendo le dovute cautele.
--la denunzia del danno temuto può essere esercitata quando si abbia ragione di temere un danno
grave e imminente da un edificio, albero o cosa altrui: il giudice disporrà le idonee cautele tecniche
o giuridiche per l'eventuale risarcimento.
CAP 19 L' ACQUISTO DEI DIRITTI REALI MEDIANTE IL POSSESSO (pagg195-200)
Abbiamo visto come possesso e proprietà siano cose differenti: vediamo ora come un semplice
possesso possa trasformarsi in proprietà vera e propria: infatti in alcuni casi la legge attribuisce al
possessore la titolarità del diritto anche se manca un efficace titolo di acquisto:
I casi sono: il possesso titolato e l'usucapione.
POSSESSO TITOLATO DI BENI MOBILI cd POSSESSO VALE TITOLO
L'art 1153 dice che chi acquista beni mobili dal non proprietario ne consegue la proprietà se
ricorrono le seguenti condizioni:
1)titolo idoneo al trasferimento del diritto,deve aversi cioè ad es un contratto di vendita idoneo dove
idoneo sta per non nullo
2)buona fede al momento dell'acquisto (ignoranza che il venditore non è il proprietario )
3)la consegna materiale del bene mobile
Non si tratta di un acquisto a titolo derivativo (perchè chi vende non è proprietario) ma originario e
perciò libero da diritti altrui sulla cosa.
In sostanza se uno mi vende un bene rubato, mi fa un contratto regolare e mi consegna la merce. Ne
divento proprietario a tutti gli effetti e il derubato non potrà pretendere nulla da me ma si dovrà
rivolgere contro chi gli ha rubato la cosa
USUCAPIONE
E' un modo di acquisto della proprietà e degli altri diritti reali di godimento derivato dal possesso
continuato per un certo tempo.
L'acquisto è a titolo originario e la proprietà della cosa si acquista libera da eventuali pesi e diritti
altrui.
Con l'usucapione si acquistano tutti i diritti reali di godimento ma non i diritti reali di garanzia.
Il ruolo centrale è dato dal possesso continuato per un certo tempo e d'altra parte l'usucapione
semplifica la prova relativa alla titolarità dei diritti reali e in particolare della proprietà favorendone
la tutela e la circolazione: così potrei acquistare un rustico senza fare ricerche sui registri in quanto
mi basterebbe sapere che il venditore ne ha avuto il possesso da almeno 20 anni perchè se non era il
proprietario lo è diventato per usucapione
L'usucapione viene in rilievo come modo di acquisto della proprietà i 2 ipotesi fondamentali:
1) possesso senza alcun titolo : usucapione ordinaria
2) possesso legittimato da titolarità valida ma inefficace perchè proveniente da chi non è
www.unictblog.com 27
Scaricato da Giovanni Porta (portagiovanni358@gmail.com)
lOMoARcPSD|7648598
titolare del diritto alienato: usucapione abbreviata (cioè compro, con regolare contratto, da
uno che non è proprietario
USUCAPIONE ORDINARIA: si compie in virtù del possesso continuato per 20 anni (art1158); in
questo caso i requisiti necessari sono
1)acquisto pacifico e pubblico cioè senza violenza o clandestinità
2)possesso continuo e non interrotto da citazione in giudizio; eventualmente con presunzione di
….............possesso intermedio
non è richiesta la buona fede
Con l'usucapione ordinaria ventennale si acquistano i diritti di proprietà e di godimento su tutti i
beni mobili, immobili, universalità di mobili e mobili registrati; per l'usucapione della piccola
proprietà rurale bastano 15 anni
USUCAPIONE ABBREVIATA : richiede oltre al possesso continuato per un certo tempo, un titolo
idoneo a trasferire il diritto, la buona fede e la trascrizione del diritto: il titolo richiesto è un titolo
valido pur se in concreto inefficace perchè non proveniente da chi è titolare del diritto alienato;
buona fede significa ignoranza non gravemente colposa dell'altruità del bene; la trascrizione del
titolo è richiesta per i soli beni immobili o beni mobili registrati ed è fondamentale perchè è da tale
momento che decorre il possesso utile per l'usucapione.
Quanto al possesso la sua durata vale in relazione al bene:
10 anni per i beni immobili e le universalità dei mobili
5 anni per la piccola proprietà rurale
3 anni per i beni mobili registrati
Anche per i beni mobili è prevista un'usucapione abbreviata di 10 anni nel caso in cui l'acquirente,
pur in buona fede, manchi di un titolo valido ( se questo vi fosse ,il diritto si acquisirebbe
immediatamente mediante la regola “possesso vale titolo”).
www.unictblog.com 28
Scaricato da Giovanni Porta (portagiovanni358@gmail.com)
lOMoARcPSD|7648598
CAP 17 LA COMUNIONE (pagg 173-180)
Si ha quando la proprietà o un altro diritto reale spetta in comune a più persone (art 1100)
I soggetti in questione sono definiti “contitolari” di uno stesso diritto sullo stesso bene.
Non si ha una pluralità di diritti ma solo uno stesso diritto distribuito fra più persone perchè spetta
contemporaneamente a più soggetti, Il diritto di ciascuno investe la totalità della cosa ma è limitato
dal diritto degli altri e la misura in cui ciascuno è ammesso a esercitarlo è espressa dal concetto di
quota: la quota è la misura della partecipazione di ciascuno alla contitolarità.
L'unicità del diritto spiega come nel caso di rinuncia di uno dei contitolari essa va ad accrescere la
quota degli altri.
Il fondamentale problema che nasce è rappresentato dall'esigenza di conciliare l'interesse
individuale con quello collettivo.
L'assetto attuale indica una tendenziale prevalenza dell'interesse collettivo su quello individuale già
per l'adozione del principio maggioritario con decisioni vincolanti per i dissenzienti; il gruppo
comunque ha competenza solo per gli interessi comuni e non deve ledere l'interesse del singolo; in
ogni caso non può individuarsi nella comunione un autonomo soggetto di diritto distinto dai
partecipanti.
Non c'è uno scopo comune come nelle associazioni: l'interesse collettivo è solo la risultante degli
interessi individuali e si riassume nelle esigenze di razionale gestione e miglior godimento della
cosa.
Si distinguono comunioni VOLONTARIE , create dalle parti, e comunioni INCIDENTALI create
dalla legge (e, tra esse le comunioni forzose che non è possibile sciogliere per volontà unilaterale).
COMUNIONE ORDINARIA: è l'ipotesi generale di contitolarità della proprietà o di un diritto
reale; è segnata dalla tendenziale prevalenza dell'interesse collettivo su quello individuale.
E' retta dal principio del concorso: ciascun partecipante può servirsi della cosa comune purchè non
ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri di farne parimenti uso.
La misura del diritto (ma anche del peso) di ciascuno è segnata dalla quota di contitolarità: le quote
sono fissate dal titolo e in mancanza di specificazione si presumono tutte uguali.
Un altro principio è quello maggioritario: le decisioni della maggioranza vincolano anche i
dissenzienti ma non possono ostacolare i diritti individuali.
E' caratterizzato da 3 profili:
1) l'uso spetta individualmente a ciascuno in proporzione alla quota e limiti indicati
2) l'amministrazione spetta collettivamente a tutti, secondo il principio maggioritario per le
decisioni di interesse comune; per gli atti di ordinaria amministrazione basta la maggioranza
semplice calcolata in base alle quote; per gli atti di straordinaria amministrazione invece
occorre una doppia maggioranza, per capi e per quote e cioè la maggioranza numerica dei
partecipanti che rappresentino almeno i 2/3 del valore della cosa.
3) La disposizione spetta individualmente a ciascuno nei limiti della sua quota, cioè ciascuno
può vendere liberamente a terzi la sua quota e può chiedere lo scioglimento della comunione
ma l'alienazione dell'intero bene richiede il consenso unanime dei contitolari.
Comunioni particolari sono:
Il CONDOMINIO
E' una particolare comunione che si instaura tra gli edifici. In essi ciascuno è contemporaneamente
proprietario esclusivo di un piano o porzione di esso e comproprietario di alcune parti comuni
suolo,scale,tetti: la comunione riguarda quindi solo parti della cosa ed è inoltre forzosa: trattandosi
di cose strumentali non è soggetta a divisione, non si può rinunciare ad essa, non si può alienare.
Il diritto sulle cose comuni è segnato dalla quota espressa in millesimi.
E' caratterizzato dalla prevalenza dell'interesse collettivo su quelli individuali
L'amministrazione è affidata a 2 organi:
1) assemblea dei condomini :è l'organo deliberativo e ha competenza generale sulla gestione
www.unictblog.com 29
Scaricato da Giovanni Porta (portagiovanni358@gmail.com)
lOMoARcPSD|7648598
della cosa comune; perchè siano valide le deliberazioni si richiede la preventiva
convocazione di tutti gli aventi diritto, la presenza di un numero minimo di condomini e
l'approvazione a maggioranza semplice; per gli atti di ordinaria amministrazione occorre in
seconda convocazione l'approvazione di 1/3 dei condomini che siano titolari di almeno 1/3
del valore dell'edificio; per gli atti di straordinaria amministrazione occorre l'approvazione
della maggioranza numerica degli intervenuti che siano titolari di almeno metà del valore
dell'edificio. Per le innovazioni occorrono maggioranze più consistenti. Le delibere possono
essere impugnate entro 30 gg
2) l'amministratore è l'organo esecutivo e ha rappresentanza anche processuale del
condominio . La sua competenza è speciale ed è limitata dalla legge e dal regolamento.
Il regolamento infine è lo statuto del condominio e contiene le norme dell'uso della cosa comune, la
ripartizione delle spese, l'amministrazione e il decoro dell'edificio; è obbligatorio quando i
condomini sono più di 10 e si approva a maggioranza semplice.
Le delibere dell'assemblea non hanno natura negoziale ma sono ATTI COLLETTIVI cioè quello
che conta non è la decisione singola ma la volontà della maggioranza; quando però si tratta di
disporre dei diritti individuali sulla cosa propria o su quella comune, si entra nel campo negoziale e
in tal caso saranno i singoli condomini a decidere: ad es chiudere la piscina condominiale significa
per ciascun condomino rinunciare alla facoltà di godimento di un bene comune quindi per attuarla
occorre il consenso di TUTTI .
La MULTIPROPRIETA' IMMOBILIARE
E' una comunione caratterizzata da un vincolo di destinazione e da una particolare modalità di
godimento ripartito di beni immobili, basata sulla turnazione cioè ciascuno dei condomini ha diritto
al godimento dell'unità immobiliare in periodi prefissati ad es 1 o + settimane l'anno.
Non è regolata da specifiche leggi; c'è un codice di consumo espresso da una direttiva UE (art 69-
81) ma si limita a disciplinare i contratti allo scopo di garantire l'acquirente pollo contro possibili
abusi del venditore, astuto professionista: tratta quindi di obblighi di informazione, di diritto di
recesso, di obblighi del venditore ecc.
Caratteristiche proprie della multiproprietà sono:
-- il vincolo negoziale turnario, per cui sarebbe una comproprietà che non stabilisce lo spazio
spettante ai diversi proprietari ma il tempo di godimento
--la indivisibilità :e questo la potrebbe far escludere come comunione, ma qui la indivisibilità non è
imposta dalla legge ma dalla impossibilità di dividere il tempo
--le particolari norme di amministrazione di solito affidata a una società di gestione.
Col tempo si sono sviluppati altri tipi di multiproprietà:
---multiproprietà azionaria in cui ciascun partecipante possiede una o più azioni privilegiate di una
società che danno diritto al godimento di unità abitative di proprietà della società stessa.
---multilocazione alberghiera in cui i partecipanti hanno diritto di godere in periodi predeterminati
di una serie di servizi tra cui l'alloggio.
Si noti che in ambedue i casi non si acquista un diritto reale (non divento proprietario) ma solo il
diritto di godimento del diritto reale.
www.unictblog.com 30
Scaricato da Giovanni Porta (portagiovanni358@gmail.com)
lOMoARcPSD|7648598
CAP 44 LE PROVE (pagg 462-469)
Secondo il nostro sistema giuridico non è il giudice che deve cercare le prove di quanto affermato
dai litiganti, bensì le parti stesse: l'onere della prova dunque, grava sulle parti (attore e convenuto)
secondo quanto stabilisce l'art 2697: chi vuol far valere un diritto deve provare i fatti che ne
costituiscono il fondamento, mentre chi vuole resistere deve provare i fatti su cui si fonda la sua
opposizione ( fatti impeditivi o modificativi o estintivi dell'altrui pretesa).
Le prove, fornite tramite MEZZI DI PROVA (documenti, dichiarazioni ecc.) sono distinte in:
---1)prove storiche che ricostruiscono i fatti da provare: documenti, testimonianze, confessione,
giuramento
---2)prove logiche che si fondano su deduzioni logiche: presunzione.
PROVA DOCUMENTALE: è fornita tramite documenti ad es certificati,ricevute ecc.
Documenti per eccellenza sono l'atto pubblico e la scrittura privata.
L'ATTO PUBBLICO è il documento redatto da un notaio (o da altro pubblico ufficiale) “autorizzato
ad attribuirgli pubblica fede”:caratteristica è la pubblica fede: l'atto infatti fa fede delle dichiarazioni
delle parti,il giudice è così tenuto a considerare come realmente avvenuti i fatti e le dichiarazioni
attestate nell'atto: chi volesse contestare tali risultanze è tenuto a instaurare un procedimento
specifico, la QUERELA DI FALSO, nel corso del quale si verificano le eventuali falsità dell'atto.
La SCRITTURA PRIVATA consiste in un documento(contratto,ricevuta) sottoscritto da un privato e
fa prova solo contro chi l'ha sottoscritta e a condizione che la sottoscrizione sia riconosciuta
dall'autore ( basta disconoscere la firma per neutralizzarla) o autenticata da un notaio.
La legge stabilisce che la scrittura privata acquisti data certa di fronte a terzi il giorno della
autenticazione da parte di un notaio o della registrazione a fini fiscali..
PROVA TESTIMONIALE non è sempre ammessa dalla legge: in particolare non è ammessa :
---per i patti contrari o aggiunti al contenuto di un documento che si affermi essere anteriori o
contemporanei al documento (non è verosimile che le parti hanno sottoscritto un accordo ma in
realtà si sono accordate verbalmente in maniera diversa da quanto scritto)
---per i contratti, i pagamenti e le remissioni di debito superiori a £ 5000
Questi limiti si riferiscono solo alle parti: i terzi possono testimoniare (essendo estranei al contratto)
La prova testimoniale è ammessa quando:
---c'è un principio di prova scritta che possa confermare la testimonianza orale
---quando la parte si è trovata nell'impossibilità morale o materiale di procurarsi una prova scritta
---quando si è perduto senza colpa il documento scritto.
La CONFESSIONE è la dichiarazione che una parte fà della verità di fatti a sé sfavorevoli:
---GIUDIZIALE quando è resa in giudizio: fà piena prova
---STRAGIUDIZIALE quando è resa fuori dal giudizio: fà piena prova se resa alla controparte; se
viene resa a terzi invece sarà valutata dal giudice caso per caso.
Il GIURAMENTO è la dichiarazione solenne di una parte circa la verità di certi fatti: può essere
prestata solo in giudizio da una sola delle parti e fa piena prova nel senso che decide la controversia
in modo definitivo anche se successivamente si dimostri falso: la parte lesa può solo chiedere il
risarcimento dei danni; può essere:
---DECISORIO se prestato da una parte su invito dell'altra:se essa rifiuta soccomberà su tale punto,
ma può richiedere che sia l'altra parte a farlo
---SUPPLETORIO se prestato su invito del giudice perchè le prove non sono convincenti o per
stimare il valore di una cosa (giuramento estimatorio).
PRESUNZIONE: mezzo di prova logica che non dà dimostrazione diretta dei fatti ma tramite
ragionamenti induttivi (da fatti noti si arriva a chiarire fatti ignoti); può essere:
---legale se stabilita dalla legge (es presunzione di possesso in tempo intermedio) e si dice assoluta
se non ammette prova contraria
---semplice se elaborata dal giudice caso per caso secondo il suo prudente apprezzamento.
www.unictblog.com 31
Scaricato da Giovanni Porta (portagiovanni358@gmail.com)
lOMoARcPSD|7648598
DIRITTO PRIVATO 2° MODULO “OBBLIGAZIONI E DIRITTI DI CREDITO”
Testo di riferimento M. Paradiso
Il riassunto segue passo passo il programma della prof Cavallaro
Dove necessario, il testo è stato integrato con gli argomenti delle slides.
By zziopippo.
www.unictblog.com 32
Scaricato da Giovanni Porta (portagiovanni358@gmail.com)
lOMoARcPSD|7648598
CAP 20 INTRODUZIONE (pagg 201-203)
Come sappiamo i diritti soggettivi si dividono in assoluti e relativi
Diritti assoluti sono i diritti della personalità e i diritti reali: si dicono assoluti in quanto possono
farsi valere verso tutti in maniera diretta cioè conferiscono una pretesa generale verso tutti i
consociati che si limitano a un “dovere negativo”, cioè devono solo astenersi dal turbare il legittimo
godimento dei beni: il diritto è suscettibile di tutela diretta e immediata nei confronti di tutti.
Diritti relativi (ad es. i diritti di credito)si dicono relativi in quanto possono farsi valere in maniera
diretta solo nei confronti di determinate persone cioè consistono in una pretesa specifica verso un
soggetto determinato e la soddisfazione del proprio interesse avviene tramite altri.
Si noti che, nel caso dei diritti relativi, gli altri consociati non hanno alcun rilievo tranne casi
particolarissimi : facciamo un esempio: nei rapporti familiari, il mantenimento dei figli viene
considerato come un “debito” del padre verso i figli : se una persona uccide un padre di famiglia gli
impedisce di ottemperare a questo debito: i figli dell'ucciso allora non possono pretendere che
l'uccisore adempia al posto del padre (cioè li mantenga) ma possono pretendere un risarcimento.
CAP 21 IL RAPPORTO OBBLIGATORIO (pagg 204-208)
Consiste in un vincolo tra due soggetti , debitore e creditore, in virtù del quale il debitore è tenuto a
eseguire una specifica prestazione a favore dell'altro: la pretesa non potrà essere avanzata nei
confronti di chiunque ma solo verso quei soggetti che hanno una specifica obbligazione.
In genere si parla di OBBLIGAZIONE quando la prestazione ha carattere patrimoniale e di
OBBLIGO quando manca tale carattere
Il codice civile dedica alle obbligazioni tutto il libro 4° e questo testimonia l'importanza delle
obbligazioni che oggi sono diventate l'asse portante dell'economia (i macchinari si comprano col
leasing che è una forma di credito, le azioni delle società non sono altro che titoli di credito ecc)
Fonti delle obbligazioni (art 1173) sono il CONTRATTO, IL FATTO ILLECITO (es il ferimento di
una persona che porta all'obbligo del risarcimento) e ogni altro atto o fatto idoneo a produrle
(arricchimento senza causa, ripetizione di indebito ecc). Si noti come la tipologia delle fonti sia
molto varia: il contratto è un negozio, il fatto illecito è un atto giuridico in senso stretto
L'obbligazione si caratterizza per la VINCOLATIVITA' ( o obbligatorietà) del comportamento e
per una peculiare COERCIBILITA': infatti ove manchi l'adempimento spontaneo del debitore, il
creditore potrà agire in giudizio chiedendo l'esecuzione forzata in forma SPECIFICA o PER
EQUIVALENTE
---SPECIFICA consente di ottenere coattivamente un risultato corrispondente all'obbligazione ad es
se un debitore mi deve una cosa, ho diritto ad avere “quella” cosa specifica ; ma non è praticabile
in tutti i casi.
---PER EQUIVALENTE consente di ottenere un risultato economico equivalente alla prestazione
ineseguita. Ad es se il debitore non può darmi “quella” cosa , ho il diritto di richiedere la vendita
forzata dei suoi beni e rifarmi sul ricavato ( la cd responsabilità patrimoniale del debitore: art 2740:
il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni, presenti e futuri)
Quindi un' OBBLIGAZIONE CIVILE si caratterizza per la presenza contemporanea di debito e
responsabilità (cioè obbligo a soddisfare il debito): se manca uno dei 2 fattori siamo in presenza di
altro: ad es il debito manca nella fideiussione (garanzia per un debito altrui); la responsabilità
manca nelle cd OBBLIGAZIONI NATURALI, obblighi che nascono nell'ambito dei doveri morali
e sociali: es pagamento dei debiti di gioco: in questi casi la legge non concede azioni per ottenere
l'adempimento coattivo del debito.
www.unictblog.com 33
Scaricato da Giovanni Porta (portagiovanni358@gmail.com)
lOMoARcPSD|7648598
CAP 22 L'OGGETTO DEL RAPPORTO OBBLIGATORIO ARTT 1174 e ss (pagg 209-221)
Oggetto del rapporto obbligatorio è la PRESTAZIONE del debitore
Per prestazione si intende il comportamento cui il debitore è tenuto, che può consistere in:
-1)DARE: cioè la consegna di un bene o il pagamento di una somma; al riguardo si distinguono:
-----obbligazioni GENERICHE quando il debitore deve consegnare una certa quantità di cose
appartenenti allo stesso genere e non ancora individuate quantitativamente;
-----obbligazioni. SPECIFICHE quando deve dare una cosa determinata (es QUEL quadro) .
-2)FARE: si tratta di eseguire un'attività ; in questo caso abbiamo la distinzione tra OBBL. DI
MEZZI e OBBL.DI RISULTATO che corrispondono alle prestazioni di attività (es un medico che
deve fare il suo lavoro indipendentemente dal risultato, se il paziente guarisce o no) e prestazioni di
risultato (un vettore deve ottenere il risultato di trasportare una cosa indipendentemente dai mezzi
che usa). Rientra nel fare anche l'obbligo di contrarre cioè di stipulare un contratto es un contratto
preliminare di vendita.
Con riguardo alle obbligazioni di fare si distinguono:
--prestazioni FUNGIBILI nelle quali è indifferente se ad adempiere sia il debitore o un terzo
--prestazioni INFUNGIBILI quando il debitore deve adempiere personalmente perchè si richiedono
qualità personali es:prestazione di “quel” professionista o di quell'artigiano.
-3)NON FARE: si tratta di un comportamento omissivo(es l'obbligo di un lavoratore di non
divulgare notizie riguardanti l'azienda in cui lavora)
Carattere distintivo della prestazione è la PATRIMONIALITA': la prestazione deve essere cioè
suscettibile di valutazione economica, anche soggettiva (se gli inquilini di un palazzo si impegnano
a non tenere animali, pena il pagamento di una penale, siamo di fronte a una obbligazione, senza la
penale no); inoltre la prestazione deve corrispondere a un interesse del creditore che può essere
oltre che materiale anche spirituale o culturale: se l'obbligazione non corrisponde a un interesse
apprezzabile (meritevole di tutela) è nulla.
La prestazione deve poi essere:
POSSIBILE: nel senso che chiunque, con una diligenza media, sarebbe in grado di adempierla ( non
costituiscono impossibilità le difficoltà nel fare la prestazione o l'incapacità finanziaria sia pure
dovuta ad eventi straordinari del tipo non posso pagare perchè poco fa ho subito una rapina)
La possibilità va intesa anche in senso giuridico, cioè la legge lo deve permettere: ad es è
impossibile l'obbligazione di vendere un bene demaniale perchè ciò è vietato dalla legge.
LECITA quando non urta contro norme imperative, l'ordine pubblico e il buon costume: è illecita
l'obbligazione di vendere appartamenti costruiti senza licenza edilizia.
DETERMINATA o almeno determinabile: quando è fissata nei suoi estremi quantitativi e qualitativi
se manca questa determinatezza ci si può affidare al giudizio di un arbiter nominato dalle parti (o
dal giudice) contro cui ci si può appellare (arbitrium boni viri): si parla invece di merum arbitrium
quando le parti danno carta bianca all'arbiter e in tal caso non ci si può appellare.
Forme particolari di obbligazione sono le OBBLIGAZIONI PECUNIARIE : esse hanno come
oggetto il denaro che di per sé non è un bene ma consente di procurarsi i beni.
Sono 3 le classiche funzioni svolte dal denaro: è mezzo di scambio, unità di misura dei valori, e
riserva di liquidità..
Importante è la distinzione tra denaro, termine generico, e MONETA la quale è denaro che ha corso
legale nello stato; a questo proposito la legge dispone nell'art. 1277 (NOMINALISMO
VALUTARIO) che i debiti pecuniari si estinguono con moneta avente corso legale nello stato al
tempo del pagamento, (il che significa che il debitore non può pagare con titoli di credito, senza il
consenso del creditore: ma un dl del 2008 vieta i pagamenti superiori a 12.500 € tramite contante o
titoli al portatore); inoltre il debitore che ha contratto un'obbligazione in valuta estera, ha facoltà di
pagare in moneta legale salvo l'indicazione differente di una clausola specifica.
www.unictblog.com 34
Scaricato da Giovanni Porta (portagiovanni358@gmail.com)
lOMoARcPSD|7648598
L'introduzione dell'euro (1° gennaio 2002) ha portato diversi problemi di valuta:
a questo proposito, lo Stato è intervenuto con 3 tipi di provvedimenti:
1)è stato previsto un periodo transitorio (1-01-1999 31-12-2001) nel quale tutte le obbligazioni
contratte potevano essere espresse sia in lire che in euro
2)a partire dal 1° gennaio 2002 l'euro è diventata a tutti gli effetti moneta avente corso legale.
3)la sostituzione della lira con l'euro è cmq retta dal principio di continuità, cioè non modifica i
contenuti dei contratti se non per l'automatica conversione della lira in euro.
Ma il denaro, si sa, è soggetto a svalutazione o rivalutazione nel tempo:se ho contratto un debito 10
anni fa e lo pago oggi, dovrò restituire la stessa somma o dovrò rivalutarla?
Il principio del NOMINALISMO DEL RAPPORTO OBBLIGATORIO afferma l'irrilevanza delle
variazioni del potere di acquisto della moneta tra il momento della nascita dell'obbligazione e il
momento della scadenza: svalutazioni o rivalutazioni della moneta sono irrilevanti, cioè dovrò
restituire oggi esattamente la stessa somma che mi è stata prestata 10 anni fa, anche se il suo valore
è diminuito. E' evidente che questa regola penalizza pesantemente il creditore: tuttavia le parti
possono decidere apposite clausole, e spesso si ricorre ad un accorgimento per evitare gli effetti
della svalutazione, concordando ad es un saggio di interesse variabile in relazione all'andamento
dell'inflazione. Cmq sia è ormai consolidata la distinzione fra:
DEBITO IN VALUTA: quando l'obbligazione è determinata fin dall'origine con riferimento a una
certa quantità di denaro
DEBITO IN VALORE quando l'obbligazione è determinata con riferimento a un valore economico
diverso dal denaro: è possibile che la prestazione venga poi quantificata in una somma di denaro ma
questa non rappresenta l'oggetto proprio del debito ma un valore rappresentativo: es nelle
obbligazioni risarcitorie l'oggetto dell'obbligazione non è il denaro ma il “reintegro del patrimonio”
che sfugge al principio nominalistico: in altre parole ciò che si chiede non è il risarcimento di tot
denaro oggi, per poi averlo tra 10 anni svalutato ( dato che non mi è permesso rivalutarlo) ma il
“reintegro del patrimonio” che sarà possibile rivalutare al momento della liquidazione.
Gli INTERESSI sono un'obbligazione pecuniaria accessoria a una principale avente come oggetto
una somma di denaro; in quanto obbligazione accessoria segue le sorti della principale ma è distinta
da essa e pertanto può formare oggetto di separati atti di disposizione (ad es ha un autonomo
termine di prescrizione). Possono avere funzione:
COMPENSATIVA (la banca mi fa un prestito e io pago gli interessi come compenso per il
godimento del denaro)
RISARCITORIA ( ad es gli interessi moratori che servono a risarcire il creditore del danno per il
ritardo dell'adempimento ma comprendono anche la quota compensativa).
FONTE degli interessi:
---Interessi CONVENZIONALI nascono da un apposito accordo tra le parti
---Interessi LEGALI: sono stabiliti dalla legge art 1282 “ i crediti pecuniari liquidi ed esigibili (cioè
non scaduti) producono interessi di pieno diritto” cioè senza bisogno di ulteriori precisazioni
normative: negli altri casi invece saranno dovuti interessi solo in presenza di esplicite disposizioni
di legge ( somme dovute dal mandante al mandatario, mutui onerosi, conti correnti e depositi
bancari). Il saggio di interesse legale per il 2010 è fissato all'1 % in ragione d'anno: le parti possono
disporre diversamente ma la pattuizione di saggi maggiori richiede la forma scritta pena la nullità.
Sono vietati gli interessi USURARI che d'altra parte rendono nulla qualsiasi trattativa: vengono
considerati usurari gli interessi che superano il cd tasso soglia calcolato trimestralmente dal
Ministero del tesoro sulla base di un tasso medio praticato da banche e intermediari finanziari
autorizzati, aumentato del 50%.
ANATOCISMO consiste nella produzione di interessi da altri interessi scaduti e non pagati: scaduta
l'obbligazione con interessi già maturati, questi si sommano al capitale e sull'ammontare totale si
calcoleranno i nuovi interessi; ma occorre un accordo tra le parti POSTERIORE alla scadenza dei
primi interessi e che si tratti di interessi dovuti da almeno 6 mesi.
3
www.unictblog.com 35
Scaricato da Giovanni Porta (portagiovanni358@gmail.com)
lOMoARcPSD|7648598
Tipo particolare di obbligazioni sono le OBBLIGAZIONI ALTERNATIVE (art 1285) in cui sono
dovute 2 o + prestazioni ma il debitore si libera eseguendone una sola (es un ristoratore offre allo
stesso prezzo un menù a base di carne oppure uno a base di pesce):
Gli elementi fondamentali sono dunque:
1)pluralità delle prestazioni, sin dalla nascita del rapporto (nelle facoltative la prestazione è 1 sola)
2)unicità dell'adempimento (nelle cumulative invece bisogna adempiere tutte le prestazioni).
Si differenziano dalle obbligazioni generiche per:
a)potere di scelta (debitore o creditore)
b)la scelta è un atto UNILATERALE RECETTIZIO in quanto acquista efficacia nel momento in cui
viene comunicato al destinatario( per vizi e capacità valgono le disposizioni vigenti sui contratti)
L'obbligazione alternativa diventa semplice (cd CONCENTRAZIONE) nel momento in cui si fa la
scelta che di solito spetta al debitore: se sopravviene un'impossibilità di scelta l'obbligazione si
considera semplice e il debitore deve eseguire quella che è rimasta possibile.
Quando però l'impossibilità sia imputabile a una delle parti questa ne risponde (vedi slides):
--se è imputabile al DEBITORE:
1)se la scelta tocca al debitore l'obbligazione diventa semplice
2)se la scelta tocca al creditore egli sceglie quella rimasta possibile o chiede risarcimento
--se è imputabile al CREDITORE:
1)se la scelta tocca al debitore egli viene liberato o sceglie quella rimasta + risarcimento
2)se la scelta tocca al creditore egli può scegliere la prestazione rimasta ma deve risarcire il debitore
per la perdita.
Le obbligazioni FACOLTATIVE si hanno quando è dovuta una sola prestazione ma il debitore ha
facoltà di liberarsi eseguendone un'altra- IUS VARIANDI- (es.un impresario prepara un cartellone
di spettacoli ma si riserva di sostituire una rappresentazione con un'altra).
IL PROBLEMA DELL'USURARIETA' SOPRAVVENUTA
La legge sull'usura è la 108 del 1996; essa introduce il tasso soglia, pone in rilievo lo stato di
difficoltà economica del debitore e rinnovella l'art 1815 cc ribadendo che, in caso di interessi
usurari, la clausola è nulla e NON E' DOVUTO ALCUN INTERESSE nemmeno quello legale.
Il legislatore però, non si preoccupò di stabilire norme transitorie per cui, fermo restando che a
partire dal '96 gli interessi usurari dovevano rispettare la legge 108, cosa succedeva per quegli
interessi pattuiti prima del 1996 e maturati dopo, interessi diventati usurari con la nuova legge?
Due erano le interpretazioni:
1)il carattere usurario si stabilisce al momento della pattuizione degli interessi
2)il carattere usurario si stabilisce al momento della maturazione (al momento del pagamento)
Nel primo caso, poiché al momento della pattuizione (prima del '96) l'interesse era perfettamente
lecito, esso rimane valido anche dopo il '96, cioè continuerò a pagare interessi usurari.
Nel secondo caso invece, non pagherò gli interessi usurari solo per le rate maturate dopo il '96.
In questa situazione caotica, intervenne la Cassazione che sostanzialmente fece sua la seconda
interpretazione, basandosi sul principio della non retroattività della legge nuova e della non
ultraattività della legge vecchia. Restava oscuro un problema fondamentale: poichè le rate maturate
dopo il '96 sono gravate da interessi usurari, applicando rigorosamente l'art 1815 non sono tenuto a
pagare nessun interesse, nemmeno quello legale, cioè il mutuo mi viene gratuito: ma se si fosse
applicato rigorosamente l'art 1815, banche e finanziarie, che vivono degli interessi, sarebbero
andate a puttane; e infatti il governo intervenne con un decreto legge 394/2000, detto decreto
salvabanche, con cui si affermava che il carattere di usurarietà si stabiliva al momento della
pattuizione (l'interpretazione 1, vedi sopra), per cui gli interessi usurari erano perfettamente
legittimi: in seguito all'ondata di proteste (tra cui parecchie obiezioni di illegittimità costituzionale)
la conversione del decreto nella legge24/2001, pur rimanendo sulle sue posizioni, apportò un
contentino a tutela del mutuatario, stabilendo per i mutui prima casa un tasso dell'8% e per mutui
non agevolati a tasso fisso, un tasso sostitutivo di quello usurario.
www.unictblog.com 36
Scaricato da Giovanni Porta (portagiovanni358@gmail.com)
lOMoARcPSD|7648598
CAP 23 I SOGGETTI DEL RAPPORTO OBBLIGATORIO (pagg 222-226)
I soggetti del rapporto obbligatorio sono i titolari di posizioni giuridiche di debito e credito e
devono essere almeno 2, il debitore e il creditore.
I soggetti devono essere determinati, o almeno determinabili al momento in cui sorge l'obbligazione
( es di determinabilità è la” promessa al pubblico” es una borsa di studio al primo classificato: qui
l'obbligazione è validamente formata perchè si tratta solo di individuare chi sarà il creditore nella
cerchia dei soggetti indicati).
Nelle OBBLIGAZIONI AMBULATORIE ( cd perchè destinate alla circolazione: ad es un titolo di
credito) può esserci un'incertezza soggettiva sul titolare del rapporto ma questo può essere in ogni
momento determinato, infatti il soggetto avente diritto è il titolare del documento di credito.
Nelle OBBLIGAZIONI REALI l'obbligato si individua in funzione della titolarità di un diritto
reale: ad es il comproprietario di un appartamento, in quanto titolare del diritto di comproprietà, è
tenuto a contribuire alle spese comuni; inoltre trasferita la titolarità della cosa, sarà trasferita
automaticamente anche l'obbligazione ad essa accessoria: se il comproprietario vende la sua parte,
chi compra è tenuto alle spese comuni.
Esistono obbligazioni in cui i soggetti sono + di due: sono le cd obbligazioni PLURISOGGETTIVE
O SOGGETTIVAMENTE COMPLESSE, in cui + debitori (detti condebitori) sono obbligati alla
stessa prestazione (es quando chirurgo e anestesista operano un paziente che muore, sono obbligati
tutti e due al risarcimento), o + creditori (concreditori) hanno diritto alla medesima prestazione (es
un'eredità lasciata a tre figli). Questo tipo di obbligazione viene interpretata in diversi modi: la
dottrina prevalente individua in esse una pluralità di rapporti obbligatori connessa ad un unica
prestazione: ci sarebbero cioè tanti rapporti obbligatori quante sono le coppie debitore-creditore( per
cui ognuno pagherebbe la sua quota); altre dottrine individuano un'unica obbligazione che fa capo a
+ soggetti (per cui uno qualsiasi dei debitori potrebbe pagare tutto ).
Cmq sia si distinguono obbligazioni solidali, parziarie e indivisibili.
OBBLIGAZIONI SOLIDALI
Si dicono solidali PASSIVE quando data una pluralità di debitori ,ciascuno dei condebitori è tenuto
a pagare l'intero e l'adempimento di uno libera anche gli altri ( art 1292): il debitore che ha pagato
ha azione di regresso vs gli altri condebitori secondo il criterio dell'interesse: se l'interesse è comune
l'obbligazione si divide in proporzione alla rispettive quote; se invece l'obbligazione è stata contratta
nell'interesse esclusivo di uno dei soggetti questi sarà tenuto a rimborsare l'intera somma a colui che
ha pagato. In caso di insolvenza di uno dei condebitori la perdita si ripartisce fra tutti gli altri.
Si dicono solidali ATTIVE quando data una pluralità di creditori, ciascuno di essi può pretendere
l'intero (es per un libretto postale intestato a + persone,a firme separate, ciascuna può prelevare la
intera somma); l'adempimento fatto nelle mani di uno di essi libera il debitore verso tutti i creditori.
Requisiti necessari perchè si abbia un'obbligazione solidale sono:
-pluralità dei soggetti :due persone che hanno in comproprietà un appartamento e lo devono pagare
-unicità della prestazione: devono pagare una somma al costruttore
-unicità della causa o fonte dell'obbligazione : un contratto unico di compravendita
Se ci sono questi requisiti si avrà AUTOMATICAMENTE il vincolo solidale passivo (la cd
presunzione di solidarietà passiva) mentre invece la solidarietà attiva non si presume e necessita di
apposita previsione,senza la quale si presume parziaria.
OBBLIGAZIONI PARZIARIE ciascuno dei debitori e ciascuno dei creditori può pretendere
soltanto la propria parte di prestazione(art 1314).Es crediti e debiti ereditari si ripartiscono tra eredi.
Può succedere che benchè l'obbligazione plurisoggettiva sia parziaria, la prestazione sia indivisibile
es animale vivo: in questo caso non potendo i debitori liberarsi prestando ciascuno solo la propria
quota, si applicano le regole della solidarietà e quindi ciascun debitore deve prestare l'intero
(art1316: indivisibili sono le obbligazioni parziarie aventi per oggetto una cosa o fatto non
suscettibile di divisione: esse sono regolate dalle norme relative alle obbligazioni solidali).
www.unictblog.com 37
Scaricato da Giovanni Porta (portagiovanni358@gmail.com)
lOMoARcPSD|7648598
CAP 24 ADEMPIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI (pagg 227-235)
L'adempimento è l'esatta realizzazione della prestazione dovuta: con l'adempimento l'obbligazione
si estingue e il debitore è libero dal vincolo obbligatorio.
Ha natura di atto giuridico in senso stretto,anche se, trattandosi di attività materiale, può risultare
congrua la qualifica di fatto giuridico.
L'adempimento deve essere (art 1218) esatto cioè conforme a determinati criteri legali: la diligenza
e la buona fede, l'esattezza giuridica e materiale della prestazione, la puntualità di tempo e luogo,
l'idoneità di chi adempie e la legittimazione di chi riceve il pagamento.
DILIGENZA E BUONA FEDE sono i criteri fondamentali che definiscono il comportamento del
debitore: per quanto riguarda la DILIGENZA, l'art 1176 fa riferimento alla diligenza del buon padre
di famiglia e alla diligenza tecnica o professionale: la prestazione diligente implica perizia (cioè
competenza, rispetto delle norme tecniche), prudenza (attenzione nell'esecuzione del compito) e
inoltre il rispetto di eventuali disposizioni legali circa il contenuto e le modalità della prestazione
(norme di sicurezza); il livello di diligenza richiesta non dipende solo dal soggetto, ma anche dal
tipo di prestazione: ad es. si richiede maggiore diligenza per custodire un quadro di Leonardo che
per custodire un'automobile.
La BUONA FEDE (art 1175) è un obbligo che impone a entrambe i soggetti un comportamento
secondo le regole della correttezza oggettiva cioè un impegno di cooperazione per salvaguardare
l'interesse dell'altro nei limiti in cui sia compatibile col proprio (non posso pagare 1000 € con
monetine da 10 cent). Costituisce clausola generale ed è rigorosamente inderogabile.
ESATTEZZA MATERIALE : quando oggetto della prestazione è un bene, si ha l'obbligo di prestare
cose di qualità non inferiore alla media e immuni da vizi che ne diminuiscano il valore;
l'adempimento deve essere totale: il creditore può rifiutare un adempimento parziale e non è tenuto
ad accettare una prestazione diversa anche se di valore superiore: se il debitore in difficoltà offre in
pagamento un bene diverso, occorre il consenso del creditore ( DATIO IN SOLUTUM ).
Il debitore può anche pagare mediante cessione di un suo credito .
REGOLARITA' GIURIDICA: il debitore deve adempiere con cose di cui abbia piena disponibilità ,
è perciò inesatto il pagamento eseguito con cose altrui o gravate da diritti da terzi (art 1192).
ESATTEZZA DEL TEMPO DELL'ADEMPIMENTO (art 1183)
---se non è determinato il tempo in cui la prestazione va eseguita il creditore può esigerla
immediatamente
--ove manchi accordo tra le parti e sia necessario un termine per la natura della prestazione questo è
stabilito dal giudice
---spetta ugualmente al giudice su istanza dell'interessato la fissazione di un termine che sia rimesso
alla discrezionalità del debitore (pago quando potrò) o del creditore (paghi quando vorrò)
---quando il termine è fissato si presume sia a favore del debitore per consentirgli di poter preparare
l'adempimento, pertanto il creditore non potrà pretendere il pagamento anticipato; però il debitore
può pagare in anticipo e chiedere la restituzione dell'arricchimento conseguito dal creditore tramite
gli interessi, dal giorno del pagamento anticipato a quello della scadenza effettiva.
Se il termine è fissato a favore del creditore (che ad es deve approntare il magazzino prima di
ricevere la merce), allora il debitore dovrà rispettare la scadenza (non può pagare in anticipo).
---il debitore decade dal beneficio del termine ove sia divenuto insolvente ovvero non abbia dato o
mantenuto le garanzie promesse( se vedo che un debitore non paga i suoi debiti, io mi devo
aspettare che non pagherà nemmeno me alla scadenza e quindi anticipo la scadenza per non
rimanere fuori dal ricavato dell'eventuale fallimento).
ESATTEZZA DEL LUOGO DELL'ADEMPIMENTO: il luogo è determinato dal titolo, dagli usi o
dalla natura della prestazione, in mancanza di indicazioni la consegna di una cosa va eseguita nel
luogo in cui si trovava la cosa quando è sorta l'obbligazione; l'obbligazione pecuniaria va pagata al
domicilio del creditore (obbl. portable), le altre al domicilio del debitore (obbl. querable).
www.unictblog.com 38
Scaricato da Giovanni Porta (portagiovanni358@gmail.com)
lOMoARcPSD|7648598
LEGITTIMAZIONE AD ADEMPIERE: obbligato ad adempiere è il debitore, ma legittimato (cioè
autorizzato) ad adempiere è anche qualsiasi terzo che ritenga di avervi interesse es la moglie che
paga i debiti del marito o un socio che paga i debiti della società per evitare il fallimento.
Il creditore non può rifiutare tale adempimento se non ha interesse che il debitore esegua di persona
la prestazione (ovviamente deve essere una prestazione fungibile come nel caso di un'obbligazione
pecuniaria); neppure il debitore può opporsi; ma se sono debitore e creditore a opporsi il terzo non
potrà adempiere.
Cmq nel caso intervenga un terzo bisogna distinguere 2 situazioni:
---PAGAMENTO DEL TERZO: è caratterizzato dalla spontaneità dell'intervento, il terzo agisce di
sua iniziativa pagando in nome proprio.
---PAGAMENTO PER MEZZO DEL TERZO: qui è il debitore che chiede al terzo di provvedere
all'adempimento in nome altrui, ad es delega una banca a effettuare il pagamento, in tal caso
l'adempimento va imputato al debitore.
Da rilevare, infine, che l'adempimento è un atto dovuto ( è conseguenza della obbligazione) per cui
se fatto da un incapace è perfettamente valido e non si può impugnare, mentre si può impugnare il
momento in cui “nasce” l'obbligazione: in altre parole un incapace non può firmare un contratto, ma
può pagare.
LEGITTIMATO A RICEVERE l'adempimento è il creditore; legittimati sono inoltre il suo
rappresentante,la persona indicata dal creditore,dalla legge o dal giudice. Il creditore è privo di
legittimazione a ricevere quando sia legalmente incapace, quando perde la disponibilità del credito
in caso di fallimento, pignoramento o sequestro e quando perde la titolarità ad es in seguito alla
cessione del credito.
Il debitore cmq viene liberato se in buona fede paga al CREDITORE APPARENTE cioè a chi
appare legittimato a riceverlo in base a circostanze univoche (es a chi presenta lo scontrino del
deposito bagagli il quale può anche non essere il proprietario dei bagagli).
EFFETTI DELL'ADEMPIMENTO
Effetto primo e fondamentale dell'esatto adempimento è l'estinzione dell'obbligazione e la
liberazione del debitore. L'adempiente ha diritto a ottenere quietanza liberatoria cioè ricevuta e ha
diritto a dichiarare quale debito intende soddisfare nel caso abbia + debiti verso lo stesso creditore
(cd IMPUTAZIONE DI PAGAMENTO): in mancanza della dichiarazione del debitore operano i
criteri dettati dalla legge: prima il debito scaduto, poi quello meno garantito, poi quello + oneroso,
infine il + vecchio.
Ulteriori effetti dell'adempimento sono l'estinzione delle garanzie reali e personali che assistevano il
credito e la liberazione di altri eventuali obbligati
In alcune circostanze è possibile la SURROGAZIONE NEL CREDITO cioè la sostituzione del
creditore con un'altra persona : in tal caso l'obbligazione muta direzione in quanto all'originario
creditore succede uno nuovo, consiste quindi nel subingresso di un terzo nella posizione creditoria.
Può avvenire:
---per volontà del creditore che cede il suo credito a un altro dietro pagamento
---per volontà del debitore (es la banca con il mutuo mi paga la casa e diventa mio creditore)
---per volontà della legge (che per es obbliga un condebitore a pagare tutto diventando così
creditore degli altri condebitori)
Il surrogato (cioè chi sostituisce) acquista il credito comprese le garanzie reali e personali.
In genere l'adempimento richiede la COOPERAZIONE DEL CREDITORE che riceve la
prestazione: questo vuol dire che il creditore deve fare quanto gli compete per mettere il debitore in
grado di adempiere ma questo non è un obbligo bensì un semplice onere. Così può succedere che il
creditore mette il bastone tra le ruote del debitore, ad es rendendosi irreperibile; a questo punto il
debitore non può rimanere indefinitamente obbligato e può avvalersi della “mora del creditore” e
della “liberazione coattiva del debitore”.
www.unictblog.com 39
Scaricato da Giovanni Porta (portagiovanni358@gmail.com)
lOMoARcPSD|7648598
MORA DEL CREDITORE (mora credendi) ha luogo quando il creditore senza legittimo motivo
rifiuta l'OFFERTA FORMALE di pagamento effettuata da parte del debitore con le seguenti
modalità:
---offerta solenne : effettuata tramite pubblico ufficiale in modo reale (cioè portando con sé la cosa,
se si tratta di obbligazioni portabili) o per intimazione a ricevere la cosa (se non sono portabili)
---offerta secondo gli usi: è effettuata direttamente dal debitore che
1)offre la prestazione ad es con una raccomandata al creditore invitandolo ad accettare la
prestazione e
2)effettua il deposito o il sequestro della cosa dovuta.
Effettuata l'offerta formale, se il creditore non accetta è costituito in mora, corre il rischio
dell'impossibilità sopravvenuta della prestazione ed è tenuto al risarcimento danni.
Si noti che con la offerta solenne è vero che il debitore non può + essere considerato inadempiente
ma è anche vero che l'obbligazione non è stata ancora adempiuta e quindi il debitore non è liberato:
ciò può essere un danno per il debitore ad es quando voglia cancellare un'ipoteca accesa a garanzia
di un debito. È prevista a tale scopo la LIBERAZIONE COATTIVA del debitore: il debitore
consegna la cosa dovuta a un terzo effettuando il “deposito” della cosa dovuta o il “sequestro” se si
tratta di un immobile; deposito e sequestro devono essere accettati dal creditore oppure convalidati
da una sentenza.
Nella pratica corrente si usa un altro sistema: un debitore può inviare ad es un vaglia postale o un
assegno al creditore e questa viene considerata una OFFERTA NON FORMALE la quale non mette
in mora il creditore ma almeno esclude la mora del debitore che non è più responsabile in caso di
impossibilità sopravvenuta, ma solo in determinate ipotesi.
In sostanza:
--se il DEBITORE è in mora è responsabile dei danni da impossibilità sopravvenuta
--se il CREDITORE è in mora è “ “ “ “
--se c'è stata offerta non formale il debitore è responsabile per le cose non ancora individuate, il
creditore per le cose individuate.
www.unictblog.com 40
Scaricato da Giovanni Porta (portagiovanni358@gmail.com)
lOMoARcPSD|7648598
CAP 25 INADEMPIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI (pagg 237-245)
L'inadempimento è l'inesatta esecuzione della prestazione dovuta (art 1218) e cioè un'esecuzione
non conforme alle regole che definiscono l'esatto adempimento: sarà quindi inesatta una prestazione
che non abbia i requisiti di diligenza, buona fede, esattezza quantitativa e qualitativa, puntualità di
tempo e luogo ecc.
In particolare l'inadempimento è :
--ASSOLUTO quando la prestazione è mancata del tutto
--RELATIVO quando la prestazione c'è stata ma risulta difforme da quella dovuta (ad es è stata fatta
in ritardo) e si dice imputabile quando ciò è dovuto a colpa del debitore.
Di fronte all'inadempimento il creditore può chiedere l'esecuzione in forma specifica se la
prestazione sia ancora possibile e il creditore abbia ancora interesse, e in ogni caso anche il
risarcimento del danno cagionato dall'inadempimento, se il debitore non prova che l'inadempimento
o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non
imputabile.
Quando una prestazione può definirsi impossibile?
In base all'art 1176 si può dire che la prestazione è impossibile quando non può essere eseguita con
l'impiego della diligenza richiesta normalmente per quel tipo di prestazione; ma l'art 1218 sembra
andare oltre, fino al limite delle possibilità umane: se l'unica strada esistente è franata e non posso
consegnare un pacco, sono stato diligente secondo l'art 1176; ma non lo sono stato secondo l'art
1218 perchè avrei potuto inviare il pacco per via aerea. Così spuntano fuori due correnti di
pensiero: una propone due regimi di responsabilità e cioè
1)nelle obbligazioni di mezzi e di dare cose specifiche, vale l'art 1176 con responsabilità per colpa
cioè non osservanza della diligenza media.
2)nelle obbligazioni di risultato e di dare cose generiche vale l'art 1218 con responsabilità oggettiva,
cioè non si è arrivati a fare l'umanamente possibile.
L'altra corrente (preferibile) non fa queste distinzioni e si appella alla diligenza del buon padre di
famiglia, ossia la diligenza media rapportata all'oggetto dell'obbligazione( posso portare con un
motorino un giornale ma non il quadro della Gioconda per la quale la diligenza media suggerisce
altri mezzi): quindi si tratterebbe di IMPOSSIBILITA' OGGETTIVA (cioè impossibile per qualsiasi
debitore medio) E RELATIVA (in rapporto al tipo di prestazione); sempre secondo questa
interpretazione, la funzione dell'art 1218 sarebbe quella di attribuire al debitore l'onere di provare
l'impossibilità della prestazione e che la causa dell'impossibilità non è a lui imputabile cioè che è
stata imprevedibile e inevitabile: classiche ipotesi di non imputabilità sono il CASO FORTUITO o
la FORZA MAGGIORE (una frana, una guerra ma anche uno sciopero generale o un fatto
dell'autorità o la morte o malattia del debitore).
La dimostrazione dell'impossibilità libera il debitore da responsabilità (IMPOSSIBILITA'
LIBERATORIA): l'impossibilità permanente determina l'estinzione dell'obbligazione.
Fra i diversi tipi di inadempimento il codice dedica particolare attenzione al RITARDO: l'art 1219
afferma che il ritardo non sempre costituisce inadempimento ad es un ritardo di pochi giorni può
essere accettato, ma quando si prolunga in modo intollerabile, si ha la MORA DEL DEBITORE
che è quindi un ritardo IMPUTABILE E QUALIFICATO cioè imputabile al debitore e qualificato
come “intollerabile”: il ritardo viene qualificato intollerabile tramite un atto di costituzione in mora
da parte del creditore cioè un'intimazione fatta per iscritto dal creditore (MORA EX PERSONA).
In altri casi la mora non richiede una specifica iniziativa del creditore, si verifica automaticamente
in determinate circostanze in cui è implicita l'intollerabilità del ritardo (MORA EX RE):
--quando il debito deriva da fatto illecito
--quando il debitore ha dichiarato per iscritto di non voler adempiere
--quando è scaduto il termine e il luogo della prestazione era il domicilio del creditore
--quando si tratta di obbligazione di non fare
Gli effetti di mora consistono nell'obbligo di risarcire il danno secondo le regole generali e
nell'aggravamento del rischio: durante la mora, la sopravvenuta impossibilità della prestazione è a
www.unictblog.com 41
Scaricato da Giovanni Porta (portagiovanni358@gmail.com)
lOMoARcPSD|7648598
carico del debitore anche se deriva da causa a lui non imputabile (se doveva consegnare frutta e non
lo ha fatto, se la frutta nel frattempo è andata a male sono cazzi suoi anche se la frutta è andata a
male a causa di un blackout generale).
La mora perciò aggrava la posizione del debitore: il debitore deve adempiere tempestivamente se
vuole evitare tale aggravio o in alternativa fare un' offerta formale o informale (questa offerta
costituisce in mora il creditore e scarica su di lui il rischio dell'impossibilità sopravvenuta).
EFFETTI DELL'INADEMPIMENTO IMPUTABILE AL DEBITORE
L'inadempimento è causa di responsabilità: l'inadempiente è infatti chiamato a rispondere delle
conseguenze del suo comportamento e anche dell'operato dei dipendenti e dei collaboratori.
La responsabilità si definisce contrattuale ma non si limita alle violazioni del contratto: comprende
tutte le ipotesi di inadempimento di una specifica preesistente obbligazione, quale che ne sia la
fonte: quindi violazione di atti e fatti idonei a produrre obbligazioni (ad essa si contrappone la
responsabilità extracontrattuale per fatto illecito o aquiliana).
Le clausole che esonerano da tale responsabilità sono valide tranne nei casi in cui l'inadempimento
sia dovuto a dolo o colpa grave (es grave negligenza).
L'inadempimento imputabile al debitore comporta l'obbligo di risarcire i danni: il risarcimento ha la
funzione di reintegrare il creditore nella stessa situazione in cui si sarebbe trovato se non vi fosse
stato l'inadempimento, tramite una prestazione diversa e succedanea: di norma questa diversa
prestazione consiste nel pagamento di una somma di denaro di ammontare equivalente al valore
della prestazione mancata (risarcimento per equivalente).
Il danno risarcibile si configura in base a 4 elementi:
----1)perdita subita e mancato guadagno:designati come DANNO EMERGENTE E LUCRO
CESSANTE: il primo consiste ad es nel valore del bene dovuto e non consegnato + le spese
sostenute; il secondo invece è il guadagno che il creditore avrebbe potuto realizzare utilizzando la
prestazione; nel caso di obbligazioni pecuniarie il risarcimento si effettua tramite gli interessi
moratori,determinati dalla legge.
----2)NESSO DI CAUSALITA' tra inadempimento e danno (art 1223): occorre quindi che l'uno sia
conseguenza immediata e diretta dell'altro: es in seguito a un incidente ferroviario Tizio viene
ricoverato in ospedale e quindi non può lavorare: si tratta di una conseguenza che non si sarebbe
verificata senza l'inadempimento. Ma fino a che punto si spinge questo nesso?
Tizio in ospedale subisce un aggravamento dei danni per imperizia medica.
Le FS sono responsabili anche dei danni subiti in ospedale?
Una parte della dottrina fa riferimento al criterio della REGOLARITA' CAUSALE: si imputano
all'inadempiente tutte le conseguenza che possono ritenersi “normali” ( FS responsabili solo dei
danni direttamente derivati dall'incidente); un'altra parte fa invece riferimento alla CAUSALITA'
TIPICA: il debitore risponde delle conseguenze che “siano attuazione di un rischio tipicamente
connesso al comportamento pur se anormali”( il vettore è responsabile del rischio cui si espone il
viaggiatore sottoponendosi a intervento e quindi anche dei danni subiti in ospedale).
----3)PREVEDIBILITA' del danno al tempo in cui è sorta l'obbligazione (art 1225): si vuole così
evitare di esporre il debitore per conseguenze che egli non poteva prevedere: così se il bene
aumenta notevolmente di valore l'inadempiente non risponderà di tale incremento (tale incremento
non sarà computato nel risarcimento); tale criterio non viene applicato quando l'inadempimento sia
doloso cioè volontario e intenzionale.
----4)IL CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE (art 1227): in tale previsione si
distinguono 2 ipotesi:
--il creditore ha contribuito col proprio comportamento a cagionare il danno: il risarcimento è
diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze
--in caso di mancata cooperazione del creditore che non si adopera nei limiti dell'ordinaria diligenza
per evitare o limitare il danno: qui il risarcimento non è dovuto.
LA RISARCIBILITA' DEL MAGGIOR DANNO
L'art 1224 cc stabilisce che al creditore che dimostra di avere subito un danno maggiore, spetta un
www.unictblog.com 42
Scaricato da Giovanni Porta (portagiovanni358@gmail.com)
lOMoARcPSD|7648598
ulteriore risarcimento che però non è dovuto se è stata convenuta la misura degli interessi moratori
(quindi superiori all'interesse legale).
Questo significa che la legge riconosce al creditore, oltre agli interessi moratori legali, anche un
risarcimento dovuto al maggior danno derivato dall'impossibilità di disporre della somma a lui
dovuta nel periodo di mora: ad es l'imprenditore che, non essendo stato pagato nei termini pattuiti,
è stato costretto, per continuare la sua attività produttiva, a rivolgersi ad una banca per un prestito,
ha diritto a un risarcimento per maggior danno, pari in questo caso alla differenza tra il tasso di
interesse pagato alla banca e il tasso d'interesse moratorio.
La Cassazione sembra avere confermato l'applicazione della norma anche al maggior danno subito
per effetto dell'inflazione, giustificandola con il fatto che il creditore avrebbe potuto investire la
somma ricevuta nei giusti termini, neutralizzando così gli effetti della svalutazione: in questo caso il
maggior danno viene valutato sulla differenza tra il tasso medio di rendimento dei titoli di stato (non
superiori a 12 mesi) e il tasso dell'interesse legale moratorio.
CAP 26 MODI DI ESTINZIONE DIVERSI DALL' ADEMPIMENTO (pagg 246-251)
Art 1230 e segg
E' possibile che l'obbligazione si estingua in altri modi che il codice designa come diversi
dall'adempimento e che la dottrina distingue in SATISFATTIVI e NON SATISFATTIVI a seconda
che comportino il soddisfacimento o meno dell'interesse dedotto dall'obbligazione.
La COMPENSAZIONE è l'estinzione dei reciproci rapporti obbligatori correnti tra i soggetti stessi.
Se un soggetto è al contempo debitore e creditore nei confronti di una stessa persona la
compensazione elimina la necessità di effettuare due distinti pagamenti:
Presupposto di questa disciplina è l'autonomia dei debiti nel senso che devono derivare da due fonti
diverse (se no si tratterebbe semplicemente di attivi e passivi). Si distinguono 3 tipi:
-1)---COMPENSAZIONE LEGALE è disposta dalla legge e opera l'estinzione automatica di debiti
reciproci che siano omogenei, liquidi ed esigibili: i debiti sono omogenei quando hanno ad oggetto
beni fungibili della stesso genere, liquidi quando sono determinati nel loro ammontare, esigibili
quando non sono sottoposti né a termine né a condizione.
-2)---COMPENSAZIONE GIUDIZIALE è pronunciata dal giudice quando si tratta di un credito
omogeneo ed esigibile, non ancora liquido (non determinato) ma di facile e pronta liquidazione.
-3)---COMPENSAZIONE VOLONTARIA è operata dalle parti con apposito accordo quando non ci
sono i requisiti per la legale o la giudiziale: l'accordo può essere preventivo riguardando così debiti
non ancora scaduti.
Una sottospecie della compensazione volontaria è la COMPENSAZIONE FACOLTATIVA che
attribuisce ad una delle parti, con atto unilaterale, il diritto potestativo di determinare la
compensazione dei debiti.
Si noti che la compensazione giudiziale e quella facoltativa richiedono rispettivamente una sentenza
e un atto (efficacia costitutiva) che segnano la data di estinzione.
La compensazione non si verifica per alcuni crediti come quelli impignorabili (es salari) e quelli
relativi alla restituzione di cose affidate in custodia o illecitamente sottratte.
La CONFUSIONE si realizza quando le qualità di creditore e debitore si riuniscono nella stessa
persona: può verificarsi in seguito a successione ereditaria o anche per atto tra vivi es se un'azienda
ha un debito con un'altra azienda e successivamente le 2 aziende si fondono, si determina
l'estinzione dell'obbligazione per il venir meno della pluralità dei soggetti.
La NOVAZIONE si verifica in base a un accordo tra le parti: le parti sostituiscono all'obbligazione
originaria una nuova obbligazione; per effetto di questa, la vecchia obbligazione si estingue e il
debitore sarà tenuto esclusivamente ad adempiere alla nuova. Si dice SOGGETTIVA quando la
modifica riguarda la persona del debitore, OGGETTIVA quando la modifica concerne l'oggetto
www.unictblog.com 43
Scaricato da Giovanni Porta (portagiovanni358@gmail.com)
lOMoARcPSD|7648598
( invece di denaro mi obbligo a dare un'auto) ovvero il titolo dell'obbligazione (invece di dare una
cosa in custodia mi obbligo a darla in comodato): gli elementi che la caratterizzano sono:
--ANIMUS NOVANDI la volontà di estinguere l'obbligazione che deve risultare in modo certo
--ALIQUID NOVI occorre che la nuova obbligazione sia sostanzialmente nuova, abbia cioè un
oggetto o un titolo diverso.
Con la novazione la vecchia obbligazione si estingue e se ne crea una nuova: questa però dipende
funzionalmente dall'originaria pertanto se questa ad es era nulla, la novazione è senza effetto.
Questo fatto della obbligazione che deve essere nuova, distingue la novazione dalla prestazione in
luogo di adempimento o DATIO IN SOLUTUM: questa comporta una semplice sostituzione della
prestazione dovuta con un'altra ma MANTIENE INALTERATA l'obbligazione originaria che si
estingue solo se e quando la nuova prestazione è stata adempiuta.
La novazione invece estingue immediatamente la vecchia obbligazione con tutti i suoi accessori: se
il debitore non adempie la nuova obbligazione, il creditore non può più chiedere l'adempimento
della prestazione originaria.
La REMISSIONE è la rinuncia del creditore al proprio diritto. Ha l'effetto di estinguere il debito
non appena è comunicata al debitore: E' un negozio unilaterale poiché consiste in una dichiarazione
del solo creditore, recettizio perchè ha effetto non appena la comunicazione giunge al debitore; non
occorre l'accettazione da parte del debitore; questi può rifiutare e in tal caso dovrà solo comunicare
il suo rifiuto che avrà l'effetto di togliere efficacia da subito all'estinzione del debito. E' un atto
gratuito e non è richiesta alcuna forma per la validità dell'atto:(può essere anche tacita e consiste
nella semplice restituzione ad es della cambiale).
Oggetto di remissione possono essere tutti i crediti salvo quelli indisponibili ( es salari): quanto agli
effetti la remissione libera il debitore e produce l'estinzione delle garanzie di credito.
IMPOSSIBILITA' SOPRAVVENUTA per causa non imputabile al debitore
L'impossibilità è un estremo oggettivo cioè tale da colpire qualunque debitore: il caso fortuito e la
forza maggiore, il fatto dell'autorità, lo sciopero generale ( ma non quello aziendale),malattia o
morte del debitore. Impossibilità non imputabile significa che non deve dipendere da un fatto che
rientra nella sfera di controllo del debitore (una rapina subita non è considerato evento
imprevedibile)
Se l'impossibilità è solo temporanea (es per malattia), il debitore è esonerato da responsabilità per
la durata dell'impedimento: se tuttavia finito l'impedimento il creditore non ha più l'interesse a
ricevere la prestazione, l'obbligazione si estingue.
Se invece si tratta di impossibilità parziale il debitore si libera eseguendo la parte di prestazione che
è rimasta possibile salvo che il creditore non abbia interesse, come sopra detto.
L'impossibilità dunque estingue l'obbligazione liberando il debitore ed esonerandolo da
responsabilità il che vuol dire che la eventuale perdita economica dovuta all'inadempimento, sarà
subita dal creditore che eventualmente potrà rifarsi su terzi che ad es sono gli autori dell'incendio
che ha distrutto la cosa dovuta, surrogando così il debitore.
12
www.unictblog.com 44
Scaricato da Giovanni Porta (portagiovanni358@gmail.com)
lOMoARcPSD|7648598
CAP 27 CIRCOLAZIONE DELLE OBBLIGAZIONI ( pagg 252-263)
Come i beni si possono trasferire da un soggetto a un altro (sono cioè suscettibili di circolazione
giuridica ), così possono trasferirsi da un soggetto a un altro anche i diritti di credito.
Anche per questi esistono acquisti a titolo originario e a titolo derivativo.
L'acquisto a titolo originario riguarda i titoli di credito in cui la prestazione è incorporata in un bene
mobile cioè il documento di credito ad es la cambiale. Al di fuori di tale ipotesi la circolazione delle
obbligazioni si realizza a titolo derivativo tramite una successione derivativo-traslativa da un
soggetto a un altro e il diritto si trasferisce con gli stessi limiti e caratteristiche che aveva in capo al
precedente titolare: si può dire molto semplicemente che la circolazione delle obbligazioni consiste
in una modificazione dei soggetti dell'obbligazione e cioè del creditore (modificazioni dal lato
attivo) e/o del debitore (lato passivo).
Il ruolo svolto da queste modificazioni è quello di far circolare già oggi quella ricchezza futura
rappresentata dai crediti così come il trasferimento dei beni fa circolare la ricchezza attuale.
MODIFICAZIONI DAL LATO ATTIVO
Si hanno quando al creditore originario subentra un nuovo creditore.
E' una vera e propria successione nel senso che il nuovo creditore subentra in una situazione
giuridica il cui contenuto rimane invariato: il nuovo creditore avrà quindi gli stessi poteri e limiti
che competevano al creditore originario: il trasferimento del creditore non richiede il consenso del
debitore essendo indifferente per il debitore adempiere a uno piuttosto che all'altro.
Le modificazioni dal lato attivo comprendono diverse situazioni come la surrogazione (pag 7) e la
delegazione attiva (vedi dopo) ma la figura di riferimento è la cessione del credito.
LA CESSIONE DEL CREDITO consiste nel trasferimento di un credito dal creditore originario
(cedente) al nuovo creditore (cessionario): il trasferimento può avvenire in diversi modi: se ad es la
cessione avviene dietro corrispettivo di un prezzo si parlerà di una vendita, se con spirito di
liberalità si parlerà di donazione; inoltre posso cedere un credito per estinguere un mio debito verso
il cessionario, si avrà allora un contratto solutorio così detto perchè si intende solvere un debito
tramite una prestazione in luogo di un adempimento (es cessione del quinto della stipendio).
Non tutti i crediti sono cedibili: vi è una incedibilità oggettiva quando il tipo di credito ha carattere
strettamente personale (i crediti alimentari) e vi è poi una incedibilità soggettiva dipendente dalla
qualità dei possibili cessionari e dalla volontà che le parti abbiano di escludere detta cedibilità.
EFFETTI: concluso l'accordo il credito si trasferisce al cessionario con effetto immediato, insieme
con gli accessori del credito (garanzie reali e personali, interessi convenzionali ecc).La posizione
debitoria resta immutata e rimangono impregiudicate le eccezioni relative al credito (il debitore
potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni che poteva opporre al creditore originario).
NOTIFICA: la cessione non richiede il consenso del debitore, egli però dovrà cmq esserne
informato: ove manchi tale conoscenza il debitore rimarrà liberato anche se adempirà verso chi non
è più creditore. La notificazione della cessione serve inoltre a risolvere il conflitto tra + cessionari di
un medesimo credito: prevale infatti la cessione NOTIFICATA per prima, anche se la cessione è
stata fatta in data posteriore.
GARANZIE: il cedente è tenuto a prestare al cessionario delle garanzie, dipendenti dalla causa
della cessione:
--A) se la cessione è a titolo oneroso il cedente deve garantire per legge solo l'esistenza del credito
(cd nomen verum) non la solvenza del debitore: tale garanzia si può anche escludere pattiziamente
(ma il cedente resta cmq obbligato per il fatto proprio) oppure si può estendere alla solvenza del
debitore ceduto (tale significato hanno le clausole “salvo buon fine” e “salvo incasso”) ma in tal
caso il cedente risponderà solo nei limiti di quanto ricevuto dal cessionario ( cioè se il debitore non
paga il cessionario, il cedente darà indietro al cessionario il prezzo avuto per la cessione + spese).
13
www.unictblog.com 45
Scaricato da Giovanni Porta (portagiovanni358@gmail.com)
lOMoARcPSD|7648598
--B)Nell'ipotesi di cessione solutoria vigono le seguenti regole:
in genere in caso di cessione di un credito in luogo di adempimento, la cessione si intende fatta per
pagare (PRO SOLVENDO) e perciò la vecchia obbligazione si estingue solo con l'effettiva
riscossione del credito ceduto.
E' però possibile che le parti abbiano espressamente convenuto che la cessione sia fatta in
pagamento PRO SOLUTO e in tal caso l'obbligazione si estinguerà immediatamente per effetto
dell'accordo di cessione rimanendo indifferente che il credito ceduto sia pagato oppure no: io ho un
debito verso A e un credito da B e per pagare A gli cedo il credito da B: se la cessione è pro
solvendo io mi libero del debito solo quando B paga; se è pro soluto sono libero già al momento
della cessione, non importa che B paghi o no.
MODIFICAZIONI DAL LATO PASSIVO (sostituzione,delegazione, espromissione e accollo)
La SOSTITUZIONE del debitore con un altro può aversi solo per successione ( ad es quando si
eredita si può anche ereditare un debito oppure quando un'azienda viene venduta, nella vendita sono
compresi anche i debiti); in tutte le altre ipotesi di modificazione del debitore (delegazione,
espromissione e accollo), il principio generale è che, senza il consenso del creditore, non è possibile
sostituire il debitore originario ma soltanto AFFIANCARE ad esso un nuovo debitore.
LA DELEGAZIONE può essere:
--1)--DELEGAZIONE DI PAGAMENTO: è l'incarico che un soggetto dà a un altro soggetto di
pagare a un terzo; l'ipotesi + frequente è quella in cui un soggetto A è contemporaneamente
creditore di B e debitore di C. A può allora utilizzare il credito che vanta nei confronti di B per
adempiere il debito verso C tramite l'istituto della delegazione (che è un mandato)
Con la delegazione di pagamento il delegante A incarica il delegato B di effettuare un pagamento al
delegatario C; il delegato B non è tenuto ad accettare l'incarico ma se accetta e lo esegue, il suo
adempimento estinguerà contemporaneamente il debito verso il delegante e il debito del delegante
verso il delegatario. Un classico esempio di questo schema è l'assegno bancario: la banca dove ho
un conto, è mia debitrice e con l'assegno paga un mio creditore. Il rapporto delegante-delegato si
chiama rapporto di PROVVISTA, quello delegante-delegatario rapporto di VALUTA.
--2)--DELEGAZIONE DI DEBITO O PROMISSORIA: riprende lo schema già visto ma se ne
discosta in quanto il delegante incarica il delegato non di pagare ma di PROMETTERE un
pagamento al delegatario.
Questo schema si ritrova nella cambiale tratta che consiste in un invito che il delegante fa ad un suo
debitore di obbligarsi verso un suo creditore; quindi lo schema è il seguente: il delegante A invita il
delegato ad obbligarsi verso un'altra persona; il delegato non è tenuto ad accettare l'incarico,ma se
accetta effettuerà la promessa al delegatario rimanendo obbligato verso di lui: “su invito di A, mi
impegno a pagarle la somma di 1000 € che A le deve a titolo di pagamento per la merce acquistata”:
in questa dichiarazione il delegato fa riferimento al rapporto di valuta tra il delegante e il delegatario
(il delegante ha comprato evidentemente merce dal delegatario e la deve pagare): in tal caso la
promessa viene titolata sul rapporto di valuta e si parla di DELEGAZIONE TITOLATA
Ciò permette al delegato di opporre eccezioni al delegatario ad es può rifiutare il pagamento
promesso perchè la merce acquistata non è stata consegnata o è viziata.
Ordinariamente tuttavia la promessa non farà riferimento ai rapporti sottostanti e si parla allora di
DELEGAZIONE ASTRATTA: “su invito di A mi impegno a pagarle la somma di 1000 €”
In tal caso il delegato non potrà opporre le eccezioni fondate su tali rapporti salvo che siano
entrambi inefficaci (cd nullità della doppia causa).
La promessa del delegato pur se accettata dal delegatario non libera il delegante: infatti la
delegazione di debito crea una nuova obbligazione a carico del delegato per effetto della sua
promessa e poichè di norma la delegazione è cumulativa tale nuova obbligazione non estingue
quella del delegante che rimane in vita.
14
www.unictblog.com 46
Scaricato da Giovanni Porta (portagiovanni358@gmail.com)
lOMoARcPSD|7648598
Il delegatario può consentire espressamente di liberare il delegante (delegazione LIBERATORIA)
e in tal caso si creerebbe una nuova obbligazione che si sostituisce a quella vecchia avendosi così
una novazione se la delegazione è astratta (l'obbligazione delegante-delegatario viene sostituita
dalla nuova obbligazione delegato-delegatario); o una mera successione del debitore se la
delegazione è titolata (nel rapporto delegante-delegatario, il delegato succede al delegante) .
Le ipotesi prese in considerazione finora sono quelle in cui il delegante è al tempo stesso creditore
del delegato e debitore del delegatario: questo tipo di delegazione è definita attiva e passiva allo
stesso tempo. E' anche possibile l'ipotesi in cui il delegante è solo debitore del delegatario e invita
un terzo ad obbligarsi verso il suo creditore: in questo caso il delegante è debitore non solo del
delegatario ma anche del delegato e si parla di delegazione passiva.
La delegazione può anche essere attiva e si ha quando il delegante A ha un credito con B ma NON
ha debiti con C: egli incarica B di obbligarsi verso C: il delegato B adempiendo estinguerà il
proprio debito verso A mentre A acquisterà un credito verso il delegatario C.
L'ESPROMISSIONE
E' un contratto tra il creditore e un terzo il quale SENZA DELEGAZIONE DEL DEBITORE, ne
assume il debito verso il creditore: caratterizzante di questa figura è dunque l'iniziativa del terzo
(espromittente) che interviene senza un previo incarico del debitore (espromesso): es un socio che
si obbliga verso i creditori della sua società per ottenere una dilazione.
L'espromittente non paga immediatamente ma si limita a promettere in proprio il pagamento del
debito altrui: l'espromissione non libera automaticamente il debitore originario e perciò è
cumulativa salvo che il creditore dichiari espressamente di liberarlo.
Per effetto dell'espromissione il terzo subentra nella stessa posizione del debitore (che cmq è in
posizione sussidiaria) e rimane obbligato in solido per lo stesso debito quindi può opporre le stesse
eccezioni del debitore originario tranne quelle relative ai rapporti personali creditore -debitore
originario e quelli fra espromittente e debitore originario esse infatti finirebbero col rendere inutile
l'espromissione.
L'ACCOLLO
Mentre nell'espromissione l'accordo è tra terzo e creditore, nell'accollo l'accordo intercorre tra terzo
e debitore: in virtù di tale accordo il terzo si assume il debito verso il creditore.
Qui è il creditore (accollatario) a rimanere estraneo al contratto che non richiede quindi il suo
consenso: è anzi possibile che non possa vantare alcun diritto nei confronti del terzo e si parla in tal
caso di ACCOLLO INTERNO poiché è soltanto verso il debitore accollato che il terzo obbliga.
Di norma però l'accordo si struttura come ACCOLLO ESTERNO che ha i caratteri di un contratto a
favore di terzi, in tal caso il creditore può aderire alla convenzione (cioè accetta) e potrà pretendere
il pagamento anche dal terzo; anche in tal caso il debitore originario non è automaticamente liberato
(salvo espressa volontà del creditore) e la nor ma è quindi cumulativa.
Per effetto dell'accollo il terzo subentra nella stessa posizione del debitore e potrà quindi opporre al
creditore tutte le eccezioni che avrebbe opposto il debitore originario.
Tutti questi strumenti visti cui si ricorre per far circolare le obbligazioni sono intercambiabili
Ad es : A ha un debito con C ma anche un credito con B B> A > C
A può fare:
--delegazione di pagamento (B paga C)
--delegazione di debito (delega B a promettere a C)
--stipula con B accollo (per cui B si accolla il debito di A vs C)
--cessione a C del proprio credito con B
15 15
www.unictblog.com 47
Scaricato da Giovanni Porta (portagiovanni358@gmail.com)
lOMoARcPSD|7648598
CAP 28 GARANZIA PATRIMONIALE GENERICA (pagg 264-272)
L'art 2740 cc afferma il principio della RESPONSABILITA' PATRIMONIALE: il debitore risponde
dell'adempimento dell'obbligazione con tutti i suoi beni presenti e futuri.
Tale principio comporta che il suo patrimonio, in caso di inadempimento, verrà espropriato e
venduto all'asta per soddisfare i creditori.
I beni del debitore quindi costituiscono la garanzia patrimoniale dei creditori.
Non sono ammesse limitazioni della responsabilità patrimoniale neppure negoziali fuorchè alcuni
casi espressamente stabiliti dalla legge che riguardano beni e diritti strettamente connessi alla
persona e alle sue primarie esigenze di lavoro e sostentamento: così non sono espropriabili alcuni
arredi della casa, gli strumenti di lavoro, crediti alimentari, mentre le retribuzioni possono essere
pignorate fino a un quinto del loro ammontare.
Fino a tempi recenti non era consentita la creazione di patrimoni separati e cioè distaccare alcuni
beni sottraendoli alla responsabilità patrimoniale e alla generale garanzia dei creditori: solo la legge
ammetteva questa facoltà in determinati casi e solo agli imprenditori.
Oggi la legge consente con maggiore larghezza anche ai privati la possibilità di costituire patrimoni
di destinazione cioè riservati a determinati scopi: in particolare gli artt 2447 bis e ss. prevedono che
le spa possano destinare uno o + patrimoni alla realizzazione di uno specifico affare, e l'art 2645 ter
prevede la possibilità dei privati di destinare beni mobili registrati e immobili alla realizzazione di
interessi meritevoli di tutela a beneficio di particolari persone fisiche o enti. In tutte queste ipotesi i
beni conferiti e i loro frutti sono soggetti a esecuzione forzata solo per i debiti contratti a tale scopo.
Il patrimonio di ciascun soggetto costituisce la garanzia patrimoniale GENERICA in quanto
riguarda TUTTI i beni del debitore e sussiste fino a quando detti beni vi siano; a tale garanzia si
contrappongono le cd garanzie SPECIFICHE che garantiscono (ossia privilegiano) un credito
rispetto a tutti gli altri.
Altro principio che regola la responsabilità patrimoniale è la PARITA' DI TRATTAMENTO DEI
CREDITORI: tutti i creditori hanno egual diritto di esser soddisfatti sui beni del debitore
indipendentemente dal momento in cui è nato il debito o dalla causa; in caso di insufficienza del
patrimonio i creditori subiranno una perdita proporzionalmente uguale; come vedremo, nelle
garanzie specifiche, ad un creditore può essere data una preferenza: in tal caso questi avrà il diritto
di soddisfarsi con precedenza sul ricavato della vendita dei beni e gli altri detti creditori chirografari
potranno soddisfarsi sul residuo.
Poiché i beni del debitore costituiscono la garanzia patrimoniale generica dei creditori, questi hanno
interesse a conservarla e cioè hanno interesse che il debitore non diminuisca il proprio patrimonio:
il debitore resta libero di disporre dei sui beni ma è consentito al creditore di intervenire qualora il
comportamento del debitore metta in pericolo il soddisfacimento del credito:
I mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale sono:
azione surrogatoria, revocatoria e sequestro conservativo
--1)-AZIONE SURROGATORIA (art 2900) è il potere del creditore di surrogarsi cioè di sostituirsi
al debitore nell'esercizio dei diritti che gli spettano verso terzi: qui il debitore, trascurando di
esercitare i propri interessi mette in pericolo il soddisfacimento del creditore.
Presupposti dell'azione surrogatoria sono:
--inerzia del debitore che trascura di esercitare i diritti ad es non riscuote un suo credito
--il pregiudizio (il danno) del creditore dovuto al fatto che il residuo patrimonio non è + sufficiente
--i diritti che il debitore trascura devono essere diritti di credito o diritti potestativi (cioè rivolti a
una persona determinata) che abbiano contenuto patrimoniale e non siano strettamente personali (ad
es l'azione surrogatoria non è ammessa nell'accettazione di una donazione)
Il potere surrogatorio può perciò esercitarsi al fine di riscuotere un credito, annullare un contratto
sfavorevole, interrompere una prescrizione.
Resta inteso che l'azione surrogatoria non porta vantaggi DIRETTI al creditore: io creditore faccio
in modo che il mio debitore riscuota un suo credito, ma questo va direttamente a lui non a me
16
www.unictblog.com 48
Scaricato da Giovanni Porta (portagiovanni358@gmail.com)
lOMoARcPSD|7648598
--2)-AZIONE REVOCATORIA: mentre l'azione surrogatoria è volta a rimediare all'inerzia del
debitore, a un suo comportamento omissivo, l'azione revocatoria è diretta a reagire contro un
comportamento commissivo cioè contro gli atti con cui il debitore deteriora la propria situazione
patrimoniale (ad es vende un suo bene, rinuncia a un credito): in tal caso il creditore può far
dichiarare questi atti inefficaci NEI SUOI CONFRONTI;
presupposti per l'azione revocatoria sono:
---l'atto di disposizione cioè un atto con cui il debitore peggiori il suo patrimonio ad es atti di
alienazione, remissione di un debito, nuovi debiti: non sono revocabili i pagamenti dei debiti scaduti
in quanto si tratta di atti giuridicamente dovuti, sono invece revocabili i pagamenti dei debiti non
ancora scaduti
---Il pregiudizio del creditore consistente nel fatto che il patrimonio rimanente è insufficiente a
garantire il pagamento dei debiti
—la conoscenza da parte del debitore del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore.
Effetto dell'azione revocatoria è l'inefficacia relativa dell'atto revocato: relativa vuol dire che l'atto
diventa inopponibile SOLO al creditore revocante ma conserva efficacia sia tra le parti sia rispetto
ai creditori che non hanno partecipato all'azione. L'atto perciò non è nullo né invalido e dunque
l'azione non ha effetto restitutorio, il bene non torna nel patrimonio del debitore, resta al terzo
acquirente ma, per il solo creditore revocante è come se non fosse mai avvenuto e può sottoporlo a
esecuzione forzata, come se fosse ancora del debitore.
I terzi che hanno acquistato dal debitore mantengono i loro diritti solo se hanno acquisito a titolo
oneroso e non sapevano (le donazioni fatte dal debitore, essendo gratuite possono essere revocate):
questi terzi che, a seguito della revoca dell'atto, hanno subito “evizione” cioè si sono visti
espropriare il bene che avevano acquistato dal debitore, possono chiedere risarcimento al debitore e
partecipare al ricavato dell'espropriazione ma solo dopo che il creditore revocante è stato
soddisfatto.
L'azione revocatoria si prescrive in 5 anni e richiede la partecipazione al giudizio di tutti gli
interessati cd litisconsorzio necessario (creditore, debitore, terzo).
La legge prevede anche la possibilità di revocare atti anteriori al sorgere del credito: ad es chiedo un
mutuo il 10 giugno ma prima ho venduto tutti i miei beni così eventualmente non possono
sequestrarmi nulla: se si accerta il dolo del venditore e di colui che ha comprato i beni, questo atto
di compravendita può essere revocato.
--3) IL SEQUESTRO CONSERVATIVO è un provvedimento preventivo e cautelare emesso dal
giudice su istanza del creditore che ha timore di perdere la garanzia del proprio credito. Impedisce
al debitore la disposizione di alcuni beni, quindi l'eventuale alienazione sarebbe inefficace
Anche questo è un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale ma è un mezzo preventivo,
anteriore quindi al compimento di atti pregiudizievoli da parte del debitore.
Nota : il DIRITTO DI RITENZIONE : se porto un piccolo elettrodomestico ad un tecnico perchè lo
ripari, questi ha il diritto di tenerlo fino al pagamento del dovuto; se “dimentico” di ritirarlo, il
tecnico può richiedere il pagamento della custodia; passato un congruo periodo di tempo il tecnico
può anche vendere l'elettrodomestico.
17
www.unictblog.com 49
Scaricato da Giovanni Porta (portagiovanni358@gmail.com)
lOMoARcPSD|7648598
CAP 29 GARANZIE PATRIMONIALI SPECIFICHE (pagg273-285)
Come si è visto, oltre alla garanzia generica sono previste ulteriori forme di garanzie.
Un primo tipo di garanzie è costituito dalle garanzie personali prestate da terzi ad es la fideiussione
in cui un terzo garantisce il debitore con tutto il suo patrimonio ( quindi si tratta di un'ulteriore
garanzia generica simile alla garanzia generica del debitore).
Forme di garanzia specifica in senso proprio sono invece i privilegi, il pegno e l'ipoteca.
[ Presentano le seguenti caratteristiche:
1)cadono su beni determinati del debitore o di un terzo e non su tutto il patrimonio
2)occorre un titolo apposito e specifico (ad es un contratto) per la loro costituzione
3)attribuiscono un diritto ulteriore e specifico al generale ius distrahendi spettante a tutti gli altri
creditori e cioè il diritto di prelazione: i creditori muniti di garanzia specifica hanno la precedenza
rispetto agli altri ( i cd chirografari) sul ricavato della vendita dei beni.
4)attribuiscono il diritto di seguito sul bene: il diritto cioè segue il bene nei suoi successivi
trasferimenti, il che significa che il creditore può espropriarlo anche al terzo acquirente: per tale
opponibilità erga omnes queste garanzie, con l'eccezione del privilegio generale, si configurano
come diritti reali.]
IL PRIVILEGIO
Il privilegio è la prelazione che la legge accorda al creditore in considerazione della causa del
credito: ci sono cioè crediti che la legge considera + importanti e che saranno i primi ad essere
soddisfatti: quindi non si tratta di un diritto autonomo distinto dal credito e ad esso accessorio
( come pegno e ipoteca), ma un carattere del credito: o il credito è privilegiato sin dalla nascita o
non potrà + esserlo e solo la legge ha il potere di conferire questa particolare garanzia che d'altra
parte cade solo sui beni del debitore non anche su un terzo (a differenza di pegno e ipoteca).
Sono previsti due tipi di privilegi generale e speciale:
--generale cade su tutti i beni mobili del debitore: non attribuisce diritto di seguito e si riferisce a
crediti relativi a spese funebri,sanitarie e alimentari, crediti per le imposte
--speciale cade su determinati beni mobili o immobili: ha un vero e proprio carattere di realità
attribuendo oltre alla prestazione il diritto di seguito: se si tratta di immobili può farsi valere contro
gli acquirenti successivi, i creditori ipotecari ecc; se si tratta di beni mobili NON potrà farsi valere
contro chi acquista, anche successivamente,la proprietà (qui si tratta di possesso titolato per il quale
la cosa si acquista libera da diritti altrui): i crediti per fitti hanno precedenza sugli arredi, i crediti
per spese di giustizia prevalgono sugli immobili ai quali si riferiscono; se + privilegi concorrono
sullo stesso bene, l'ordine è fissato dagli art 2777 e ss; inoltre sui mobili il pegno prevale sul
privilegio speciale, mentre sugli immobili il privilegio speciale prevale sull'ipoteca.
Le altre garanzie specifiche sono il pegno e l'ipoteca
Sono cause di prelazione che attribuiscono a un creditore un vero e proprio diritto reale sul bene che
ne costituisce oggetto: si tratta di diritti su beni altrui (al pari degli altri diritti minori come la
servitù) e sono detti di garanzia in quanto attribuiscono al creditore alcuni poteri specifici a tutela
del suo credito; hanno le segg caratteristiche comuni:
--diritto di prelazione nella distribuzione del denaro ricavato dalla vendita dei beni vincolati
--diritto di seguito cioè il diritto di far espropriare il bene anche se esso sia nel frattempo passato in
proprietà di altri: il diritto segue infatti il bene (e in ciò si manifesta il suo carattere di realità), come
nel privilegio speciale;
--a differenza dei privilegi speciali che sono accordati solo dalla legge, essi sono costituiti per
volontà dei privati, per questo possono costituirsi anche dopo il sorgere del credito
--abbisognano di un titolo (contratto di pegno o ipoteca)
--mentre i privilegi cadono solo sui beni dei debitori, pegno e ipoteca possono costituirsi anche sui
beni di un terzo datore (ovviamente con il suo consenso) che risponderà del debito non con il suo
patrimonio ( come il fideiussore) ma con il bene offerto in garanzia.
Carattere comune a pegno e ipoteca è l'accessorietà: sono cioè diritti accessori al credito e pertanto
ne seguono le vicende e in particolare si estinguono in caso di estinzione del credito garantito.
www.unictblog.com 50
Scaricato da Giovanni Porta (portagiovanni358@gmail.com)
lOMoARcPSD|7648598
La legge difende sia l'interesse del creditore che quello del debitore:
se la cosa data in pegno o ipoteca perisce, il creditore può chiedere un'altra idonea garanzia
( compresa l'eventuale indennità assicurativa sulla cosa) oppure l'immediato pagamento del credito.
D'altra parte la legge vieta il cd PATTO COMMISSORIO e cioè il patto col quale si conviene che in
mancanza del pagamento la proprietà della cosa passi al creditore: si è voluto evitare così che il
creditore possa approfittare della condizione di debolezza del debitore per arricchirsi a suo danno
Invece è valido il patto con cui si stabilisce che la cosa passi immediatamente in proprietà del
creditore e che in caso di esatto adempimento essa torni al debitore (ALIENAZIONE IN
GARANZIA) il che sembra in contrasto col divieto di patto commissorio ma non lo è: qui si
tratterebbe infatti di atti non collegati DIRETTAMENTE all'inadempimento, cioè il debitore è
libero di valutare se gli conviene vendere al creditore (acquisire un credito vs il creditore con il
quale quindi avrebbe contemporaneamente un debito e un credito da compensare), eventualmente
con patto di riscatto o di retrovendita, oppure cedere il bene al creditore come datio in solutum.
Tutto questo, detto tra noi, è un modo di aggirare il divieto di patto commissorio.
Il PEGNO
E' un diritto reale che vincola un bene mobile del debitore a garanzia di un credito.
Il diritto attribuisce al creditore la facoltà di espropriare la cosa anche se essa sia stata alienata a
terzi (diritto di seguito) e di soddisfarsi con prelazione su di essa.
Oggetto di pegno possono essere i beni mobili, le universalità di mobili e i crediti del debitore o di
un terzo datore di pegno. Si costituisce con apposito contratto (scritto e con data certa quando il
valore del credito supera 5000 £ o l'oggetto del pegno è un credito) che ha natura di contratto reale
in quanto richiede anche la consegna della cosa al creditore o ad un terzo designato dalle parti:
occorre inoltre che la cosa resti in possesso del creditore o del terzo pena il venir meno della
garanzia. Lo spossessamento del debitore ha inoltre funzione di pubblicità se pur indiretta (perchè
non esiste un registro sul quale annotare il diritto); il consegnatario non può usare la cosa né
concedere ad altri il godimento, deve piuttosto custodirla e restituirla una volta che sia stato pagato
il debito garantito: può usare la cosa se quest'uso è necessario alla sua conservazione es un gregge
di pecore o se si tratta di cose fungibili come il denaro: ad es la cauzione versata dall'inquilino come
garanzia per le pigioni e gli eventuali danni, è denaro che passa al creditore padrone di casa ( il cd
PEGNO IRREGOLARE) che dovrà in seguito restituirlo o trattenerlo tutto o in parte per
inadempimento o danno
Se il debito garantito non viene pagato il creditore può far vendere la cosa o farsi assegnare in
pagamento la cosa, realizzando una sorta di datio in solutum.
L'IPOTECA
E' un diritto reale che vincola un bene immobile a garanzia di un credito: essa attribuisce al
creditore ipotecario il diritto di espropriare il bene anche in confronto del terzo acquirente (diritto di
seguito) e di soddisfarsi con prelazione sul ricavato della vendita forzata.
Oggetto di ipoteca sono i beni immobili, i mobili registrati, i diritti reali di godimento sugli stessi e
le rendite dello stato e si estende ai miglioramenti e alle accessioni.
Caratteri dell'ipoteca sono la specialità e l'indivisibilità, cioè può costituirsi solo su beni
specialmente indicati e per una somma determinata: non sono quindi ammesse ipoteche generali.
E' inoltre indivisibile perchè sussiste per intero sopra tutti i beni vincolati, cioè se pago l'ipoteca
solo in parte essa continua a gravare su tutti i beni vincolati.
Per costituire l'ipoteca occorrono 2 elementi:
--il titolo che autorizzi il creditore perchè trattandosi di una garanzia specifica non basta la semplice
esistenza del credito
--l'iscrizione nei pubblici registri che è una forma di pubblicità costitutiva senza la quale l'ipoteca
non può sorgere
Fonti del diritto di iscrivere ipoteca sono la legge, la sentenza del giudice, la volontà provata, per
cui avremo un'ipoteca legale, giudiziale e volontaria.
L'IPOTECA LEGALE nasce grazie alla legge che attribuisce tale diritto a:
--chi ha venduto un immobile o mobile registrato a garanzia del pagamento
www.unictblog.com 51
Scaricato da Giovanni Porta (portagiovanni358@gmail.com)
lOMoARcPSD|7648598
--coeredi, soci e altri condividenti a garanzia del pagamento dei conguagli in denaro che gli spettano
possono accendere ipoteca sugli immobili dell'eredità;
--lo stato sui beni di un imputato a pagamento delle spese processuali e delle pene pecuniarie.
E' iscritta d'ufficio al momento della trascrizione dell'atto di acquisto o di divisione e prevale sulle
trascrizioni e iscrizioni già eseguite contro l'acquirente.
L'IPOTECA GIUDIZIALE trova titolo in sentenza o altro provvedimento che condanni il debitore
al pagamento di una somma di denaro o all'adempimento di un'altra obbligazione: presentando
questo provvedimento, il creditore può ottenere iscrizione di ipoteca sul pubblico registro.
L'IPOTECA VOLONTARIA nasce da un contratto o da dichiarazione unilaterale, redatti per atto
pubblico o scrittura privata autenticata, può gravare sia su beni del debitore, sia sui beni di un terzo
che lo consenta, sia su una vendita futura di un bene ( ma qui l'iscrizione potrà avvenire solo al
momento in cui si concretizzerà la vendita)
Come detto,la pubblicità ipotecaria ha funzione costitutiva, l'ipoteca non nasce se non quando è
iscritta: l'iscrizione viene effettuata sui pubblici registri del luogo dove si trova il bene e secondo la
natura del bene ( ci sono il registro immobiliare, il registro automobilistico, il registro navale ecc)
e occorre presentare il titolo (contratto o sentenza) e un'apposita nota
Su uno stesso bene sono possibili+ ipoteche successive per crediti diversi e a ciascuna di esse
viene assegnato un numero o grado dell'ipoteca in base al quale si determina la precedenza in ordine
alla soddisfazione del credito: i creditori però possono effettuare uno scambio di grado dell'ipoteca;
l'iscrizione ipotecaria conserva la sua efficacia per 20 anni dopo di che si estingue a meno che il
creditore non proceda tempestivamente alla sua rinnovazione; decorsi i 20 anni si può procedere a
una nuova iscrizione che ovviamente si metterà in coda dietro le altre che le sono anteriori.
Il creditore può far valere il diritto di ipoteca anche nei confronti di un terzo che ha semplicemente
acquistato un bene già gravato di ipoteca e che quindi non c'entra per niente nel debito;
il terzo acquirente, se vuole evitare che il bene gli venga espropriato, ha tre possibilità:
--pagare egli stesso i creditori ipotecari surrogandosi così nel credito pagato
--effettuare il rilascio dei beni ipotecati con apposita dichiarazione al tribunale che nomina un
amministratore nei cui confronti avverrà l'espropriazione (in sostanza l'esproprio avviene lo stesso
ma l'onore del terzo è salvo perchè l'esproprio è fatto contro l'amministratore)
--effettuare la PURGAZIONE DELLE IPOTECHE cioè liberare i beni tramite un apposito
procedimento e l'offerta d una somma di denaro a tacitazione dei crediti garantiti.
Invece il terzo datore di ipoteca (chi ipoteca un bene proprio a favore di un altro) risponde solo per
il bene ipotecato, non può avvalersi delle facoltà di cui gode il terzo acquirente, nemmeno del
beneficium excussionis (vedi fideiussione): può solo pagare i creditori per evitare l'espropriazione.
Riguardo l'estinzione delle ipoteche bisogna distinguere:
Alcune cause di estinzione incidono sul titolo e perciò travolgono anche l'iscrizione che pur essendo
elemento costitutivo ha solo funzione strumentale: così il pagamento del credito, il perimento della
cosa,la rinuncia all'ipoteca, fanno venir meno il titolo e si può chiedere allora la cancellazione.
Altre cause incidono direttamente sull'iscrizione e perciò fanno venir meno il diritto, ma non
escludono che l'ipoteca si possa nuovamente iscrivere: es l'estinzione si verifica per il decorso del
termine di 20 anni dall'iscrizione salvo restando la possibile ipotesi di rinnovazione.
NOTA: il pegno, con lo spossessamento, esclude il debitore dalla gestione dei suoi beni e ciò
rappresenta uno svantaggio per il debitore-imprenditore ad es nel caso di materie prime o
semilavorati che avrebbero bisogno di completare il loro ciclo di produzione. Per tale motivo la
legge prevede il pegno rotativo e il pegno fluttuante ( pegni anomali).
Il pegno rotativo era originariamente previsto nel caso in cui l'oggetto del pegno siano i prosciutti
doc: il debitore può mantenere il possesso dei suoi prosciutti per consentirne la produzione e la
successiva vendita sostituendoli nel pegno con altri di analogo valore; il pegno fluttuante riguarda
gli strumenti finanziari (ad es azioni): il pegno riguarda tutti i titoli del debitore: esso consente al
debitore di sostituire i singoli titoli con altri di pari valore in modo da potere negoziare i titoli
“liberati”evitando le perdite dovute alla loro immobilizzazione.
E' dubbio che i 2 istituti possano estendersi ad altri casi.
www.unictblog.com 52
Scaricato da Giovanni Porta (portagiovanni358@gmail.com)
lOMoARcPSD|7648598
Il divieto di patto commissorio è stato abolito per alcuni contratti di pegno detti di garanzia
finanziaria, quando siano stipulati con banche o altri operatori professionali.
A parte questi casi, oggi viene considerato lecito il cd patto marciano con il quale si conviene che il
bene passerà al creditore nel caso di inadempimento ma previa stima del suo valore da parte di un
terzo con diritto del debitore a ricevere l'eventuale eccedenza di valore rispetto al credito garantito.
CAP 40 LE PROMESSE UNILATERALI (pagg 420-424)
Sono negozi giuridici unilaterali che consistono in una dichiarazione emessa da una parte che si
obbliga ad effettuare una prestazione: le sole promesse unilaterali ammesse dal codice sono: la
promessa di pagamento, la ricognizione di debito, la promessa al pubblico e i titoli di credito.
LA PROMESSA DI PAGAMENTO è l'impegno unilaterale di effettuare una prestazione a favore di
un destinatario es ti pagherò 100 euro tra un mese.
LA RICOGNIZIONE DI DEBITO è la dichiarazione unilaterale con cui un soggetto riconosce di
essere debitore di una somma, anche implicitamente (es chiedere una dilazione è riconoscere
implicitamente un proprio debito).
Entrambe possono essere titolate o astratte cioè possono o no far riferimento al titolo o alla causa
dell'obbligazione( cioè ti pagherò per questo motivo oppure semplicemente ti pagherò); tali
dichiarazioni non sono però idonee a far nascere un'obbligazione: occorre infatti una causa lecita
che giustifichi il mio obbligo e non basta che mi impegni a pagare o che riconosca di essere
debitore. Quindi entrambe non sono fonte di obbligazione, ma non sono inutili, viene attribuito ad
esse valore probatorio: poiché con esse il debitore riconosce il suo debito, il destinatario è
dispensato dall'onere di provare la causa su cui è fondato il debito che si presume quindi esistente,
fino a prova contraria (astrazione processuale).
Vera e proprie fonte di obbligazione è invece la PROMESSA AL PUBBLICO cioè la promessa di
una prestazione a favore di chi si trova in una determinata situazione, es mancia competente a
favore di chi ritrova un cane smarrito, premio al millesimo cliente: la promessa è un negozio
unilaterale non recettizio poiché non ha un destinatario determinato, è immediatamente vincolante
non appena resa pubblica, non richiede accettazione, ha efficacia di 1 anno, è revocabile per giusta
causa; mentre l'offerta al pubblico è una proposta contrattuale liberamente revocabile e vincolante
solo dopo l'accettazione.
I TITOLI DI CREDITO sono documenti che contengono la promessa di una prestazione a favore di
chi risulti possessore del documento ( es cambiale e assegno): la prestazione in essi indicata si
incorpora nel documento e circola secondo la regole proprie dei beni mobili: il documento serve a
realizzare una rapida e sicura circolazione del credito in quanto basta trasferire il possesso del
documento per conseguire il trasferimento del credito, così basta girare l'assegno per trasferire il
diritto di credito incorporato nell'assegno: la circolazione del credito è rapida. perchè non occorre la
notifica del debitore o la sua accettazione, e sicura perchè il debitore ceduto può opporre al
cessionario solo le eccezioni basate sul titolo documentale (ad es che la firma è falsa o che il
documento non ha i requisiti formali) prescindendo dall'esistenza di una valida causa obligandi
(astrazione sostanziale.
Ci sono diversi titoli di credito:
--titoli al portatore (es buoni del tesoro): il trasferimento del titolo avviene con la consegna e il
possessore ha diritto a riscuotere con la semplice presentazione di esso
--titoli all'ordine (cambiale, assegni) sono intestati a una data persona e il trasferimento si opera con
la consegna del documento e la sua girata (autorizzazione a pagare un altro)
--titoli nominativi (es obbligazioni di società) sono intestati a favore di una persona non solo sul
documento ma anche sul registro dell'emittente: entrambi sono necessari per la legittimazione.
Biglietti teatrali, scontrini del deposito bagagli, sono DOCUMENTI DI LEGITTIMAZIONE, cioè
documenti che hanno il solo scopo di identificare chi abbia diritto alla prestazione; TITOLI
IMPROPRI sono ad es i vaglia postali in cui c'è il trasferimento di un diritto di credito senza
l'osservanza delle norme che regolano le cessioni.
www.unictblog.com 53
Scaricato da Giovanni Porta (portagiovanni358@gmail.com)
lOMoARcPSD|7648598
CAP 41 RESPONSABILITA' PER FATTO ILLECITO art 2043 cc e ss (pagg 425-451)
Costituiscono fonti di obbligazione i fatti illeciti cioè fatti e atti che cagionano un danno ad altri e
quindi sono vietati dalla legge. Sono fonti di obbligazione RISARCITORIA, cioè obbligano a
risarcire, a riparare il danno cagionato ad altri; l'istituto si chiama responsabilità extracontrattuale e
la qualifica di extracontrattuale sottolinea che la responsabilità nasce al di fuori di uno specifico
rapporto obbligatorio tra le parti.
Tale responsabilità, disciplinata dal diritto privato, si qualifica come “civile” per contrapporla a
quella penale che deriva da fatti costituenti reato per i quali è prevista una sanzione detta pena ( es
reclusione): mentre l'illecito penale è TIPICO, cioè si può essere condannati solo se il fatto è
espressamente previsto dalla legge come reato, l'illecito civile è ATIPICO, cioè non è necessario che
la legge preveda questo o quel comportamento, basta che sia violato un interesse tutelato dalla
legge: art 2043 “qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga
colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”. Viene chiamata anche responsabilità aquiliana
dalla legge romana da cui deriva.
I requisiti della responsabilità sono:
1)—IL FATTO: può essere un fatto giuridico in senso stretto (crollo di un edificio) o un atto
giuridico: la legge parla di “qualunque atto” quindi saranno rilevanti sia fatti commissivi che fatti
omissivi (una mancata azione, es un casellante che non chiude il passaggio a livello).
2)---IL DANNO: consiste nella lesione di un interesse tutelato dalla legge: il danno si dice
patrimoniale quando riguarda un bene economico, non patrimoniale quando riguarda un bene della
persona: l'onore, l'integrità psicofisica ecc.
Le ipotesi di risarcibilità di danno non patrimoniale sono aumentate notevolmente rispetto al
passato sia per espressa previsione testuale (cioè per nuove leggi) sia per via interpretativa (cioè
interpretazione estensiva di leggi esistenti).
Tra i casi previsti dalla legge va menzionata la risarcibilità del danno derivante da lesione dell'onore
come pure il danno derivante dalla violazione delle norme relative alla privacy, alla pari
opportunità, alla discriminazione sul lavoro per motivi razziali, etnici o religiosi.
In via interpretativa è ammesso risarcimento per la lesione dei diritti fondamentali della persona e in
particolare quelli costituzionalmente garantiti: valga per tutti il danno derivante dalla
compromissione del rapporto parentale conseguente alla uccisione di un figlio.
E' inoltre ormai consolidata la risarcibilità del danno non patrimoniale alla persona, sia il danno
biologico inteso come lesione dell'integrità psicofisica sia il danno morale inteso come dolore e
sofferenza.
3)---L'INGIUSTIZIA DEL DANNO: il danno deve essere ingiusto, deve cioè ledere un diritto o un
interesse protetto dalla legge (se apre un negozio accanto al mio, ricevo un danno perchè parte dei
miei clienti mi lascia, ma non posso chiedere risarcimento,non ho il diritto all'esclusiva della
clientela). L'impostazione tradizionale individuava il carattere dell'ingiustizia solo nella violazione
di un diritto assoluto (reale o della personalità) ma oggi si parla di ingiustizia anche nel caso di
lesione di un semplice interesse tutelato o di un diritto di credito
Quanto ai diritti di credito, la lesione deve provenire da terzi i quali rendano impossibile
l'adempimento o la prestazione del debitore: così avviene se il fatto illecito del terzo comporta la
morte del debitore di una prestazione personale e insostituibile: un padre di famiglia viene ucciso e i
figli hanno diritto a risarcimento perchè il padre non può + adempiere al debito che ha con loro di
mantenerli (cd TUTELA ESTERNA del credito).
4)---il NESSO DI CAUSALITA': deve esistere un nesso di causalità tra il fatto e l'evento dannoso:
si rilevano solo i danni che siano conseguenza immediata e diretta dell'illecito: va evidenziato che
se + persone hanno concorso a cagionare il danno, sono tutte obbligate al risarcimento con vincolo
di solidarietà, anche se diverso è stato il loro ruolo.
5)---IL DOLO E LA COLPA: si ha dolo quando l'evento è voluto come conseguenza dell'azione
dell'agente, si ha colpa quando vi sia negligenza e imprudenza cioè inosservanza di leggi e
www.unictblog.com 54
Scaricato da Giovanni Porta (portagiovanni358@gmail.com)
lOMoARcPSD|7648598
regolamenti: in sostanza si rimprovera al soggetto di non aver utilizzato la diligenza media
6)---L'IMPUTABILITA': l'atto dannoso deve essere imputabile al suo autore e cioè deve essere
commesso con coscienza e volontà;
L'imputabilità è esclusa in alcuni casi:
--se non si ha la capacità di intendere o la capacità di volere quindi la capacità naturale es soggetto
drogato non per sua colpa oppure sotto la minaccia di una pistola; ma se il soggetto si fosse
volontariamente ubriacato la sua responsabilità sarebbe piena e si parla di “azione libera in
causa”per evidenziare che il soggetto si è liberamente messo in quelle condizioni di incapacità che
sono state causa del danno.
--se il soggetto, pur essendo capace, non ha libertà di scelta:es legittima difesa (purchè la difesa sia
proporzionata all'offesa), o soggetto nell'esercizio delle sue funzioni (agente di polizia)
L'imputabilità è invece ATTENUATA nello stato di necessità cioè per salvare sé o altri dal pericolo
e in questo caso la legge prevede il pagamento di un'indennità al danneggiato la cui entità è decisa
dal giudice.
La responsabilità dal punto di vista civile, può ricadere non solo su chi ha commesso il fatto, ma
anche su altri: in tal caso si parla di RESPONSABILITA' INDIRETTA ad es:
--responsabilità dei genitori e dei tutori per il danno causato dal fatto illecito dei figli minori o dei
soggetti affidati in tutela; essi risponderanno in via esclusiva del danno causato dalle persone a loro
affidate quando queste siano incapaci di intendere e volere oppure rispondono in via concorrente del
danno se le persone erano naturalmente capaci e quindi pienamente responsabili (es apprendisti)
--responsabilità dei datori di lavoro per danni arrecati dai dipendenti nell'esercizio delle loro
incombenze es il medico risponde dei danni causati dall'infermiere suo dipendente.
La RESPONSABILITA' OGGETTIVA è una sottospecie di responsabilità extracontrattuale che non
è legata al comportamento del danneggiante (non c'è dolo nè colpa): nella società moderna si sono
moltiplicati i rischi connessi all'impiego di grandi energie e di alte velocità per cui i danni in un
certo modo sono inevitabili e il relativo rischio è socialmente accettato: ma non sarebbe giusto che
chi ha subito un danno di questo genere, non venga risarcito.
Le ipotesi + frequenti di responsabilità oggettiva sono:
--esercizio di attività pericolosa per sua natura o per i mezzi usati; l'esercente sarà responsabile dei
danni causati salvo che non dimostri di aver adottato tutte la misure idonee a evitarli.
--circolazione dei veicoli senza guida di rotaie (autobus) il conducente è responsabile se non prova
di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno; responsabile in solido con il conducente è il
proprietario del veicolo se non prova che la circolazione è avvenuta contro la sua volontà
--cose o animali in custodia: la responsabilità grava su chi utilizza o tiene presso di sé cose o
animali pur se non pericolosi (es bombole di gas, cani)
--rovina di edificio o di una sua parte es crollo di un balcone: il proprietario è responsabile dei danni
se non prova che la causa è dovuta a causa diversa da difetto di manutenzione
--prodotti difettosi: la responsabilità ricade sul produttore per il danno arrecato alle persone.
IL RISARCIMENTO consiste in una prestazione atta a riparare la perdita subita dal danneggiato.
La forma ordinaria è quella del risarcimento per equivalente cioè una somma di denaro pari al
valore del danno, tenendo conto del danno emergente, del lucro cessante (come nella responsabilità
contrattuale).
Quando si tratta di un danno alle persone che abbia conseguenze permanenti es invalidità
lavorativa, la liquidazione può avvenire anche sotto forma di rendita vitalizia, ma spesso si
preferisce liquidare una somma unica rapportata a prevedibili mancati guadagni futuri.
Il risarcimento può avvenire anche in forma specifica cioè tramite il ripristino della situazione
preesistente all'illecito es riparazione del bene danneggiato, ma se questo fosse troppo oneroso, il
giudice può disporre il risarcimento per equivalente.
DIFFERENZE TRA RESPONSABILITA' CONTRATTUALE ED EXTRACONTRATTUALE
Sia la responsabilità contrattuale che quella extracontrattuale scaturiscono da un illecito:
inadempimento di una obbligazione stabilita da un contratto nel primo caso, violazione del principio
neminem laedere (non nuocere a nessuno) nel secondo caso.
www.unictblog.com 55
Scaricato da Giovanni Porta (portagiovanni358@gmail.com)
lOMoARcPSD|7648598
Tuttavia sussistono differenze in tema di prova, danno risarcibile e prescrizione.
--PROVA :
-----Nella responsabilità contrattuale il creditore insoddisfatto deve provare il suo credito e l'entità
del danno, il debitore deve provare che l'inadempimento non è a lui imputabile;
-----Nella responsabilità extracontrattuale è il danneggiato che deve provare non solo l'illecito e
l'entità del danno ma anche la colpa o il dolo di chi ha commesso l'illecito.
--PRESCRIZIONE
La responsabilità per fatto illecito è soggetta a una prescrizione di 5 anni, + breve di quella prevista
per l'inadempimento che è di 10 anni
--RISARCIMENTO
-----Nella responsabilità per inadempimento colposo il risarcimento è limitato ai danni prevedibili
al momento in cui è nata l'obbligazione
----Nella responsabilità aquiliana non opera tale limite
La giurisprudenza ammette poi il concorso di responsabilità contrattuale e extracontrattuale: in altre
parole uno stesso fatto può ledere un diritto tutelato sia nella vita di relazione sia da uno specifico
contratto: per es il viaggiatore rimasto ferito in un incidente ferroviario, può invocare, secondo la
sua convenienza, sia l'inadempimento del contratto di trasporto, sia la responsabilità
extracontrattuale.
NOTA: rapporto tra danno e illiceità
Ciò che è fonte di responsabilità non è tanto il fatto illecito quanto il fatto che produce danno.
Non sempre le due figure coincidono: nell'illecito può mancare il danno (Tizio attraversa la mia
proprietà ma non danneggia le colture) e viceversa nel danno può mancare l'illecito.
L'atto si qualifica illecito quando è contra ius e basta, non si richiede per forza il danno: se passo per
un fondo altrui, questo è un illecito perchè la legge me lo vieta, non importa se faccio danni o meno,
se c'è dolo o no.
La legge offre in questo caso strumenti di reazione all'illecito e in particolare mezzi di tutela
preventiva o reintegrativa: le misure preventive sono dirette a impedire il compimento dell'illecito ,è
la cd azione inibitoria; le misure integrative hanno la funzione di reintegrare il soggetto leso nella
situazione giuridica alterata.
Viceversa la legge a volte consente il compimento di atti dannosi leciti: le ipotesi principali sono
quelle di accesso al fondo altrui per riportare o recuperare la cosa propria, le immissioni intollerabili
ma consentite: in tali casi la legge contempera gli interessi in conflitto consentendo l'attività
dannosa ma imponendo al contempo di corrispondere un'indennità al danneggiato; si differenzia dal
risarcimento perchè non comprende tutto il danno ma costituisce un equo ristoro o compenso per il
pregiudizio.
24
www.unictblog.com 56
Scaricato da Giovanni Porta (portagiovanni358@gmail.com)
lOMoARcPSD|7648598
CAP 42 OBBLIGAZIONI NASCENTI DALLA LEGGE (pagg 444-451)
La legge dedica una disciplina specifica ad alcuni fatti idonei a generare obbligazioni che sono
raggruppati in appositi titoli del libro 4° del cc artt 2028-2042 e che sono comunemente detti
“obbligazioni nascenti dalla legge”.
A questa definizione si obietta che non è la legge la “fonte” di queste obbligazioni perchè a monte ci
sono i fatti che determinano l'instaurarsi dell'obbligazione: se è vero che la legge impone ai genitori
il mantenimento dei figli è pur vero che a monte c'è il fatto di averli generati.
Piuttosto il dato che accomuna questo tipo di obbligazioni è che sono atti o fatti giuridici in senso
stretto;esse sono la gestione di affari altrui, il pagamento dell'indebito e l'arricchimento senza causa.
GESTIONE DEGLI AFFARI ALTRUI : qui la legge considera l'ipotesi in cui un soggetto gestisce
un affare altrui senza essere obbligato; nessuno può vincolare giuridicamente altre persone ma si
consideri ad es il caso in cui l'interessato non può provvedere perchè ammalato o all'estero: allora si
prevede che se qualcuno assume spontaneamente la gestione di un affare altrui sarà innanzitutto
obbligato a continuarla fino a quando l'interessato non è in grado di provvedere da sé: il gestore è
inoltre tenuto ad operare prestando la diligenza del buon padre di famiglia. L'interessato dovrà
rimborsare le spese necessarie che il gestore abbia assunto in suo nome e non importa il risultato
finale che potrebbe anche essere negativo, importa che all'inizio l'azione del gestore si presentasse
vantaggiosa o necessaria.
Questo istituto non si applica per quegli atti di gestione compiuti contro l'espresso divieto
dell'interessato, purchè tale divieto non si presenti contrario alla legge, all'ordine pubblico o al buon
costume: posso dare da mangiare a un cane abbandonato alla catena, anche contro il divieto del
padrone.
PAGAMENTO DELL'INDEBITO: si ha quando una persona esegue una prestazione non dovuta
detta appunto indebita: ciò può verificarsi per diversi motivi: contratto nullo o annullato o risolto
oppure un debito già estinto; la legge considera il pagamento dell'indebito come fonte di
obbligazione del ricevente che infatti ha l'obbligo di restituire quanto indebitamente ricevuto mentre
chi ha pagato ha diritto a riavere (ri-petere) la prestazione eseguita (cd ripetizione dell'indebito).
Esistono 2 ipotesi:
EX RE= INDEBITO OGGETTIVO quando la prestazione non è dovuta da nessuno: L'accipiens
( cioè il ricevente) riceve quindi un pagamento oggettivamente non dovuto e non giustificato
(perchè il contratto è nullo, perchè il pagamento è già stato fatto ecc): chi ha pagato avrà diritto alla
restituzione e anche ai frutti e interessi a partire dal giorno del pagamento se chi lo ha ricevuto è in
malafede, dal giorno della domanda se in buona fede.
EX PERSONA=INDEBITO SOGGETTIVO quando la prestazione non tocca a chi effettivamente
ha pagato ma toccava a una terza persona es pago per errore una bolletta del vicino; qui chi ha
pagato ha diritto alla restituzione solo se il pagamento è avvenuto per errore scusabile; se non c'è er
rore vuol dire che si voleva pagare e si ha l'ipotesi di adempimento del terzo.
La ripetizione non è ammessa:
--nelle OBBLIGAZIONI NATURALI: si tratta di quegli obblighi che nascono nell'ambito dei
doveri morali e sociali es pagare i debiti di gioco; essi non danno luogo a vere e proprie
obbligazioni vincolanti; se vengono spontaneamente adempiute non si può agire per ottenerne la
restituzione a meno che la prestazione non sia stata eseguita da un incapace in quanto è un atto
negoziale che richiede la capacità di agire.
--nei CONTRATTI CONTRARI AL BUON COSTUME: questi contratti sono nulli, nessun
adempimento è dovuto e le prestazioni già eseguite si devono restituire ma non è ammessa azione di
ripetizione da parte di chi sia partecipe dell'immoralità; se l'immoralità è bilaterale nessuno è
ammesso alla ripetizione; se l'immoralità è solo di una parte sarà questa a non poter chiedere la
restituzione: es se un funzionario pubblico costringe un privato a pagargli una somma per il disbrigo
di un documento, immorale è il funzionario non il privato che quindi può richiedere la restituzione
della somma.
www.unictblog.com 57
Scaricato da Giovanni Porta (portagiovanni358@gmail.com)
lOMoARcPSD|7648598
ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA: si ha quando un soggetto consegue un incremento
patrimoniale in danno di un altro senza che tale incremento abbia adeguata giustificazione.
Il nostro ordinamento prevede che gli spostamenti patrimoniali devono avere causa che li giustifichi
giuridicamente (ad es un contratto deve avere una causa), quindi chi ha conseguito un arricchimento
ingiustificato in danno di un altro è tenuto, nei limiti dell'arricchimento, a indennizzare quest'ultimo
della correlativa diminuzione patrimoniale (art 2041);
Questa azione ha 2 caratteristiche:
---si dice generale perchè concessa in genere a chiunque si trovi nelle condizioni dette, senza
ulteriori specificazioni circa il tipo di arricchimento o la sua provenienza.
---si dice residuale perchè è concessa nei casi in cui il danneggiato non può esercitare un'altra
azione per farsi indennizzare del pregiudizio per cui non può essere utilizzata nei casi in cui la legge
prevede una specifica azione.
In concreto le ipotesi in cui può avvenire quest'azione sono quelle in cui l'arricchimento deriva da:
--atto dell'arricchito che tuttavia non sia fonte di responsabilità civile extracontrattuale es Tizio
consuma il vino di Caio posto nel frigorifero comune; si tratta in tal caso di un errore scusabile e
Caio dovrà solo esser indennizzato secondo l'art 2041 non come responsabilità di atto illecito
(perchè manca il dolo o colpa)
--atto dell'impoverito il quale esegue una prestazione non dovuta per la quale non sia in concreto
esercitabile la ripetizione di indebito es ho pagato un debito altrui, sapendolo, quindi non posso
agire per la ripetizione; potrò però agire verso il debitore con l'azione di arricchimento.
L 'azione di arricchimento è meno favorevole di altre specifiche azioni previste in quanto prevede
un doppio limite quantitativo, l'arricchimento dell'uno e l'impoverimento dell'altro: cioè non si può
richiedere + della propria perdita patrimoniale né + dell'effettivo vantaggio altrui.
26
www.unictblog.com 58
Scaricato da Giovanni Porta (portagiovanni358@gmail.com)
lOMoARcPSD|7648598
CAP 51 I CONTRATTI DI CREDITO E GARANZIA (pagg 527-533)
Il MUTUO è un contratto col quale una parte ( mutuante) consegna all'altra ( mutuatario) una
determinata quantità di denaro e quest'ultima si obbliga a restituire altrettante cose della stessa
specie e qualità.
Funzione del mutuo è quella di mettere una somma di denaro a disposizione di un soggetto che ne
acquista la piena disponibilità e può farne l'uso che crede: gli impieghi sono perciò irrilevanti anche
se recenti disposizioni hanno reso rilevante in alcuni casi la destinazione della somma, destinazione
che il mutuatario è tenuto a rispettare: sono i cd mutui di scopo.
Il mutuo è un contratto reale, si perfeziona solo con la consegna della cosa mutuata.
Oggetto del contratto possono essere anche cose diverse dal denaro purchè fungibili e consumabili
se no si rientra rispettivamente nella locazione e nel comodato.
Il mutuo si presume oneroso salvo diversa volontà delle parti , cioè il mutuatario deve corrispondere
gli interessi al mutuante che saranno dovuti nella misura legale se le parti non hanno pattuito un
tasso superiore ; il termine di restituzione è fissato dai contraenti e la sua osservanza assume
ordinariamente rilievo essenziale tanto che l'inadempimento di una sola rata consente di richiedere
l'immediata restituzione dell'intero capitale.
LA CESSIONE DEI CREDITI D'IMPRESA O FACTORING: è il contratto con il quale un'impresa
vende a un soggetto specializzato (detto factor) i crediti inerenti alla sua attività e il cessionario si
impegna a gestire tali crediti e a concedere anticipi sul loro ammontare; il factoring è caratterizzato
da una cessione sistematica (non episodica) dei crediti d'impresa a favore di un intermediario
finanziario con la funzione di gestire i crediti e il finanziamento dell'impresa cedente.
A differenza della cessione del credito, qui il cedente deve garantire la solvenza del debitore.
Le imprese trovano conveniente far intervenire un operatore specializzato, il factor, che si assume
l'obbligo di gestire il credito svolgendo le operazioni di fatturazione e riscossione e rimettendo poi il
ricavato all'impresa cedente: è previsto che il factor conceda all'impresa anche un anticipo
sull'ammontare dei crediti inferiore al loro importo;
Tale specifica disciplina si applica in presenza di alcuni requisiti:
--il factor cessionario deve essere una banca o un intermediario finanziario professionista
--il cedente deve essere un imprenditore
--la cessione deve riguardare i crediti sorti da contratti stipulati nell'esercizio dell'attività di impresa
ma anche da contratti futuri purchè stipulati entro i 2 anni successivi.
La cessione è opponibile a terzi (ad es cessionari dello stesso credito) quando il factor ha pagato il
corrispettivo della cessione e il pagamento ha data certa.
LA FIDEIUSSIONE (art 1936) è il contratto con il quale una parte, detta fideiussore, garantisce
l'adempimento di un'obbligazione altrui obbligandosi personalmente verso il creditore.
Costituisce una forma di garanzia personale del credito che impegna tutto il patrimonio del garante
ma senza vincoli specifici su questo o quel bene, a differenza delle garanzie reali che vincolano beni
specifici e determinati.
Funzione della fideiussione è la garanzia del debito altrui e da ciò deriva la caratteristica della
figura: l'accessorietà rispetto al debito garantito (cd DIPENDENZA FUNZIONALE) : la
fideiussione infatti non è valida se non è valida l'obbligazione principale e inoltre non può eccedere
quanto è dovuto dal debitore né essere prestata a condizioni + onerose.
Il fideiussore può opporre al creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale, tuttavia
solitamente, specie nelle fideiussioni prestate a favore di una banca,si usa la clausola SOLVE ET
REPETE per effetto della quale il fideiussore non potrà sollevare eccezioni se non dopo l'integrale
pagamento del debito.
27
www.unictblog.com 59
Scaricato da Giovanni Porta (portagiovanni358@gmail.com)
lOMoARcPSD|7648598
I soggetti della fideiussione sono dunque 3, tuttavia il contratto è tra fideiussore e creditore e non si
chiede l'adesione del debitore garantito né che egli ne sia a conoscenza, invece la dichiarazione di
fideiussore deve essere espressa non bastando una manifestazione tacita di volontà.
Per effetto del contratto il fideiussore diviene obbligato in solido col debitore principale e il
creditore potrà rivolgersi indifferentemente a uno dei due per riavere l'intero
Il fideiussore può servirsi di due benefici:
---il beneficio di escussione che gli consente di chiedere,nel caso il debitore sia stato insolvente, la
preventiva esecuzione dei beni del debitore principale indicando i beni da sottoporre a esecuzione e
l'azione esecutiva si configura quindi come un onere per il creditore (in sostanza il fideiussore che
deve pagare al posto del debitore, prima di pagare, può chiedere l'esecuzione sui beni del debitore)
---il beneficio della divisione che, nel caso ove esistano + fideiussori, limita la responsabilità di
ciascuno dei fideiussori alla quota del debito assunta da ciascuno.
Il fideiussore che ha pagato il debito è surrogato nei diritti che il creditore aveva verso il debitore e
può così agire in regresso contro di lui (debitore)per ottenere il rimborso di capitale interessi e spese
E' ammessa anche la fideiussione omnibus e cioè prestata per tutti i debiti che un soggetto ha o
potrà assumere in futuro verso un creditore, di solito una banca; la figura però si presta ad abusi
proprio per questa incertezza sull'importo: la legge ha stabilito dunque che è valida la fideiussione
prestata per un'obbligazione futura se in essa è indicato l'importo massimo garantito e inoltre il
fideiussore è liberato se il creditore ha fatto credito al soggetto garantito dopo il sensibile
peggioramento delle sue condizioni patrimoniali.
IL CONTRATTO AUTONOMO DI GARANZIA (o garanzia a prima richiesta) è un contratto
atipico nato nella pratica del commercio internazionale dove è noto col nome di bid bond: il tratto
saliente è costituito dall'autonomia della garanzia rispetto all'obbligazione garantita: il garante non
può sollevare alcuna eccezione, deve adempiere a prima richiesta e dopo il pagamento potrà
rivolgersi in via di regresso al debitore garantito per ottenere il rimborso di quanto pagato.
Si realizza perciò una forma di astrazione della garanzia dal debito sottostante;
Molto + blanda è la garanzia offerta dalla lettera di patronage che consiste nella dichiarazione con la
quale una società controllante attesta alcune circostanze e assume alcuni impegni di una società
controllata: in caso di inadempimento della società controllata, il creditore può chiedere
risarcimento ex art 2043 avendo fatto affidamento sulle dichiarazioni della lettera.
L'Anticrèsi è un contratto col quale il debitore cede il godimento di un immobile al creditore perchè
ne percepisca i frutti imputandoli agli interessi e al capitale (cioè il creditore viene soddisfatto del
suo credito attraverso i frutti ricavati dall'immobile): ha durata max 10 anni e necessita di forma
scritta e trascrizione (per l'opponibilità a terzi).
28
www.unictblog.com 60
Scaricato da Giovanni Porta (portagiovanni358@gmail.com)
lOMoARcPSD|7648598
PARADISO DIRITTO PRIVATO 3° MOD – I CONTRATTI by zziopippo
CAP 30 IL CONTRATTO COME FONTE DI OBBLIGAZIONE (pagg 286-295)
Le singole fonti di obbligazione sono ( art 1173) “ il contratto, il fatto illecito e qualunque atto o
fatto idoneo a produrle”.
Il libro IV regola i contratti e + precisamente il titolo II i contratti in generale e il titolo III i singoli
contratti (vendita, locazione ecc)
Il contratto secondo l'art 1321 è l'accordo di due o + parti per costituire, regolare o estinguere tra
loro un rapporto giuridico patrimoniale, con i relativi diritti e obblighi (obbligazioni): esso
costituisce lo strumento principale con cui si attua il trasferimento della proprietà e degli altri diritti
reali sui beni.
Il termine contratto viene usato sia per indicare l'atto vero e proprio sia per indicare il rapporto cioè
gli effetti che da esso derivano ad es i doveri di mutua assistenza per i coniugi derivano dall'atto di
matrimonio, se questo manca tali doveri non sorgeranno.
L'accordo deriva dalla libera volontà delle parti per cui si configura come negozio.
Principio fondamentale è l' AUTONOMIA CONTRATTUALE che stabilisce:
1)la facoltà di concludere o no un contratto e di scegliere liberamente la controparte(cd libertà
contrattuale in senso negativo)
2)la facoltà di determinare liberamente il contenuto del contratto entro i limiti imposti dalla legge
cd libertà contrattuale in senso positivo; ciò significa che le parti possono derogare dalle
disposizioni di legge ma solo se si tratta di norme derogabili: ad es un venditore deve garantire la
cosa venduta immune da vizi ma , poiché si tratta di una norma derogabile, ci si può accordare per
escludere questa garanzia ma se il venditore in malafede ha taciuto al compratore i vizi della cosa,
la legge interviene annullando il patto.
3)la facoltà di redigere contratti cd innominati o atipici che cioè non trovano rispondenza con i tipi
stabiliti dalla legge (ad es il leasing)
A proposito del punto 1 bisogna però rilevare che ci sono delle limitazioni:
--esiste un obbligo legale di contrarre in alcuni casi particolari ad es le assunzioni obbligatorie di
categorie protette, come gli invalidi;
--la libera scelta della controparte non si può basare su criteri di discriminazione razziale,
etnica,religiosa, sul sesso, sulla disabilità della persona (obbligo di non discriminare): non è
consentito rifiutare un contratto di lavoro o un contratto di locazione (o anche aumentare il prezzo
della locazione) in base a queste discriminazioni: ove ciò accada, il giudice può ordinare la
cessazione del comportamento discriminativo ed eventualmente il risarcimento del danno anche non
patrimoniale.
A questo punto facciamo una digressione: il trasferimento di proprietà può essere effettuato anche
con un ATTO UNILATERALE ad es una donazione o una promessa di vendita ecc: la legge però
diffida degli atti unilaterali sia perchè verrebbe meno il principio secondo cui il singolo non può
entrare nella sfera giuridica altrui, sia perchè verrebbe ad alterarsi la disciplina dei contratti che si
fonda sul cd SINALLAGMA cioè sullo scambio delle prestazioni : io ti vendo una cosa, tu mi dai
denaro cioè un'altra cosa. Per questo motivo gli atti unilaterali sono limitati dalla legge nel numero
(cd numero chiuso degli atti unilaterali) e accuratamente disciplinati da specifiche norme che
stabiliscono sia il tipo che gli effetti (cd tipicità degli atti unilaterali).
I contratti sono variamente CLASSIFICATI:
--si dicono bilaterali quando intervengono due parti con interessi contrapposti: sono i contratti di
scambio es vendite;
--plurilaterali quando intervengono + parti con interessi NON contrapposti come i contratti di
società in cui le diverse parti hanno un interesse o uno scopo comune.
--onerosi in cui una parte affronta un sacrificio l'altra offre una prestazione es vendita
--gratuiti in cui c'è solo il sacrificio di una parte es donazione
--aleatori in cui una prestazione dipende da un evento casuale es l'assicurazione
www.unictblog.com 61
Scaricato da Giovanni Porta (portagiovanni358@gmail.com)
lOMoARcPSD|7648598
CAP 31 LA FORMAZIONE DEL CONTRATTO: ATTI PREPARATORI (pagg 296-304)
Prima che il contratto venga stipulato c'è la fase delle trattative in cui le parti tentano di raggiungere
un'intesa: sebbene in tale fase le parti non hanno alcun obbligo tra loro, ciò non vuol dire che
possano comportarsi come vogliono: l'art 1337 cc stabilisce infatti che esse devono comportarsi
secondo buona fede che in questo caso significa correttezza.
Violazione della correttezza è la rottura ingiustificata delle trattative, l'intraprendere una trattativa
sapendo di non avere mezzi sufficienti, tacere alla controparte che esiste qualche causa di invalidità
del contratto ecc.
La correttezza è una obbligazione che comporta una RESPONSABILITA' PRECONTRATTUALE,
quindi non adempierla comporta l'obbligo di risarcire il danno emergente e il lucro cessante come
avviene nella disciplina dei contratti: solo che nel nostro caso il contratto non c'è (perchè non è
ancora stato firmato) e quindi il danno emergente consiste nelle spese fatte inutilmente ad es
consulenze, redazione di progetti, viaggi; il lucro cessante è costituito dal guadagno che avrei
realizzato impegnandomi in un altro affare invece di perdere tempo con questa contrattazione
inutile (cd interesse negativo).
Una volta concluse le trattative con esito positivo, non è detto che si debba stipulare subito il
contratto; per varie ragioni la stipula può essere rinviata a tempi successivi: ma se voglio essere
sicuro che poi il contratto venga stipulato alle condizioni già stabilite, posso richiedere la
sottoscrizione di vincoli particolari detti RAPPORTI GIURIDICI PREPARATORI come prelazione,
contratto preliminare ecc., che bloccano l'affare, fissando subito il suo contenuto e rinviano la
stipula del contratto vero e proprio.
Il CONTRATTO PRELIMINARE è un contratto come gli altri che si caratterizza però per l'oggetto
che è l'obbligo di stipulare un successivo contratto: è molto diffuso nel campo immobiliare dove
viene comunemente chiamato compromesso (e si può trascrivere): perchè sia valido è necessario
che il preliminare abbia stessa forma e sostanza del contratto definitivo con indicazione
dell'oggetto, prezzo ecc.
Le parti sono obbligate a concludere il contratto definitivo, non possono rifiutarsi se sono pentite
dell'affare: esse possono sciogliersi solo per una giusta causa (ad es se si scopre che la casa è stata
costruita abusivamente): in caso di rifiuto di una delle parti, il giudice emanerà una sentenza che
produrrà gli stessi effetti del contratto non concluso (esecuzione in forma specifica), come ad es una
traslazione della proprietà, tenendo anche conto della trascrizione
Secondo le slides della Cavallaro sarebbe anche possibile la risoluzione del contratto+ risarcimento
Il contratto preliminare può vincolare anche una sola delle parti (preliminare unilaterale).
La PRELAZIONE non comporta nessun obbligo di contrarre ma quello di preferire un certo
contraente: il soggetto obbligato cioè, non è tenuto a stipulare il contratto ma se deciderà di farlo,
dovrà attribuire la preferenza al prelazionario e ove questi rifiuti, sarà libero di vendere ad altri;
la prelazione può derivare da un accordo delle parti, cd PATTO DI PRELAZIONE e in caso di
violazione si può richiedere solo il risarcimento; oppure dalla legge ,cd PRELAZIONE LEGALE,
che ad es prevede per i coeredi il diritto di prelazione ove uno di essi voglia alienare la sua quota
oppure per i fondi rustici il diritto di prelazione del vicino, se coltivatore diretto: in questi casi, se la
prelazione non viene rispettata e il bene viene venduto ad altri, si potrà ottenere il retratto del bene
cioè il trasferimento del bene coattivo al prelazionario con risoluzione della vendita precedente.
www.unictblog.com 62
Scaricato da Giovanni Porta (portagiovanni358@gmail.com)
lOMoARcPSD|7648598
CAP 32 I REQUISITI DEL CONTRATTO : L'ACCORDO DELLE PARTI (pagg 305-324)
Il contratto, perchè sia valido, deve presentare dei requisiti determinati dalla legge ( art 1325);
questi requisiti vengono distinti in:
--requisiti ESSENZIALI, la cui mancanza ne determina la invalidità (il contratto non è in grado di
produrre gli effetti giuridici voluti): accordo delle parti, causa, oggetto, forma
--requisiti ACCIDENTALI che possono essere inseriti o no nel contratto secondo l'intesa delle parti,
senza che abbia a soffrirne la validità del contratto stesso che cmq ne è condizionato ( ad es se
faccio una donazione a una persona posso porre come condizione che consegua una laurea o superi
un certo esame ecc): essi sono: condizione, termine, modo o onere .
NOTA 1 Bisogna innanzitutto chiarire chi siano le parti: sarebbe facile dire infatti che le parti
sono quelle che “fanno” il contratto: ad es si pensi a un contratto stipulato non dal diretto interessato
ma da un suo rappresentante: in tal caso il rappresentante stipula il contratto ma gli effetti del
contratto (cioè diritti e obblighi da esso derivanti) cadranno sul diretto interessato: occorre dunque
distinguere la PARTE IN SENSO FORMALE (quella che “forma” il contratto) e PARTE IN
SENSO SOSTANZIALE (quella su cui si producono gli effetti)
Si noti che la parte formale deve avere capacità di agire, mentre la parte sostanziale può anche non
averla ma deve cmq possedere la capacità giuridica, ad es un minore (che ha capacità giuridica ma
non capacità di agire) può essere parte sostanziale ( può ricevere una donazione) ma non formale
(non può effettuare la dichiarazione di accettazione della donazione, che verrà fatta dai genitori).
NOTA 2 Non si faccia l'errore di dire che un contratto bilaterale è quello tra due persone: quello
che importa è che ci siano due “centri di interesse”: un contratto di vendita tra + venditori e +
compratori è considerato bilaterale perchè ci sono 2 centri di interesse, uno di chi vende, l'altro di
chi compra; plurilaterali sono solo i contratti di società nei quali i centri di interesse sono tanti
quanti sono i soci.
ACCORDO DELLE PARTI
E' l'intesa, la convergenza delle parti su un certo programma contrattuale
L'accordo può raggiungersi in modo:
--ESPRESSO verbalmente, con scritti, con gesti convenzionali ( es alzare la mano in un'asta)
--TACITO con comportamenti cd CONCLUDENTI cioè comportamenti da cui inequivocabilmente
si può desumere la volontà del soggetto( salire su un autobus vuol dire che si intende concludere un
contratto di trasporto). Il silenzio non è un consenso tranne in casi determinati da accordi precedenti
es una casa editrice mi invia i primi fascicoli di un'opera con l'accordo che se non li restituisco vuol
dire che accetto di acquistare l'intera opera.
Le modalità concrete con cui si raggiunge l'accordo sono.
--1)SCAMBIO DI PROPOSTA E ACCETTAZIONE: molto diffuso nella pratica quotidiana, basti
pensare ai cd preventivi per l'acquisto di macchinari o per l'esecuzione di lavori: in questo tipo di
contratto un proponente sottopone un certo programma contrattuale a un soggetto detto oblato, il
quale può accettare o meno; sono necessari i seguenti elementi:
--la proposta deve essere completa, cioè deve contenere gli elementi essenziali del contratto
--l'accettazione deve essere completa e conforme cioè accettare integralmente tutti i punti
( altrimenti si configura come una controproposta che deve a sua volta essere accettata dalla
controparte)
--l'accettazione deve essere tempestiva e giungere al proponente nei termini di tempo da lui stabiliti
o cmq in tempi ragionevoli ( non posso aspettare un anno che mi giunga l'accettazione)
--proposta e accettazione hanno carattere recettizio cioè la loro efficacia è subordinata alla
conoscenza da parte dei destinatari
Il contratto si ritiene concluso nel momento in cui il proponente ha notizia dell'accettazione: prima
di questo momento sia il proponente, sia l'oblato, possono revocare rispettivamente la proposta e
www.unictblog.com 63
Scaricato da Giovanni Porta (portagiovanni358@gmail.com)
lOMoARcPSD|7648598
l'accettazione, senza che ciò comporti responsabilità salvo che il proponente ad es confidando
in buona fede sull'accettazione della controparte, abbia iniziato i lavori senza aspettare
l'accettazione; revoca si ha anche per morte o sopravvenuta incapacità di una delle parti.
In alcuni casi però la revoca non è ammessa (proposta irrevocabile):
--quando il proponente con atto unilaterale, si obbliga a mantenere, cioè a non ritirare la sua
proposta per un certo periodo di tempo per dar modo all'oblato di decidere con calma
--oppure quando sono le due parti a decidere in tal senso con un contratto di opzione con il quale
l'opzionario acquista il diritto potestativo di chiudere il contratto con una dichiarazione unilaterale
di accettazione
Il contratto di opzione assomiglia al preliminare unilaterale in quanto si ha un vincolo per una sola
delle parti (il proponente nel caso della proposta; colui che promette la vendita, nel caso del
preliminare); la differenza è che
--nella proposta irrevocabile il contratto si chiude con UNA dichiarazione di volontà da parte di chi
accetta, mentre nel preliminare ne occorrono DUE
--nel preliminare il promittente ha l'obbligo di eseguire con diligenza tutto ciò che occorre per
potere poi stipulare il contratto (preparare i documenti ecc) e se non lo fa incorre nella
responsabilità contrattuale; nella proposta irrevocabile questo obbligo non c'è e cmq una eventuale
responsabilità sarebbe di tipo precontrattuale
--in caso di inadempimento del preliminare il giudice emetterà una sentenza costitutiva del contratto
( cioè il contratto sarà forzosamente fatto); in caso di inadempimento dell'opzione il giudice
emetterà una sentenza dichiarativa che accerti che il contratto si è già concluso per effetto
dell'accettazione..
Un tipo particolare di proposta contrattuale è l'OFFERTA AL PUBBLICO, cioè l'offerta rivolta a
una pluralità di persone: essa equivale a una proposta contrattuale se contiene gli elementi essenziali
del contratto come un vestito in vetrina con il cartellino del prezzo: si entra, si accetta la proposta, si
paga, il contratto è concluso: non essendo recettizia (perchè il destinatario non si conosce) diventa
efficace non appena è resa pubblica ( quando il vestito è messo un vetrina) e il commerciante può
revocarla quando vuole, ritirando il vestito dalla vetrina.
I CONTRATTI PLURILATERALI APERTI O DI ADESIONE (ad es contratti di società e di
associazioni) sono contratti già conclusi ma aperti all'adesione di altri soggetti, adesione che viene
indirizzata ai contraenti originari oppure ad un organo apposito, con ciò concludendo il contratto in
quanto l'adesione equivale all'accettazione; ma in alcuni casi viene richiesta l'approvazione e in tal
caso l'adesione non è + un'accettazione ma una proposta e sarà l'organo ad accettarla o meno.
--2)INIZIO DELL'ESECUZIONE: nelle vendite su catalogo siamo fuori dallo schema generale
proposta-accettazione: innanzitutto la legge non parla di proposta ma di “invito all'acquisto” ;in
secondo luogo non c'è comunicazione di accettazione da parte del compratore il quale ordina
direttamente (si potrebbe dire che ordine e accettazione coincidono); e infine il contratto si chiude al
momento in cui faccio l'ordine-accettazione cioè prima che il proponente abbia notizia dell'ordine
(manca dunque il carattere recettizio).
--3)CONTRATTI CON OBBLIGAZIONI DEL SOLO PROPONENTE
L'esempio è la fideiussione con cui un soggetto garantisce il pagamento di un debito di un altro :
anche qui siamo di fronte a un contratto che non ha bisogno di una espressa accettazione da parte
dell'oblato il quale può rifiutare la proposta ma la mancanza di questo rifiuto equivale ad
accettazione: si tratta quindi di “silenzio circostanziato” ossia di silenzio al quale la legge attribuisce
il valore di assenso in considerazione che dal contratto derivano all'oblato solo vantaggi.
--4)CONTRATTI REALI: sono quelli in cui, oltre al consenso delle parti, occorre la TRADITIO, la
consegna della cosa (res, da cui il nome), ad es il comodato o il mutuo: fino a quando non avviene
la consegna il contratto non si considera concluso.
--5)CONTRATTI STANDARD sono quelli in cui la contrattazione non esiste: si prenda ad es. un
contratto di fornitura di energia elettrica: al cliente l'azienda presenta un modulo prestampato da
accettare o rifiutare: il fatto che le condizioni sono poste da una sola delle parti, comporta una serie
www.unictblog.com 64
Scaricato da Giovanni Porta (portagiovanni358@gmail.com)
lOMoARcPSD|7648598
5
di problemi:
--il cliente,che spesso firma senza leggere, deve essere a conoscenza delle condizioni generali di
contratto, o almeno deve avere la possibilità di conoscerle (la legge parla di conoscenza astratta nel
senso che è sufficiente che vengano messe a disposizione del cliente, che poi questi li legga o no
sono affari suoi) e inoltre queste condizioni generali devono essere chiare e non ambigue ( in caso
di ambiguità verranno interpretate sempre a favore del cliente)
--poichè il contratto è unilaterale, riguardo il contenuto ci possono essere le cd clausole
VESSATORIE, clausole cioè che vanno o a sfavore del cliente ( decadenze, restrizioni alla libertà
contrattuale vs terzi, tacite proroghe, clausole compromissorie che affidano a privati la soluzione di
future liti ecc) o a favore di chi ha predisposto il contratto (facoltà di recedere dal contratto,
limitazioni di responsabilità): l'art 1341 prescrive che tali clausole se esistono devono essere
sottoscritte separatamente dal contratto: chiaramente questa tutela del consumatore è insufficiente,
perchè di fatto il cliente non può rifiutare queste clausole.
Tuttavia la legge, che fino a qualche tempo fa non faceva distinzione tra contratti tra privati o tra
società o tra industria e consumatore, si è resa conto che spesso una delle parti contraenti è in
condizioni di inferiorità nei confronti dell'altra ad es il consumatore o il piccolo industriale che
fornisce pezzi a una grande industria, e ha evidenziato un nuovo principio, quello del divieto di
abuso di potere contrattuale a carico del contraente che si trovi in posizione di forza:
A)Per i contratti tra imprenditori, la legge 192 del 1998 ha introdotto la tutela dell'imprenditore
debole ossia del subfornitore che fornisce ad altra impresa prodotti e servizi: è chiara qui la
dipendenza economica del subfornitore che non può vendere a nessun altro il suo prodotto per cui
potrebbe essere soggetto ad abusi da parte dell'industria maggiore: la legge quindi richiede la forma
scritta del contratto, garanzie di pagamento, nullità di clausole vessatorie ecc; ma più in generale la
legge si occupa di intese anticoncorrenziali, di pubblicità ingannevole ecc.
B)Più numerosi sono gli interventi legislativi a difesa del consumatore, tanto che sono stati
racchiusi nel cd codice del consumo (2005) che detta regole specifiche su singoli aspetti del
contratto ma anche alcuni principi generali di correttezza,trasparenza, equità:
---sono stati sanciti i DIRITTI FONDAMENTALI DEL CONSUMATORE: alla salute, alla
sicurezza e qualità dei prodotti, a una informazione appropriata ( indicazioni sulla composizione,
sulla presenza di sostanze nocive) divieto di pubblicità ingannevole o scorretta (vietata la pubblicità
subliminale)
---Sono stati conferiti poteri istruttori, inibitori e sanzionatori all'AUTORITA' GARANTE DELLA
CONCORRENZA E DEL MERCATO.
---Le ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI sono state legittimate ad agire a tutela degli interessi
collettivi dei consumatori, potendo chiedere al giudice di inibire atti e comportamenti lesivi e di
adottare misure idonee a correggere gli effetti dannosi e infine di esercitare azioni collettive
risarcitorie nei confronti di chi ha leso i diritti di una pluralità di consumatori
Particolare attenzione è rivolta ai RAPPORTI TRA CONSUMATORE E PROFESSIONISTA:
consumatore è chi agisce per scopi estranei alla propria attività imprenditoriale o professionale;
professionista è chi agisce nell'esercizio delle proprie attività imprenditoriali o professionali;
per questi rapporti la legge sancisce la nullità di alcune clausole contrattuali a prescindere dalla
eventuale e specifica sottoscrizione, le già ricordate clausole vessatorie che determinano un
significativo squilibrio di diritti e obblighi a sfavore del consumatore e sulle quali deciderà il
giudice caso per caso: la nullità è relativa cioè si limita alle clausole vessatorie mentre il contratto
rimane valido per il resto. L'art 33 cod cons considera vessatorie le clausole:
--che escludono o limitano la responsabilità del professionista in caso di morte o danno del cliente
–che escludono o limitano diritti del consumatore in relazione a disdetta, recesso ecc
--che impongono penali eccessive o modifiche unilaterali del contratto senza giusti motivi.
Deroghe sono previste per contratti di prestazioni di servizi finanziari e per le clausole che sono
state oggetto di trattative tra cliente e professionista perchè in tal caso verrebbe a mancare la
predisposizione unilaterale del contratto.
www.unictblog.com 65
Scaricato da Giovanni Porta (portagiovanni358@gmail.com)
lOMoARcPSD|7648598
CAP 33 CAUSA OGGETTO FORMA (pagg 325-338)
LA CAUSA DEL CONTRATTO
Per causa si intende comunemente la funzione economico-sociale del contratto e cioè lo scopo cui è
diretto un certo schema contrattuale: così ad es la compravendita ha lo scopo di scambiare una cosa
contro un prezzo: si tratta di un elemento comune alle due parti ed è questo che la distingue dai
“motivi” che invece sono gli scopi individuali ( compro un libro per leggerlo o per regalarlo a un
amico) che sono giuridicamente irrilevanti a meno che:
--questi motivi siano inseriti nel contratto come clausole condizionali (compro il libro ma mi riservo
di restituirlo se il mio amico ce l'ha già)
--i motivi siano illeciti, comuni (ambedue le parti ne traggono profitto) e determinanti (il contratto è
stato fatto esclusivamente per tale motivo)
--i motivi siano erronei: ha rilievo nella donazione e nel testamento :lascio un bene a Tizio perchè,
errando, lo ritengo mio nipote: l'atto è annullabile se l'errore è desumibile dall'atto.
Diversa è invece la PRESUPPOZIONE: l'es classico è l'affitto di un balcone a un soggetto che
vuole assistere a una manifestazione di piazza, manifestazione che poi non viene fatta: secondo la
giurisprudenza si tratterebbe di una condizione IMPLICITA nel contratto: ciascuna delle due parti,
chi affitta e chi prende in affitto,lo fa per quel motivo e non per altri, quindi c'è un presupposto
oggettivo e comune (la manifestazione di piazza) sul quale si basa l'intero contratto; venendo meno
questo presupposto si ha diritto allo scioglimento del contratto.
La causa è un elemento essenziale la cui mancanza o illiceità produce la nullità del negozio.
Tuttavia sono possibili negozi in cui la causa non c'è o che cmq prescindono dalla causa: sono i cd
negozi astratti che non sono ammessi dalla legge italiana tranne la cambiale:ad es ordino della
merce pagandola con una cambiale che consegno al venditore il quale la gira subito a un terzo; poco
dopo il contratto viene annullato; allo scadere della cambiale, il terzo si presenta da me per
riscuotere e io non posso rifiutarmi anche se il contratto per il quale ho rilasciato la cambiale è
risultato nullo: per il terzo il negozio è astratto in quanto non ha nulla a che vedere con la
compravendita, il SUO negozio prescinde cioè dalla causa sottostante.
L'art 1322 stabilisce che la causa deve essere “diretta a realizzare interessi meritevoli di tutela” ,
quindi una causa, oltre che lecita, deve avere un certo RILIEVO (il fatto che io paghi una persona
perchè diventi mia amica è irrilevante) e deve emergere nel contratto, in sostanza non posso
trasferire la proprietà di un mio bene a un altro soggetto se non risulta “a che titolo”,per quale
motivo
Infine un altro problema, riguardante la causa, è il fatto che a volte un contratto viene stipulato per
cause diciamo così diverse ad es un matrimonio fatto allo scopo di acquisire la cittadinanza: la legge
ammette in certi casi il perseguimento di interessi diversi rispetto a quelli tipici (si parla in questi
casi di uso indiretto del negozio), ma NON quando lo scopo è quello di eludere l'applicazione di
una norma imperativa: si parla in tal caso di negozio in frode alla legge,un negozio cioè che rispetta
la lettera della legge ma in concreto serve a violarne i precetti: in tal caso il contratto è nullo per
illiceità della causa.
Tradizionalmente i contratti vengono distinti in 2 categorie, tipici e atipici.
CONTRATTI TIPICI O NOMINATI sono quelli che la legge disciplina: vendita,locazione,mutuo;
le parti possono adottare questi modelli in cui la meritevolezza della causa è predefinita dalla legge
CONTRATTI ATIPICI o INNOMINATI non disciplinati da apposite leggi ma molto diffuse nella
pratica,ad es il leasing, per i quali si fa ricorso alla disciplina generale dei contratti, a accordi tra le
parti o all'analogia; qui la meritevolezza della causa è stabilita caso per caso
Contratti atipici particolari sono i contratti misti che hanno caratteri vicini a diverse forme di
contratto ( il leasing ad es ha caratteri vicini sia alla locazione sia all'opzione di vendita): in tali casi
si usano il criterio di prevalenza (quando appaiano prevalenti somiglianze con un certo tipo di
contratto) o il criterio della combinazione ( si applicano regole diverse per ogni clausola)
www.unictblog.com 66
Scaricato da Giovanni Porta (portagiovanni358@gmail.com)
lOMoARcPSD|7648598
L'OGGETTO DEL CONTRATTO
Per oggetto si intende il contenuto del contratto cioè l'insieme delle disposizioni contrattuali ad es la
determinazione del bene, il prezzo, il termine di pagamento o di recesso ecc
L'oggetto deve avere le segg caratteristiche:
1)POSSIBILITA' cioè deve essere realizzabile con la normale diligenza se si tratta di una
prestazione; se si tratta di un bene materiale significa l'esistenza materiale del bene che può cmq
essere anche un bene futuro (una casa da costruire); l'impossibilità originaria provoca la nullità del
contratto, quella sopravvenuta ne provoca la risoluzione.
2)LICEITA': non deve essere contrario a norme imperative o all'ordine pubblico e al buon costume
3)DETERMINATEZZA: l'oggetto deve essere determinato cioè specificato con esattezza o
perlomeno determinabile in base a criteri stabiliti dalla legge ad es riferimento a prezzi di listino o a
tariffe professionali,oppure in base a criteri stabiliti dalle parti ad es riferimenti all'indice ISTAT,
oppure affidamento ad un arbitraggio cioè a un terzo detto arbitratore,che proceda a un equo
apprezzamento il cd arbitrium boni viri la cui decisione è impugnabile ad es se è palesemente iniqua
e sarà il giudice a farla; esiste anche il merum arbitrium, in cui le parti si impegnano ad accettare le
decisioni dell'arbitratore quali che siano e in tal caso esse non saranno impugnabili a meno che non
si provi la malafede del terzo.
LA FORMA
E' il modo di manifestazione della volontà negoziale cioè il modo con cui viene comunicata alla
cerchia sociale
Questa manifestazione in linea generale è libera, può quindi essere espressa (con parole, scritti,
gesti) o tacita (silenzio circostanziato vedi prima) oppure possono essere le parti stesse ad es in un
preliminare di vendita, a scegliere una forma piuttosto che un altra (cd forma convenzionale)
Tuttavia in certi casi la legge impone una certa forma ( NEGOZI FORMALI) senza la quale il
contratto è nullo (forma ad substantiam)
Si richiede la forma scritta
--per atto pubblico (pena la nullità): per i contratti di donazione e per la costituzione di società di
capitali o di fondazioni, per le convenzioni matrimoniali
--per scrittura privata:
– contratti di alienazione della proprietà e degli altri diritti reali su immobili
– locazioni abitative
– contratti relativi a operazioni di banca o di SIM
(soc.intermediaz.Mobiliare).
Da notare che la compravendita immobiliare ,pur potendo bastare la scrittura privata, viene fatta per
atto pubblico per i noti problemi di trascrizione e opposizione a terzi (vedi mod 1).
I CONTRATTI A PROVA FORMALE sono quelli per i quali la legge prescrive la forma scritta
solo al fine di provare la sua esistenza in caso di contestazioni (forma ad probationem): un esempio
sono i contratti assicurativi per la cui efficacia basterebbe anche la stipula verbale, ma in caso di
contestazioni, se non c'è la prova scritta, non bastano le prove ordinarie es i testimoni, ma occorre o
la confessione o il giuramento
Infine i DOCUMENTI INFORMATICI sono equiparati in tutto e per tutto a quelli cartacei,
compresa la sottoscrizione con firma digitale.
www.unictblog.com 67
Scaricato da Giovanni Porta (portagiovanni358@gmail.com)
lOMoARcPSD|7648598
CAP 34 LE CLAUSOLE ACCIDENTALI DEL CONTRATTO (pagg 339-349)
Come sappiamo i contraenti possono arricchire un contratto inserendo particolari clausole, anche in
deroga a norme di legge non imperative, per soddisfare specifiche esigenze ed interessi: queste
clausole accessorie vengono dette elementi accidentali per contrapporli agli essenziali la cui
mancanza pregiudica la validità del contratto:invece in mancanza degli elementi accidentali, il
contratto è perfettamente valido.
Le clausole accessorie + frequenti sono condizioni, termini e modo.
CONDIZIONI
La condizione è una clausola che subordina gli effetti del contratto a un avvenimento futuro e
incerto; si distinguono 2 casi:
--condizione sospensiva: l'efficacia del contratto è sospesa fino al verificarsi dell'evento: ti dono la
bottega studio a condizione che tu ottenga la licenza: prima tu ottieni la licenza e poi la donazione
avrà effetto, il contratto avrà i suoi effetti solo al verificarsi della condizione.
--condizione risolutiva :l'efficacia viene meno al verificarsi dell'evento: compro la bottega ma se
non ottengo la licenza il contratto sarà risolto ( prima compro la bottega poi ottengo la licenza): il
contratto ha effetti immediati (divento subito proprietario) ma potrebbero cadere al verificarsi
dell'impossibilità di ottenere la licenza.
Si può dire che la clausola condizionale attribuisce rilievo giuridico e importanza a interessi
specifici e individuali , cioè ai “motivi” di cui si è parlato nel precedente capitolo.
In linea di massima è consentito apporre condizioni in tutti gli atti negoziali, ma ci sono casi previsti
dalla legge in cui ciò non è consentito, i cd atti puri o legittimi ad es cambiale, negozi familiari,
matrimonio; d'altra parte ci sono casi in cui è la legge a imporre le condizioni, la cd condizione
legale ad es condizione per l'efficacia di una donazione al nascituro non concepito, è la sua nascita.
Abbiamo detto che l'evento deve essere futuro e incerto ( o almeno ignorato dalle parti) e questa
incertezza può dipendere dal caso oppure dalla volontà ( condizione potestativa) di una delle parti
che decide o in base a un suo interesse (condizione potestativa semplice: se mi trasferisco in altra
città, ti vendo la mia casa) oppure in base a un suo arbitrio ( condizione meramente potestativa: ti
vendo casa se voglio, se lo riterrò opportuno: in tal caso l'atto è nullo).
Infine l'evento deve essere ovviamente possibile e lecito
La condizione impossibile (se costruisci un grattacielo in un giorno) rende nullo il contratto se è
sospensiva; se invece è risolutiva la clausola si considera come non apposta.
La condizione è illecita quando è contraria a norme imperative o al buon costume o all'ordine
pubblico e quando costituisce una pressione indebita sulla libertà individuale ( ti do un bene a
condizione che tu abbandoni la tua religione)
Come appare evidente,nel contratto sottoposto a condizioni si è in una situazione di incertezza
giuridica (cd pendenza della condizione): se ho comprato una bottega a condizione di ottenere la
licenza, la bottega è mia ma potrebbe non esserla in futuro e allora cosa posso o non posso fare?
La legge tende a garantire la possibilità dell'acquisto e a tale scopo dispone che ciascuna delle parti
debba comportarsi secondo buona fede ( questo vuol dire che devo conservare il bene e non
deteriorarlo) e se una parte fa in modo che l'evento condizionante non avvenga, il giudice
considererà come avvenuto l'evento (se prometto un premio alla mia squadra a patto che vinca 10
partite e poi faccio in modo che la squadra faccia solo 8 partite, la legge considererà ugualmente
come fatte 10 partite); per il resto si possono compiere atti conservativi ( chiedere il sequestro del
bene) e anche atti dispositivi, cioè vendere a terzi la bottega , ma se poi non ottengo la licenza e
devo ritornare la bottega al proprietario, la seconda vendita sarà come si dice travolta dalla
risoluzione del primo contratto.
Quando l'evento si verifica la situazione di incertezza si risolve e il contratto diventa efficace (o
inefficace nel caso della condizione risolutiva): gli effetti sono retroattivi cioè nell'esempio
precedente in cui io ho venduto a terzi la bottega, se sono riuscito ad ottenere la licenza è come se io
avessi avuto effettivamente la bottega sin dal momento in cui ho firmato il contratto, quindi la mia
www.unictblog.com 68
Scaricato da Giovanni Porta (portagiovanni358@gmail.com)
lOMoARcPSD|7648598
vendita a terzi sarà valida. Tuttavia la legge prevede che la retroattività possa essere esclusa dalla
volontà delle parti o dalla natura del rapporto (ad es nei contratti di lavoro continuato lascia ferme le
prestazioni già eseguite).
IL TERMINE
Stabilisce l'inizio o la fine degli effetti del contratto, o cmq la durata del rapporto.
Caratteristica del termine è di essere stabilito in relazione ad un evento futuro e certo e può
consistere in una data prefissata (cd termine determinato) o in un qualsiasi altro accadimento purchè
certo (cd termine indeterminato): si suole dire che il termine è “certo se” e” certo o incerto quando”,
cioè il termine è certo ma il quando può essere certo (es il1°maggio) o incerto (il giorno delle
prossime elezioni).
Come la condizione anche il termine ha la funzione di adeguare gli effetti del contratto agli specifici
interessi delle parti , anche qui ci sono atti legittimi cioè che non ammettono termine (es
matrimonio), termine potestativo (affidato alla scelta di una delle parti), ma non ha effetti retroattivi.
Nota: sui termini efficacia, perfezione e adempimento: stipulo un contratto di locazione il 1°
maggio (termine di perfezione), pattuendo una durata dal 1° al 31 agosto (termine di efficacia) e il
pagamento al 31 luglio (termine di adempimento).
IL MODO NEI NEGOZI GRATUITI
E' una limitazione apposta a una attribuzione gratuita: es dono una casa al vescovo affinchè ne
faccia un centro di accoglienza: si tratta dunque di un peso o onere che grava sul beneficiario
riducendone i vantaggi.
Anche la clausola modale costituisce un mezzo per attribuire rilevanza a particolari motivi
individuali: la sua particolarità è che può essere inserita solo nei negozi gratuiti come donazioni,
testamento, comodato; l'onere può consistere in un dare, in un fare, in un non fare; in ogni caso
costituisce una vera e propria obbligazione giuridicamente vincolante: l'adempimento coattivo può
essere richiesto da chiunque vi abbia interesse mentre la risoluzione si può avere solo se è stata
prevista nel contratto
LA CLAUSOLA PENALE E LA CAPARRA
Sono pattuizioni che servono a rafforzare il vincolo contrattuale, semplificando la prova e la
liquidazione dei danni da inadempimento o recesso
CLAUSOLA PENALE è la determinazione anticipata e forfettaria del risarcimento in caso di
inadempimento o ritardo (es in un contratto di appalto si pattuisce che per ogni giorno di ritardo
nella consegna saranno dovuti 100 €): la parte a favore della quale opera la clausola non è tenuta a
provare di aver subito un danno dall'inadempimento né a quanto esso ammonta perchè la somma è
stabilita forfettariamente: la penale cmq può essere ridotta dal giudice ove sia manifestamente
eccessiva.
LA CAPARRA CONFIRMATORIA è la somma consegnata a una parte al momento della
conclusione del contratto, a garanzia dell'impegno contrattuale (ed eventualmente a titolo di acconto
sulla prestazione dovuta); in caso di inadempimento di chi ha dato la caparra, l'altra parte può
recedere dal contratto e ritenere la caparra; in caso di inadempimento di chi ha ricevuto la caparra,
sarà l'altra parte a poter recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra versata: cmq la
parte fedele conserva la facoltà di chiedere la risoluzione o l'esecuzione coattiva + risarcimento.
LA CAPARRA PENITENZIALE è la somma consegnata a una parte a titolo di corrispettivo per il
futuro ed eventuale esercizio del recesso; cioè si dà la possibilità a una parte di recedere dal
contratto per decisione unilaterale e la somma andrà all'altra parte.
LA MULTA PENITENZIALE è l'obbligo di versare alla controparte una somma di denaro da parte
di chi recede dal contratto: la differenza con la caparra penitenziale è che qui la somma è versata al
momento del recesso: il recesso produce effetti solo quando la prestazione è eseguita.
www.unictblog.com 69
Scaricato da Giovanni Porta (portagiovanni358@gmail.com)
lOMoARcPSD|7648598
CAP 35 INVALIDITA' DEL CONTRATTO (pagg 350-377)
Abbiamo visto come il contratto necessiti di requisiti essenziali e come le ulteriori clausole
accidentali debbano rispondere a determinate caratteristiche: si parla dunque di validità del contratto
per indicare la sua conformità alle regole dettate dalla legge e viceversa invalidità quando esso non
sia validamente formato e in tal caso il contratto non è idoneo a conseguire gli effetti cui è diretto.
Si distinguono 3 forme di invalidità: nullità, annullabilità e rescindibilità.
La nullità è la forma di invalidità generale nel senso che è conseguenza di tutte quelle ipotesi in cui
un negozio è contrario a norme imperative salvo che la legge disponga diversamente( art 1418); le
altre due sono forme speciali che conseguono solo nei casi previsti dalla legge.
LA NULLITA'
La nullità è la forma generale e + grave di invalidità e comporta la radicale e definitiva inefficacia
dell'atto.Un contratto è nullo quando manca o è illecito uno dei suoi requisiti essenziali.
1)MANCANZA DEI REQUISITI
--mancanza della causa
--mancanza dell'oggetto o oggetto impossibile o indeterminato
--mancanza della forma (es stipulo verbalmente una compravendita immobiliare)
--mancanza dell'accordo tra le parti per:
----A)mancanza di volontà: ad es nei casi di dichiarazione non seria (scherzosa ad es scambierei la
mia auto per la tua bici) o nella violenza fisica ( in un'asta alzo il braccio del mio vicino; drogo
l'altro contraente)
----B)divergenza tra volontà e dichiarazione: sono i casi di errore ostativo (voglio scrivere 1100 e
invece scrivo 1010) per il quale la nullità sembra un provvedimento eccessivo per cui la legge
preferisce inquadrarlo nei vizi del consenso; e di simulazione per il quale si rimanda al cap effetti
del contratto
2)ILLICEITA' DEL CONTRATTO
Il contratto è illecito quando è contrario a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume:
L'ordine pubblico è l'insieme dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico, si tratta cioè di
quei principi irrinunciabili che sono esplicitati in norme di legge oppure principi non scritti ma
comunemente accettati.
Il buon costume è l'insieme dei principi morali comunemente accolti nella società e attinenti sia alla
sfera sessuale sia alle regole dell'onestà e correttezza: esempi di negozi immorali sono i contratti
relativi alla prostituzione e pornografia, la corruzione di un funzionario pubblico, l'affitto di utero.
Nulli infine, come sappiamo, sono i contratti con motivo illecito da ambo le parti e i contratti in
frode alla legge.
L'AZIONE DI NULLITA'
La nullità opera automaticamente per cui l'azione di nullità (cioè l'azione con cui si fa valere in
giudizio la nullità dell'atto) è un'azione di mero accertamento: il giudice dovrà semplicemente
accertare e far constatare pubblicamente (sentenza dichiarativa) che il contratto è nullo.
L'azione di nullità può essere fatta valere da chiunque vi ha interesse e può anche essere rilevata
d'ufficio dal giudice; essa è imprescrittibile, salvi (art 1422) gli effetti dell'usucapione e della
prescrizione degli atti di ripetizione: cioè se ho acquistato un immobile e, passati 20 anni, il giudice
dichiara nullo il contratto, l'immobile resta a me per usucapione; né d'altra parte, a prescindere
dall'usucapione, posso restituire l'immobile e riavere indietro il prezzo pagato se ormai è prescritta
l'azione di ripetizione cioè di restituzione.
RECUPERO DEL CONTRATTO NULLO
La nullità è una forma di invalidità insanabile: le parti possono solo fare una rinnovazione del
contratto, ma si tratta appunto di un contratto nuovo.
Ferma l'insanabilità del negozio nullo, sono previste alcune forme di recupero dell'atto nullo fondate
su un meccanismo di modificazione legale dell'atto: sono la nullità parziale e la conversione:
---La nullità parziale è la nullità che riguarda solo una parte del contratto ad es: se vendendo un
www.unictblog.com 70
Scaricato da Giovanni Porta (portagiovanni358@gmail.com)
lOMoARcPSD|7648598
terreno mi riservo la proprietà degli alberi da frutto, questa clausola è palesemente contro legge: la
nullità si limita alla clausola o riguarda tutto il contratto?
La risposta sta nell'importanza che si attribuisce alla clausola: se la clausola è importante nel senso
che le parti non avrebbero concluso il contratto senza di essa, cade l'intero contratto; in caso
contrario cade solo la clausola e il rimanente contratto rimane valido anche senza una dichiarazione
di volontà delle parti (principio della conservazione del contratto).
Cosa diversa è invece la cd inserzione automatica di clausola cioè quando la legge prevede che le
clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative: ad es se in una locazione ad uso
commerciale si è pattuita una durata di 4 anni, il contratto rimane valido ma la sua durata sarà
quella minima stabilita dalla legge, cioè 6 anni.
---La conversione è la trasformazione legale del contratto nullo in un contratto valido e diverso,
come si ritiene che le parti lo avrebbero voluto se avessero conosciuto la causa di nullità: ad es un
assegno senza data, e come tale nullo, può valere come promessa di pagamento: quello che conta è
la corrispondenza sostanziale tra il nuovo contratto e quello nullo, cioè il nuovo contratto deve
perseguire lo stesso scopo del contratto nullo, sia pure per vie diverse.
La conversione FORMALE invece si ha quando un atto pubblico è nullo per difetto di forma ma
può essere valido come scrittura privata: qui c'è un cambiamento della forma non della sostanza.
L'ANNULLABILITA'
E' una forma meno grave di nullità: il negozio annullabile è provvisoriamente efficace ma si tratta di
una efficacia precaria perchè gli effetti possono venir meno a seguito di sentenza di annullamento su
domanda della parte tutelata. A differenza della nullità che garantisce interessi generali,
l'annullabilità tutela interessi individuali di uno dei contraenti cui spetta la decisione se tenere fermo
l'atto o farlo cadere con l'impugnazione giudiziale: ad es la minore età è causa di annullabilità del
contratto: ma la decisione se farlo annullare o meno viene affidata al minore (o al suo
rappresentante legale) in relazione alla convenienza economica.
In linea generale si può dire che l'annullabilità è sancita quando la nullità sembra eccessiva.
L'annullabilità è una forma speciale di invalidità, prevista dalla legge in determinati casi: questo
vuol dire che la violazione di una norma imperativa comporterà annullabilità nei casi previsti dalla
legge e nullità in tutti gli altri casi.
I casi previsti dalla legge sono quelli in cui si vuole tutelare la libertà del volere e sono i casi di
incapacità di agire e i vizi della volontà
L'INCAPACITA' DI AGIRE
Il negozio è annullabile nel caso dell'incapacità di una delle parti, legale o naturale.
--incapacità legale di agire: è la condizione in cui si trovano alcuni soggetti (minori, interdetti e in
parte inabilitati) i quali incontrano limitazioni nel compimento degli atti giuridici, che richiedono l'
intervento di altri soggetti incaricati della loro protezione: nel caso che questi soggetti abbiano
compiuto questi atti a loro preclusi, essi possono essere annullati su richiesta dell'incapace o del suo
rappresentante ( a meno che il minore non abbia nascosto la sua minore età)
--incapacità naturale di agire è la condizione di chi sia stato incapace di intendere e volere al
momento dell'atto (es era ubriaco):in tal caso per ottenere l'annullamento da parte dell'incapace
occorre:
--per i contratti dimostrare la malafede della controparte
--per gli altri atti dimostrare che dall'atto deriverebbe un notevole danno all'incapace
I VIZI DEL CONSENSO ( o DELLA VOLONTA')
Sono ipotesi in cui la volontà del negozio c'è ( se non ci fosse l'atto sarebbe nullo)ma è distorta da
fattori esterni:ad es sotto intimidazione di una banda criminale, vendo la mia azienda: qui c'è la
volontà di vendere ma solo per evitare il male minacciato, il consenso cioè è viziato e la legge mi
offre il rimedio dell'annullabilità.
Il codice considera come vizi del consenso: l'errore, la violenza e il dolo:
L'ERRORE: consiste in una falsa conoscenza della realtà che determina una delle parti a un
contratto che, senza quell'errore, non avrebbe mai fatto: ad es compro un quadro pensando sia un
www.unictblog.com 71
Scaricato da Giovanni Porta (portagiovanni358@gmail.com)
lOMoARcPSD|7648598
originale e invece è una copia;
l'errore è causa di annullamento del contratto se è essenziale e riconoscibile dall'altro contraente:
--riconoscibile dall'altro contraente significa che una persona di normale diligenza avrebbe potuto
rilevarlo.
--essenziale si riferisce al fatto che chi ha stipulato il contratto non lo avrebbe mai fatto senza
quell'errore: l'art 1429 elenca alcuni casi tipici di errore essenziale riguardanti:
-- natura e oggetto del contratto: es del quadro-copia
--qualità dell'oggetto: compro pane comune pensando che sia invece pane dietetico
--identità e qualità dell'altro contraente: assumo un laureato pensando che sia iscritto all'albo.
--aspetti quantitativi: compro una pezza di stoffa pensando che sia sufficiente per un vestito
Infine parliamo del cd errore di diritto che sostanzialmente è l'ignorare l'esistenza di una legge: es
compro un'anfora antica e la pongo in vendita non sapendo che ci sono leggi che lo vietano: se
avessi saputo dell'esistenza di tali leggi non avrei mai comprato l'anfora; in questo caso posso
richiedere l'annullamento della compravendita:Il fatto rilevante ai fini dell'annullabilità è che
l'errore si riferisca a un elemento interno del contratto: spieghiamoci con un esempio: se compro un
terreno pensando, erroneamente, che sia edificabile posso chiedere l'annullamento del contratto
( qui il fattore edificabilità si riferisce al terreno oggetto del contratto); se compro un terreno
pensando erroneamente che i terreni intorno non siano edificabili, non posso chiedere
l'annullamento perchè la non edificabilità si riferisce ad elementi estranei al contratto.
IL DOLO: è un inganno che induce in errore l'altro contraente: esso è causa di annullamento del
contratto quando sia determinante per il consenso, cioè quando senza di esso l'altro contraente non
avrebbe mai stipulato; se invece il raggiro non è stato decisivo per la stipulazione ma solo influito
sul suo contenuto, il contraente ingannato può richiedere solo il risarcimento del danno (cd dolo
incidente): il tipo di dolo fin qui descritto, si chiama dolus malus e si distingue dal dolus bonus che
consiste nella esagerata esaltazione della merce: tali atteggiamenti sono in genere tollerati, anche se
questa tolleranza via via tende a diminuire (vedi quanto detto a proposito della difesa del
consumatore dalla pubblicità ingannevole e aggressiva).
Si può ingannare una persona anche tacendo, pur avendo l'obbligo di informazione, e in tal caso si
parla di dolo omissivo.
Rispetto all'errore, per il dolo non conta che l'elemento sia estraneo o no al contratto.
Inoltre il contratto è annullabile anche quando i raggiri sono stati fatti da un terzo, se erano noti al
contraente che ne ha tratto vantaggio.
LA VIOLENZA: è la minaccia di un male ingiusto e notevole alla persona o ai beni del contraente,
esercitata al fine di estorcere il consenso a un determinato contratto o negozio: il minacciato è posto
nell'alternativa tra il resistere alla pressione, rischiando di subire il male, o il cedere stipulando il
contratto.
Anche qui si presume che la volontà ci sia, se non ci fosse si avrebbe nullità dell'atto e non
l'annullabilità: si tratta cmq di violenza psichica che lascia pur sempre liberi di scegliere, cosa che
manca nella violenza fisica che porta quindi alla nullità.
Riguardo la definizione sopraddetta (minaccia di male ingiusto e notevole):
--la minaccia deve essere tale da impressionare una persona sensata: non è ammesso come minaccia
il cd timore reverenziale cioè la soggezione verso persone autorevoli e influenti perchè questa
soggezione dipende da fattori interni (cd metus ab intrinseco) a meno che tale soggezione non sia
ingigantita apposta da pressioni esterne, allusioni (cd metus ab extrinseco)
--il male minacciato deve essere notevole cioè rilevante economicamente e ingiusto in quanto lede
un interesse protetto dalla legge.
L'AZIONE DI ANNULLAMENTO
E' la domanda giudiziale diretta a far annullare il contratto: a differenza dell'azione di nullità che
può essere proposta da chiunque abbia interesse,essa spetta al soggetto tutelato, quindi all'incapace
o al suo rappresentante legale, al contraente il cui consenso è viziato da errore, dolo, violenza:
questo ribadisce come l'annullabilità è diretta all'interesse individuale, la cui valutazione è rimessa
alla parte interessata.
www.unictblog.com 72
Scaricato da Giovanni Porta (portagiovanni358@gmail.com)
lOMoARcPSD|7648598
L'azione si prescrive in 5 anni a partire dal momento in cui è cessata l'incapacità o si è scoperto
l'errore o il dolo o è cessata la violenza. Trascorso tale periodo non è più possibile un'azione
autonoma diretta a far annullare l'atto ma rimane la possibilità di chiedere l'annullamento “in via di
eccezione” nel corso di un giudizio cui la parte tutelata è chiamata per l'esecuzione del contratto: in
sostanza, ho comprato il solito quadro pensando fosse originale e non avendo abbastanza soldi dico
al venditore che li porterò il giorno successivo; a casa mi accorgo che il quadro è una copia e che
quindi c'è la possibilità di annullamento del contratto, ma poiché non ho versato ancora una lira,
non faccio nulla; passano 5 anni e l'azione di annullamento non posso + farla: a questo punto il
venditore mi chiama in giudizio per essere pagato e io dovrei pagarlo ma nel corso del giudizio
posso chiedere l'annullamento in via di eccezione.
EFFETTI DELL'ANNULLAMENTO
Con la sentenza di annullamento il contratto-atto viene travolto e conseguentemente viene meno il
rapporto sorto dal contratto: la sentenza è dunque costitutiva (non dichiarativa come quella di
nullità) perchè ad essa va riportata l'eliminazione del contratto.
La sentenza ha effetto retroattivo: è come se il contratto non fosse mai stato stipulato, non solo non
si è tenuti ad eseguirlo ma le prestazioni eventualmente eseguite vanno restituite, perchè a questo
punto risultano prive di giustificazione; ma rispetto a terzi, la retroattività non è assoluta: la legge
prevede che l'annullamento non dovuto a incapacità legale, non pregiudica i diritti acquisiti a titolo
oneroso da terzi in buona fede.
L'annullamento del contratto dà diritto al risarcimento dei danni sempre che vi sia colpa dell'altro
contraente ( che ad es era a conoscenza della minore età dell'altro)
CONVALIDA DEL CONTRATTO ANNULLABILE
A differenza del contratto nullo, il contratto annullabile è sanabile e ciò spetta alla parte tutelata
(cioè al minore ecc) che può, se vuole, convalidare il contratto a patto che sia cessata l'incapacità o
la violenza e siano stati scoperti errore e dolo.
La convalida è un vero e proprio atto negoziale e richiede una dichiarazione di volontà che può
essere o espressa (un'esplicita dichiarazione di convalida) o tacita ( un comportamento concludente
da cui si desume la volontà di convalidare l'atto.
In alcuni casi invece l'atto può essere sanato dalla controparte: è il caso della rettifica in caso di
errore: se l'errore è stato scrivere 1010 al posto di 1100 il tutelato può richiedere l'annullamento ma
la controparte può evitarlo offrendo di eseguire il contratto per 1100
LA RESCINDIBILITA'
E' una forma particolare di invalidità contrattuale che si avvicina alla annullabilità: il contratto può
essere rescisso quando è stato concluso a condizioni inique per la condizione di alterata libertà del
volere di uno dei contraenti; in particolare quando le condizioni inique sono state determinate dallo
stato di bisogno o dallo stato di pericolo in cui si trovava uno dei contraenti.
L'azione di rescissione compete solo alla parte che si sia trovata nello stato di pericolo o bisogno; a
differenza dell'annullamento, si prescrive in 1 anno e non ammette convalida, mentre è ammessa la
rettifica, cioè il contraente contro cui è rivolta la rescissione, può evitarla offrendo un supplemento
di prestazione che ridia equilibrio al contratto; la rescissione è pronunciata dal giudice e ha effetto
retroattivo solo tra le parti.
RESCISSIONE PER STATO DI PERICOLO:stato di pericolo è la condizione del soggetto che
contrae per la necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona 1447)
I requisiti sono dunque l'attualità del pericolo, la gravità e la relazione alla persona non ai beni
patrimoniali ( non è richiesto che il pericolo sia reale, può essere anche putativo) e l'iniquità delle
condizioni contrattuali ossia la sproporzione tra l'entità delle 2 prestazioni che cmq la controparte
può riequilibrare con la rettifica
RESCISSIONE PER STATO DI BISOGNO: lo stato di bisogno è la condizione di seria difficoltà
economica in cui versa una parte: per la rescissione del contratto occorrono anche la lesione e
l'approfittamento della controparte: la lesione è una sproporzione tra le 2 prestazioni ben precisata e
cioè una delle prestazioni deve valere più del doppio dell'altra; l'approfittamento si realizza quando
l'altra parte è consapevole dell'altrui difficoltà e trae vantaggio da questa situazione.
www.unictblog.com 73
Scaricato da Giovanni Porta (portagiovanni358@gmail.com)
lOMoARcPSD|7648598
14
CAP 36 EFFETTI DEL CONTRATTO (pagg 378-388)
Nel momento in cui il contratto è perfezionato o concluso, i soggetti che lo hanno stipulato sono
tenuti (in quanto il contratto ha forza di legge tra le parti: art 1372) a subirne gli effetti che
consistono nel “costituire, modificare o estinguere un rapporto giuridico” (art 1321).
Gli effetti vanno distinti in fondamentali e finali.
--effetti fondamentali sono i vincoli COMUNI A OGNI CONTRATTO che salvaguardano e
garantiscono gli interessi di tutte le parti: cioè in tutti i contratti esiste il divieto di scioglimento
unilaterale e l'obbligo per le parti di conservare integre le ragioni della controparte
--effetti finali o tipici che variano in relazione al tipo di contratto e salvaguardano un interesse
specifico: ad es effetto tipico della permuta è uno scambio di beni.
Si può osservare che mentre gli effetti finali possono essere modificati dalle parti (ad es si possono
rinviare nel tempo), per gli effetti fondamentali ciò non è possibile.
A seconda degli effetti finali si distinguono contratti a effetti obbligatori e contratti a effetti reali:
--contratti a effetti obbligatori comportano obblighi per una o ambedue le parti: ma praticamente
tutti i contratti determinano effetti obbligatori, necessari per conseguire l'interesse comune.
--contratti a effetti reali producono l'immediata attribuzione del diritto alla controparte:es basta il
semplice consenso per trasferire immediatamente la proprietà di una cosa determinata cioè ben
specificata: non occorre nemmeno la consegna della cosa, per cui ad es se compro un quadro in una
galleria d'arte ripromettendomi di portarlo a casa il giorno successivo e durante la notte il quadro
viene rubato, dovrò ugualmente pagarlo. Si faccia attenzione che per avere l'immediata attribuzione
del diritto occorre che il bene sia ESISTENTE e INDIVIDUATO: la individuazione del bene si
ottiene con la SEPARAZIONE del bene, cioè non basta dire al venditore che compro 100 Kg di
pesche, occorre scegliere le cassette e metterle da parte e in tale preciso momento “quelle” pesche
sono mie;se questo non succede, la individuazione avverrà nel momento in cui la merce mi sarà
consegnata e sarà questo il momento in cui la merce sarà mia a tutti gli effetti; questo vuol dire che
se durante il trasporto la merce viene rubata, ne risponde il venditore.
Nel caso di beni non esistenti (una casa ancora da costruire) la proprietà non viene trasferita
immediatamente ma quando la casa sarà costruita: la legge parla in questi casi di vendita con effetti
obbligatori nel senso che con il contratto l'acquirente si impegna a comprare la casa e il costruttore a
costruirla.
Un'altra distinzione riguarda il MODO con cui si conclude il contratto: la regola generale, come
abbiamo visto, è che basta il consenso delle parti (contratti consensuali); ma i cd CONTRATTI
REALI per la loro conclusione, invece richiedono tassativamente la consegna materiale della cosa :
ad es per il comodato non basta il semplice consenso ma occorre la consegna del bene.
LO SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO CONTRATTUALE : IL RECESSO
Una volta che si è instaurato il rapporto contrattuale, esso può essere sciolto solo per accordo tra le
parti; può anche sciogliersi con atto unilaterale (il recesso) se previsto nel contratto o se stabilito
dalla legge.
L'accordo tra le parti cd mutuo dissenso, consiste in un vero e proprio contratto diretto a estinguere
il precedente negozio e come tale è necessaria la stessa forma del contratto che si vuole estinguere
( ma per il preliminare di vendita la legge permette l'accordo verbale e la distruzione della scrittura
privata).
Il recesso è invece un atto unilaterale recettizio con il quale si esercita il diritto potestativo di
sciogliere il rapporto, diritto che deve essere previsto dal contratto ( con eventuali condizioni,
caparra, multa penitenziale ecc) o, in alcuni casi, dalla legge ( ad es scioglimento da parte del datore
di lavoro di contratto di lavoro subordinato, per giusta causa): il recesso può essere esercitato finchè
il contratto non ha avuto inizio di esecuzione ( salvo i contratti di durata)
Il codice del consumo prevede il diritto di recesso anche per i contratti stipulati al di fuori dei locali
commerciali (es vendite porta a porta) nel presupposto che il cliente potrebbe essere in qualche
www.unictblog.com 74
Scaricato da Giovanni Porta (portagiovanni358@gmail.com)
lOMoARcPSD|7648598
15
modo indotto a comprare impulsivamente: il compratore ha il diritto di essere informato per iscritto
sull'esistenza del diritto di recesso che può essere esercitato entro 10 giorni lavorativi: analoga la
disciplina per i cd contratti a distanza cioè stipulati senza la presenza fisica e simultanea delle due
parti ( es tramite telefono o computer)
Lo scioglimento ha in genere effetti retroattivi: è come se il contratto non fosse mai esistito e le
prestazioni già eseguite dovranno essere restituite salvo che nei contratti a esecuzione continuata o
periodica (es un contratto di fornitura elettrica).
NOTA:la revoca è l'atto con cui si ritira un precedente atto unilaterale: ad es si revoca il testamento,
la procura ecc.
INTEGRAZIONE DEL CONTRATTO
A norma degli artt 1374 e 1375, il contratto obbliga le parti non solo a quanto è espresso nel
contratto ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo legge, usi, equità e buone fede:
--leggi: sono già state descritte altrove sia le norme dispositive (le disposizioni suppletive che
suppliscono a una mancata previsione contrattuale ad es le norme sui vizi della cosa) che quelle
cogenti cioè valide anche contro le disposizioni contrattuali (vedi inserzione automatica di clausole
in tema di affitti commerciali)
--usi: si riferiscono per lo + a clausole d'uso che, essendo sistematicamente inserite in determinati
tipi di contratto, tendono a diventare una consuetudine tanto da essere per così dire sottintese a
meno che non si decida espressamente per altro ( ad es è sottinteso che se compro un mobile, mi
venga portato a casa e montato)
--equità è un criterio di equilibrio dei sacrifici reciproci
--buona fede impone di salvaguardare l'altrui interesse nel limite in cui sia compatibile con il
proprio ( è giusto che l'assicuratore, al momento del rinnovo, mi avverta se il valore dell'oggetto da
assicurare è diminuito).
www.unictblog.com 75
Scaricato da Giovanni Porta (portagiovanni358@gmail.com)
lOMoARcPSD|7648598
16
CAP 37 IL CONTRATTO E I TERZI (pagg389-398)
Il contratto ha forza di legge tra le parti, ma rispetto ai terzi non produce nessun effetto diretto.
Ovviamente può produrre effetti indiretti: es se viene venduta la casa che io ho in locazione, dovrò
fare i conti col nuovo proprietario: in questo caso un contratto tra 2 soggetti provoca effetti indiretti
su un terzo.
Gli effetti diretti riguardano solo casi previsti dalla legge (art 1372):
--1)-CONFLITTO TRA PIU' ACQUIRENTI DI UNO STESSO DIRITTO
a)se oggetto del contratto è un bene immobile o mobile registrato: vale la trascrizione
b)se oggetto del contratto è un bene mobile: vale la regola possesso vale titolo
c)se oggetto del contratto è un'universalità di mobili: vale la priorità dell'acquisto
d)se oggetto del contratto sono i diritti reali di godimento: prevale chi per primo ha conseguito il
...godimento della cosa o chi ha un titolo di data anteriore.
e)se oggetto del contratto è un credito vale la cessione notificata per prima con data certa
--2)-CONTRATTO A FAVORE DI TERZI
Qui i contraenti prendono il nome di stipulante e promittente: per effetto di tale contratto, un
soggetto, estraneo al contratto stesso, acquista il diritto di pretendere una prestazione dal
promittente: l'esempio classico è l'assicurazione sulla vita a favore di un terzo; il terzo ossia il
beneficiario rimane estraneo al rapporto contrattuale, può solo fare una dichiarazione di
accettazione con la quale rende irrevocabile la prestazione a suo favore (fino a tale momento lo
stipulante può cambiare beneficiario); il promittente da parte sua è tenuto a eseguire quanto
promesso e può opporre al terzo ad es il fatto di non aver ricevuto il prezzo pattuito.
--3)-IL CONTRATTO SIMULATO
Si parla di simulazione quando le parti fingono di stipulare un contratto ma in realtà o non ne
vogliono gli effetti (simulazione assoluta) oppure vogliono effetti diversi (simulazione relativa).
Un esempio di simulazione assoluta potrebbe essere quando le parti stipulano una vendita ma né il
venditore (simulato alienante) vuole realmente vendere, né il compratore (simulato acquirente)
vuole realmente comprare: le parti allora oltre alla dichiarazione di vendita ne emettono
contestualmente un'altra in cui dichiarano la loro vera volontà.
Un esempio di simulazione relativa è quella per cui in un contratto di locazione dichiarano un certo
prezzo pattuito e in una controdichiarazione si specifica che il prezzo pattuito è un altro.
Le ragioni della simulazioni possono essere varie, lecite o no ( nell'esempio del prezzo, le ragioni
sono di natura fiscale); se sono illecite l'atto sarà nullo (ma nella simulazione del prezzo l'atto sarà
valido ma si applicheranno sanzioni tributarie); se invece le ragioni sono lecite, il negozio simulato
produrrà gli effetti voluti realmente e cioè , negli esempi precedenti, il bene resterà del proprietario,
il prezzo della locazione sarà quello realmente pattuito nella controdichiarazione.
Qualora il simulato acquirente ad es volesse approfittare della situazione (tenendo per sé il bene) il
simulato alienante (senza limiti di tempo per la simulazione assoluta; entro 5 anni per la
simulazione relativa) può agire in giudizio per far dichiarare la simulazione, ossia per far dichiarare
al giudice i reali effetti voluti dalle parti: la simulazione deve essere provata per iscritto.
Si ha simulazione anche in caso di INTERPOSIZIONE FITTIZIA DI PERSONA: ad es stipulo una
donazione a favore di Tizio ma in realtà, con l'accordo di tutti gli interessati, il mio intendimento è
di beneficiare Caio il quale sarà l'effettivo titolare dei diritti attribuiti con la donazione.
In ogni caso con la simulazione si crea una apparenza valida per i terzi che nasconde una realtà
diversa: quindi un terzo facendo affidamento su quello che appare, potrebbe compiere degli atti che
poi risulteranno svantaggiosi, quindi deve essere in qualche modo tutelato e in effetti lo è ,con
alcune regole:
-1--i terzi possono far valere la simulazione quando pregiudica i loro diritti : ad es io inquilino
www.unictblog.com 76
Scaricato da Giovanni Porta (portagiovanni358@gmail.com)
lOMoARcPSD|7648598
17
posso oppormi allo sfratto del simulato acquirente, rilevando che egli non è il proprietario
-2-- il cd principio di apparenza: coloro che, senza colpa, hanno fatto affidamento su una situazione
apparente, mantengono i diritti acquisiti su tale base: se ho acquistato un immobile dal simulato
acquirente senza sapere che in realtà non era il proprietario, rimango proprietario ferme restando le
regole sulla trascrizione (della domanda giudiziale): vengono quindi tutelati i terzi che abbiano
acquistato in buona fede, a titolo oneroso, e che abbiano trascritto prima della trascrizione della
domanda giudiziale.
-3—anche per i creditori vale la regola 1, cioè possono far valere la simulazione di vendita e quindi
rifarsi sulla vendita del bene; una situazione curiosa si ha quando ci sono 2 categorie di creditori,
quelli del simulato alienante (che hanno interesse a far dichiarare la simulazione) e quelli del
simulato acquirente (che hanno interesse a mantenere la situazione apparente): l'art 1416 dispone
che i creditori dell'alienante hanno la precedenza perchè il loro credito esisteva quando ancora
l'alienante era titolare dei beni poi fittiziamente alienati
--4)-IL CONTRATTO FIDUCIARIO
Se temendo una confisca dei miei beni li vendo ad un amico con l'intesa che li trasferirà a un mio
parente, si ha un contratto fiduciario (fiducia cum amico); ugualmente quando vendo a un creditore
con l'intesa che mi restituirà il bene una volta saldato il mio debito (fiducia cum creditore);
qui, a differenza del contratto simulato, l'effetto è realmente voluto, solo che è strumentale rispetto a
un fine ulteriore, quindi rientrerebbe nel cd uso indiretto del negozio: il negozio fiduciario è
ammesso dalla legge se è lecito lo scopo ( se no sarebbe un negozio in frode alla legge); nel caso in
cui il fiduciario ( l'amico o il creditore) non adempie l'impegno di ritrasferire il bene, il fiduciante
non potrà farselo restituire, potrà solo chiedere il risarcimento dei danni.
www.unictblog.com 77
Scaricato da Giovanni Porta (portagiovanni358@gmail.com)
lOMoARcPSD|7648598
18
CAP 38 LA RAPPRESENTANZA (pagg 399-410)
Abbiamo visto, a proposito delle parti, come esse possano essere distinte in parte in senso formale
(il soggetto che emette la dichiarazione negoziale) e parte in senso sostanziale (il soggetto su cui
cadono gli effetti); spesso i 2 soggetti coincidono, altre volte no, cioè la legittimazione (la facoltà di
disporre di un diritto) non coincide con la titolarità del diritto, basti pensare ai genitori che sono
legittimati ad amministrare i beni del minore.
La situazione più comune è la cd rappresentanza che è il potere attribuito a un soggetto detto
rappresentante, di compiere atti giuridici che producono effetti nella sfera di un altro soggetto detto
rappresentato: è un istituto generico, non ammesso solo per pochi atti personali ad es il matrimonio.
Si distinguono 2 forme di rappresentanza:
1)RAPPRESENTANZA DIRETTA in cui il rappresentante compie atti giuridici in nome e
nell'interesse del rappresentato che quindi, come parte sostanziale, assumerà tutti i diritti e gli
obblighi che nascono dal contratto;
2)RAPPRESENTANZA INDIRETTA (o interposizione gestoria) in cui il rappresentante agisce
nell'interesse altrui ma in nome proprio: quindi ad es acquista a nome proprio e poi dovrà
ritrasferire, con atto apposito, all'interessato.
Chi dà questi poteri al rappresentante?
La volontà privata (rappresentanza volontaria) oppure la legge (rappresentanza legale).
---rappresentanza legale è prevista dalla legge in alcuni casi ad es nell'incapacità legale.
NOTA: si parla comunemente di rappresentante legale anche a proposito di amministratori di enti
giuridici, ma il termine è improprio perchè l'amministratore non è un altro soggetto ma si identifica
con l'ente.
Il potere di rappresentanza è conferito nell'interesse del rappresentato, ma a volte anche
nell'interesse del rappresentante ( un soggetto può concedere ai suoi creditori il potere di vendere i
suoi beni per soddisfarsi sul ricavato)
---la rappresentanza volontaria è conferita all'interessato con un apposito negozio, la procura o
delega: essa è un atto unilaterale che non richiede l'accettazione e che ha lo scopo di far conoscere
agli altri che il delegato può compiere atti giuridici in nome del delegante: questo documento di
delega deve essere esibito come prova, se richiesto da terzi.
La procura può essere SPECIALE,se conferita per singoli affari, o GENERALE se conferita per
tutti gli affari del delegante esclusi gli atti di straordinaria amministrazione non espressamente
indicati (es vendite patrimoniali)
Il potere di rappresentanza si estingue per revoca (sempre possibile tranne che il potere è conferito
anche nell'interesse del rappresentante), per l'estinzione dei rapporti tra rappresentante e
rappresentato, la sopravvenuta incapacità, il compimento dell'affare.
Oltre a questi aspetti esterni, bisogna analizzare anche gli aspetti interni e cioè il rapporto tra
rappresentante e rappresentato:
---Nella rappresentanza legale il rappresentante deve essere capace di agire mentre in quella
volontaria è il rappresentato che deve avere tale capacità ( il rappresentante potrebbe anche non
averla, basta che abbia capacità di intendere e volere ad es un minore è in grado di fare piccole
spese in nome e per conto dei genitori e il contratto è valido); ovviamente gli eventuali vizi della
volontà riguarderanno il rappresentante.
---Se il rappresentante, invece di perseguire l'interesse del rappresentato, tutela il suo o quello di
terzi, si parla di CONFLITTO DI INTERESSI, ritenuto illecito dalla legge per cui un contratto è
annullabile, a patto che l'altro contraente ne fosse a conoscenza, e non importa se la vendita sia stata
fatta al giusto prezzo, basta che il rappresentante si trovi nella situazione di conflitto;
RAPPRESENTANZA SENZA POTERE (art 1398) è il caso di chi agisce come rappresentante
senza esserlo, cd falso rappresentante, oppure il caso del rappresentante che va oltre il limite del
mandato (ad es ha il potere di locare e invece vende): il contratto eventualmente stipulato è
www.unictblog.com 78
Scaricato da Giovanni Porta (portagiovanni358@gmail.com)
lOMoARcPSD|7648598
inefficace, cioè non produrrà effetti, ma non è nullo perchè la legittimazione a compiere l'atto non è
un requisito essenziale e ,d'altra parte, la legittimazione può avvenire successivamente: è possibile
infatti, che l'interessato ratifichi, cioè approvi (anche tacitamente) l'atto che acquista efficacia con
effetto retroattivo. Cmq il falso rappresentante è responsabile dei danni sofferti dall'altro contraente
(terzo) che abbia confidato senza colpa nella validità del contratto.
IL CONTRATTO PER PERSONA DA NOMINARE
E' un contratto in cui una parte si riserva la facoltà di nominare successivamente il soggetto su cui
cadranno gli effetti del contratto stesso: se, nel termine stabilito, viene effettuata la dichiarazione di
nomina accompagnata contestualmente dall'accettazione del nominato, il contratto produrrà i suoi
effetti in capo al designato fin dal momento della conclusione del contratto; in caso contrario gli
effetti ricadranno su chi ha stipulato; si tratta di una clausola spesso usata nei preliminari di vendita
o nelle aste quando l'interessato non vuole comparire: si parla anche di rappresentanza eventuale di
persona incerta: eventuale in quanto se manca la nomina o l'accettazione, la rappresentanza non c'è;
persona incerta in quanto chi stipula non dice per conto di chi.
La dichiarazione di nomina deve essere fatta entro 3 giorni salvo accordo diverso ( passati 3 giorni
scatta una doppia imposizione fiscale come se ci fosse un doppio trasferimento); essa, al pari
dell'accettazione è un atto unilaterale recettizio, soggetto agli stessi requisiti di forma e di pubblicità
previsti per il contratto
LA CESSIONE DEL CONTRATTO
E' il negozio con cui una parte, col consenso dell'altra, sostituisce a sé un terzo nei rapporti derivanti
da un contratto a prestazioni corrispettive (art 1406): ad es cedo al nuovo inquilino il contratto di
fornitura del gas. La cessione del contratto non è un contratto tipico, e la sua disciplina ricalca
quella dettata per la cessione del credito salvo che qui non viene ceduto solo il lato attivo bensì
l'intera posizione contrattuale e perciò anche le obbligazioni.
I soggetti del negozio prendono il nome di cedente (colui che cede la propria posizione contrattuale
e che esce dal contratto), ceduto( il contraente originario che rimane vincolato) e il cessionario (il
nuovo soggetto)
Secondo gli orientamenti attuali, si tratterebbe di un contratto plurilaterale, occorrendo per la sua
validità il consenso del contraente ceduto che di solito viene dato preventivamente (ad es l' ENEL
nei suoi contratti prevede la possibilità di cessione del contratto) ; la cessione non ha effetto
retroattivo e, trattandosi di contratti di durata, restano ferme le prestazioni già eseguite.
Il cedente è tenuto a garantire verso il cessionario la validità del contratto trasferito non il suo
adempimento; il cedente è liberato dalle sue obbligazioni verso il ceduto; i rapporti tra ceduto e
cessionario sono regolati dal contratto che rimane invariato (il nuovo inquilino sarà obbligato verso
l'azienda del gas alle stesse condizioni): l'azienda del gas potrà sospendere la fornitura ove siano
rimaste insolute bollette arretrate del cedente (inadempimento), ma non può richiederne il
pagamento al cessionario.
Accanto alla cessione negoziale, ci sono numerosi casi di cessione legale, cioè è la legge che
determina il trasferimento AUTOMATICO del rapporto contrattuale da un soggetto a un altro: es
trasferimento dell'assicurazione della cosa venduta.
IL SUBCONTRATTO
Con il subcontratto si dà vita a un nuovo contratto derivato da quello precedente che continua a
sussistere tra le parti originarie, ad es l'inquilino che subloca a un altro in tutto o in parte: qui uno
dei contraenti originari utilizza la sua posizione contrattuale per stipulare un nuovo contratto con un
terzo; entrambi i contratti rimangono fermi e ciascuno risponde esclusivamente verso il proprio
contraente (l'inquilino paga il proprio locatore e dovrà farsi pagare dal sublocatario.
La tendenza attuale è comunque quella di limitare questo tipo di contratti.
www.unictblog.com 79
Scaricato da Giovanni Porta (portagiovanni358@gmail.com)
lOMoARcPSD|7648598
20
CAP 39 L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO : RISOLUZIONE (pagg 411-419)
Esecuzione del contratto significa che le obbligazioni in esso previste, devono essere adempiute:
così ad es il venditore deve consegnare la cosa, garantire che sia esente da vizi ecc, l'acquirente da
parte sua deve ricevere la cosa, pagarne il corrispettivo ecc.
Che cosa succede se le prestazioni contrattuali (o parte di esse) non vengono adempiute?
In tal caso interviene la legge che prevede degli istituti volti a tutelare il contraente fedele:
--la cd ECCEZIONE DI ADEMPIMENTO prevede che ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di
adempiere la sua obbligazione se l'altro non adempie la propria: in sostanza se le prestazioni dovute
sono in rapporto reciproco (sinallagma contrattuale: io pago il bene e il venditore me ne trasferisce
la proprietà), mancando una di queste prestazioni, l'altra non ha più ragione di esistere.
Questa facoltà tuttavia può essere esclusa con la clausola “solve et repete”, (frequente nei contratti
standard conclusi mediante moduli: contratti energia elettrica, telefono ecc) che significa prima
paghi poi chiedi, cioè non si può rifiutare il pagamento di una bolletta telefonica adducendo che c'è
un errore di conteggio: solo dopo aver pagato si potranno far valere le proprie ragioni; questa
clausola (che cmq deve essere sottoscritta a parte) è oggi espressamente inclusa tra le clausole
abusive con conseguente inefficacia (art 33 codice del consumo)
--la SOSPENSIONE DELLA PRESTAZIONE prevede che ciascun contraente può sospendere
l'esecuzione della sua prestazione se le condizioni patrimoniali dell'altro (ad es sull'orlo del
fallimento) sono divenute tali da porre in pericolo l'adempimento della sua prestazione.
Questi due rimedi sono evidentemente temporanei: se l'inadempimento si protrae nel tempo, il
contraente fedele ha due possibilità di tutela:
1)la MANUTENZIONE DEL CONTRATTO che consiste nel chiedere al giudice di condannare il
contraente a eseguire il contratto eventualmente con esecuzione forzata se questa è possibile; la
richiesta di manutenzione non preclude il ricorso alla risoluzione;
2)la RISOLUZIONE: è lo scioglimento del contratto per cause SUCCESSIVE alla sua stipulazione
(mentre invece l'annullamento consegue a cause sorte DURANTE la formazione del contratto)
Ha efficacia retroattiva SOLO tra le parti, non pregiudica quindi i diritti dei terzi,ferma restando la
regola sulla trascrizione della domanda giudiziale: ad es se compro un bene e il contratto si risolve
per inadempimento del venditore che non me lo ha consegnato, è come se il venditore non avesse
mai perso la proprietà del bene e mi spetta il risarcimento (danno emergente e lucro cessante): se,
nel frattempo, il venditore ha venduto il bene a un terzo, questi mantiene il suo acquisto a meno che,
in caso di bene immobile o mobile registrato, io non abbia provveduto ad effettuare la trascrizione
della domanda giudiziale.
Si distinguono 3 tipi di risoluzione:
1)RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO
E' lo scioglimento dovuto all'inadempimento imputabile a uno dei contraenti: in questo caso occorre
che l'inadempimento sia grave cioè di non scarsa importanza: come già detto, di fronte
all'inadempimento il contraente fedele può chiedere la manutenzione o la risoluzione: chiesta la
manutenzione può sempre richiedere successivamente la risoluzione, ma se chiede la risoluzione
non può più chiedere la manutenzione.
Può essere distinta in 2 tipi:
A)RISOLUZIONE GIUDIZIALE: il giudice emana la sentenza costitutiva di scioglimento del
contratto che si verifica al momento della pronuncia
B)RISOLUZIONE DI DIRITTO O AUTOMATICA, può aversi per:
---diffida ad adempiere: se voglio evitare le spese di una lite giudiziaria, posso inviare alla parte
inadempiente per iscritto, una intimazione ad adempiere entro un limite di tempo congruo (almeno
15 gg) con l'avvertenza che, in caso contrario, il contratto si intenderà risolto di diritto
---termine essenziale:il contratto si risolve automaticamente anche in caso di tardivo e INUTILE
adempimento (ad es il sarto non mi consegna in tempo il vestito di nozze): a meno che non si
www.unictblog.com 80
Scaricato da Giovanni Porta (portagiovanni358@gmail.com)
lOMoARcPSD|7648598
comunichi alla controparte di volersi ancora avvalere della prestazione.
---clausola risolutiva espressa: quando nel contratto è presente la clausola che prevede l'automatica
risoluzione del contratto in caso di inadempimento di una delle parti (ma deve essere un
inadempimento ben specificato nel contratto, non generico ad es un colore, una qualità ecc): in
questi casi basta che la parte interessata comunichi all'altra di volersi avvalere della clausola e da
quel momento il contratto è risolto.
2)RISOLUZIONE PER IMPOSSIBILITA' SOPRAVVENUTA
L'impossibilità sopravvenuta della prestazione è causa di risoluzione AUTOMATICA E
IMMEDIATA del contratto e non dà luogo a risarcimento del danno (perchè non c'è colpa) ma al
rimborso ad es se un concerto non si fa ho diritto al rimborso del biglietto
3)RISOLUZIONE PER ECCESSIVA ONEROSITA'
La risoluzione può avvenire quando eventi eccezionali e imprevedibili alterino l'originario
equilibrio di valore delle due prestazioni rendendone una eccessivamente onerosa: ad es se ho
stipulato un contratto di fornitura di gasolio e il prezzo lievita notevolmente, posso chiedere la
risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta.
Allo scopo di evitare speculazioni, la legge ha stabilito precise condizioni (art 1467):
a)deve trattarsi di contratti a esecuzione differita o, in caso di contratti continuati, di prestazioni
future: in altre parole si può chiedere la risoluzione per gli adempimenti futuri, che non sono ancora
stati fatti, anzi che non sono stati nemmeno iniziati (se lo sono, la risoluzione non è ammessa)
b)occorre che l'onerosità sia notevole cioè tale da superare i normali rischi per cui la svalutazione
monetaria ad es non è considerata una onerosità eccessiva
c)l'onerosità deve essere dovuta ad eventi straordinari e imprevedibili
Ricorrendo tali condizioni, la parte pregiudicata può chiedere la risoluzione, ma la controparte può
evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto, ristabilendo così l'equilibrio
di valore delle prestazioni (è la cd rettifica).
www.unictblog.com 81
Scaricato da Giovanni Porta (portagiovanni358@gmail.com)
lOMoARcPSD|7648598
22
I SINGOLI CONTRATTI
CAP 46 INTRODUZIONE
Il libro IV del codice civile, titolo III regola i singoli contratti cioè i cd contratti tipici o nominati
che hanno una speciale considerazione da parte della legge in virtù della loro frequenza e rilevanza
nella pratica degli affari (cmq molti di questi contratti nominati sono collocati in altri libri ad es la
donazione trova posto nel libro dedicato alle successioni).
Da notare che ai singoli contratti si applica sia la disciplina generale (relativa ai caratteri comuni ai
diversi contratti) sia la regolamentazione specifica per ciascun tipo, e quindi sorge il problema di
combinare le diverse regole, adattandole di volta in volta al singolo contratto, fermo restando che, in
caso di contrasto, la lex specialis prevale sulla lex generalis.
Ma prima di applicare le regole, bisogna capire che tipo di contratto abbiamo davanti, ossia
procedere alla INTERPRETAZIONE del contratto che consiste nell'accertare quale sia la reale e
comune intenzione delle parti (interpretazione soggettiva); per far questo si usano i criteri letterale,
globale, sistematico, restrittivo o estensivo (come già visto nell'interpretazione della legge
modulo1°).
Qualora con tali criteri il contratto rimane ancora oscuro, si utilizzerà l'interpretazione OBIETTIVA
basata sul principio di conservazione (meglio interpretare una clausola in modo che abbia effetto
anziché interpretarla in modo che non abbia nessun effetto) e sugli usi del luogo.
Ricostruito così il significato del contratto, si può procedere alla sua QUALIFICAZIONE cioè alla
individuazione del modello cui riferirsi e quindi della disciplina che si può applicare ad esso,
sempre tenendo conto che si tratta di operazioni a carattere economico.
Naturalmente, se con questo tipo di procedimento non è possibile ricondurre l'accordo contrattuale a
un contratto tipico, si dovrà concludere che si tratta di un contratto atipico (o + frequentemente
misto).
www.unictblog.com 82
Scaricato da Giovanni Porta (portagiovanni358@gmail.com)
lOMoARcPSD|7648598
23
CAP 47 I CONTRATTI DI ALIENAZIONE DEI BENI (pagg 485-498)
LA VENDITA
E' il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un
altro diritto, da un soggetto a un altro a titolo oneroso cioè a fronte della corresponsione di una
somma di denaro o prezzo (e in ciò si distingue dalla permuta).
CAUSA della compravendita è il trasferimento della titolarità di un diritto
OGGETTO del contratto è un diritto reale o di credito, che può riguardare qualsiasi bene, materiale
o immateriale, mobile o immobile.
Il contratto è chiamato consensuale in quanto si conclude col semplice consenso e il trasferimento
di proprietà si realizza immediatamente senza bisogno della consegna della cosa.
Si possono avere anche tipi particolari di vendite, le cd vendite a effetti obbligatori, in cui la
conclusione del contratto non comporta l'immediato trasferimento della proprietà ma l'obbligo per il
venditore di procurare l'acquisto al compratore; esse sono:
1)la vendita di cose future, cose cioè che ancora devono venire in esistenza es i frutti che voglio
comprare prima che nascano: qui il venditore si obbliga a procurare l'acquisto in capo al compratore
e la proprietà si trasferisce quando la cosa viene ad esistenza; nel frattempo il venditore deve
svolgere il suo compito con diligenza media e cioè il coltivatore deve curarsi delle piante, in caso
contrario risponderà di inadempimento; se nonostante la diligenza media la cosa non viene ad
esistenza il contratto è nullo a meno che il compratore non si addossi il rischio e in tal caso pagherà
anche se la cosa non viene in esistenza
2)la vendita di cosa altrui: qui la cosa esiste ma chi la vende non ha il titolo di proprietà e si obbliga
a procurare la vendita in capo al compratore ( mi obbligo a farti avere quel terreno perchè sono
sicuro di convincere il proprietario): se non ci riuscirà sarà inadempiente e dovrà risarcire anche i
danni
3)la vendita di cose generiche: cose generiche sono cose individuate solo nel genere ad es acquisto
da un grossista 100 Kg di arance: il trasferimento di proprietà qui avviene nel momento della
cosiddetta INDIVIDUAZIONE cioè nel momento in cui la cosa si determina esattamente ( cioè
QUESTI 100 Kg di arance) e nella pratica ciò avviene quando le arance sono consegnate al vettore
( quindi, se le arance si perdono in seguito a un incidente stradale mentre me le stanno portando, io
non devo pagare)
4)la vendita alternativa: si ha quando il trasferimento si riferisce a 2 cose tra le quali scegliere: il
trasferimento si realizza nel momento in cui viene effettuata la scelta (vedi anche obbligazioni
alternative): è considerata un atto negoziale, a differenza della individuazione che è un atto
giuridico in senso stretto, perchè la scelta determina l'oggetto stesso del contratto che rappresenta un
interesse sostanziale del compratore.
LE OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE
Per l'art 1476 esse sono:
1)Consegna della cosa al compratore, compresi accessori, pertinenze e frutti nel luogo dove essa si
trova al momento del contratto
2)far acquistare la proprietà della cosa nel caso di vendita a effetti obbligatori
3)GARANZIA PER EVIZIONE: obbligo del venditore è il trasferimento della PIENA titolarità del
diritto, cioè trasferire un diritto che non possa essere contestato da terzi:
--nel caso in cui il terzo dimostri di essere titolare del diritto (con la rivendica), il bene gli sarà
restituito (evizione totale) e il compratore, chiamando in causa il venditore (cd denunzia della lite),
può chiedere la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno comprendente il prezzo pagato
+ le spese sostenute
--nel caso di evizione parziale, in cui il terzo dimostri di essere proprietario solo di una parte del
bene oppure abbia qualche altro diritto (servitù, usufrutto,ipoteca ecc), il compratore ha diritto alla
www.unictblog.com 83
Scaricato da Giovanni Porta (portagiovanni358@gmail.com)
lOMoARcPSD|7648598
risoluzione del contratto solo se si ritiene che non l'avrebbe mai comprata sapendo che era gravata
da diritti altrui: in caso contrario può chiedere solo una riduzione del prezzo, salvo sempre il
risarcimento del danno.
4)la garanzia per i vizi della cosa (presenti già al momento della consegna), sia i difetti strutturali
sia quelli funzionali, a patto che:
----siano vizi di un certo rilievo tali da rendere la cosa inservibile all'uso o da diminuirne
notevolmente il prezzo: vengono chiamati vizi redibitori e consentono la restituzione della cosa e il
rimborso del prezzo pagato
---siano vizi occulti cioè non conosciuti né facilmente riconoscibili da parte del compratore salvo
che il venditore abbia dichiarato falsamente che la cosa era esente da vizi.
In ogni caso il compratore che vuole avvalersi della garanzia ha l'onere di effettuare la denuncia dei
vizi al venditore entro 8 gg dalla consegna se si tratta di vizi apparenti, dalla scoperta se si tratta di
vizi occulti, pena la decadenza della garanzia: la prescrizione è di un anno a partire dal giorno della
consegna.
La garanzia offre al compratore 2 alternative a scelta:
---o la risoluzione del contratto con restituzione della cosa e rimborso del prezzo( actio redibitoria)
---o la riduzione del prezzo (actio aestimatoria)
In ambedue i casi c'è anche il risarcimento danni se il venditore non prova che ignorava senza colpa
i vizi della cosa.
La garanzia può essere esclusa su accordo tra le parti (vendo nello stato in cui si trova)ma tale
accordo è nullo se il venditore è in mala fede (cioè sapeva del vizio).
Ci sono altri due casi di inadempimento del venditore:
--il caso in cui la cosa venduta non ha le qualità promesse( ma parte della dottrine tende ad
assimilare questi casi ai vizi della cosa)
--il caso della vendita di cosa diversa in cui ha caratteristiche tali da poter essere considerata un
bene diverso da quello pattuito: in tal caso si può risolvere il contratto senza i termini di decadenza
e prescrizione previsti per i vizi.
LE OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE
Obbligo fondamentale è il pagamento del prezzo: il prezzo è liberamente fissato dalle parti o in
mancanza di accordo da un terzo nominato dalle parti o dal giudice; abbiamo già visto l'intervento
della legge al fine di stabilire il giusto prezzo ( riferimento a listini, tariffe professionali ecc)
Si ricordi che la mancata fissazione del prezzo è motivo di nullità del contratto.
Il corrispettivo per il trasferimento di proprietà oltre che da una somma di denaro può essere
costituito dalla cessione di un altro bene o di altri diritti; si realizza così la cd permuta che è un tipo
di contratto autonomo, distinto dalla vendita ma regolato per gran parte dalla disciplina delle
vendite.
TIPI PARTICOLARI DI VENDITA
-1)VENDITA CON PATTO DI RISCATTO in cui il venditore si riserva il diritto di riavere la
proprietà della cosa venduta mediante restituzione del prezzo: si tratterebbe quindi di una vendita
immediatamente efficace ma sottoposta a condizione risolutiva costituita dalla dichiarazione
unilaterale del venditore riscattante, mentre il compratore è in uno stato di mera soggezione( nulla
deve fare e nulla può fare) : l'effetto è di tipo retroattivo reale e il riscatto travolge i diritti
eventualmente acquisiti da terzi, salve le regole della trascrizione o del possesso titolato; il riscatto
deve esercitarsi entro 2 anni per i mobili e 5 anni per gli immobili, allo stesso prezzo con nullità per
l'eccedenza.
Alcuni assimilano il riscatto a una opzione d'acquisto.
Il patto di retrovendita invece, obbliga il compratore a rivendere al venditore ed è in sostanza una
specie di preliminare di vendita
-2)VENDITA CON RISERVA DI PROPRIETA': un es è la vendita a rate in cui il venditore, a
garanzia del pagamento integrale del prezzo, si riserva la proprietà fino al pagamento dell'ultima
rata: si deve sottolineare subito che l'effetto di riserva della proprietà non è conseguenza automatica
della rateizzazione ma DEVE espressamente essere pattuito, in caso contrario valgono gli effetti
www.unictblog.com 84
Scaricato da Giovanni Porta (portagiovanni358@gmail.com)
lOMoARcPSD|7648598
ordinari della compravendita (ovvero il bene è di mia proprietà sin dall'inizio); nella vendita rateale
con riserva di proprietà c'è la convenienza sia del venditore (che può contare sul fatto che il
compratore non può disporre del bene a favore di terzi, se no sarebbe appropriazione indebita, e
inoltre in caso di inadempimento potrà riprenderlo senza ricorrere alla espropriazione forzata e
senza subire il concorso di altri creditori), sia del compratore che può entrare in possesso del bene
immediatamente e goderne liberamente anche se si assume il rischio connesso al perimento; a difesa
dell'acquirente, la legge prevede (art 1525) che il mancato pagamento di una sola rata che non
superi l'ottava parte del prezzo, non dà luogo alla risoluzione del contratto; e inoltre l'eventuale
risoluzione non esclude il diritto alla restituzione delle rate già pagate, salvi i diritti del venditore a
un equo compenso per l'uso della cosa.
-3)VENDITA DI IMMOBILI: si distingue in vendita a misura (prezzo a un tanto per unità di misura
es al mq, con possibilità di correzione successiva) e vendita a corpo (il bene è venduto a un prezzo
globale, forfettario con possibilità di correzione se una misura successiva accerti una differenza di
almeno 1 ventesimo rispetto a quella dichiarata).
E' nullo l'atto di compravendita in assenza della concessione edilizia ( e anche gli atti inerenti ai
diritti reali con esclusione dei diritti reali di garanzia e le servitù)
-4)VENDITA DI BENI MOBILI: qui di particolare c'è:
-- in caso di inadempimento è prevista una particolare procedura di esecuzione coattiva: il
contraente fedele può far comprare o vendere la cosa ( a seconda che si tratti rispettivamente del
compratore o del venditore) e chiedere la differenza di prezzo oltre al danno
--si può ottenere la risoluzione di diritto tramite dichiarazione unilaterale (tipo diffida ad adempiere)
--si può ottenere la ripresa delle cose non pagate, purchè la domanda in giudizio venga fatta entro
15 gg dalla consegna;
--garanzia sui beni di consumo( artt128-135 cod.consumo): riguarda i contratti tra consumatori e
professionisti che hanno per oggetto beni di consumo (qualsiasi bene mobile tranne acqua, luce,
gas) non conformi al contratto (cioè che non corrispondono a quanto pattuito, che non
corrispondono a quanto detto dal venditore o a quello che c'è scritto sull'etichetta ecc. ):deve
trattarsi di vizi occulti ed esistenti al momento della consegna e che si manifestano entro 2 anni da
essa: fatta la denuncia entro 2 mesi dalla scoperta, il consumatore ha diritto alla riduzione del
prezzo o alla risoluzione del contratto o alla riparazione o alla sostituzione; l'azione si prescrive in
24 mesi + 2 mesi per la denuncia tot 26 mesi e non sono ammesse clausole che limitano tale diritto
ma solo quelle che offrano una tutela + ampia. La controparte è IL VENDITORE
--garanzia di buon funzionamento riguarda i difetti sopravvenuti ad es un guasto meccanico (ed è
quella che comunemente troviamo nelle confezioni ): la legge la prevede anche in mancanza di
patto espresso e in tal caso occorre la denuncia entro 30 gg dalla scoperta; prescrizione 6 mesi.: la
controparte qui è IL PRODUTTORE.
-5)Altre figure particolari di vendita sono:
-vendita con riserva di gradimento da parte del cliente che chiude il contratto con una dichiarazione
unilaterale
--vendita a prova, vendita su campione ecc.
www.unictblog.com 85
Scaricato da Giovanni Porta (portagiovanni358@gmail.com)
lOMoARcPSD|7648598
CAP 48 I CONTRATTI DI UTILIZZAZIONE DEI BENI (pagg 499-506)
LA LOCAZIONE
E' il contratto con cui una parte si obbliga a far godere all'altra una cosa mobile o immobile per un
dato tempo, verso un corrispettivo ( è un contratto consensuale a effetti obbligatori)
I soggetti sono: il locatore (il proprietario) che ricava un'utilità economica (canone) e il conduttore
(nel caso di immobili è l'inquilino) che ha la detenzione (NON il possesso) della cosa;
riguardo la durata, in relazione all'accordo tra le parti, possiamo avere:
--locazione a tempo determinato: alla scadenza il contratto si scioglie automaticamente senza
bisogno di disdetta, ma può aversi un tacito rinnovo per un uguale periodo, se il conduttore rimane e
il locatore non si oppone;
--locazione a tempo indeterminato, quando le parti non fissano una scadenza: in tal caso è la legge a
determinare il periodo e il contratto si rinnova tacitamente in mancanza di disdetta.
In relazione all'oggetto del contratto, la legge prevede diversi sottotipi di locazione a seconda del
tipo di bene, regolati da leggi speciali: così se si tratta di immobili urbani vale la legge 392/1978, se
si tratta di navi o aeromobili vale il codice di navigazione, se si tratta di beni produttivi ad es fondi
rustici vale la legge 203/1982 e si parla di affitto, ecc
Le obbligazioni del locatore sono (art 1575):
--consegnare la cosa in buono stato: in caso contrario si può richiedere la risoluzione o una
riduzione del canone
--mantenere la cosa in buono stato: eccettuate le spese di piccola manutenzione che spettano al
conduttore, tutte le altre sono a carico del locatore
--garantire il pacifico godimento della cosa locata: se il conduttore subisce MOLESTIE DI FATTO,
cioè molestie da parte di terzi che non riguardano i diritti sulla cosa ad es il vicino che occupa
semplicemente il mio posto macchina, egli è tenuto a difendersi da solo (ad es con la
reintegrazione); se il conduttore subisce molestie da parte di un terzo che pretende di avere diritti
sulla cosa (MOLESTIE DI DIRITTO) ad es il vicino che occupa il mio posto macchina affermando
che è il suo, il locatore è tenuto a garantirlo assumendo la lite giudiziaria dalla quale il conduttore
può escludersi con una semplice richiesta.
Le obbligazioni del conduttore (art 1587) sono:
--prendere in consegna la cosa e utilizzarla per l'uso convenuto: il conduttore non può cedere ad
altri il contratto senza consenso del locatore ma può sublocare (salvo diverso accordo) e in tal caso
il locatore può rifarsi sul subconduttore per canoni non pagati
--pagare il canone alle scadenze stabilite
--restituire la cosa, alla fine della locazione, nello stesso stato in cui si trovava quando l'ha ricevuta
salvo l'usura per il normale uso: per quanto riguarda le modifiche e migliorie eventualmente
apportate dal conduttore, se non sono state preventivamente approvate dal locatore, il conduttore
non ha diritto a indennità, anzi è tenuto alla asportazione se il locatore non vuole ritenerle.
LE LOCAZIONI URBANE
Sono disciplinate dalla legge 392/1978 (Equo Canone) nata con l'intento di calmierare il mercato
degli affitti e di assicurare una maggiore tutela ai conduttori, considerati parte debole del rapporto:
tale legge limitava considerevolmente il potere dei locatori in ordine alla durata del contratto e al
canone (non poteva superare il 3,85% del valore dell'immobile) con il risultato di ridurre il numero
degli alloggi disponibili sul mercato perchè i proprietari trovavano scarsa convenienza al contratto;
per questo motivo la legge è intervenuta successivamente, liberalizzando parzialmente la materia
del canone con le leggi 359/1992 e 431/1998 .
Tali leggi operano in primo luogo una distinzione tra locazioni abitative e non abitative.
LOCAZIONI ABITATIVE
Hanno ad oggetto immobili destinati a esigenze continuative di abitazione ( con esclusione di
abitazioni transitorie ad es per studio o vacanze, degli alloggi di edilizia pubblica, dele case di
particolare pregio): i contratti previsti sono di vario tipo:
www.unictblog.com 86
Scaricato da Giovanni Porta (portagiovanni358@gmail.com)
lOMoARcPSD|7648598
---contratti liberi nel canone e nella disciplina del rapporto, salvo che per la durata minima di 4
anni, automaticamente rinnovabili salvo disdetta del locatore (motivata da necessità abitative
proprie, ristrutturazione dell'immobile ecc)
---contratti agevolati o calmierati, stipulati su schemi contrattuali elaborati dalle organizzazioni dei
locatori e dei conduttori; godono di facilitazioni fiscali
---contratti di natura transitoria, consentono una durata ridotta del contratto per soddisfare esigenze
particolari quali ad es l'uso per ragioni di studio
---contratti a equo canone: sono i contratti stipulati prima della legge 341/1998 che restano in vigore
fino alla loro scadenza.
Le caratteristiche principali sono:
--possibilità di recesso unilaterale del conduttore se ricorrono gravi motivi
--divieto di sublocazione e di cessione del contratto (eccetto la successione del contratto a favore di
familiari conviventi, coniuge nei casi di morte del conduttore, divorzio e separazione)
LOCAZIONI NON ABITATIVE
Riguardano i locali destinati ad attività industriali, commerciali, artigianali e alberghiere.
Si caratterizzano per:
--durata non inferiore a 6 anni (9 per le attività alberghiere): se si pattuisce un termine inferiore esso
verrà sostituito di diritto: vedi inserzione automatica di clausole)
--facoltà di recessione unilaterale del conduttore
--tacito rinnovo del contratto se nessuno chiede disdetta ( ma il locatore può disdire solo per
specifici motivi)
--gli aumenti del canone annuale non possono superare il 75% dell' indice ISTAT
--divieto di sublocazione e di cessione del contratto (salvo che venga ceduta anche l'azienda)
--il conduttore ha diritto di prelazione sulla vendita
--per attività commerciali svolte a contatto con il pubblico, è prevista, alla fine della locazione, una
indennità per la perdita dell' avviamento.
IL LEASING
E' una figura contrattuale legalmente atipica che consiste nel contratto con cui una parte concede
all'altra il godimento di un bene verso un canone periodico e, inoltre l'opzione per l'acquisto del
bene alla fine del contratto: come si vede ci sono elementi della locazione, della vendita a rate e del
mutuo; il concedente-locatore è un operatore specializzato, di solito collegato a una banca o a una
società finanziaria, che, dopo la stipulazione del contratto di leasing, compra il bene dal fabbricante
e lo consegna al concessionario-conduttore: questi si obbliga a pagare i canoni pattuiti e assume i
rischi per la perdita del bene e alla scadenza potrà decidere se acquistare il bene o prorogare il
contratto o stipularne uno nuovo.
Una variante è il cd lease-back: qui il proprietario del bene (di solito un immobile) lo vende a una
società finanziaria ottenendone il corrispettivo e il diritto di godere del bene verso il pagamento di
un canone nonché la facoltà di riacquistarne la proprietà alla fine del rapporto: il senso
dell'operazione sta nell'autofinanziamento, cioè l'imprenditore che vende l'azienda, ne ricava un
capitale e contemporaneamente può continuare la normale attività e in seguito col riscatto può
tornare ad essere proprietario dell'azienda
IL COMODATO
E' il contratto con cui il comodante consegna al comodatario una cosa perchè se ne serva per il
tempo e l'uso determinati; è un contratto reale cioè si conclude con la consegna della cosa; è
essenzialmente gratuito (se ci fosse un corrispettivo sarebbe una locazione) tranne le spese ordinarie
necessarie per l'uso del bene; può essere collegato a un contratto oneroso (es l'apparecchio
telefonico fornito dall'azienda telefonica); il bene può essere immobile o mobile ma in ogni caso
deve essere inconsumabile (se no la restituzione sarebbe impossibile).
Il comodatario è tenuto a custodire la cosa con l'ordinaria diligenza e non può concederla in
godimento a terzi; la restituzione avviene alla scadenza del contratto.
www.unictblog.com 87
Scaricato da Giovanni Porta (portagiovanni358@gmail.com)
lOMoARcPSD|7648598
28
CAP 50 I CONTRATTI DI COLLABORAZIONE (pagg 518-526)
IL MANDATO
E' il contratto con cui una parte (detta mandatario) si obbliga a compiere uno o + atti giuridici per
conto dell'altra (detta mandante): caratteristico del mandato è il carattere giuridico e non materiale
dell'attività, quindi ad es stipulare un contratto.
Il mandato può essere con o senza rappresentanza:
--Mandato con rappresentanza è quello con cui il mandatario compie atti giuridici non solo
nell'interesse ma anche nel nome del mandante in capo al quale si produrranno immediatamente gli
effetti dell'atto
--Mandato senza rappresentanza è quello in cui il mandatario compie gli atti nell'interesse del
mandante ma in nome proprio per cui gli atti produrranno effetti in capo al mandatario: sarà poi il
mandatario, in esecuzione all'incarico, a ritrasferire i diritti acquistati al mandante con un successivo
contratto.
NOTA: il mandato è un CONTRATTO consensuale, bilaterale, ad effetti obbligatori, destinato a
produrre effetti solo tra le parti, che prevede l'obbligo di compiere atti giuridici: può essere gratuito
ma nel silenzio delle parti si presume oneroso, quindi ti pago tot perchè tu faccia questo.
La rappresentanza è invece un ISTITUTO GIURIDICO che attribuisce il potere di compiere atti che
si ripercuotono nella sfera di un altro soggetto, potere che nasce da un atto unilaterale (o dalla
legge) detto procura destinata a valere soprattutto nei confronti di terzi.
In caso di inadempimento da parte del mandatario:
--se si tratta di beni immobili o mobili registrati, il mandante dovrà chiedere l'esecuzione in forma
specifica dell'obbligo di ritrasferire il bene acquistato
--se si tratta di beni mobili, per esigenze di snellezza, il mandante può direttamente esercitare la
rivendica sia nei confronti del mandatario che del venditore ( come se fosse il proprietario: la
rivendica infatti è prerogativa del proprietario)
Il mandatario deve eseguire l'incarico con la ordinaria diligenza e deve informare correttamente il
mandante e consegnare le cose ricevute;
da parte sua il mandante deve fornire al mandatario tutti i mezzi necessari per svolgere il suo
compito, compreso il rimborso delle spese sostenute.
Il mandato si estingue per il compimento dell'atto, scadenza del termine, sopravvenuta incapacità
del mandante o del mandatario, per rinunzia del mandatario e per revoca del mandante: la revoca è
libera ma se il mandato era oneroso o irrevocabile, il mandante deve risarcire il danno.
La revoca non è ammessa nel mandato in rem propriam, quando cioè il mandatario ha qualche
interesse ad es quando è incaricato di vendere un bene e parte del ricavato va a lui.
IL FRANCHISING
La concessione di vendita è il contratto con cui un produttore di beni fornisce i propri prodotti ad
alcuni soggetti (detti concessionari), i quali si impegnano a rivenderli con la propria organizzazione
utilizzando il marchio del produttore; il concessionario quindi utilizza il marchio come elemento di
richiamo, il produttore si assicura la diffusione del proprio prodotto sul mercato senza le spese di
una propria organizzazione commerciale.
Il franchising è un ulteriore sviluppo della concessione di vendita, caratterizzato da un controllo più
stretto del produttore-concedente sul concessionario in ordine all'organizzazione aziendale,
pubblicità, arredamento, marketing.
Tale contratto oggi è disciplinato dalla legge 129/2004 che lo denomina affiliazione commerciale:
a garanzia dell'affiliato è imposta la forma scritta e l'obbligo di fornire una serie di informazioni,
tanto che esiste la possibilità di annullabilità del contratto per dolo in caso di false informazioni.
www.unictblog.com 88
Scaricato da Giovanni Porta (portagiovanni358@gmail.com)
lOMoARcPSD|7648598
29
CAP 54 LE DONAZIONI ( pagg 548-559)
La donazione, secondo l' art 769, è il contratto con cui una parte, per spirito di liberalità, arricchisce
l'altra tramite l'attribuzione di un diritto o l'assunzione di una obbligazione.
Si tratta quindi di un atto gratuito (nel quale cioè manca una controprestazione) caratterizzato dallo
spirito di liberalità. Occorre dunque distinguere tra atti di liberalità e atti che non costituiscono
liberalità:
per atto di liberalità si intende un atto diretto all'arricchimento disinteressato di un'altra persona,
senza altra motivazione se non la benevolenza. Quindi:
---atti che hanno uno scopo vengono esclusi: ad es i regali fatti dalle ditte a fini promozionali, i
regali connessi a doveri morali e sociali (perchè sarebbero adempimento di un'obbligazione
naturale) o a usi e convenzioni sociali, il comodato d'uso (perchè di solito collegato a un contratto
oneroso), l'atto di dotazione di una fondazione (perchè legato alla necessità di fornire mezzi
economici all'istituto);
--alcuni atti gratuiti come la remissione di un debito o il pagamento di un debito altrui, non
autorizzano a parlare di liberalità solo per la loro gratuità ma devono essere esaminati caso per caso:
in altre parole posso rimettere un debito per evitarmi ulteriori fastidi e questo non costituisce atto di
liberalità, lo è invece se lo faccio ad es perchè il mio debitore non è in floride condizioni
economiche ecc.
--altri atti sono liberali e gratuiti ma non possono definirsi donazioni perchè impiegano uno
strumento diverso: ad es se faccio un'assicurazione sulla vita a favore di un terzo faccio un atto di
liberalità che viene considerato, nel sentire comune, come una donazione ma giuridicamente non lo
è, è un negozio indiretto (sono i cd “atti diversi dalle donazioni che costituiscono cmq delle
liberalità”: vedi ultimo paragrafo del capitolo)
Tornando alla donazione, funzione o causa del contratto è lo spirito di liberalità, inteso come
arricchimento disinteressato della controparte: attenzione, questo non vuol dire che il motivo per cui
faccio la donazione sia irrilevante, anzi: il motivo illecito, ovviamente, è causa di nullità; l'errore sul
motivo (ad es faccio una donazione a favore di chi penso, erroneamente, mi ha salvato la vita) è
causa di annullabilità se si tratta di motivo determinante e risulti dall'atto; motivi rilevanti si
riscontrano nelle donazioni obnuziale e remuneratoria
Quanto al contenuto, sebbene l'arricchimento possa consistere nell'assunzione di una obbligazione,
purchè di dare, tuttavia è + frequente che consista nell'attribuzione di un diritto es la proprietà di un
fondo: la donazione avrà quindi effetti reali, immediatamente si trasferisce al beneficiario la
proprietà del fondo; è frequente che il donante si riservi l'usufrutto dell'immobile, usufrutto che può
essere anche riservato a terzi ma non successivamente (la successione dell'usufrutto è come
sappiamo vietata); non è ammessa la donazione di beni futuri o di beni altrui.
Stipulato il contratto, il donante è tenuto a eseguire la prestazione e sarà responsabile in caso di
inadempimento ( ma solo per dolo o colpa grave)
La DONAZIONE MODALE è la donazione gravata da un “modo” ossia un onere che il donatario
è obbligato ad eseguire: es dono il mio teatro ma dovrai periodicamente consentire l'accesso
gratuito agli studenti; l'onere non è un corrispettivo, deve essere lecito, possibile e rientrare nei
limiti di valore della donazione ( cioè il donatario non ci deve rimettere).
Se il modo non viene adempiuto può agire qualsiasi interessato (nell'es del teatro qualsiasi
studente), mentre la risoluzione può essere richiesta dal donante e dai suoi eredi solo se prevista
nell'atto.
Quanto alla FORMA, si deve rilevare che la donazione viene considerata come un contratto
bilaterale vero e proprio ( secondo il principio dell'autonomia per cui non è permesso entrare nella
sfera altrui senza il suo consenso) e come tale necessita di:
1)Atto pubblico con assistenza di 2 testimoni: il donante deve avere piena capacità di disporre dei
www.unictblog.com 89
Scaricato da Giovanni Porta (portagiovanni358@gmail.com)
lOMoARcPSD|7648598
propri beni ( non è ammesso il rappresentante legale in sostituzione dell'incapace)
2)Accettazione (che può avvenire anche dopo l'atto di donazione)da parte del donatario che può
anche essere un minore, un interdetto o inabilitato, un nascituro concepito o no; può essere il
coniuge o anche un ente dotato o no di personalità giuridica.
Essendo la donazione un contratto, si applicano le regole generali riguardanti validità ed efficacia
dei contratti: oltre a queste l'annullamento può essere pronunciato per incapacità naturale, per errore
sul motivo (che risulti dall'atto e sia determinante); la nullità si ha per donazioni su beni futuri, per
illiceità, per impossibilità del motivo o dell'onere;
Al fine di salvaguardare la volontà del donante la legge prevede la cd conferma delle donazioni
nulle per cui gli eredi che, conoscendo la causa di nullità, hanno dato conferma o dato esecuzione
alla donazione, dopo la morte del donante non possono far valere l'invalidità
La revoca della donazione può avvenire per fatti sopravvenuti : revoca per ingratitudine (quando il
donatario ha commesso gravi atti contro il donante o i suoi ascendenti e discendenti), revoca per
sopravvenienza di figli e anche per la condizione di riversibilità cioè la clausola secondo cui il bene
torna al donante in caso di premorienza del donatario e dei suoi eredi con efficacia retroattiva.
La revoca però non si opera con una dichiarazione unilaterale ma richiede una sentenza del giudice
e ha effetto a partire dall'emissione della stessa e non pregiudica i terzi che hanno acquistato dal
donatario (quindi a differenza della riversibilità, non c'è effetto retroattivo)
TIPI PARTICOLARI DI DONAZIONE
A seconda dei motivi si distinguono delle sottospecie di donazione tra le quali ricordiamo:
1)la donazione remuneratoria cioè quella fatta per riconoscenza o per meriti: in considerazione del
particolare motivo che la anima, il donante è tenuto alla garanzia per evizione e non può revocarla
2)la donazione obnuziale fatta per un futuro matrimonio a favore degli sposi o dei loro figli
nascituri: è unilaterale e non costituisce un contratto: è nulla se il matrimonio non viene celebrato
3)la donazione manuale è quella che ha come oggetto beni mobili di poco valore come elemosine,
erogazioni liberali a partiti, associazioni religiose ecc. Si perfeziona con la “tradizione” ossia con la
consegna materiale del bene: è quindi un contratto reale
4)le “liberalità d'uso” sono infine donativi ricorrenti nell'uso sociale es la mancia, i regali a parenti e
amici nelle ricorrenze, ma non sono considerate donazioni.
LE DONAZIONI INDIRETTE
Come abbiamo precedentemente visto, ci sono atti gratuiti che realizzano l'arricchimento del
beneficiario con spirito di liberalità tramite strumenti diversi dalla donazione (ad es la remissione di
un debito o la rinuncia a un usufrutto): fanno parte dei negozi indiretti ammessi dalla legge ( tranne
quelli che realizzano una frode alla legge): poiché tali atti realizzano un risultato analogo alla
donazione, essi sono soggetti alla revocazione e alle regole della riduzione delle donazioni che
abbiano leso la quota degli eredi legittimari.
Un accenno infine alla donazione mista o negotium mixtum cum donatione, che si ha quando si
acquista da un soggetto un bene per una cifra di molto superiore al prezzo di mercato o quando si
vende a un soggetto un bene per una cifra di molto inferiore: in ambedue i casi la sproporzione di
prezzo è conosciuta e voluta al fine di arricchire la controparte che accetta.
Già dalla denominazione (donazione e negotium, sono 2 cose che cozzano tra loro) si intuisce che la
sua classificazione è cosa ardua: infatti ha caratteri della donazione (ha spirito di liberalità ma non è
gratuita) e del negozio ( a condizioni che sarebbero inique): la tendenza è quella di applicare regole
diverse alle due “facce” del contratto.
La vendita “per una lira” è una donazione indiretta attuata per il tramite formale di un atto di
vendita.
www.unictblog.com 90
Scaricato da Giovanni Porta (portagiovanni358@gmail.com)
lOMoARcPSD|7648598
QUADRO RIASSUNTIVO
NULLITA' cause : a)mancanza requisiti essenziali (causa, oggetto, forma)
b)mancanza volontà (violenza fisica)
c)illiceità della causa
azione di nullità: a)automatica
b)spetta a chiunque abbia interesse
c)sentenza dichiarativa
effetti: come se il contratto non fosse stato mai stipulato
le prestazioni eseguite devono essere restituite
recupero: tramite conversione; nullità parziale
prescrizione: imprescrittibile
ANNULLABILITA' cause: a)incapacità di agire
b)vizi del consenso (errore, dolo, violenza psichica)
azione di annullamento:a)spetta alla parte debole
b)sentenza costitutiva
effetti: il contratto cade al momento della sentenza
effetto retroattivo tra le parti (le prestazioni effettuate vanno
restituite) e verso i terzi (tranne nell'incapacità legale)
recupero: convalida tacita o espressa
prescrizione: 5 anni
RESCINDIBILITA' cause : condizioni inique in situazione di pericolo o bisogno
azione: compete alla parte debole
effetti: retroattivo solo tra le parti, i terzi conservano i diritti acquisiti
recupero: ammessa solo la rettifica
prescrizione: 1 anno
RISOLUZIONE: cause sopravvenute dopo la stipula (nella nullità cause già presenti alla stipula)
a)inadempimento grave di una parte
b)impossibilità sopravvenuta
c)eccessiva onerosità
effetto retroattivo solo tra le parti
RECESSO : atto unilaterale, recettizio determinato:
a)da un accordo tra le parti (multa penitenziale ecc)
b)dalla legge: – licenziamento per giusta causa
-- recesso del consumatore
www.unictblog.com 91
Scaricato da Giovanni Porta (portagiovanni358@gmail.com)
Potrebbero piacerti anche
- Pride and Prejudice: Bestsellers and famous BooksDa EverandPride and Prejudice: Bestsellers and famous BooksValutazione: 4.5 su 5 stelle4.5/5 (19653)
- Art of War: The Definitive Interpretation of Sun Tzu's Classic Book of StrategyDa EverandArt of War: The Definitive Interpretation of Sun Tzu's Classic Book of StrategyValutazione: 4 su 5 stelle4/5 (3321)
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeDa EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeValutazione: 4.5 su 5 stelle4.5/5 (20025)
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeDa EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeValutazione: 4 su 5 stelle4/5 (5795)
- Habit 1 Be Proactive: The Habit of ChoiceDa EverandHabit 1 Be Proactive: The Habit of ChoiceValutazione: 4 su 5 stelle4/5 (2556)
- The 7 Habits of Highly Effective PeopleDa EverandThe 7 Habits of Highly Effective PeopleValutazione: 4 su 5 stelle4/5 (353)
- The 7 Habits of Highly Effective People: The Infographics EditionDa EverandThe 7 Habits of Highly Effective People: The Infographics EditionValutazione: 4 su 5 stelle4/5 (2475)
- The Picture of Dorian Gray: Classic Tales EditionDa EverandThe Picture of Dorian Gray: Classic Tales EditionValutazione: 4 su 5 stelle4/5 (9756)
- American Gods: The Tenth Anniversary EditionDa EverandAmerican Gods: The Tenth Anniversary EditionValutazione: 4 su 5 stelle4/5 (12947)
- Habit 3 Put First Things First: The Habit of Integrity and ExecutionDa EverandHabit 3 Put First Things First: The Habit of Integrity and ExecutionValutazione: 4 su 5 stelle4/5 (2507)
- Wuthering Heights (Seasons Edition -- Winter)Da EverandWuthering Heights (Seasons Edition -- Winter)Valutazione: 4 su 5 stelle4/5 (9486)
- How To Win Friends And Influence PeopleDa EverandHow To Win Friends And Influence PeopleValutazione: 4.5 su 5 stelle4.5/5 (6521)
- The 7 Habits of Highly Effective PeopleDa EverandThe 7 Habits of Highly Effective PeopleValutazione: 4 su 5 stelle4/5 (2567)
- The Iliad: A New Translation by Caroline AlexanderDa EverandThe Iliad: A New Translation by Caroline AlexanderValutazione: 4 su 5 stelle4/5 (5718)
- The Iliad: The Fitzgerald TranslationDa EverandThe Iliad: The Fitzgerald TranslationValutazione: 4 su 5 stelle4/5 (5646)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItDa EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItValutazione: 4.5 su 5 stelle4.5/5 (3278)
- Habit 6 Synergize: The Habit of Creative CooperationDa EverandHabit 6 Synergize: The Habit of Creative CooperationValutazione: 4 su 5 stelle4/5 (2499)
- Wuthering Heights Complete Text with ExtrasDa EverandWuthering Heights Complete Text with ExtrasValutazione: 4 su 5 stelle4/5 (9929)
- The Odyssey: (The Stephen Mitchell Translation)Da EverandThe Odyssey: (The Stephen Mitchell Translation)Valutazione: 4 su 5 stelle4/5 (7770)
- The Picture of Dorian Gray (The Original 1890 Uncensored Edition + The Expanded and Revised 1891 Edition)Da EverandThe Picture of Dorian Gray (The Original 1890 Uncensored Edition + The Expanded and Revised 1891 Edition)Valutazione: 4 su 5 stelle4/5 (9054)