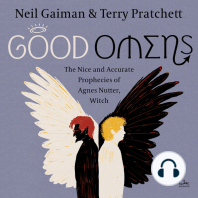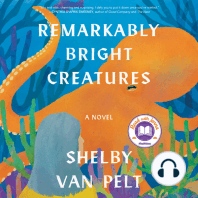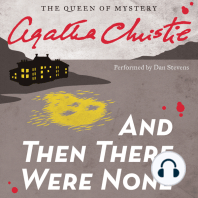Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
BARRIERA
Caricato da
Elisa LuèCopyright
Formati disponibili
Condividi questo documento
Condividi o incorpora il documento
Hai trovato utile questo documento?
Questo contenuto è inappropriato?
Segnala questo documentoCopyright:
Formati disponibili
BARRIERA
Caricato da
Elisa LuèCopyright:
Formati disponibili
Sin dal Cinquecento, si sono formulate diverse ipotesi circa le modalità e i tempi del popolamento
dell’America. Si pensava che gli Indiani fossero schiavi a coloro che avrebbero potuto costituire il
fondamento di una nuova res publica cristiana, e ci si chiedeva se la loro razza fosse superiore o
inferiore. Possiamo affermare che alcuni aspetti di fondamentale importanza circa gli attuali
principi inalienabili dell’uomo, il rifiuto di ogni forma di razzismo ecc, traggono spunto dalle
riflessioni di alcuni intellettuali, tra cui Montaigne e Tommaso Moro, proprio sulle descrizioni degli
Indiani. Occorre sottolineare inoltre, che il relativismo culturale trova il suo fondamento nel
commento sui sacrifici umani e sul cannibalismo dei Tupinambà redatto da Montaigne. Ad oggi,
grazie ad alcune recenti ricerche antropologiche, possiamo affermare che gli Indiani siano dal
punto di vista genetico molto simili alle popolazioni della Cina e del Giappone, e dal punto di vista
antropologico siano discendenti di alcune bande di cacciatori abitanti dell’Asia nord-orientale ai
tempi dell’ultima glaciazione. Questi gruppi di persone giunsero in America in seguito a una
colonizzazione involontaria, provocata dalla necessità di seguire gli animali e di disporre di aree
disabitate, e secondo le ultime ricerche, colonizzarono la Beringia tra i 30000 e i 20000 PP; un
territorio emerso dopo l’ultima glaciazione, grazie all’abbassamento del livello del mare. Da lì, si
spinsero poi verso sud, approdarono in Messico e, superando l’istmo di Panama, raggiunsero
l’America Meridionale per poi spargersi in Amazzonia. In seguito a questo contatto, e dopo
millenni di isolamento, l’America presentava una situazione molto variegata; alcune regioni erano
abitate da bande di cacciatori, altre da orticultori o ancora da popolazioni che praticavano
agricoltura intensiva; le popolazioni erano organizzate in tribù, bande e Stati: ciò ha permesso di
suddividere il territorio da nord a sud in diverse aree culturali, i cui confini erano piuttosto
variabili. Non potendo analizzare tutte le aree, prenderemo in considerazione quelle più
complesse e articolate: La Mesoamerica e il Perù.
La Mesoamerica
La Mesoamerica, chiamata e definita dall’antropologo Paul Kirchoff nel 1943, presenta un
territorio diviso in subaree alquanto diverse, che si estende dalle aree del Messico centro-
settentrionale, alle foreste pluviali dell’Honduras e della penisola di Nicoya in Costa Rica. Sebbene
la varietà di ecosistemi potrebbe suggerire caratteristiche divergenti, questo territorio offre una
forte e del tutto inaspettata omogeneità culturale, caratterizzata da una condivisa ideologia circa i
sistemi di scrittura, miti e divinità comuni e stili architettonici simili. In quest’area si sviluppò un
lungo processo di evoluzione dalla caccia all’agricoltura seguito dal Preclassico ( 1800 a.C.-150
d.C.) e dal Postclassico (150-900). Nella primo periodo, possiamo riscontare una prima
stratificazione sociale e la nascita di un potere, il cui nucleo lo troviamo nella zona della Costa del
Golfo; la cultura predominante di questo e quella olmeca. In un contesto che vedeva la fioritura di
centri e culture regionali, emerse la città di Teotihuacan: “la città degli dei”. La sua cultura
differisce dal resto delle culture mesoameriche, in quanto si dirige verso una società idraulico-
burocratica, tipica del Vecchio Mondo e un sistema di produzione asiatico. Nel 650, il centro
cerimoniale fu incendiato e non rinacque più dalle sue ceneri.
Nel Postclassico, il territorio è occupato da due grandi stati: Tula, nell’altopiano centrale e Chicen
Itza, nello Yucatàn. Nel primo troviamo un’influenze prettamente maya, mentre nel secondo
vediamo la comparsa di tratti culturali e stili tipicamente messicani. In seguito alla fine di queste
due predominanti entità politiche, vediamo un periodo caratterizzato da diverse lotte tra città-
stato per ottenere l’egemonia del territorio, in particolare nell’area Maya questa situazione durò
fino alla Conquista, mentre il resto della Mesoamerica cadde sotto il controllo dell’impero azteco
fino al 13 Agosto 1521, quando l’ultimo imperatore si arrese agli Spagnoli.
Il Perù
L’area peruviana confina a ovest con l’oceano Pacifico, a est con la Ceja de Selva, a sud con la zona
desertica delle Ande e a nord con la steppa umida dell’alta montagna. Da un punto di vista
strettamente culturale, troviamo relazioni più profonde e antiche con i territori confinanti,
nonostante ciò ha sviluppato tratti tipici culturali tra cui l’uso delle stesse piante alimentari, la
presenza dei camelidi, l’enfatizzazione del vestito e del tessuto, una visione dualistica della società
e l’utilizzo di abachi per fare i calcoli. Verso il 500 d.C., due piccoli Stati della Sierra del Sud e
dell’altopiano attorno a Titicaca,Huari e Tiahuanaco iniziarono una politica espansionistica che in
poco si concluse con l’affermazione dei primi due grandi imperi della zona delle Ande centrali. La
ragione del loro collasso, del tutto ipotetica,giace nelle avversità climatiche di una zona al limite:
oltre 3800 m s.l.m. In seguito alla loro scomparsa riemersero le tradizioni locali, con l’affermazione
della cultura Chimù, che arrivò a formare uno stato con capitale Chan Chan. A partire dal 1438 gli
Inca tentarono di fondere i territori conquistati, ma la debolezza del potere sfociò in una guerra
civile che facilitò l’invasione straniera.
La barriera del significato
Da diversi anni non vengono più pubblicati libri di sintesi circa le culture nate in America prima
dell’arrivo degli Europei. E’ pertanto chiaro che non si supera la “barriera del significato”, quando
per spiegare alcune manifestazioni di ciò che definiamo l’ ”altro”, si fa ricorso a spiegazioni che
anche un bambino potrebbe dare. E’ sufficiente pensare a come per anni gli studiosi delle clulture
mesoamericane hanno descritto scrupolosamente i calendario di 260 giorni, senza chiedersi da
dove esso aveva origine.
Oltre la barriera del significato
Prendendo in considerazione la concezione dello spazio, le popolazioni mesoamericane
collocavano il mondo conosciuto in un universo più ampio che includeva il cosmo stesso, il mondo
degli dei, il passato, il futuro, la conoscenza, i protagonisti dei miti cosmogonici ecc. Le varie parti
dell’universo, le superfici terrestri, il centro, la periferia, la destra e la sinistra venivano identificati,
nelle varie culture, con qualità e colori diversi.
Per quanto riguarda il tempo, sappiamo che gli Inca avevano un calendario lunare, con i nomi dei
mesi e delle cerimonie. In Mesoamerica la concezione del tempo era il prodotto dell’interazione di
due cicli: l’anno solare di365 giorni e il calendario rituale di 260 giorni; combinati tra loro
formavano un periodo di 18980 giorni, 52 anni, chiamato anche “secolo mesoamericano”. La
natura di questo calendario era come divinizzata, ruotando su se stesso riproponeva le stesse
energie del passato e quelle che si sarebbero manifestate nel futuro; il non considerare gli anni
bisestili enfatizzava la sacralità del calendario,un eterno ritorno.
Considerando la scrittura, possiamo identificare culture filografiche come i Maya che usavano la
scritture, e culture misografiche come Teotihuacan, che si limitavano all’utilizzo di glifi in contesti
isolati. Ad oggi possiamo distinguere scritture logo-sillabiche, come quella maya o epiolmeca, da
altre ideografiche con una parte fonetica non del tutto chiara, come quella mexica e mixteca.
Con la Conquista, gli spagnoli portarono in America il modello della monarchia assoluta da poco
affermatasi in Europa; nonostante ciò i re delle società, in quanto garanti dell’equilibrio e della
fertilità, venivano comunque “sacralizzati”.
Traducendo letteralmente i testi aztechi, ne esce una storia della Conquista non plausibile,
sebbene sia molto ricca di date e dettagli della storia evenemenziale e siano diffuse bufale
grottesche, tra cui il sacrificio di 80400 prigionieri a Ahuitzol per la consacrazione di alcuni
ampliamenti del Templo Mayor; alcune opere hanno messo in evidenza la scarsa attendibilità delle
fonti spagnole.
In Mesoamerica la fine delle grandi potenze si concluse in modo traumatici; si è ricorso a due
modelli per spiegare questo fenomeno: quello delle “invasioni barbariche” e quello dell’
“insurrezione dei contadini”, nonostante non fossero molto soddisfacenti. Un modello
decisamente più attendibile è quello di Matos Moctezuma, ovvero che la fine violenta delle
potenze dominanti è dovuta alla fragilità del tipo di stato che si era affermato in Mesoamerica; si
mantenevano sovrani e leggi locali e ci si limitava a riscuotere il tributo. Cosi facendo si allargava il
dominio, aumentando però progressivamente il numero di nemici, senza aumentare le forze di
coesione; questi ultimi si coalizzavano per poi liberarsi dello stato egemone.
Ad oggi è rimasta aperta la questione delle culture precolombiane, poiché sono condannate ad
una alterità ferma a cinquecento anni fa che, sebbene sia molto affascinante, risulta molto lontana
e incomprensibile. E’ ovvio che nessuno potrà mai immaginare cosa avrebbero realizzato queste
culture se il loro sviluppo non fosse stato interrotto dall’invasione europea; in questo caso sono di
grande aiuto i grandi della letteratura ispanoamericana, i quali ci hanno permesso di rivivere
frammenti di realtà che non avremmo mai immaginato e che avremmo potuto perdere per
sempre. Tra questi incontriamo Miguel Angel Asturias, in Hombres de maiz, ci mostra come il
nagaulismo dei Maya, ovvero la credenza nel nagual, un’anima individuale esterna alla persona
fisica, ritenuta uno spirito ausiliario, può essere una visione del mondo accettabile anche ai giorni
nostri. In conclusione, ci sono diverse domande che tutti si pongono; ad esempio che posto
occupano le culture precolombiane nella storia dell’uomo o ancora quanto possano essere fondati
i giudizi di repulsione ammirazione che hanno suscitato in noi sin dal XVI secolo.
Potrebbero piacerti anche
- The 7 Habits of Highly Effective People: The Infographics EditionDa EverandThe 7 Habits of Highly Effective People: The Infographics EditionValutazione: 4 su 5 stelle4/5 (2475)
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeDa EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeValutazione: 4.5 su 5 stelle4.5/5 (20026)
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeDa EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeValutazione: 4 su 5 stelle4/5 (5795)
- Art of War: The Definitive Interpretation of Sun Tzu's Classic Book of StrategyDa EverandArt of War: The Definitive Interpretation of Sun Tzu's Classic Book of StrategyValutazione: 4 su 5 stelle4/5 (3321)
- Habit 1 Be Proactive: The Habit of ChoiceDa EverandHabit 1 Be Proactive: The Habit of ChoiceValutazione: 4 su 5 stelle4/5 (2556)
- American Gods: The Tenth Anniversary EditionDa EverandAmerican Gods: The Tenth Anniversary EditionValutazione: 4 su 5 stelle4/5 (12948)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItDa EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItValutazione: 4.5 su 5 stelle4.5/5 (3278)
- Pride and Prejudice: Bestsellers and famous BooksDa EverandPride and Prejudice: Bestsellers and famous BooksValutazione: 4.5 su 5 stelle4.5/5 (19653)
- The 7 Habits of Highly Effective PeopleDa EverandThe 7 Habits of Highly Effective PeopleValutazione: 4 su 5 stelle4/5 (353)
- Habit 6 Synergize: The Habit of Creative CooperationDa EverandHabit 6 Synergize: The Habit of Creative CooperationValutazione: 4 su 5 stelle4/5 (2499)
- Habit 3 Put First Things First: The Habit of Integrity and ExecutionDa EverandHabit 3 Put First Things First: The Habit of Integrity and ExecutionValutazione: 4 su 5 stelle4/5 (2507)
- The 7 Habits of Highly Effective PeopleDa EverandThe 7 Habits of Highly Effective PeopleValutazione: 4 su 5 stelle4/5 (2567)
- How To Win Friends And Influence PeopleDa EverandHow To Win Friends And Influence PeopleValutazione: 4.5 su 5 stelle4.5/5 (6521)
- Remarkably Bright Creatures: A NovelDa EverandRemarkably Bright Creatures: A NovelValutazione: 4.5 su 5 stelle4.5/5 (5511)
- The Perfect Marriage: A Completely Gripping Psychological SuspenseDa EverandThe Perfect Marriage: A Completely Gripping Psychological SuspenseValutazione: 4 su 5 stelle4/5 (1108)
- Wuthering Heights (Seasons Edition -- Winter)Da EverandWuthering Heights (Seasons Edition -- Winter)Valutazione: 4 su 5 stelle4/5 (9486)
- The Iliad: A New Translation by Caroline AlexanderDa EverandThe Iliad: A New Translation by Caroline AlexanderValutazione: 4 su 5 stelle4/5 (5718)
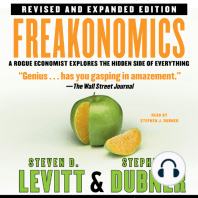
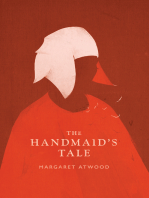


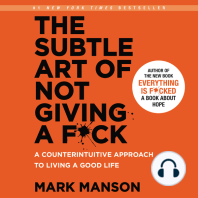


![American Gods [TV Tie-In]: A Novel](https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/audiobook_square_badge/626321117/198x198/22ab6b48b6/1712683119?v=1)