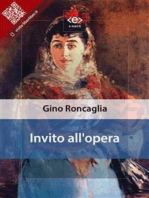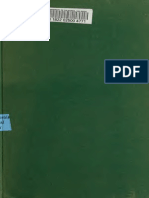Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
Teatro e Musica Alla Corte Di Urbino Patrizio Paci
Caricato da
PatrizioPaciCopyright
Formati disponibili
Condividi questo documento
Condividi o incorpora il documento
Hai trovato utile questo documento?
Questo contenuto è inappropriato?
Segnala questo documentoCopyright:
Formati disponibili
Teatro e Musica Alla Corte Di Urbino Patrizio Paci
Caricato da
PatrizioPaciCopyright:
Formati disponibili
Bella musica parmi il Cantar Bene…
Teatro e Musica alla Corte di Urbino
di Patrizio Paci
Le origini “moderne” del recitar cantando risalgono forse ad 80 anni prima
della rappresentazione dell’Euridice di Jacopo Peri, realizzata a Firenze il 6
ottobre 1600, in occasione delle nozze di Maria de’ Medici con Enrico IV di
Francia. Gli intermedi, eseguiti nel 1589 durante gli intervalli della commedia
“La Pellegrina” di Girolamo Bargagli, occorsi alla Camerata de’ Bardi per
mettere in pratica gli studi di Vincenzo Galilei sul recitar cantando e sulla
tragedia greca, in realtà sono nati diversi anni prima e non a Firenze, ma alla
corte degli Este a Ferrara verso la fine del 1400, quando i musici di corte ne
iniziarono la produzione per inserirli nelle prime commedie tradotte in volgare.
Nel 1486 fu rappresentata la commedia I Menecmi di Plauto, in occasione del
fidanzamento di Isabella d’Este con Francesco Gonzaga. Il duca Ercole I d’Este
fece costruire delle case di legno da usare come sfondo per la scenografia. Lo
spettacolo fu pubblico, nella piazzetta municipale. Negli intervalli della
commedia furono inseriti i primi intermedi celati, probabilmente scritti dal
musico di corte Johannes Martini. Nel 1505, in occasione del matrimonio di
Lucrezia Borgia con Alfonso d’Este, furono rappresentate 5 commedie plautine
con i primi intermedi apparenti. Nel 1508 fu rappresentata la Cassaria di
Ludovico Ariosto, con la prima scenografia bidimensionale prospettica,
realizzata dall’architetto Pellegrino da Udine. Isabella d’Este, abile e preparata
musicista, trasferì questo nuovo concetto musicale alla corte di Mantova, ma
anche Urbino, dove regnava la cognata, subì l’influenza ferrarese,
diventandone la succursale teatrale. Ferrara, Mantova e Urbino, un triangolo
culturale alla base del concetto umanista che portò a scegliere la monodia
accompagnata, come forma musicale più adatta alla recitazione. Non bisogna
dimenticare, in questo periodo storico, la graduale affermazione del sistema
tonale e la pratica piuttosto comune di eseguire la frottola e il madrigale,
cantando la melodia e sostituendo le altre parti polifoniche con il basso
continuo, pratica in via di affermazione definitiva. Ad Urbino, in occasione del
carnevale, il 6 febbraio 1513, in un salone del Palazzo Ducale, fu allestita La
Calandria, commedia, ornata con musiche bizzarre, tutte nascoste et in diversi
lochi, tradotta in volgare dal Cardinal Bibbiena, prologo, allestimento ed
intermedi musicali di Baldassar Castiglione, sostenitore della linea classicistica
degli umanisti nel privilegiare la monodia vocale con accompagnamento
strumentale, considerata l’equivalente moderno del canto ad lyram, quasi
anticipando il recitativo melodrammatico fiorentino. Un dialogo immaginario,
descritto nel Libro del Cortegiano (1528) di Baldassar Castiglione, si svolge alla
Corte di Urbino, presso il palazzo di Guidobaldo da Montefeltro: un gruppo di
illustri invitati dell’epoca (1) trascorre la serata svolgendo un gioco di società
colto, quello di formar con parole un perfetto cortegiano, ossia di costruire,
attraverso le sequenze dialogiche dei vari partecipanti al gioco, un ritratto del
perfetto modello dell’uomo di corte. La padronanza della conoscenza musicale,
nonché l’abilità nel canto e nell’uso degli strumenti musicali, vengono delineati
fin da subito dai dialoganti fra le discipline e le attività a cui il cortegiano deve
sapersi dedicare, dopo l’abilità nell’uso delle armi e la conoscenza delle lettere.
Si legge infatti come il perfetto cortegiano debba essere anche un musico, in
particolare come debba essere sicuro a libro (ossia in grado di conoscere la
partitura e la teoria musicale) e contemporaneamente come debba saper
padroneggiare l’utilizzo di vari instrumenti. Queste competenze musicali
vengono elencate e delineate nello specifico con un finto dialogo, dove
Federigo Fregoso, nipote di Federico da Montefeltro ed allievo del Castiglione,
risponde a Gaspar Pallavicino, nel II libro, paragrafo XIII:
Bella musica parmi il cantar bene a libro (2) sicuramente e con bella maniera;
ma ancor molto più il cantare alla viola perchè tutta la dolcezza consiste quasi
in un solo, e con molta maggior attenzione si nota ed intende il bel modo e l
'aria, non essendo occupate le orecchie in piu che in una sol voce, e meglio
ancor vi si discerne ogni piccolo errore; il che non accade cantando in
compagnia perchè l’uno aiuta l’altro. Ma soprattutto parmi gratissimo il cantare
alla viola per recitare (3); il che tanto di venusta ed efficacia aggiunge alle
parole, che è gran maraviglia.
(1) La duchessa Elisabetta Gonzaga, Emilia Pio, Cesare Gonzaga, cugino dell’autore, Ludovico di Canossa, il Cardinal
Bibbiena, Federico e Ottaviano Fregoso, Pietro Bembo, Giuliano de’ Medici, Gaspare Pallavicino e Bernardo Accolti
(Unico Aretino).
(2) Cantar bene a libro inteso come cantare leggendo lo spartito musicale.
(3) Cantare alla Viola per recitare, inteso come cantare con la viola da pizzico, strumento simile al liuto, quindi cantare
la melodia con accompagnamento del basso continuo.
Dunque un documento eloquente, su come si dovesse musicare il recitato, di
parecchi anni precedente il Dialogo della musica antica et della moderna
(1581) di Vincenzo Galilei, dove sono esplicate le tesi e le teorie sul recitar
cantando fiorentino. Altro accenno viene fatto a Pesaro nel 1571 alla corte di
Guidobaldo II Della Rovere, in occasione dell’arrivo di Lucrezia d’Este, quando
in una commedia di Felice Paciotto furono inseriti degli intermedi, fra cui uno
incentrato sulla figura di Orfeo, ruolo che imponeva un’esecuzione basata su
una sorta di recitar cantando ante litteram.
Nonostante si sia dedicata agli intermedi molto più tardi, rispetto alle altre corti
italiane, Firenze ha fatto la parte da padrone, in virtù del fatto che al contrario
di Ferrara, Mantova ed Urbino, ha sempre dato grande risalto e visibilità agli
eventi legati alla nascita del melodramma, inviando puntualmente alle stampe
e a alle cronache del tempo i resoconti di Michelangelo Buonarroti (nipote del
celebre scultore) sulle sfarzose feste medicee.
Ma Urbino possiede un primato, da sempre arbitrariamente attribuito
all’architetto Vincenzo Scamozzi, autore dei primi teatri rinascimentali di
Vicenza e di Sabbioneta, con i palcoscenici tridimensionali a scena fissa
prospettica: il pittore urbinate Girolamo Genga realizzò per La Calandria la
prima scenografia tridimensionale prospettica, con quinte praticabili (fondali
dipinti simili alle tavole urbinati). Da una descrizione dell’allestimento che
Baldassar Castiglione inviò per lettera a Ludovico da Canossa, si deduce che la
tavola urbinate della Città ideale, conservata nel Museo di Baltimora, abbia in
parte ispirato la scenografia del Genga:
“La Città ideale” tavola di autore ignoto urbinate, conservata al Museo di Baltimora.
La scena era finta una contrada ultima tra il muro della terra e l’ultime case. Dal palco
in terra era finto naturalissimo il muro della città con dui torrioni, da’ capi della sala:
sul’uno stavano li pifari, su l’altro i trombetti: nel mezzo era pur un altro fianco di bella
foggia. La sala veniva a restare, come il fosso della terra, traversata da dui muri, come
sostegni d’acqua. La scena poi era finta una città bellissima, con le strade, palazzi,
chiese, torri, strade vere: et ogni cosa di rilievo, ma aiutata ancora da bonissima
pittura, e prospettiva bene intesa. Tra le altre cose ci era un tempio a otto facce di
mezzorilievo, tanto ben finito, che con tutte l’opere del Stato d’Urbino non saria
possibile a credere che fosse fatto in quattro mesi: tutto lavorato di stucco, con historie
bellissime, finte le finestre d’alabastro, tutti gli architravi e le cornici d’oro fino ad
azzurro oltremarino, et in certi lochi, vetri finiti di gioie, che parevano verissime; figure
intorno tonde, finte di marmo, colonnette lavorate. Saria longo a dire ogni cosa. Questo
era quasi nel mezzo. Da un de’ capi era un arco triomfale, lontano dal muro ben una
canna, fatto al possibil bene. Tra l’architravo et il volto dell’arco era finto di marmo, ma
era pittura, la historia delli tre Horatii, bellissima. In due cappellette sopra li dui pilastri
che sostengono l’arco, erano due figurette tutte tonde, due Vittorie con trofei in mano,
fatte di stucco. In cima dell’arco era una figura equestre bellissima, tutta tonda, armata
con un bello atto, che ferìa con una hasta un nudo che gli era a’ piedi: dall’un canto e
dall’altro del cavallo erano dui come altaretti, sopra quali era a ciascuno un vaso di foco
abondantissimo, che durò fin che durò la Comedia. Finita poi la Comedia, nacque sul
palco all’improvviso un Amorino di quelli primi, e nel medesimo abito: il quale dichiarò
con alcune poche stanze la significazione delle intromesse, che era una cosa continuata
e separata dalla Comedia. Dette le stanze e sparuto l’Amorino, s’udì una musica
nascosa di quattro viole, e poi quattro voci con le viole, che cantorno una stanza con un
bello aere di musica, quasi una oratione ad Amore.
Nel 1514 La Calandria fu replicata a Roma per Papa Leone X, con le
scenografie di Baldassarre Peruzzi. Le commedie proseguirono poi a Pesaro,
Milano e Firenze, dove venne rappresentata La Mandragola di Niccolò
Machiavelli con intermedi a mò di canzonette e madrigali del fiammingo
Philippe Verdelot, infine a Vicenza, nel 1585 in occasione dell’inaugurazione del
Teatro Olimpico, costruito da Andrea Palladio e terminato da Vincenzo
Scamozzi, dove venne rappresentato l’Edipo di Sofocle, musicato in alcune
scene da Andrea Gabrieli, con cori che procedevano nota contro nota in senso
omoritmico, assicurando la comprensione del testo. Nel 1590 a Sabbioneta
venne inaugurato, in occasione del carnevale, il Teatro all’Antica, primo teatro
moderno inserito all’interno di un edificio appositamente costruito, anch’esso
progettato dallo Scamozzi che anticipa soluzioni architettoniche del successivo
periodo barocco. Per l’occasione il Duca di Mantova Vespasiano costituì una
compagnia di comici formata da giovani sabbionetani, stipendiati ed obbligati a
recitare nella città ducale due mesi nel corso di ogni anno. Il duca diede loro il
nome di “Confidenti” e il privilegio di esporre lo stemma ducale durante le
recite, ovunque essi si recassero. La Camerata de’ Bardi a Firenze iniziò ad
interessarsi al recitar cantando dal 1573, con gli studi sulla tragedia greca del
Galilei, sperimentati nel 1586, con gli intermedi rappresentati durante la
commedia l’Amico Fido di Giovanni de’ Bardi, musiche di Cristofano Malvezzi e
Alessandro Striggio, quando fu inaugurato, per le nozze di Virginia de’ Medici e
Cesare d’Este, il Teatro Mediceo degli Uffizi, progettato da Giorgio Vasari e
terminato da Bernardo Buontalenti e consacrati definitivamente nel 1589 per la
commedia La Pellegrina di Girolamo Bargagli in occasione delle nozze di
Ferdinando de’ Medici con Cristina de Lorena.
Bibliografia: Musiche nella storia. Dall’età di Dante alla Grande Guerra - Franco Piperno
Musiche in commedia e intermedi alla corte di Guidubaldo II Della Rovere Duca di Urbino - Franco Piperno
Musica e armonia a corte: la lezione di Castiglione - Giada Tecchio - Enciclopedia Treccani
Il Libro del Cortegiano - Baldassar Castiglione
Potrebbero piacerti anche
- Letteratura FlautisticaDocumento29 pagineLetteratura Flautisticailenia100% (1)
- Paola Manni La Lingua Di Dante PDFDocumento19 paginePaola Manni La Lingua Di Dante PDFLaura RamosNessuna valutazione finora
- Riassunto Storia Della Musica Occidentale Vol 2Documento11 pagineRiassunto Storia Della Musica Occidentale Vol 2Roberta Pascarella100% (4)
- Nuovo Manuale Di Storia Del Teatro AlongeDocumento74 pagineNuovo Manuale Di Storia Del Teatro AlongeFederico Cupellini100% (1)
- LA DAMA BOBA +lope de La VegaDocumento6 pagineLA DAMA BOBA +lope de La VegaEleonora MassaroNessuna valutazione finora
- Commedie in Musica e Febi Armonici - Drammi ItaloDocumento8 pagineCommedie in Musica e Febi Armonici - Drammi ItaloMarcia KaiserNessuna valutazione finora
- Riassunto Di Storia Della Musica Occidentale, M. Carrozzo e C. Cimagalli - Volume 2Documento23 pagineRiassunto Di Storia Della Musica Occidentale, M. Carrozzo e C. Cimagalli - Volume 2GaiaNessuna valutazione finora
- Diapositive - Il Gioco Musicale Nel 400 e 500Documento72 pagineDiapositive - Il Gioco Musicale Nel 400 e 500Marco SuraceNessuna valutazione finora
- Storia-della-Musica-R-Allorto Dal 600 Ad Oggi PDFDocumento65 pagineStoria-della-Musica-R-Allorto Dal 600 Ad Oggi PDFGabriele MarzoccaNessuna valutazione finora
- Tesi 16Documento2 pagineTesi 16Giovanni De Simone PianistNessuna valutazione finora
- Respighi PDFDocumento52 pagineRespighi PDFGiovanni Luigi100% (1)
- SD LAML17 1752a 01Documento50 pagineSD LAML17 1752a 01francesco volturale0% (2)
- Gioachino Chiarini. Plauto, La Farsa, La FestaDocumento4 pagineGioachino Chiarini. Plauto, La Farsa, La FestaEmilio ZainaNessuna valutazione finora
- La Storia Del Melodramma in SintesiDocumento8 pagineLa Storia Del Melodramma in SintesiFamigliaRussoNessuna valutazione finora
- 13.0 L'opera Di CorteDocumento5 pagine13.0 L'opera Di CorteMarco PorcelluzziNessuna valutazione finora
- Il Seicento - Madrigale e Generi Rappresentativi - 12 Maggio 2020Documento4 pagineIl Seicento - Madrigale e Generi Rappresentativi - 12 Maggio 2020Iris AmicoNessuna valutazione finora
- Lezione Storia Della MusicaDocumento2 pagineLezione Storia Della MusicaLara VarinNessuna valutazione finora
- La Lira Da Braccio e La Resurrezione Di OrfeoDocumento8 pagineLa Lira Da Braccio e La Resurrezione Di OrfeoStefano A E LeoniNessuna valutazione finora
- 6 MelodrammaDocumento2 pagine6 MelodrammagiorgioNessuna valutazione finora
- Domenico Mazzocchi Di Alfredo Romano 2Documento10 pagineDomenico Mazzocchi Di Alfredo Romano 2bibliotevaminio4250Nessuna valutazione finora
- 16 Monteverdi e La Scuola Veneziana SCUOLAromanaDocumento4 pagine16 Monteverdi e La Scuola Veneziana SCUOLAromanaWilliam Erselli100% (1)
- Monteverdi e Il MelodrammaDocumento1 paginaMonteverdi e Il MelodrammapedrosinaNessuna valutazione finora
- Il Pianoforte Di Beethoven by Carlo de IncontreraDocumento335 pagineIl Pianoforte Di Beethoven by Carlo de IncontreraAnonymous tIYTpTk7bNessuna valutazione finora
- Analisi SchenkerianaDocumento6 pagineAnalisi SchenkerianaDaniela FioraniNessuna valutazione finora
- Appunti LibroDocumento38 pagineAppunti LibroDilettaNessuna valutazione finora
- Storia Della MusicaDocumento83 pagineStoria Della MusicaAnonymous SAuK4CNessuna valutazione finora
- 4 Orfeo MonteverdiDocumento21 pagine4 Orfeo MonteverdiFrancesco BergonzaniNessuna valutazione finora
- Frottola e MadrigaleDocumento7 pagineFrottola e MadrigaletampueddyNessuna valutazione finora
- SFRM - 8 - Tipologie Formali Dell'opera in MusicaDocumento8 pagineSFRM - 8 - Tipologie Formali Dell'opera in MusicaHera GuglielmoNessuna valutazione finora
- Scuola Musicale NapoletanaDocumento8 pagineScuola Musicale NapoletanaDarkAngel GamingNessuna valutazione finora
- Intermedii Et Concerti 1591Documento182 pagineIntermedii Et Concerti 1591Ovidiu IlocNessuna valutazione finora
- Claudio MeruloDocumento3 pagineClaudio MerulokusalanandaNessuna valutazione finora
- 1 MonodiaDocumento15 pagine1 MonodiaFrancesco RonzioNessuna valutazione finora
- Storia e Storiografia I - MonteverdiDocumento5 pagineStoria e Storiografia I - MonteverdiDenis MazzolaNessuna valutazione finora
- Storia Della Musica - Il MelodrammaDocumento8 pagineStoria Della Musica - Il MelodrammaMiriana ScivoliNessuna valutazione finora
- Storia Della Musica Interrogazione 24 GennaioDocumento5 pagineStoria Della Musica Interrogazione 24 Gennaiodavidepag10Nessuna valutazione finora
- Domenico Mazzocchi Di Alfredo RomanoDocumento10 pagineDomenico Mazzocchi Di Alfredo Romanobibliotevaminio4250Nessuna valutazione finora
- Lococo, Giusepina - I Testi Del Petrarca Nel Repertorio Musicale Del QuattrocentoDocumento14 pagineLococo, Giusepina - I Testi Del Petrarca Nel Repertorio Musicale Del QuattrocentoMau AlvaradoNessuna valutazione finora
- Concerto 1012Documento20 pagineConcerto 1012chocorireNessuna valutazione finora
- Storia Della MusicaDocumento4 pagineStoria Della Musicavershininas2005Nessuna valutazione finora
- Breve Storia Del TeatroDocumento3 pagineBreve Storia Del TeatroNoemiCiullaNessuna valutazione finora
- Claudio Monteverdi e La Musicalita Del DDocumento16 pagineClaudio Monteverdi e La Musicalita Del DMónica Canales Marquez100% (1)
- Intrecci Sonori (Silvana Chiesa)Documento1 paginaIntrecci Sonori (Silvana Chiesa)Urbano VIIINessuna valutazione finora
- I Quattro Antichi Conservatori Di NapoliDocumento93 pagineI Quattro Antichi Conservatori Di NapoliClaudio TornaboniNessuna valutazione finora
- Nota CriticaDocumento2 pagineNota CriticaGregorio Maria PaoneNessuna valutazione finora
- Falstaffdi Salieri Quaderni Di Musicolog PDFDocumento31 pagineFalstaffdi Salieri Quaderni Di Musicolog PDFCesar Octavio Moreno ZayasNessuna valutazione finora
- Introduzione Fu Il Lauro Sempre VerdeDocumento4 pagineIntroduzione Fu Il Lauro Sempre VerdeEmanuele Salvatore Paolo DuchettaNessuna valutazione finora
- Monteverdi e La Musica Del Suo Tempo Fellerer 24315410Documento13 pagineMonteverdi e La Musica Del Suo Tempo Fellerer 24315410Venturini MauroNessuna valutazione finora
- Dialogus de Musica IlTrionfodiBaccoDocumento4 pagineDialogus de Musica IlTrionfodiBaccoFacundo NunesNessuna valutazione finora
- Articolo Teuzzone CagliariDocumento4 pagineArticolo Teuzzone CagliariAlessandro BorinNessuna valutazione finora
- Tesi BaroccoDocumento3 pagineTesi BaroccoClaudio MartoneNessuna valutazione finora
- Ram 0401Documento38 pagineRam 0401ddNessuna valutazione finora
- Musica in Arte - Il ConcertoDocumento35 pagineMusica in Arte - Il ConcertoMarco SuraceNessuna valutazione finora
- Tesina 8Documento15 pagineTesina 8Lorenzo MatteiNessuna valutazione finora
- A Voce Sola PDFDocumento20 pagineA Voce Sola PDFjcp50% (2)
- Mozart 2Documento5 pagineMozart 2Silvia AntoniNessuna valutazione finora
- Troisieme SuitteDocumento31 pagineTroisieme SuittePro GalmatNessuna valutazione finora
- Claudio Monteverdi e Ecco Mormorar L'ondeDocumento6 pagineClaudio Monteverdi e Ecco Mormorar L'ondeLuca Bellogi0% (1)
- S Mercadante Francesca Da Rimini Ed CritDocumento9 pagineS Mercadante Francesca Da Rimini Ed Critmarinka123234Nessuna valutazione finora
- L'opera RomanaDocumento3 pagineL'opera Romanab8fffxjdybNessuna valutazione finora
- La Lauda Francescana e Le Sacre Rappresentazioni Patrizio PaciDocumento3 pagineLa Lauda Francescana e Le Sacre Rappresentazioni Patrizio PaciPatrizioPaciNessuna valutazione finora
- Le - Prime - Forme - Di Polifonia - Ars Antiqua - La Scuola - Di - Notre - Dame - Patrizio - PaciDocumento3 pagineLe - Prime - Forme - Di Polifonia - Ars Antiqua - La Scuola - Di - Notre - Dame - Patrizio - PaciPatrizioPaciNessuna valutazione finora
- Teatro e Musica Alla Corte Di Urbino Patrizio PaciDocumento4 pagineTeatro e Musica Alla Corte Di Urbino Patrizio PaciPatrizioPaciNessuna valutazione finora
- La Lauda Francescana e Le Sacre Rappresentazioni Patrizio PaciDocumento3 pagineLa Lauda Francescana e Le Sacre Rappresentazioni Patrizio PaciPatrizioPaciNessuna valutazione finora
- Le - Prime - Forme - Di Polifonia - Ars Antiqua - La Scuola - Di - Notre - Dame - Patrizio - PaciDocumento3 pagineLe - Prime - Forme - Di Polifonia - Ars Antiqua - La Scuola - Di - Notre - Dame - Patrizio - PaciPatrizioPaciNessuna valutazione finora
- Teatro e Musica Alla Corte Di Urbino Patrizio PaciDocumento4 pagineTeatro e Musica Alla Corte Di Urbino Patrizio PaciPatrizioPaciNessuna valutazione finora
- La Lauda Francescana e Le Sacre Rappresentazioni Patrizio PaciDocumento3 pagineLa Lauda Francescana e Le Sacre Rappresentazioni Patrizio PaciPatrizioPaciNessuna valutazione finora
- Le - Prime - Forme - Di Polifonia - Ars Antiqua - La Scuola - Di - Notre - Dame - Patrizio - PaciDocumento3 pagineLe - Prime - Forme - Di Polifonia - Ars Antiqua - La Scuola - Di - Notre - Dame - Patrizio - PaciPatrizioPaciNessuna valutazione finora
- Il Significato Della CommediaDocumento4 pagineIl Significato Della CommediaAmir ChoksiNessuna valutazione finora
- Il Genere ComicoDocumento5 pagineIl Genere ComicoPaolo RattiNessuna valutazione finora
- GoldoniDocumento2 pagineGoldoniMario CaredduNessuna valutazione finora
- I MenecmiDocumento2 pagineI MenecmiSylvia DuruNessuna valutazione finora
- Appunti LatinoDocumento6 pagineAppunti LatinoLORENZO BAXNessuna valutazione finora
- Lett LatinaDocumento134 pagineLett Latinabri nicNessuna valutazione finora
- Le Caratteristiche Del Testo TeatraleDocumento14 pagineLe Caratteristiche Del Testo TeatraleTommaso De santisNessuna valutazione finora
- Tipi Goldoniani e Libretti DoperaDocumento23 pagineTipi Goldoniani e Libretti Doperagiovanna balconiNessuna valutazione finora
- Nevio EdizioneDocumento155 pagineNevio Edizionedumezil3729Nessuna valutazione finora
- MenandroDocumento5 pagineMenandroSara occhiniNessuna valutazione finora
- Teatro GrecoDocumento5 pagineTeatro GrecomatteosetturaNessuna valutazione finora
- 06 Canzone NapoletanaDocumento18 pagine06 Canzone Napoletanascaricone71Nessuna valutazione finora
- Classico Tenacious D TabsDocumento2 pagineClassico Tenacious D TabsSleaz11Nessuna valutazione finora
- Goldoni Carlo - La Donna Di GarboDocumento45 pagineGoldoni Carlo - La Donna Di GarboSebastianNessuna valutazione finora
- La Lirica Di Antonio Brocardo. I Cantier PDFDocumento72 pagineLa Lirica Di Antonio Brocardo. I Cantier PDFdiradosta_1992Nessuna valutazione finora
- Uocchie C'arraggiunateDocumento2 pagineUocchie C'arraggiunateLudovico GaudioNessuna valutazione finora
- Menandro Da Bibliotheke 2011Documento56 pagineMenandro Da Bibliotheke 2011Paolo ScelfoNessuna valutazione finora
- AululariaDocumento6 pagineAululariaKate100% (1)
- Prove Di DrammaturgiaDocumento48 pagineProve Di DrammaturgiaRenata SavoNessuna valutazione finora
- Parte 2 - Corso FranceseDocumento42 pagineParte 2 - Corso FranceseIlaria ManciniNessuna valutazione finora
- Ope Red I Battista G 00 GuarDocumento508 pagineOpe Red I Battista G 00 Guarjoshua80Nessuna valutazione finora
- Compendium (G.Marciani) - Letteratura GrecaDocumento44 pagineCompendium (G.Marciani) - Letteratura GrecaGiacomo MarcianiNessuna valutazione finora
- Storia Del Teatro e Dello SpettacoloDocumento24 pagineStoria Del Teatro e Dello Spettacolotora92Nessuna valutazione finora
- Beccaria Della CommediaDocumento484 pagineBeccaria Della CommediaAntonio MaNessuna valutazione finora
- 2004la Formazione Artistica Parte 2 24R0001Documento279 pagine2004la Formazione Artistica Parte 2 24R0001donovanejanNessuna valutazione finora