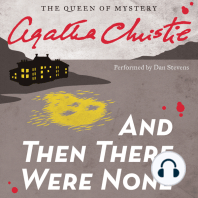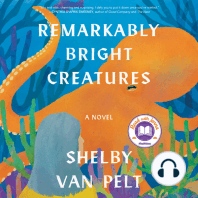Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
Boeri Vs Roccella
Caricato da
idrial890 valutazioniIl 0% ha trovato utile questo documento (0 voti)
37 visualizzazioni16 pagineTitolo originale
boeri vs roccella
Copyright
© Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Formati disponibili
PDF, TXT o leggi online da Scribd
Condividi questo documento
Condividi o incorpora il documento
Hai trovato utile questo documento?
Questo contenuto è inappropriato?
Segnala questo documentoCopyright:
Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Formati disponibili
Scarica in formato PDF, TXT o leggi online su Scribd
0 valutazioniIl 0% ha trovato utile questo documento (0 voti)
37 visualizzazioni16 pagineBoeri Vs Roccella
Caricato da
idrial89Copyright:
Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Formati disponibili
Scarica in formato PDF, TXT o leggi online su Scribd
Sei sulla pagina 1di 16
111/126 111
D I A L O G O 1
DIALOGO SUI PRECARI
E IL CONTRATTO UNICO
La precarietà è oggi la vera emergenza sul fronte del mercato
del lavoro. Come affrontarla? Un contratto unico con tutele
crescenti nel tempo può essere la soluzione? O, al contrario,
non farebbe che aggravare il problema e indebolire
ulteriormente i lavoratori? Un confronto schietto
e approfondito su uno dei più gravi problemi del nostro paese.
TITO BOERI / MASSIMO ROCCELLA
Tito Boeri: La proposta del «contratto unico» è stata presentata per la
prima volta dal professor Pietro Garibaldi e da me nel 2002 all’univer-
sità Statale di Milano e poi sul sito lavoce.info.
Da che cosa derivava questa nostra proposta, che naturalmente oggi, con
questa crisi economica, ci sentiamo ancor più di rilanciare? All’origine
c’era la constatazione che nel nostro mercato del lavoro fossero avvenuti
una serie di sviluppi importanti, alcuni positivi altri molto meno. Noi cer-
cavamo di affrontare le patologie che sembravano emergere e che sono di-
ventate ancora più evidenti negli anni successivi. Siamo passati – e qui vi è
la radice della grande trasformazione nel mercato del lavoro cui abbiamo
assistito – da una fase di sostenuta crescita economica, in cui si registrava-
no significativi tassi di crescita del prodotto interno lordo, non accompa-
112 gnata però da un’altrettanto sostenuta capacità del sistema di generare
nuovi posti di lavoro (è ciò che nelle pubblicazioni in lingua inglese viene
definita jobless growth, crescita senza lavoro), a una situazione esattamen-
te rovesciata, in cui la nostra economia è entrata in una fase di stagnazio-
ne che di fatto continua da circa la metà degli anni Novanta e tuttavia è
riuscita a creare moltissimi posti di lavoro, più di 2 milioni.
Quindi siamo passati dalla crescita senza posti di lavoro alla crescita del
lavoro senza crescita economica, che – mutuando ancora un’espressione
dall’inglese – potremmo definire growthless job creation.
Perché è avvenuto tutto ciò? Senza dubbio c’è stato il contributo impor-
tante esercitato dall’immigrazione: in un paese immobile come il nostro
gli immigrati sono andati a tappare dei buchi che l’offerta di lavoro de-
gli italiani non riusciva a soddisfare. C’è stata poi una forte moderazione
salariale, legata a vari fattori fra cui la stessa immigrazione e la compar-
sa, appunto, del precariato, che rappresenta l’effetto estremo del cre-
scente dualismo del nostro mercato del lavoro.
La ragione più importante dei cambiamenti intervenuti nel rapporto tra
crescita economica e occupazione è proprio in questo dualismo. Dopo le
più significative riforme del mercato del lavoro che sono state prodotte
in Italia negli ultimi anni, la capacità del nostro sistema economico di
creare occupazione è aumentata.
Questo è un fenomeno – sulla cui analisi teorica abbiamo lavorato molto
io e il professor Garibaldi – che abbiamo definito honeymoon, cioè «luna
di miele»: quando in un mercato del lavoro che ha un regime di prote-
zione dell’impiego abbastanza forte si introduce la possibilità per il da-
tore di lavoro di assumere dei lavoratori molto flessibili e non eccessiva-
mente tutelati, i datori di lavoro – durante fasi non negative del ciclo –
possono costruirsi una specie di «cuscinetto» di lavoratori, i quali saran-
no i primi a essere mandati via qualora la situazione del ciclo dovesse
peggiorare. Ecco perché può avvenire che, anche quando l’economia non
va a gonfie vele, si registri un aumento dell’occupazione.
Chiarito – per sommi capi – il quadro di fronte al quale ci troviamo, pas-
siamo a vedere le patologie dalle quali è affetto, che sono principalmen-
te tre.
Il primo aspetto rimanda all’eccessiva complessità normativa determina-
ta dalla moltiplicazione delle figure contrattuali. A questo ha contribui-
to un pensiero giuslavorista che riteneva importante diversificare le figu-
re contrattuali; era un po’ l’idea della cassetta degli attrezzi, dello statu-
to dei lavori, attraverso i quali poter coprire una pluralità di prestazioni
e di esigenze che nei rapporti di lavoro già esistono e in questo modo
possono trovare una sorta di riconoscimento e «tipizzazione». A lungo
andare questo approccio ha però prodotto una giungla molto intricata, e
poco trasparente, di formule contrattuali in cui è difficile orientarsi sia
da parte dei lavoratori che da parte dei datori di lavoro, i quali, infatti,
hanno quasi sempre bisogno di rivolgersi a un consulente del lavoro.
Il secondo aspetto davvero grave e preoccupante concerne l’asimmetria 113
molto forte che viene a crearsi nei trattamenti nel mercato del lavoro,
asimmetria che penalizza soprattutto i giovani, perché sono loro a entra-
re nel mercato del lavoro da una porta secondaria, attraverso queste
nuove tipologie contrattuali, senza riuscire ad accedere – nemmeno in un
secondo momento – al mercato del lavoro cosiddetto primario. Questo
spiega anche perché i lavoratori con i contratti precari sono pagati di
meno degli altri: perché sono in una posizione contrattuale più debole.
Le imprese non investono nella formazione di questi lavoratori perché
sanno già che saranno i primi a dover andare via nel caso in cui le cose
cominciassero ad andare male. Gli stessi lavoratori non hanno incentivi
a investire nel capitale umano, che sarebbe poi il modo migliore da par-
te loro per tutelarsi contro i rischi di mercato.
La terza patologia è forse quella più grave. I lavoratori precari sono de-
stinati ad avere carriere lavorative discontinue, con frequenti episodi di
disoccupazione e salari bassi. Con le nuove regole del regime previden-
ziale – un regime di tipo contributivo – questi lavoratori sono destinati
ad arrivare alla fine della loro carriera lavorativa con dei trattamenti
previdenziali molto bassi, in molti casi al di sotto del minimo vitale. È
bene porsi ora questo problema, dal momento che a mio giudizio non
può essere risolto rivedendo ulteriormente le regole a regime del nostro
sistema previdenziale. La riforma del ’96, almeno a regime, funzionerà;
cioè dal 2032 in poi avremo un sistema previdenziale sostenibile, quindi
non c’è bisogno di tornarci sopra. Il problema di fondo è rivedere le re-
gole del mercato del lavoro, perché è lì il nodo fondamentale da scioglie-
re. Non è possibile che questi lavoratori vengano lasciati in una situazio-
ne così svantaggiosa.
Veniamo allora – molto sinteticamente – alla nostra proposta. Noi pen-
siamo che si debba superare questa stridente asimmetria tra i contratti a
tempo indeterminato e le altre tipologie contrattuali, asimmetria che si è
creata anche per l’incentivo fortissimo che le imprese hanno nel ricorre-
re ai contratti flessibili, dal momento che quelli a tempo indeterminato
hanno fin da subito – o meglio, dopo il periodo di prova – regimi di pro-
tezione dell’impiego molto stringenti.
Nella nostra proposta noi sosteniamo che si debbano creare degli stan-
dard minimi applicati a tutte le tipologie contrattuali; per esempio i con-
tributi previdenziali devono essere gli stessi per tutti i tipi di lavori che
vengono svolti, mentre allo stato attuale la diversità di trattamento con-
tributivo implica uno sconto sul costo del lavoro per molte di queste ti-
pologie contrattuali atipiche. In secondo luogo deve essere istituito un
salario minimo orario, che deve tutelare tutti i lavoratori, e quindi anche
quelli cosiddetti precari, i quali molto spesso hanno un potere contrat-
tuale così basso da essere costretti a svolgere prestazioni a dei salari ora-
ri davvero bassissimi. Pensiamo solo al fatto che in Italia ci sono persone
che percepiscono meno di 5 euro all’ora. Poi è necessario far pagare di
114 più i contributi contro la disoccupazione, per chi assume con contratti a
tempo determinato, affinché i datori di lavoro che ricorrono a contratti a
termine siano maggiormente responsabilizzati dal momento che è più al-
ta la possibilità da parte dei loro assunti di ritrovarsi disoccupati.
Il nostro «contratto unico» si prefigge infine di rendere progressiva la co-
struzione delle tutele nei primi tre anni del rapporto lavorativo, in modo
tale da non porre il datore di lavoro di fronte al forte deterrente all’as-
sunzione costituito dalle garanzie contenute nel tradizionale contratto a
tempo indeterminato. Il nostro «contratto unico» è da subito a tempo in-
determinato, ma pone in essere una protezione contro il rischio di licen-
ziamento economico che è crescente con la durata dell’impiego: ad esem-
pio, un risarcimento pari a 15 giorni di retribuzione per ogni 3 mesi di
lavoro, fino ad arrivare – dopo tre anni – al corrispettivo di sei mesi di
retribuzione.
I primi tre anni funzionano quindi come un periodo di inserimento, di
prova, e questa formula già garantisce una maggiora tutela rispetto alla
situazione attuale, in cui durante il periodo di prova si può essere licen-
ziati da un giorno all’altro senza nessun tipo di compensazione. Dopo i
tre anni si passa integralmente all’attuale normativa standard dei rap-
porti di lavoro.
Perché, tuttavia, pensiamo che queste norme non sarebbero più un de-
terrente alle assunzioni, come è stato in passato? Perché nel corso dei tre
anni si è investito nel capitale umano del lavoratore: a quel punto diven-
terebbe molto costoso per l’impresa privarsi del contributo di quel lavo-
ratore e ricominciare a formarne un altro. La formazione – come ho ac-
cennato prima – è la tutela maggiore di cui oggi dispone il lavoratore,
perché il datore di lavoro che ha investito nella sua formazione sa che in
caso di licenziamento deve investire altrettanto nella formazione di un
altro lavoratore. E questi costi rappresentano un grande deterrente al li-
cenziamento.
Massimo Roccella: Le proposte del professor Boeri e del professor Gari-
baldi possono essere discusse da un duplice punto di vista: da un punto di
vista politico e da un punto di vista tecnico. Io partirei da quest’ultimo –
riservandomi di toccare solo in seconda battuta gli aspetti politici – e più
precisamente dall’analisi del presupposto teorico, degli assunti economici
che sorreggono l’impianto propositivo del professor Boeri.
Nel libro Un nuovo contratto per tutti, a pagina 49, si fa riferimento al-
le valutazioni dell’Ocse sulla rigidità dei mercati del lavoro. Testualmen-
te si legge: «Per avere un quadro più preciso di cosa è successo in Italia
in questi anni è bene rapportarsi a quanto avvenuto negli altri paesi Oc-
se. L’Italia vanta uno dei regimi di protezione all’impiego per lavoratori
a tempo indeterminato più restrittivi dell’intera area Ocse».
A questo punto mi sarei aspettato che si entrasse un po’ più nel dettaglio.
È noto che tutti gli economisti di impostazione più o meno liberista, ma
anche i giuslavoristi che si ispirano alla stessa scuola di pensiero, hanno 115
costruito le proprie proposte di liberalizzazione del mercato del lavoro, e
segnatamente di liberalizzazione della disciplina dei licenziamenti, pro-
prio basandosi sugli studi dell’Ocse. L’Ocse un po’ di anni addietro, at-
torno alla metà degli anni Novanta, aveva costruito un indice di prote-
zione dell’impiego in base al quale si classificava, appunto, il grado di ri-
gidità dei vari mercati del lavoro nazionali.
Secondo questo indice – volendo sorvolare sul fatto che i criteri utilizza-
ti dall’Ocse erano fortemente discutibili, anzi, valutati con l’ottica di un
giurista, risultavano assolutamente arbitrari – l’Italia risultava in cima
alla scala delle rigidità. Successivamente, nel 2004, l’Ocse ha riveduto le
proprie stime e ha ammesso di essersi sbagliata; ha ammesso che quella
scala classificatoria, per quanto riguardava il nostro paese, era basata su
informazioni erronee, cosicché il grado di rigidità dell’impiego per il no-
stro paese, che negli anni Novanta secondo l’Ocse corrispondeva a un
valore di 2,8, è precipitato a 1,8. Ebbene, di questa revisione di criteri
non vi è traccia nei lavori degli economisti, né dei giuristi, che si sono ri-
fatti agli studi dell’Ocse. E non ve n’è traccia neanche nel libro di Boeri
e Garibaldi. Dunque Boeri e Garibaldi continuano a fare riferimento
all’Ocse, sostenendo che il nostro mercato del lavoro sarebbe caratteriz-
zato da uno dei regimi più restrittivi per quanto riguarda le tutele nei
confronti del licenziamento, ma lo fanno trascurando dati della stessa
fonte Ocse che oggi dicono esattamente il contrario.
Sempre nel libro di Boeri e Garibaldi, a un certo punto si ventila l’ipotesi
che in realtà la nostra legislazione in materia di licenziamenti non sarebbe
in quanto tale così rigida, ma lo diventerebbe per via dell’applicazione giu-
risprudenziale. Dicono Boeri e Garibaldi: «Molti economisti e giuslavoristi
hanno più volte sostenuto che la “giusta causa” con l’obbligo del reintegro
inserita nello statuto dei lavoratori non è di per sé troppo rigida, non è il ve-
ro problema. Diventa invece tale a causa del comportamento dei giudici del
lavoro, nell’esercizio dell’amplissimo potere discrezionale che la legge loro
concede». E concludono: «Che sia frutto delle leggi o delle interpretazioni
troppo rigide fornite dalla giurisprudenza, il risultato è lo stesso: licenziare,
in Italia, è un’impresa davvero difficile» (pp. 53 s.). Anche in questo caso ci
si aspetterebbe che vengano forniti dati a supporto di un’affermazione così
impegnativa. Invece dati non se ne leggono; non se ne leggono nel libro di
Boeri e Garibaldi e non se ne leggono neanche nelle opere di altri economi-
sti che hanno sostenuto le medesime cose, come ad esempio in Goodbye Eu-
ropa dei professori Francesco Giavazzi e Alberto Alesina. Nel libro di Gia-
vazzi e Alesina si legge: «Non solo la legge impone severe restrizioni sui li-
cenziamenti, ma perfino nel caso in cui i datori di lavoro si attengono a es-
sa, spesso intervengono i giudici, decidendo solitamente in favore dei lavo-
ratori» (p. 80). Anche qui non si portano dati a sostegno di affermazioni co-
sì impegnative.
116 In ogni caso: esistono dati in proposito? I dati esistono, e non confortano le
affermazioni che ho ricordato poco sopra. Prendiamo i più recenti dati
Istat, pubblicati nel 2006, con riguardo alle controversie di lavoro in mate-
ria di licenziamenti. Ebbene, l’Istat ci dice che la media nazionale di acco-
glimento dei ricorsi in materia di licenziamenti, nel biennio 2003-2004, è
stata di poco superiore al 60 per cento, per essere precisi il 61,3 per cento.
Ma si badi bene che questo dato, che già è ben lontano dal suffragare la te-
si secondo cui i giudici del lavoro sarebbero particolarmente disponibili nei
confronti dei lavoratori (siamo di poco sopra al fifty-fifty), in realtà dice più
di quanto non appaia. La serie dell’Istat è costruita prendendo in conside-
razione la causa in quanto tale, nella quale non rientrano solo i licenzia-
menti ma anche, ad esempio, le domande legate a questioni retributive. E
quindi l’Istat calcola come ricorso accolto anche quello in cui sia stata ac-
colta soltanto la richiesta di pagamento di differenze retributive, ma maga-
ri respinta la contestazione relativa al licenziamento.
C’è poi la tesi sostenuta da altri studiosi della stessa area – penso a uno
studio di alcuni anni fa degli economisti Andrea Ichino e Michele Polo e
del più noto giurista Pietro Ichino – i quali cercarono di dimostrare che
l’applicazione della disciplina sui licenziamenti sarebbe più rigida nelle
aree meridionali del paese, perché i giudici sarebbero – come dire? –
mossi da compassione per il povero lavoratore impossibilitato a reperire
facilmente un nuovo posto di lavoro. Tale studio è di un rigore metodo-
logico pressoché pari a zero. A suo tempo lo commentai in questi termi-
ni e oggi vedo che i dati Istat ancora una volta mi danno ragione: la me-
desima rilevazione che ricordavo prima segnala che la percentuale di ac-
coglimento dei ricorsi scende al 53 per cento al Sud, al 51 per cento nel-
le isole, mentre è al 60,8 per cento nel Nord-Ovest, al 57 per cento nel
Nord-Est e addirittura al 68,3 per cento al centro. Quindi non è affatto
vero che i giudici meridionali siano più propensi a riconoscere le ragioni
dei lavoratori, semmai lo sono meno.
Dunque tutte le cose che si sono scritte per sostenere, in primo luogo, che
la nostra legislazione in materia di licenziamento è particolarmente re-
strittiva e, in secondo luogo, che, quand’anche non lo fosse, molto re-
strittivi sarebbero i giudici del lavoro, non soltanto non riposano su dati
empirici, ma anzi sono da questi contraddette.
Questa è la cornice teorica entro la quale è formulata anche la proposta
del «contratto unico», ed è evidente che se la cornice teorica non regge
alla prova empirica anche la proposta concreta ne risulta compromessa.
Ora, per quanto concerne l’analisi di tale specifica proposta, sarà una
deformazione professionale, ma i giuristi sono abituati a utilizzare le pa-
role con proprietà di linguaggio e quindi se dicono «contratto unico», in-
tendono dire proprio «contratto unico». Invece nella proposta di Boeri e
Garibaldi il contratto unico non è affatto un contratto unico. È un con-
tratto ulteriore, nel senso che verrebbe introdotta una nuova tipologia
contrattuale che si affiancherebbe a tutte quelle oggi esistenti, le quali ri-
marrebbero perfettamente in vita così come sono, grossomodo identiche. 117
Ma questo contratto non sarebbe rivolto a una specifica tipologia di la-
voratori o a un segmento del mercato del lavoro, poniamo ad esempio
quello dei giovani. Il contratto unico sarebbe di applicazione generaliz-
zata, sarebbe in altri termini la modalità (potenziale) di ingresso nel
mercato del lavoro per tutti coloro che verrebbero assunti dal giorno suc-
cessivo all’introduzione nell’ordinamento del preteso contratto unico.
Ora: questo contratto potrebbe essere uno strumento per migliorare le
condizioni lavorative e le tutele rispetto alle situazioni attualmente esi-
stenti? No, sfortunatamente le peggiorerebbe. Il contratto unico sarebbe
sì un contratto a tempo indeterminato, ma si badi bene che «contratto a
tempo indeterminato» non è affatto sinonimo di impiego stabile, tant’è
vero che all’inizio del secolo scorso – non voglio farla troppo lunga, ma
non si può evitare di ricordarlo – furono proprio le imprese a battersi
perché fosse legittimato, in un sistema che allora lo negava, il contratto
di lavoro a tempo indeterminato, naturalmente con clausola di licenzia-
mento libero incorporata. E di questo appunto si tratta nel caso della
proposta dei professori Boeri e Garibaldi: un contratto a tempo indeter-
minato con libertà di licenziamento nei primi tre anni di durata del rap-
porto.
Boeri e Garibaldi insistono molto sul fatto che alla scadenza del contrat-
to a termine il lavoratore non ha diritto ad alcunché, ma dimenticano di
dire che durante il periodo di vigenza di un contratto a termine i lavora-
tori sono assistiti dal massimo grado di stabilità, nel senso che è impos-
sibile sciogliersi legittimamente da un contratto a termine. Il contratto a
termine è connotato da quella che i giuristi chiamano efficacia reale per
ambedue le parti del rapporto, il che vuol dire che se un datore di lavoro
volesse risolvere dopo ad esempio tre mesi un contratto a termine della
durata di tre anni sarebbe tenuto a corrispondere al lavoratore un risar-
cimento del danno pari alle retribuzioni dei 33 mesi restanti; mentre, nel
caso della proposta di Boeri e Garibaldi, un datore di lavoro che avesse la
stessa bella idea sarebbe tenuto a corrispondere un indennizzo pari a 15
giorni di retribuzione. Come si vede, la differenza non è di poco conto.
Nell’analisi di Boeri e Garibaldi c’è inoltre un errore di diritto. Boeri e
Garibaldi evidentemente pensano che allo stato attuale, durante il perio-
do di prova, i datori di lavoro possano fare quello che vogliono. Questo
sarebbe vero se fossimo ancora nel 1979. Si ignora che, dal 1980, c’è
stata un’evoluzione alquanto significativa nel nostro diritto del lavoro.
Per effetto di una sentenza della Corte costituzionale è stato chiarito che
i datori di lavoro possono sì licenziare liberamente durante il periodo di
prova, ma il lavoratore ha diritto di rivolgersi al giudice e di dimostrare
che il licenziamento non è stato affatto dovuto al mancato superamento
della prova, ma ad altre ragioni, con tutte le conseguenze del caso.
Quindi, come si vede, qui si prospetta davvero un bel salto da un sistema
che riconosce un significativo apparato di tutele, a uno che non ne rico-
118 nosce affatto. Quello suggerito da Boeri e Garibaldi è, a mio parere, un
salto nel vuoto.
Boeri: I giuristi e gli economisti utilizzano metodi e strumenti analitici di-
versi tra di loro, per cui non necessariamente le valutazioni convergono.
Però non per questo io ritengo che il lavoro dei giuristi sia inutile o in qual-
che modo lo giudico con i toni che ha appena usato il professor Roccella.
Detto questo, l’indice dell’Ocse è stato rivisto perché nelle sue versioni pre-
cedenti, quando veniva usato agli inizi degli anni Novanta, erano stati in-
seriti fra i costi di licenziamento anche e soprattutto i trattamenti legati al
tfr, e quindi alla liquidazione. È noto che il tfr nasce come uno strumento
di severance (di indennità), ma la liquidazione viene concessa anche a chi
si separa volontariamente da un’impresa, quindi non è legittimo conside-
rarla parte integrante dei costi legati al licenziamento. Tuttavia, i lavorato-
ri che hanno scelto di affidare il tfr ai fondi pensione hanno vissuto questa
scelta come riduzione delle tutele contro i licenziamenti. Inoltre, anche nel-
le graduatorie corrette dell’Ocse – ed è a queste che noi ci riferiamo nel no-
stro libro – l’Italia è comunque tra i paesi più rigidi. Lo si vede prendendo
in considerazione gli indici specifici per i contratti cosiddetti regolari, cioè
quelli a tempo indeterminato, non se invece si considerano i contratti tem-
poranei. D’altra parte la legislazione sui contratti a tempo indeterminato è
rimasta la stessa, come l’Ocse rileva, e infatti il punteggio dell’Italia è ri-
masto invariato dagli anni Ottanta in poi.
Anche la legislazione sui licenziamenti collettivi è molto restrittiva in Ita-
lia secondo le classifiche e i parametri dell’Ocse. Questi ultimi sono chia-
ramente delle misure perfettibili, come anche la nostra discussione di-
mostra, ma comunque sono in linea con le valutazioni che molti altri
hanno effettuato delle rigidità dei sistemi di protezione dell’impiego in
diversi paesi.
Ora, in Italia sono state fatte delle riforme importanti nel regime di pro-
tezione dell’impiego, legate appunto all’introduzione dei contratti tem-
poranei. Oggi i vari contratti atipici costituiscono il canale principale di
ingresso nel mondo del lavoro: sappiamo che il 70 per cento dei lavora-
tori sotto i 40 anni viene assunto tramite queste nuove formule contrat-
tuali. Per cui, quando l’Ocse nel corso del tempo aggiorna i suoi indica-
tori, è evidente che recepisce anche le novità della legislazione. E questo
spiega – come il professor Roccella avrebbe dovuto tener presente – la
diminuzione del punteggio attribuito all’Italia. Tale diminuzione è dovu-
ta unicamente ai contratti atipici, non ai contratti regolari, la cui rigidità
è rimasta uguale nel corso del tempo.
Fatta questa precisazione, perché definiamo la nostra proposta «contrat-
to unico»? Perché questo è il tipo di struttura che vorremmo assumesse
il mercato del lavoro in Italia. L’idea è che il contratto a tempo indeter-
minato deve tornare a essere la modalità principale di ingresso nel mer-
cato del lavoro, per tutti. Noi siamo contrari a dei trattamenti specifici
per i giovani, perché i trattamenti specifici sono quelli che spesso porta-
no a delle condizioni di dualismo e di segregazione. Credo che la lezione 119
principale che si debba trarre da ciò che è successo in tutti questi anni è
che, quando si creano dei regimi ad hoc per alcune categorie di lavorato-
ri, esiste sempre fortissimo il rischio di una segregazione.
Negli ultimi anni chi è entrato nel mercato del lavoro attraverso le colla-
borazioni coordinate e continuative, i contratti a progetto oppure i con-
tratti a tempo determinato, è sempre vissuto con la paura di veder inter-
rotto improvvisamente il rapporto di lavoro. E questa paura può anche
generare profezie che si autoavverano, perché i lavoratori che vivono ta-
li situazioni sono anche quelli con i minori incentivi alla formazione,
all’investimento nel proprio capitale umano, e quindi quelli che si trova-
no più esposti ai rischi del mercato.
Tutto ciò è molto importante per capire il significato della nostra propo-
sta. Non pensiamo che sia giusto proibire tutti gli altri contratti oggi esi-
stenti, perché tale misura comporterebbe il serio rischio di distruggere
posti di lavoro. Ciò che vogliamo fare è incentivare i datori di lavoro a
utilizzare il contratto a tempo indeterminato come modalità principale
di assunzione anche dei giovani, uscendo dunque dall’impasse e dal dua-
lismo che caratterizza l’attuale mercato del lavoro. A tal fine il nostro
schema suggerisce di uniformare i livelli base di garanzia per tutti i la-
voratori ed eliminare così quell’elemento di deterrenza all’assunzione co-
stituito dall’assetto dell’attuale contratto a tempo indeterminato. Così il
datore di lavoro non sarebbe più obbligato a impegnarsi fin dall’inizio in
un rapporto necessariamente di lunga durata nei confronti del lavorato-
re. Teniamo conto che negli ultimi anni la composizione della nostra for-
za lavoro è molto cambiata: ci sono molti immigrati, ci sono molte per-
sone su cui è anche difficile acquisire a priori delle informazioni adegua-
te per capirne la qualità lavorativa, e quindi mi pare ragionevole che il
datore di lavoro disponga di un certo periodo di tempo nel quale possa
acquisire informazioni sul lavoratore e valutarne le prestazioni.
Quanto alla critica mossa dal professor Roccella secondo la quale il nostro
contratto abbasserebbe le tutele, rispondo che non è affatto vero. Sicura-
mente le innalzerebbe moltissimo rispetto a coloro che entrano nel merca-
to del lavoro con le modalità attuali. Poiché è sicuramente molto più forte
la protezione garantita da un contratto a tempo indeterminato sul model-
lo del nostro «contratto unico», rispetto a quella garantita dai contratti di
collaborazione coordinata e continuativa (nella pubblica amministrazio-
ne) o dai contratti a progetto (nel settore privato). Nei casi appena citati
c’è chiaramente un impegno a portare a termine il contratto, ma non c’è
nessun tipo di vincolo o di costo che impedisca al datore di lavoro di di-
sfarsi semplicemente del lavoratore alla scadenza del contratto.
E questi contratti costituiscono oggi la modalità principale di ingresso nel
mercato del lavoro, di fronte alla quale la possibilità di un contratto a tem-
po indeterminato, con tutele crescenti nel corso del tempo e con un appro-
do ultimo nell’alveo della legislazione attualmente in vigore per i contratti
120 a tempo indeterminato, rappresenta senza dubbio un miglioramento con-
siderevole. Significa non avere più di fronte agli occhi una scadenza, con
tutti i disagi, anche a livello esistenziale, che questa comporta.
Roccella: Innanzitutto mi dispiace se il professor Boeri se l’è presa. Io – si
sa – discuto sempre con molto calore, ma voglio rassicurarlo che ho la mas-
sima stima per gli studiosi di altre discipline e in particolare per gli econo-
misti, tant’è che ho accettato di far parte della redazione della neonata rivi-
sta telematica Economia e politica. Quindi il problema non è questo; il pro-
blema è che quando si discute, soprattutto fra studiosi di diverse discipline,
bisogna avere un minimo di codice comunicativo comune. E non si possono
cambiare le carte in tavola. Ho davanti a me uno scritto di Emilio Rayneri,
che è uno dei più prestigiosi sociologi del lavoro italiani. Commentando
l’evoluzione dei dati Ocse di cui si è parlato, Rayneri dice testualmente:
«Dopo la revisione dell’indice Ocse, il valore di tale indice precipita a 1,8.
L’Italia risulta così sin dalla fine degli anni Ottanta tra i paesi europei ove i
rapporti di lavoro a tempo indeterminato sono meno protetti contro i licen-
ziamenti individuali». Perché, si faccia attenzione su questo punto, l’indice
Ocse è stato costruito sui rapporti di lavoro a tempo indeterminato. I lavori
atipici non c’entrano, sono un’altra cosa.
Per quanto concerne i licenziamenti collettivi, cui ha accennato il profes-
sor Boeri, una delle ragioni per la quale le analisi dell’Ocse sono sempre
apparse poco convincenti – almeno secondo una valutazione di tipo giu-
slavoristico – sta nel fatto che esse sono incentrate sui licenziamenti in-
dividuali, mentre per valutare il grado di rigidità di un mercato del lavo-
ro bisogna sempre ricordare che esistono due tipi di licenziamenti: gli in-
dividuali e, appunto, i collettivi.
Ebbene, al contrario di quanto ha appena sostenuto il professor Boeri,
nel nostro paese il licenziamento collettivo è facilissimo. La legislazione
in materia di licenziamenti collettivi si fonda su una direttiva europea al-
la quale il nostro paese si è uniformato, e lo ha fatto con ritardo e al li-
vello più basso possibile. Ciò che differenzia il nostro sistema di prote-
zione dell’impiego da quelli propri dei paesi più avanzati, come Francia
e Germania, è che in questi paesi gli imprenditori che vogliono effettua-
re un licenziamento collettivo sono obbligati a predisporre dei costosissi-
mi piani sociali di accompagnamento dei lavoratori licenziati. Da noi
non c’è nulla di tutto ciò. Da noi fare un licenziamento collettivo è la co-
sa più facile del mondo. Quindi, per favore, non scherziamo su queste
cose, che hanno un fondamento normativo ed empirico a tutti noto.
Ritorniamo al contratto unico. Ribadisco: qui davvero si rischia di parla-
re due linguaggi diversi. Non ha nessun senso comparare le mele con le
pere e dire, ad esempio, che alla scadenza di un contratto a termine il la-
voratore non ha diritto a nulla, mentre nel caso del contratto unico sin
dall’inizio avrebbe diritto a qualche cosa. Bisogna comparare situazioni
omogenee. Quello che è certo è che, se tu sei licenziato durante un con-
tratto a termine in maniera arbitraria, hai diritto a un risarcimento inte-
grale del danno, corrispondente alle retribuzioni del periodo sino al ter- 121
mine originario del rapporto, mentre nel caso del contratto unico venti-
lato da Boeri e Garibaldi, il risarcimento sarebbe veramente irrisorio.
Ma andiamo al punto di sostanza. La proposta del contratto unico viene
formulata come tentativo di superare la segmentazione del mercato del la-
voro, ma in realtà darebbe luogo a una segmentazione ben più profonda e
strutturale perché Boeri e Garibaldi immaginano che al termine del triennio
il datore di lavoro, avendo investito in capitale umano, sarebbe portato –
come dire? – quasi automaticamente a confermare il lavoratore in servizio
con tutte le tutele dell’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori. Ma le cose
non stanno affatto così: questa è una rappresentazione semplificata del
mercato del lavoro, come se esistessero imprese tutte identiche e lavoratori
tutti identici. In particolare l’offerta di lavoro è assolutamente diversificata:
ci sono lavoratori con competenze molto elevate ed altri con competenze
molto basse, destinati a mansioni per il cui espletamento è necessario e suf-
ficiente un brevissimo periodo di prova, non certamente tre anni come im-
maginano Boeri e Garibaldi. Pensate che per imparare a fare il cassiere di
un supermercato sia necessario un periodo di inserimento di tre anni? E
pensate che al termine del triennio non sarebbe molto più conveniente per
il datore di lavoro licenziare quel lavoratore e assumerne un altro, sempre
con clausola di licenziamento incorporata? La verità è che in questo modo
si finirebbe col creare una casta molto ristretta di lavoratori che accedereb-
bero al beneficio dell’articolo 18, circondata da un vastissimo settore del
mercato del lavoro che alla stabilità non arriverebbe mai. Allora sì, a quel
punto l’articolo 18 diventerebbe un privilegio e si creerebbero le condizioni
per la sua abrogazione definitiva.
Boeri: Io sono abituato a usare i dati ufficiali e non a citarli di seconda
mano attraverso i libri di altri. I dati Ocse ci dicono che sui licenziamen-
ti collettivi l’Italia ha un punteggio di 4,9, che mi sembra essere il pun-
teggio più alto tra i paesi europei.
Un fatto importante che è intervenuto nel nostro mercato del lavoro ne-
gli ultimi dieci anni è costituito dal considerevole aumento dei posti di
lavoro. È un risultato che a mio giudizio non va assolutamente perso: noi
dobbiamo riuscire a trovare un modo per garantire una serie di diritti e
tutele ai lavoratori, che siano però compatibili con la possibilità da par-
te del sistema di creare dei posti di lavoro. Ed è per questo che non pen-
siamo che la soluzione sia quella di buttare via tutto ciò che è stato fatto
negli scorsi anni.
Io non so quale sia la proposta del professor Roccella per superare il dua-
lismo del mercato del lavoro. Immagino, da ciò che dice, che lui propon-
ga di abolire tutti i contratti a termine, tutte le figure atipiche, e di la-
sciare come unica tipologia contrattuale il contratto a tempo indetermi-
nato. Questo ci riporterebbe esattamente alla situazione pre-’94, con le
relative patologie del sistema di allora, un livello di disoccupazione dop-
pio di quello attuale nel lungo periodo.
122 Bene, la nostra proposta è diversa. È una proposta che dà delle tutele de-
cisamente superiori a quelle di cui gode la maggior parte delle persone
che entra oggi nel mercato del lavoro. Il termine di paragone del nostro
«contratto unico» non può essere – come suggerisce il professor Roccella
– solo l’attuale contratto a tempo indeterminato, ma anche tutti quei
contratti atipici che oggi sono il principale canale di inserimento nel
mondo del lavoro.
Mi si chiede che cosa impedisce al datore di lavoro, dopo tre anni, di licen-
ziare il lavoratore? In primis ci sono questi sei mesi di indennità che do-
vrebbero essere corrisposti al lavoratore e che oggi non ci sono. Oggi il da-
tore di lavoro non deve pagare assolutamente nulla quando, al termine del
contratto, decide di non rinnovarlo. Tra l’altro i contratti a tempo determi-
nato e le collaborazioni coordinate e continuative hanno una durata media
di un anno, un anno e mezzo, quindi le mensilità residue nel caso di lin-
cenziamento prima della scadenza, di cui parlava prima il professor Roc-
cella, sono più o meno al livello dei pagamenti che noi prevediamo. Inoltre,
c’è il costo di formare un altro dipendente, un costo molto elevato. Infine –
ripeto – c’è anche da considerare il problema dei salari minimi, che è mol-
to importante, perché un conto è pagare sei mensilità a un salario di 5 eu-
ro l’ora, un altro conto è invece dover ottemperare a un minimo salariale
più consistente e pagare le indennità sulla base di quel minimo.
Detto questo, ripeto che il problema vero di fronte al quale ci troviamo è
di riuscire a valorizzare i risultati ottenuti negli ultimi dieci anni in ter-
mini occupazionali (forte incremento dell’occupazione e riduzione della
disoccupazione, in particolare della disoccupazione giovanile), eliminan-
do però le patologie che si sono venute a creare, prima fra tutte questo
dualismo del nostro mercato del lavoro. La nostra è una proposta che
cerca di portare aventi parallelamente entrambi questi obiettivi.
Roccella: Innanzitutto la questione della creazione dei posti di lavoro.
Come sicuramente il professor Boeri non ignora, questa tesi è molto con-
testata. Del resto, nello stesso libro di Boeri e Garibaldi si riconosce ciò
che tutti in realtà sanno, ovvero che buona parte dei nuovi posti di lavo-
ro è frutto dell’emersione dal sommerso dovuta alla regolarizzazione dei
lavoratori immigrati.
Questo è un punto davvero importante, perché non ci si può limitare a dire
che l’Italia sarebbe passata da una situazione di crescita senza occupazione
a una situazione di crescita dell’occupazione senza crescita economica. Beh,
qui ci sarebbe un vero e proprio salto di paradigma teorico che meriterebbe
di essere spiegato un po’ più accuratamente. Siccome non abbiamo il tem-
po di approfondire più di tanto, mi limito a dire che forse la questione è un
po’ più complicata di come la mettono Boeri e Garibaldi.
Forse la spiegazione dell’apparente crescita di posti di lavoro è di carat-
tere eminentemente statistico. Mi spiego cercando di semplificare molto:
quando cresce l’occupazione i lavoratori di solito stanno meglio perché
cresce anche il loro reddito. Invece è noto che le cose sono andate ben di-
versamente nel nostro paese. Allora si può avanzare l’ipotesi che in 123
realtà non siano stati creati più posti di lavoro – intendendo come tali i
posti di lavoro quanto meno a tempo pieno – ma ci sia stata solamente
una redistribuzione dell’occupazione fra figure lavorative precarie.
Ma se, invece che ragionare in termini rozzamente statistici, discutessi-
mo in termini di volume di occupazione, allora ci accorgeremmo che il
volume dell’occupazione non è affatto cresciuto, e questo spiega agevol-
mente perché i lavoratori stanno peggio e non meglio di prima.
Boeri dimostra ancora una volta di ignorare dati elementari del diritto
del lavoro. Ecco: supporre che io, o chiunque altro, voglia ritornare a
una situazione pre-’94 in cui sarebbe esistito soltanto il contratto di la-
voro a tempo indeterminato, questo sì è davvero un po’ offensivo.
In primo luogo, prima del 1994 non esisteva soltanto il contratto di la-
voro a tempo indeterminato: il contratto a termine, ad esempio, esiste da
tempo immemorabile e già prima del 1994 era stato ampiamente flessi-
bilizzato. Ma il punto non è questo. Il mercato del lavoro, va ribadito an-
cora una volta, non è una cosa omogenea; il mercato del lavoro è necessa-
riamente articolato, nel mercato del lavoro non esistono soltanto posti di
lavoro a tempo pieno e indeterminato. Io vorrei arrivare a una situazione
in cui, quando si è di fronte a esigenze produttive stabili, si venga assunti
con un contratto di lavoro a tempo indeterminato, mentre l’occupazione
temporanea sia riservata soltanto a rapporti di lavoro che rispondono a
esigenze obiettivamente temporanee. Poi – guardi come sono estremista –
vorrei arrivare a una situazione in cui, quando si svolge un rapporto di la-
voro dipendente, si sia assunti con un contratto di lavoro subordinato (e
non impiegati, in maniera truffaldina, come co.co.co. o lavoratori a pro-
getto, come avviene, ad esempio, nei call center), e quando si svolge un
rapporto di lavoro autonomo, si impieghi viceversa il contratto d’opera.
Ma chi sostiene, oltre a me, queste cose? Le sosteneva il programma
dell’Unione. Ecco, quello era un buon programma di politica del lavoro:
non è stato realizzato, e adesso è inutile discutere se per mancanza di vo-
lontà o di possibilità. Sappiamo come sono andate le cose in quel biennio,
sappiamo anche che quel governo aveva una maggioranza parlamentare
esigua. In ogni caso, la mia prospettiva è esattamente quella di una «ri-re-
golamentazione» del mercato del lavoro che distingua situazioni diverse,
ma anche che non sia ispirata da un falso riformismo.
Boeri: Di desideri è lastricata la via dell’inferno. Speravo in proposte, in-
vece ascolto solo slogan. Dire che sarebbe giusto che i contratti a tempo de-
terminato venissero usati per prestazioni genuinamente temporanee e che
i contratti di collaborazione coordinata e continuativa dovrebbero essere
riservati a dei rapporti di lavoro veramente autonomo è una bellissima co-
sa. Sono assolutamente d’accordo. Sappiamo benissimo, però, che questo
non avviene; e la ragione per cui non avviene è che non basta scriverlo in
una legge o in un programma elettorale. Bisogna trovare gli strumenti, gli
incentivi, le modalità per far sì che poi questo avvenga.
124 Manteniamoci ai fatti, a partire dalla questione dei volumi di lavoro. Le
ore lavorate in Italia nell’ultimo decennio sono aumentate assieme al nu-
mero di persone impiegate. Questi sono i dati sui volumi di lavoro. E ri-
tengo non ci siano altri modi di misurare il lavoro.
Certamente il fatto che si sia creato molto lavoro tramite questi contratti a
tempo determinato, legati spesso a salari molto bassi, ha fatto sorgere mol-
to malcontento in un numero assai elevato di lavoratori. La nostra proposta
cerca di affrontare questa insoddisfazione alla radice, indicando degli stru-
menti con i quali tali problemi possono essere risolti, cioè fornisce incentivi
all’assunzione a tempo indeterminato e scoraggia l’abuso di formule con-
trattuali improprie rispetto all’effettiva prestazione lavorativa. Secondo le
nostre stime, con il «contratto unico» che proponiamo il 90 per cento delle
assunzioni tornerebbero a essere a tempo indeterminato.
Rompere il dualismo presente nell’attuale mercato del lavoro dovrebbe
essere la priorità di ogni politica del lavoro oggi in Italia. Siamo di fron-
te a un’enorme questione generazionale, perché coloro che per primi pa-
gano sulla propria pelle l’attuale dualismo sono i giovani, che sistemati-
camente sono costretti a subire una condizione di discriminazione e infe-
riorità. Negli ultimi quindici anni il rapporto tra salari di ingresso e sala-
ri medi si è considerevolmente abbassato e le carriere lavorative sono di-
ventate discontinue. E tutto ciò rimanda al problema di sostenibilità nel
lungo periodo a cui ho fatto cenno nel mio primo intervento.
Formulando la nostra proposta abbiamo cercato di tenere conto delle
reazioni che il mercato ha di fronte a qualsiasi innovazione legislativa,
anche perché spesso in Italia – e le conseguenze sono sotto gli occhi di
tutti – si è legiferato ignorando questi problemi.
Io non credo che chi ha introdotto queste nuove tipologie contrattuali nel
nostro ordinamento pensasse che avrebbero generato una situazione di
dualismo così pronunciato, in cui per altro non vi è possibilità di comu-
nicazione e passaggio da un settore all’altro (da quello del lavoro preca-
rio a quello del lavoro stabile).
Tuttavia questo è ciò che è avvenuto e non possiamo non tenerne conto,
non possiamo non aggiornare le nostre analisi alla luce dei risultati
dell’esperienza e non calibrare le nostre proposte sulle previsioni che
possono essere effettuate con i nuovi dati di cui disponiamo.
C’è anche da ricordare, come dicevo all’inizio, che il contratto unico si
inserisce all’interno di un quadro organico di riforme che vanno dal sa-
lario minimo orario agli ammortizzatori sociali, di cui trattiamo in ma-
niera molto più approfondita nel nostro libro.
In queste settimane si sono lette anche altre proposte su questo argo-
mento. Per esempio quella di Ichino che, per come io ho avuto modo di
conoscerla, riprende in parte il principio che ha ispirato il nostro ragio-
namento, ovvero l’idea di costruire delle tutele progressive con la durata
dell’impiego e di aumentare anche il contenuto risarcitorio delle tutele
stesse, anch’esso peraltro proporzionato alla durata dell’impiego. Tutta-
via la proposta di Ichino non prevede che il lavoratore, alla scadenza del 125
terzo anno, cominci a godere della protezione dell’obbligo di reintegro in
caso di licenziamento senza giusta causa. Questa mi sembra la differen-
za più importante che c’è tra le due proposte. La nostra mantiene in vi-
gore l’articolo 18, che scatta dopo il terzo anno di contratto: a quel pun-
to, infatti, non crediamo che possa costituire un deterrente all’assunzio-
ne, e quindi può benissimo rimanere all’interno del nostro ordinamento.
D’altra parte anche Ichino avverte la necessità di rafforzare il nostro si-
stema di ammortizzatori sociali. Per fortuna questa questione è final-
mente entrata nel lessico e nella discussione politica in Italia, dopo anni
in cui si è colpevolmente sottovalutato il problema.
Non mi sembra invece che Ichino nella sua bozza affronti la questione del
salario minimo. Per noi è parte integrante della riforma. Il contratto unico
agisce sulla quantità e stabilità del lavoro. Il salario minimo sulla sua remu-
nerazione. Sul salario minimo era uscita prima delle elezioni una proposta
del leader del Pd Veltroni, ma francamente non era molto chiara.
Roccella: Che cosa si può dire in conclusione? Si può provare a formu-
lare una valutazione degli effetti che le proposte di Boeri e Garibaldi
avrebbero sul mercato del lavoro italiano.
Ma per fare questa valutazione è necessario prima chiedersi a che cosa ser-
vano le regole di diritto del lavoro, in particolare le protezioni contro il li-
cenziamento. Ora, dopo anni di studi e ricerche, non c’è nessuna evidenza
empirica che sia stata in grado di dimostrare un qualche nesso fra regimi di
protezione dell’occupazione e andamento dei livelli occupazionali. La verità
è un’altra: le protezioni contro il licenziamento rafforzano i lavoratori nel
rapporto di lavoro e, ovviamente, rafforzano la loro propensione a iscriver-
si al sindacato, rendendone così più forte la capacità rivendicativa.
Ora, con una prospettiva come quella delineata da Boeri e Garibaldi,
tutto questo rischierebbe di scomparire nel giro di pochi anni. È del tut-
to evidente che lavoratori sottoposti al ricatto del licenziamento, nel pe-
riodo di inserimento triennale si guarderebbero bene dall’iscriversi al
sindacato. Ma in realtà se ne guarderebbero bene anche dopo, perché
nell’eventualità di un licenziamento successivo dovrebbero ricominciare
la via crucis di un nuovo inserimento nel mercato del lavoro, sempre con
un contratto apparentemente a tempo indeterminato, ma in realtà strut-
turalmente precario. E l’effetto sarebbe veramente devastante perché,
come lo stesso Boeri ha confermato, qui non si tratta di una formula di
inserimento per i giovani; qui si tratta di una formula contrattuale ap-
plicabile a tutto il mercato del lavoro.
Da un punto di vista politico, che dire? Qui le valutazioni sono piuttosto
sconsolate. Mentre sul versante dell’opposizione parlamentare si riprende a
discutere sulla necessità di mettere mano (nel senso di «manomettere»)
all’articolo 18, sul versante della maggioranza di governo si procede diritti
come un carro armato. Mentre da parte dell’opposizione ci si balocca con
queste proposte astratte e astruse, il governo sta infatti per approvare – è
126 proprio questione di pochi giorni – un progetto di legge che inciderà in ma-
niera radicale sul nostro diritto del lavoro e sull’effettività dei diritti dei la-
voratori. Si tratta dell’introduzione di una forma di arbitrato sostanzial-
mente obbligatorio e per giunta di equità (dunque con piena libertà per gli
arbitri di non applicare le norme di legge e di contratto collettivo, bensì di
decidere la controversia secondo discrezionali criteri di giustizia), che ver-
rebbe consentito attraverso la stipulazione stessa del contratto individuale
di lavoro, quindi nel momento di massima debolezza del lavoratore. Per
questo sarà, di fatto, un arbitrato obbligatorio.
A quel punto stia pur tranquillo il professor Boeri che il problema dell’ar-
ticolo 18 e qualsiasi altro problema di effettività delle norme lavoristiche
non si porrà più, perché diventerà impossibile andare davanti a un giudi-
ce per rivendicare la tutela dei propri diritti. In questo modo anche i pro-
fessori Boeri e Garibaldi potranno essere soddisfatti, perché qual è la pro-
spettiva strategica che si percepisce in maniera assolutamente nitida da
queste proposte? È il tentativo di evitare la possibilità che i diritti dei la-
voratori possano essere resi effettivi attraverso la contestazione giudizia-
ria. La logica del contratto unico, appunto, porta a questo se, pur di fron-
te a un licenziamento che in via di principio risulta privo di giustificato
motivo, qualsiasi contestazione giudiziaria è inutile, perché il legislatore
preventivamente ha già stabilito che cosa il lavoratore può ottenere una
volta dimostrata l’eventuale illegittimità del licenziamento.
Anzi, un problema di illegittimità non si pone più neppure, perché tutto
quello a cui il lavoratore avrebbe diritto è un’attribuzione patrimoniale ri-
sarcitoria predefinita. E, badate bene, che si tratti di una logica coerente ed
omogenea lo dimostra proprio la proposta in tema di salario minimo, che
sarebbe interessante discutere nel dettaglio, ma non è questa la sede. Mi li-
mito a porne in rilievo soltanto un punto: il salario minimo del professor
Boeri, che di per sé mi vedrebbe d’accordo (tanti anni addietro io sostenni
un’ipotesi di introduzione nell’ordinamento di un salario minimo legale),
costituisce un altro esempio di riformismo capovolto. Il salario minimo del
professor Boeri sarebbe un salario più basso di quello previsto nei contratti
collettivi nazionali di lavoro e comporterebbe la conseguenza, assolutamen-
te molto significativa per i datori di lavoro, di rendere impossibile il ricorso
al giudice per vedersi riconosciuto un salario corrispondente a quello previ-
sto nei contratti collettivi. Ecco, in questi termini è evidente che risultereb-
be inaccettabile per i sindacati: ancora una volta si tratterebbe di una pro-
posta che minerebbe alla radice l’effettività dell’azione sindacale nel nostro
paese. Per questo ho parlato di riformismo capovolto.
(a cura di Emilio Carnevali)
Potrebbero piacerti anche
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeDa EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeValutazione: 4.5 su 5 stelle4.5/5 (20015)
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeDa EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeValutazione: 4 su 5 stelle4/5 (5794)
- The 7 Habits of Highly Effective People: The Infographics EditionDa EverandThe 7 Habits of Highly Effective People: The Infographics EditionValutazione: 4 su 5 stelle4/5 (2475)
- Art of War: The Definitive Interpretation of Sun Tzu's Classic Book of StrategyDa EverandArt of War: The Definitive Interpretation of Sun Tzu's Classic Book of StrategyValutazione: 4 su 5 stelle4/5 (3321)
- Habit 1 Be Proactive: The Habit of ChoiceDa EverandHabit 1 Be Proactive: The Habit of ChoiceValutazione: 4 su 5 stelle4/5 (2556)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItDa EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItValutazione: 4.5 su 5 stelle4.5/5 (3275)
- American Gods: The Tenth Anniversary EditionDa EverandAmerican Gods: The Tenth Anniversary EditionValutazione: 4 su 5 stelle4/5 (12945)
- Habit 3 Put First Things First: The Habit of Integrity and ExecutionDa EverandHabit 3 Put First Things First: The Habit of Integrity and ExecutionValutazione: 4 su 5 stelle4/5 (2507)
- The 7 Habits of Highly Effective PeopleDa EverandThe 7 Habits of Highly Effective PeopleValutazione: 4 su 5 stelle4/5 (2566)
- Pride and Prejudice: Bestsellers and famous BooksDa EverandPride and Prejudice: Bestsellers and famous BooksValutazione: 4.5 su 5 stelle4.5/5 (19653)
- Habit 6 Synergize: The Habit of Creative CooperationDa EverandHabit 6 Synergize: The Habit of Creative CooperationValutazione: 4 su 5 stelle4/5 (2499)
- How To Win Friends And Influence PeopleDa EverandHow To Win Friends And Influence PeopleValutazione: 4.5 su 5 stelle4.5/5 (6520)
- The 7 Habits of Highly Effective PeopleDa EverandThe 7 Habits of Highly Effective PeopleValutazione: 4 su 5 stelle4/5 (353)
- The Iliad: A New Translation by Caroline AlexanderDa EverandThe Iliad: A New Translation by Caroline AlexanderValutazione: 4 su 5 stelle4/5 (5718)
- Remarkably Bright Creatures: A NovelDa EverandRemarkably Bright Creatures: A NovelValutazione: 4.5 su 5 stelle4.5/5 (5483)
- The Perfect Marriage: A Completely Gripping Psychological SuspenseDa EverandThe Perfect Marriage: A Completely Gripping Psychological SuspenseValutazione: 4 su 5 stelle4/5 (1107)
- Wuthering Heights (Seasons Edition -- Winter)Da EverandWuthering Heights (Seasons Edition -- Winter)Valutazione: 4 su 5 stelle4/5 (9486)




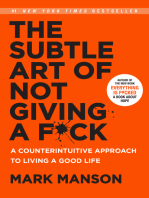









![American Gods [TV Tie-In]: A Novel](https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/audiobook_square_badge/626321117/198x198/22ab6b48b6/1712683119?v=1)