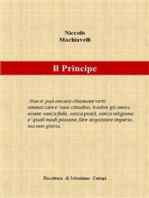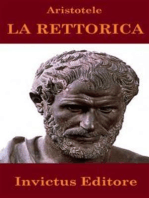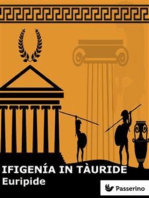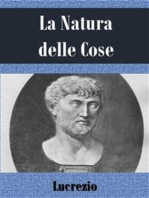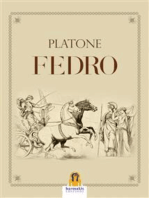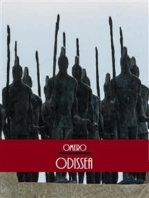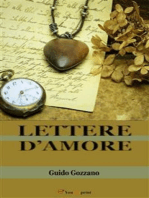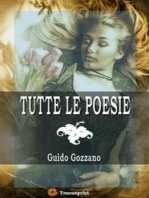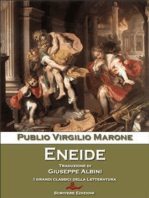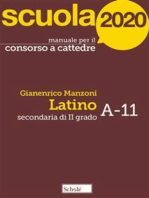Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
Paniere Domande Aperte
Caricato da
Valentina MancusoCopyright
Formati disponibili
Condividi questo documento
Condividi o incorpora il documento
Hai trovato utile questo documento?
Questo contenuto è inappropriato?
Segnala questo documentoCopyright:
Formati disponibili
Paniere Domande Aperte
Caricato da
Valentina MancusoCopyright:
Formati disponibili
lOMoARcPSD|5715493
Esame 13 Settembre 2019, domande+risposte
Lingua e letteratura latina (Università degli Studi di Bergamo)
StuDocu non è sponsorizzato o supportato da nessuna università o ateneo.
Scaricato da Marianna Tallarico (mariaanna.tallarico@hotmail.it)
lOMoARcPSD|5715493
LEZIONE 11
Cause della decadenza della lingua latina.
Dal punto di vista della lingua letteraria la lingua latina si mantiene sino al sec. VIII
ma dal punto di vista della lingua parlata la divisione dell’Impero introdotta da Diocleziano
porta al delinearsi dei primi confini linguistici e sviluppi autonomi.
Poi dal 476, anno della fine dell’Impero romano d’Occidente, la situazione cambia:
se nella parte orientale dell’Impero il latino non era mai diventato la prima lingua,
nella parte Occidentale, invece, il latino come lingua di Roma muore,
poiché in tutte le regioni, in seguito alla frantumazione della vecchia unità politica,
si costituiscono unità linguistiche minori,
e in alcune regioni il sopraggiungere di nuovi popoli (i ‘barbari’)
determina la sovrapposizione e l’affermazione di una nuova lingua, quella dei vittoriosi,
che fa scomparire qualsiasi traccia di latino.
Quali istituzioni garantiscono la sopravvivenza del latino nel Medioevo?
-Il mantenimento di un sistema amministrativo affidato a funzionari latini
in molti regni romano barbarici es. Ostrogoti in Italia,
-Istruzione scolastica ancora fondata su grammatica e retorica
-Il cristianesimo, in cui il latino è la lingua tecnica e letteraria che agisce come superstrato
ma nel contempo subisce l’influenza dei nuovi ambienti,
sia in forma di forestierismi, che di calchi linguistici.
LEZIONE 12
Illustra il concetto di "tradizione dei classici".
-Tradizione diretta: Testo che ci è stato trasmesso da una o più copie.
I testimoni nella loro intenzione vogliono riprodurre l’originale
ma ovviamente prima del 1450 si tratta di copie manoscritte,
e in quanto tali necessariamente uniche e diverse l’uno dall’altro,
anche se anche le edizioni a stampa, soprattutto nei primi periodi,
possono presentano testimoni diversi l’uno dall’altro.
Nella tradizione classica latina però nulla ci è arrivato in originale ma solo tramite copie
il che ha prodotto lievi o meno lievi alterazioni.
-Tradizione indiretta: citazioni e testimonianze di un’opera che si trovano nelle opere di altri scrittori.
Essa permette di conoscere opere che altrimenti non conosceremmo
perché nessuna copia ne è stata conservata.
La tradizione dei classici si è trasmessa prima tramite papiro, poi tramite codex,
infine con l’invenzione della stampa dopo la metà del 400 a stampa.
Ovviamente la trasmissione di un testo nei secoli comporta incidenti di percorso
dovuti all’usura del tempo, a eventi storici o naturali, all’uomo
e da qui dunque la necessità di stabilire un testo scientificamente attendibile per i filologi
tramite recensione, emendazione, fino alla creazione di un’edizione critica,
ovvero un testo ricondotto alla forma il più possibile vicina alle intenzioni dell’autore.
LEZIONE 13
Cosa si intende per 'strati' della lingua?
Nel latino di ogni fase possiamo trovare diversi strati o livelli stilistici:
- lingua letteraria, che si distingue in lingua della prosa e lingua poetica;
- lingue tecniche delle varie attività (agricola, giuridica, sacrale, politica, militare).
- lingua d’uso della conversazione e della corrispondenza
(che spesso ricorre a termini tecnici);
- lingua volgare: la lingua degli indotti,
di cui abbiamo testimonianze filtrate attraverso la lingua scritta, in iscrizioni,
presso grammatici che ci documentano errori popolari.
Accanto a questi ‘strati’ della lingua vi è poi il latino volgare,
ossia la lingua letteraria ed ecclesiastica che sopravvive fino alla fine del Medioevo.
Scaricato da Marianna Tallarico (mariaanna.tallarico@hotmail.it)
lOMoARcPSD|5715493
LEZIONE 14
In cosa si differenzia la lingua letteraria poetica da quella della prosa?
-La lingua letteraria della poesia prevede un testo in versi che segue le regole della metrica
e può essere di diversi generi: tono alto per tragedia e epica; medio per elegia; umile per commedia e satira
-La lingua letteraria della prosa viene usata per oratoria (che ha punti in contatto con la lingua d’uso), storiografia (che
ha punti di contatto con la poesia) e trattatistica (spesso linguaggio tecnico)
Stile attico e stile asiano: caratteri ed esponenti.
In età classica vi furono due scuole di retorica, su modello della cultura ellenistica, a Roma:
-Asianesimo/stile asiano, che si diffuse a Roma nel II sec. a.C., proveniva dall’Oriente,
che ricorreva a figure retoriche, a una certa ampollosità della frase,
ed a elementi sentimentali e patetici cercando di muovere le corde emotive dell’uditorio.
-Atticismo/stile attico, assume come modelli gli oratori attici del V e IV sec. a.C,
prevede uno stile scarno e severo, che si concentri maggiormente sul contenuto che sulla forma,
anche se la forma non era dimenticata: si doveva ottenere un discorso efficace, chiaro, essenziale, elegante.
Tra i sui esponenti ricordiamo Giulio Cesare.
Il potente mezzo di affermazione dello stile attico fu la scuola poiché vi si insegnava
un greco piano, chiaro, aderente alle regole e ai modelli, scritto in dialetto attico.
Figure retoriche di suono, di posizione, semantiche...
FIGURE DI SUONO:
- Allitterazione: ripetizione di suoni all’inizio o all’interno di parole consecutive
- Poliptoto: accostamento della medesima parola con desinenze diverse
- Omoteleuto: uguale terminazione delle parole in successione
- Anafora: ripetizione di una o più parole all’inizio di segmenti di testo
-
FIGURE DI POSIZIONE:
-Enjambement: elemento sintattico della frase continua nella prima parola del verso successivo (poesia)
-Anastrofe: inversione dell’ordine naturale delle parole
-Iperbato: inversione dell’ordine naturale delle parole con inserimento di altri elementi
-Chiasmo: gli elementi costitutivi della frase sono disposti a forma di X
creando un incrocio immaginario tra due coppie di parole (versi o prosa): A, B, B, A
-Parallelismo: al contrario del chiasmo prevede la disposizione di parole in serie simmetriche: A, B, A, FIGURE
SEMANTICHE:
-Climax: disposizione delle parole in gradazione, crescente o decrescente
-Ossimoro: accostamento di parole di significato contrario
-Metafora: similitudine abbreviata (senza cioè elementi che introducono il paragone)
che trasferisce il significato di una parola dal senso proprio al senso figurato
-Metonìmia: tipo di metafora con cui si sostituisce un termine con un altro in contiguità con il primo. es. effetto per causa
-Sineddoche: trasferimento di significato con estensione o restringimento del significato di una parola
es. il tutto per la parte, o la parte per il tutto.
- Ipallage: attribuire a un termine una qualificazione, determinazione o specificazione che spetterebbe al termine vicino.
In genere riguarda l’aggettivo attribuito a un sostantivo e in questo caso si parla anche di enallage
es. le mura dell’alta Roma, invece di le alte mura di Roma.
FIGURE SINTATTICHE:
-Accumulatio: elencare in modo ordinato e coerente o caotico e casuale di più parole, immagini o aggettivi
-Endiadi: coordinazione di due termini per esprimere un unico concetto
-Concordanza ad sensum: concordare un verbo nella forma del plurale con un termine che,
pur essendo di forma singolare, esprime una valenza di pluralità
Litote: attenuazione di un concetto mediante la negazione del contrario.
Enfasi: dare particolare rilievo espressivo a una parola o ai passi salienti di un discorso o di uno scritto.
Scaricato da Marianna Tallarico (mariaanna.tallarico@hotmail.it)
lOMoARcPSD|5715493
LEZIONE 15
Esempi di mimesis nei confronti del mondo greco nella lingua poetica latina.
I primi autori di letteratura latina sono anche grammatici,
hanno studiato le teorie stilistiche e grammaticali greche
ed hanno contribuito con le loro opere a diffonderle,
come attesta anche il lessico tecnico grammaticale latino, che adotta in larghissima misura termini greci.
Il teorico per eccellenza è Aristotele, che si dedicò allo studio della tradizione poetica e letteraria greca:
per lui la lingua deve essere chiara, diversa per poesia e prosa, adeguata al genere.
I concetti di imitatio / contaminatio e plagio nella cultura classica.
La lingua letteraria presuppone l’esistenza di modelli letterari,
che sono un riferimento costante per esaminare l’aderenza / il distacco del singolo
e dunque per definire lo stile personale di un autore.
Nel mondo antico un principio cardine dell’espressione letteraria era l’Imitatio,
che non va intesa secondo i termini moderni del plagio letterario
ma che va calata entro la dimensione classica di rispetto di una tradizione:
nella poesia l’imitazione, lungi dall’essere un demerito, era obbligatoria.
Questo si riferisce non solo all’ambito latino, ma attinge anche dalla tradizione greca,
infatti l’influsso di Omero e della sua lingua considerata la lingua poetica ideale,
fu importantissimo per la lingua poetica latina.
LEZIONE 16
Il condizionamento metrico nella lingua poetica va inteso come un elemento coercitivo e limitante?
La lingua poetica è diversa da quella della prosa
perchè la necessità di rispettare le regole prosodiche impone una serie di condizionamenti stringenti:
la successione obbligata di sillabe brevi e lunghe bandisce l’uso di certe parole e agevola l’impiego di altre.
Già grammatici antichi imputavano a tale condizionamento
la maggior libertà concessa alla lingua della poesia:
soprattutto l’esametro, metro importato dalla Grecia,
crea difficoltà alla lingua latina che presenta un minor numero di sillabe brevi rispetto alla greca
e dunque determinate parole dovevano essere eliminate o modificate.
Ma il condizionamento metrico non opera solo a livello del lessico:
a livello della morfologia troviamo delle forme assolutamente artificiali e non corrette grammaticalmente.
Quali sono gli strumenti a disposizione della ricerca espressiva in poesia.
Il massimo obiettivo della lingua poetica è la ricerca di espressività
attraverso un’elaborazione linguistica che comprende:
-ampio ricorso alle figure retoriche (anche della lingua della prosa, ma nella poesia è spinto all’estremo),
soprattutto metafore, che sono un buon strumento per la variatio e per aggirare difficoltà metriche;
-predilezione per la paratassi ;
-eliminazione di parole “vuote” come preposizioni o congiunzioni
-designazione dei soggetti mediante patronimico
-linguaggio figurato.
L’insieme di questi espedienti non agevola la comprensione,
ma l’artificialità e l’esclusività rientrano pienamente nei canoni classici della poesia.
Scaricato da Marianna Tallarico (mariaanna.tallarico@hotmail.it)
lOMoARcPSD|5715493
LEZIONE 17
Lingua d'uso, Tecnicismo, Espressività, Lingua letteraria:
illustra le caratteristiche e le azioni di questi concetti nella lingua.
Il linguista Aldo Luigi Prosdocimi ha individuato 4 forze attive all’interno della lingua:
lingua d’uso ed espressività e tecnicismo e lingua letteraria,
ognuna delle quali agisce in modo diverso e con forza diversa all’interno della storia della lingua.
Lingua d’uso è una lingua che agisce sotto la spinta dell’affettività e dell’espressività.
Le attestazioni di lingua d’uso si ritrovano nei generi comici che mirano a mostrare la realtà quotidiana
e lo statuto stilistico è umile e basso.
Il linguaggio tecnico si caratterizza per:
-precisione e definizione obbiettiva, dunque estranei ad intenti espressivi od emotivi
-comprensibilità: cercano il termine più adatto a descrivere un oggetto o concetto
anche a costo di ricorrere ad altre lingue,
quindi non si preoccupano del purismo linguistico
-standardizzazione: struttura sintattica semplice e semplificata con formule memorizzabili e ripetibili
L’importanza del tecnicismo muta nel tempo
e la sua forza è inversamente proporzionale al peso della tradizione della lingua letteraria:
se la tradizione letteraria è alta, essa fa da barriera alla penetrazione del tecnicismo.
Sopravvivenza del latino come lingua tecnica: illustra e chiarisci questa espressione.
Il latino perdurò nel corso del Medioevo e dell’età moderna come lingua tecnica:
- nell’Alto Medioevo era la lingua della cultura, degli uomini di potere,
la lingua della Chiesa e del rito (per quanto incomprensibile alle masse),
dunque qualsiasi fosse la lingua parlata, se si scriveva si usava il latino.
- Nel pieno Medioevo, con l’affermarsi dei volgari nazionali anche a livello scritto e letterario,
il latino permane come lingua di certi settori culturali: la chiesa, la scienza, il diritto.
In questo senso sopravvive come lingua tecnica,
sempre più isolata e distaccata dagli usi linguistici correnti.
- Nel Basso Medioevo conosce una ripresa con gli umanisti e gli esponenti del Rinascimento
- Il latino sopravvive fino ad oggi come lingua specifica della cancelleria pontificia
e della produzione letteraria papale (le encicliche).
Scaricato da Marianna Tallarico (mariaanna.tallarico@hotmail.it)
lOMoARcPSD|5715493
LEZIONE 18
Figure retoriche ed elementi tipici della lingua d'uso.
Anafora, iperbole, metafora, anacoluto.
Caratteristiche della lingua d'uso.
- tendenza a ricorrere ad espressioni di tenerezza, che sostituiscono espressioni logiche e precise;
- tendenza da evitare i concetti astratti e predilezione per un realismo anche crudo;
- tendenza all’esagerazione e all’iperbole;
- tendenza alla contaminazione di espressioni e locuzioni:
mescolanze sintattiche, fonetiche, morfologiche, che spesso sfociano nell’anacoluto.
- avversa alla subordinazione: predilige la libera aggregazioni di frasi, senza collegamento di particelle.
- avversa alla coordinazione : elimina le congiunzioni e fa seguire le brevi frasi in modo giustapposto
per rendere l’eloquio eccitato ed emotivo
A livello di lessico, la lingua d'uso si contraddistingue per...
-ricorso alle espressioni di tenerezza,
-espressioni esagerate e intensificate per rendere il tono emotivo,
- metafore con un tipo di esagerazione popolare
che equipara completamente l’oggetto del paragone con ciò che viene assunto come termine,
- selezione nel campo degli aggettivi:
tutti quelli che indicano qualità astratte o intellettuali sono evitati e sostituiti da perifrasi
oppure assunti ma ‘rinforzati’ per adattarli alle proprie esigenze.
In quali ambiti letterari latini è più facile trovare attestazioni della lingua d'uso?
Nella tradizione latina le attestazioni di lingua d’uso sono offerte dalla lingua dei generi comici,
che mira alla rappresentazione di realtà quotidiane e ha uno statuto stilistico di tipo umile o basso.
LEZIONE 19
Fenomeni tipici del latino volgare.
-Cambiamento riguardo alle vocali:
da un sistema fondato sulla durata nel latino classico
(le vocali lunghe avevano una durata doppia rispetto alle brevi
e questo bastava per distinguere i significati di due parole)
si passa a un sistema fondato sulla qualità vocalica/ apertura
(le vacali breve tendono ad aprirsi e le lunghe tendono a chiudersi-> vocali aperte-chiuse)
-Generi maschile, femminile e neutro diventano maschile e femminile-> declino del neutro
-Da verbi attivi, passivi e deponenti (forma passiva con significato attivo)
a deponenti che rientrano nella categoria degli attivi.
-Comparativi e superlativi sono resi con suffissi che generano forme sintetiche
-Confusione tra forme della V e I declinazione e assorbimento della IV declinazione nella II
-Accusativo soppianta in nominativo.
Per latino volgare si intende...
Con latino volgare si intende il latino scritto che, nelle sue devianze dalla norma,
asseconda o tradisce la lingua parlata dalla maggioranza incolta.
La definizione «latino volgare» non è stata inventata dagli studiosi moderni:
già nella bassa antichità e nei primi secoli del Medioevo
si indicava il linguaggio del popolo in opposizione al linguaggio letterario
con gli appellativi lingua «rustica» o «volgare».
Scaricato da Marianna Tallarico (mariaanna.tallarico@hotmail.it)
lOMoARcPSD|5715493
LEZIONE 20
Caratteristiche del latino medievale.
La nostra conoscenza del latino medievale, come per quello classico,
si basa essenzialmente su fonti letterarie
anche se esse non erano impermeabili nei confronti della lingua parlata.
Inoltre, in età medievale entra in gioco anche il ruolo della scuola
poiché il latino medievale nasce dall’esperienza scolastica e sullo studio della Bibbia e del Salterio.
Il latino medievale era caratterizzato da un ampio vocabolario,
formatosi dalla confluenza nel latino di parole provenienti dal lessico di numerose altre lingue.
In particolare è stato fortemente influenzato dalla lingua della Vulgata,
che contiene peculiarità aliene alla lingua latina classica,
conseguenza di una più o meno stretta correlazione con il greco e l'ebraico.
Numerose parole furono assunte anche dal lessico del germanico
parlato dalle diverse popolazioni germaniche che migrarono in direzione dell'impero romano.
Si creano anche nuovi generi:
-agiografia (Atti dei martiri, Passioni, Vite di Santi)
-libri liturgici (Bibbia, Salterio, sermonari, confessionari, raccolte di exempla, inni)
-libri fantastici (letteratura apocalittica, scritti su Visioni)
Illustra la posizione di Agostino relativamente alla cultura classica
La Chiesa, di fronte al quadro storico mutato, dovette decidere:
rottura completa con il passato pagano o assorbimento e accettazione?
Prevalse la soluzione di Agostino, a cui dobbiamo la nostra conoscenza della letteratura classica.
Agostino infatti sosteneva che il sapere dei filosofi non era da respingere nella loro totalità:
se vi erano idee vere e conforme alla fede cristiana esse andavano rivendicate ai cristiani
poiché loro le possedevano ingiustamente.
Allo stesso modo sosteneva che le dottrine dei Gentili non contenevano solo false superstizioni
ma esse contenevano anche arti liberali, precetti utili alla morale, alcune verità sul culto dell’unico Dio.
Caratteristiche del latino cristiano
Con latino cristiano si intende la lingua usata dai cristiani dal II sec d.C e propria della letteratura cristiana.
E’ una lingua ricca di tecnicismi derivanti da ebraico e greco
o collegati alle nuove concezioni della religione cristiana (cristianismi).
Al suo interno vi sono diversi registri:
latino cristiano letterario tipico della letteratura cristiana antica e medievale;
latino cristiano scritto ma di stile più umile destinato alla predicazione popolare;
latino cristiano parlato che coincide con il latino volgare.
Scaricato da Marianna Tallarico (mariaanna.tallarico@hotmail.it)
lOMoARcPSD|5715493
Esame 13 Settembre 2019, domande+risposte
Lingua e letteratura latina (Università degli Studi di Bergamo)
StuDocu non è sponsorizzato o supportato da nessuna università o ateneo.
Scaricato da Marianna Tallarico (mariaanna.tallarico@hotmail.it)
lOMoARcPSD|5715493
LEZIONE 21 e 22 - > no domande aperte
LEZIONE 23
Funzione della sententia nello stile di Seneca.
Lo stile di Seneca è anticiceroniano perché basato sulla frase, sulla sententia,
mentre nell’epoca di Cesare e di Cicerone era il periodo.
Seneca ebbe grande successo tra i giovani ma in molti criticarono il suo stile e i suoi contenuti
(Quintiliano, Frontone, imperatore Caligola, i padri della Chiesa)
perché considerati una moda pericolosa e traviante.
Nel Medioevo Seneca fu conosciuto in modo indiretto e imperfetto, confondendolo con Seneca padre,
tuttavia i suoi scritti morali furono apprezzati e copiati,
ma la sua fortuna si sviluppa nel teatro elisabettiano (Marlowe, Shakespeare), nel teatro romantico tedesco,
nel teatro classico francese (Racine, Corneille) e presso gli illuministi es. Voltaire.
Perché possiamo dire che in Agostino convivono tradizione pagana e cristiana?
Agostino, dopo essere cresciuto studiando la tradizione e la sapienza antica, si converte,
ponendo il problema di dover rinnegare o meno quel sapere precedente per aderire alla parola di Cristo.
La sua soluzione comportava un riversamento di tutta la tradizione classica nella matrice giudaico-cristiana
e questo segnerà tutta l’identità culturale dell’Occidente.
Agostino fu per molto tempo il più autorevole padre della Chiesa,
e la sua influenza si è manifestata nell’ambito della Chiesa, della filosofia e della letteratura.
Egli fu influente anche nel pensiero filosofico dell’Umanesimo,
in virtù della rinascita del pensiero platonico che caratterizzò il XV e il XVI secolo.
Successivamente anche Cartesio e Pascal ne ripresero alcune tematiche.
Anche la letteratura italiana deve molto ad Agostino per quanto riguarda
la letteratura autobiografica di introspezione psicologica, di analisi interiore, e memoriale.
Illustra le tappe fondamentali nella tradizione manoscritta dei testi classici
Vi furono tappe fondamentali nella trascrizione dei manoscritti classici:
- fra il II e il IV secolo d.C. si registrò la “codificazione”
cioè il definitivo passaggio dal papiro in rotolo (volumen)
alla pergamena ripiegata e tagliata in fogli (codex);
- VI-VIII sec vi fu la copiatura dei classici negli scriptoria monastici
- fra l’VIII e il IX la rinascita culturale promossa da Carlo Magno
e l’universale affermarsi della scrittura minuscola, detta perciò carolina, condusse alla
traslitterazione dei precedenti codici nella nuova scrittura;
- Università nel XII sec;
- Umanesimo nel XIV – XV sec;
- tra la fine del XV e il XVI secolo si ebbe la traslitterazione
dal libro manoscritto al libro stampato
Eneide e impegno politico del poeta.
L’Eneide diventò immediatamente il poema epico nazionale e un testo di studio scolastico
(come lo era stato per l’Iliade e l’Odissea).
La fama di Virgilio continua nel Medioevo, anche per alcune distorte interpretazioni delle sue opere:
venne infatti considerato un profeta dell’avvento di Cristo.
Al contrario gli Umanisti ne ebbero una visione più storicizzata e filologicamente corretta.
L’Eneide oltre ad essere la più famosa opera letteraria latina
è riflesso di una nuova epoca della storia di Roma,
anche se la sensibilità poetica di Virgilio impedisce al poema di divenire una mera propaganda politica
divenendo piuttosto il sunto della Storia di Roma
e delle attese nei confronti del futuro che, per Virgilio, non paiono essere nelle mani degli uomini.
Scaricato da Marianna Tallarico (mariaanna.tallarico@hotmail.it)
lOMoARcPSD|5715493
LEZIONE 24
Illustra il significato e l'importanza dell'Eneide.
Il poema dell’Eneide nacque sia per soddisfare la richiesta di Augusto
di creare un'opera che narrasse la grandezza di Roma,
sia da un'esigenza personale del poeta di trattare il dato storico.
Per evitare di creare un'opera che fosse incentrata esclusivamente sulla figura di Augusto,
Virgilio fece conciliare l'elemento storico con quello mitologico
e riuscì a farlo anche attraverso l'inserimento delle profezie, in particolare nei libri I e III.
Perché l'Eneide è stata definita poema dei vinti?
E’ definito “poema dei vinti” perché molte vite vengono sacrificate affinché Enea raggiunga il suo scopo. Una dei
vinti è Didone, regina di Cartagine, la quale si innamora perdutamente di Enea.
Quando l'eroe decide di ripartire per l'Italia, in preda alla disperazione, lei si toglie la vita.
Metti a confronto la figura di Ulisse con quella di Enea.
Il protagonista dell’Eneide è un eroe in viaggio, come Ulisse nell’Odissea di Omero,
e il suo viaggio presenta forti analogie con quello omerico sia per alcuni episodi, che per alcuni personaggi. Tuttavia,
se confrontiamo i due eroi, prevalgono le differenze:
-Il viaggio di Ulisse è un ritorno, quello di Enea un’andata
-L’obbiettivo di Ulisse è la patria, la casa, la famiglia;
Enea invece le ha perdute perché il progetto di creare un impero gli impone la rinuncia ai desideri umani.
-Rispetto a Ulisse, Enea non è un eroe audace e sanguigno,
ma mostra grande sensibilità e commozione nei confronti dei suoi compagni e addirittura dei suoi nemici
L'originalità dell'Eneide intatti è che è caratterizzata da toni malinconici, lontani dai modelli omerici.
Perché scegliere un troiano come capostipite della gens Iulia?
La leggenda di Enea narra di un principe troiano che scampa all’assedio di Troia
e che conduce un gruppo di uomini in giro per il Mediterraneo, fino ad approdare nel Lazio,
dove si unisce ad una principessa latina Lavinia, diventando progenitore della gens Iulia,
collegandosi all’antico fondatore Romolo.
La scelta di Enea sta nella legittimazione del potere di Giulio Cesare e del figlio adottivo Ottaviano Augusto
infatti il figlio di Enea, Ascanio, viene denfinito un antenato della gens Giulia,
e, all’indietro, fino a Venere, la divinità madre di Enea.
La celebrazione della gens Iulia, diventa così celebrazione del principe,
ma anche identificazione delle due divinità fondanti la Romanità:
Venere, dea dell’amore e madre di Enea, e Marte, dio della guerra e padre di Romolo e Remo.
Viene così celebrata la figura di Augusto, che ha origine dalla gens Iulia
(il figlio di Enea viene presentato come l'antenato della gens Iulia).
Nell' Eneide l'onore e la dignità dei Romani si salvano
attraverso la descrizione del rapporto tra Troiani e Greci:
i Troiani erano considerati gli antenati dei Romani,
mentre i Greci, che avevano assediato e distrutto Troia, erano i loro nemici.
Ciò nonostante, all'epoca in cui l'Eneide fu scritta, i Greci erano un popolo che faceva parte dell'Impero,
ed era allo stesso tempo assoggettato ma anche rispettato e considerato per la sua cultura e civiltà.
Si sosteneva infatti che i Greci avevano battuto i Troiani soltanto grazie al trucco del cavallo di legno
e non con una battaglia sul campo.
Mito e storia nell'Eneide.
Il rapporto tra mito e storia nell’Eneide è complesso:
-da un lato è vero che la trama narra una vicenda mitica
-dall’altro lato alla base del mito c’è la storia della celebrazione di un’età
in cui un pater patriae ha imposto la concordia sopraffacendo a un’epoca di guerre civili.
l nucleo ideologico del poema viene espresso per la prima volta nei vv. 291-296 del Libro I,
in cui Giove rassicura Venere preoccupata per la sorte del figlio ed emette la profezia sul futuro di Roma. Alla base
dunque di questa celebrata età dell’oro da recuperare e ripristinare
possiamo immaginare il trauma vissuto da Virgilio, come tutti i romani, delle recenti guerre civili,
che si traduce nel poema con un contrasto in cui il nemico va debellato senza pietà.
Scaricato da Marianna Tallarico (mariaanna.tallarico@hotmail.it)
lOMoARcPSD|5715493
LEZIONE 25
Confronta il proemio dell'Eneide con il proemio dell'Odissea.
Caratteristiche comuni dei due proemi:
-entrambi incipit di poemi epici, quindi dello stesso genere (ma appartengono ad epoche diverse)
-entrambi, nella versione originale greca, scritti in esametri dattilici, e nella traduzione italiana, sono in endecasillabi
- presenza dell'ira che forma una climax discendente
-oggetto del canto del poeta:
nell'Odissea si parla più che altro dell'errare,
anche se vi sono scene di battaglia e richiami alla guerra di Troia;
nell'Eneide si propongono prima le peregrinazioni del protagonista e poi la guerra per ottenere il territorio del Lazio.
- presenza dei protagonisti nel primo verso
Differenze:
- posizione e tipo di invocazione alla Musa.
nel primo verso dell’Odissea poiché all'epoca di Omero il culto delle Muse era molto più radicato nella cultura locale;
nel poema di Virgilio la Musa compare solo nell'ottavo verso, dopo la presentazione del contenuto del poema.
Quale fu il ruolo di Mecenate e della politica augustea in relazione all'Eneide?
Mecenate, consigliere, alleato ed amico dell'imperatore Augusto,
formò un circolo di intellettuali e poeti che protesse, incoraggiò e sostenne nella loro produzione artistica
perché le loro opere favorivano il Principato, la grandezza di Roma e le azioni politiche imperiali.
Virgilio entrò a far parte di questo circolo di intellettuali legati a Mecenate
e il poema dell’Eneide nacque sia per soddisfare la richiesta di Augusto
di creare un'opera che narrasse la grandezza di Roma,
Quale importanza ha nell'Eneide l'ambientazione dei fatti?
L'Eneide è ambientata in luoghi molto diversi tra loro,
infatti si svolge in parte in Oriente e in parte in Occidente,
e vi sono dettagliati paesaggi naturali e città.
Il poema fu composto quando a Roma si stavano verificando grandi cambiamenti politici e sociali,
in quanto dopo la caduta della Repubblica la guerra civile aveva scosso fortemente la società,
e il ritorno alla pace, dopo tanti anni di guerre, stava cambiando le categorie sociali e usi culturali.
Per affrontare questa situazione, Augusto cercava di riportare Roma verso i valori morali tradizionali:
l'Eneide infatti mostra Enea come un uomo dedito allo sviluppo del suo paese,
anziché interessato ai propri problemi,
cosa che ha reso possibile arrivare alla fondazione e alla gloria di Roma.
Scaricato da Marianna Tallarico (mariaanna.tallarico@hotmail.it)
lOMoARcPSD|5715493
Quali aspetti del personaggio di Enea dimostrano che è un uomo pio?
Enea dimostra di essere un uomo pio, dimostrando Pietas, che è un valore fondante per la società romana,
che indica il rispetto per la famiglia, la devozione religiosa e il sentimento d'amore patriottico.
-Per la famiglia:
nel momento in cui si rende conto della disfatta di Troia ed è invitato da Venere, sua madre,
a fuggire per andare nel Lazio a fondare una nuova città,
si reca dai suoi cari per trarli in salvo, in particolare suo padre Anchise.
Nonostante il rifiuto iniziale di Anchise - che non vuole fuggire e morire da esiliato -
Enea lo porta in salvo portandolo sulle spalle.
-Per gli dei:
nonostante il fatto che Enea abbandoni la patria senza combattere,
cosa imperdonabile stando al codice militare romano,
la sua pietas è dimostrata dal fatto di ubbidire al volere degli dei,
sia in questo caso, sia quando Giove gli ordinerà di lasciare Cartagine per seguire il suo destino.
-Per la patria:
mostra pietas per la patria -quella futura- visto che non seguirà i suoi interessi,
ma metterà al primo posto questa missione: fondare una nuova città, come voluto dagli dei.
Enea dunque non veniva soprannominato il pio non perché fosse buono e misericordioso,
ma perché era non solo particolarmente devoto agli dèi, come si vede dalla cieca fiducia nei loro presagi,
ma anche perché incarnava perfettamente i valori di rispetto dell'unità familiare,
e perché obbediva sempre agli dèi e al fato,
mettendo in secondo piano le vicende personali come l'amore per Didone.
Con quale episodio inizia l'Eneide?
Giunone va da Eolo per chiedere di liberare i venti che tiene in una caverna per travolgere le navi troiane
e in cambio Giunone offre ad Eolo la più bella delle ninfe, Deiopea, ed Eolo accetta lo scambio.
Il poema inizia in medias res, a metà degli avvenimenti con una scena epica e drammatica:
la tempesta è metafora delle difficoltà della vita.
L’episodio è fondamentale per comprendere la dinamica del poema,
infatti il naufragio serve a giustificare l’arrivo di Enea a Cartagine e l’incontro con Didone.
La scena inizia con immagini apocalittiche,
per poi giungere a scene idilliache una volta approdati sulle coste africane:
è la tecnica del contrasto che Virgilio utilizza spesso nel corso del poema.
Scaricato da Marianna Tallarico (mariaanna.tallarico@hotmail.it)
lOMoARcPSD|5715493
LEZIONE 26
Perché Giunone è ostile ad Enea?
Giunone era ostile ad Enea perché:
- la stirpe troiana era stata generata dall'adulterio tra Giove e la mortale Elettra;
-perchè si narrava che dalla stirpe troiana ne sarebbe nata un'altra che avrebbe distrutto Cartagine (città devota a Giunone) ;
-adirata per il giudizio di Paride che l’aveva giudicata meno bella di Venere
assegnando a quest’ultima la mela d’oro per avere in moglie Elena
In che senso Enea è definito pius? Si facciano esempi della sua pietas.
Enea è definito pius perchè possiede la pietas
e dunque rispetta le volontà divine e i vincoli che ne derivano verso la patria e la famiglia.
La pietas (rispetto degli dei, dei parenti e dei valori umani)
implica infatti l'accettazione del dolore proprio e dei propri cari,
pur di realizzare la missione voluta dal destino.
Questa sua caratteristica lo accompagnerà per tutto il suo viaggio
es. quando dovrà lasciare Didione e permettere che lei si uccida.
O socii -neque enim ignari sumus ante malorum- O passi graviora, dabit deus his quoque finem...
revocate animos, maestumque timorem mittite: forsan et haec olim meminisse iuvabit.
A chi si rivolge Enea e in che situazione si trova?
La tempesta scatenata da Eolo, re dei venti, su richiesta di Giunone, per ostacolare il viaggio di Enea,
travolge alcune navi dei troiani e disperde le altre.
Enea, si rivolge ai compagni con un discorso per infondere in loro fiducia e finge una sicurezza che non ha.
L’episodio è fondamentale per comprendere la dinamica del poema
poiché mette in risalto la pietas di Enea e la sua capacità di superare gli ostacoli.
Fortunatamente interviene Nettuno che ristabilisce la calma,
riprendendo i venti che avevano agito senza il suo permesso
e consentendo ad Enea di sbarcare, con le sette navi superstiti, sulle coste della Libia,
anche se hanno perso molti compagni e molti loro alleati che diventano con loro esuli.
Quali funzioni riveste, dal punto di vista della trama, la tempesta all'inizio del libro I?
Il naufragio serve a giustificare l’arrivo di Enea a Cartagine e l’incontro con Didone.
l’antecedente omerico è il naufragio di Ulisse dopo essere partito dall’isola in cui Calipso lo aveva a lungo trattenuto.
La tempesta serve poi a mostrare la pietas di Enea e la sua capacità di superare gli ostacoli.
Scaricato da Marianna Tallarico (mariaanna.tallarico@hotmail.it)
lOMoARcPSD|5715493
LEZIONE 27
Destino personale e universale nell'Eneide.
Il destino personale di Enea non è il fine ultimo,
ma è una missione storica e un destino universale che abbraccia secoli e nazioni
anche se comunque ha bisogno dell’opera di un singolo uomo.
Già all’inizio del poema Virgilio aveva anticipato che tutto sarebbe stato in funzione di Roma
e in questo senso il viaggio di Enea è profondamente diverso da quello di Ulisse
perché l’origine, il punto di inizio, in questo caso, non sta dietro, ma davanti ad Enea e ai suoi compagni:
dalle fiamme distruttrici e dalle ceneri di Troia, dove tutto è morte,
si dischiude all’improvviso la possibilità di un nuovo inizio, di una nuova origine.
Alla fine del brano Venere, travestita da cacciatrice,
si presenta al figlio per esortarlo a recarsi nella vicina Cartagine, dove gli verrà offerta una regale ospitalità.
Che rapporto c'è tra Enea e la madre Venere?
Esemplifica con passi del primo libro le tue affermazioni.
Mentre Nettuno placa la tempesta e i Troiani si organizzano sulle coste della Libia,
la scena si sposta nuovamente sul piano divino quando nell’alto dei cieli Venere si avvicina a Giove
e gli chiede perché Enea, suo figlio, sia perseguitato dalla sventura e non riesca a raggiungere la patria promessa.
Giove la tranquillizza con una profezia dicendole che il destino di Enea non è cambiato:
da lui discenderà la stirpe Giulia, dominatrice del mondo, e nel Lazio sorgeranno Roma e l’Impero.
Virgilio, con questa profezia, oltre a calmare i timori di Venere,
fa irrompere la storia nel mito dichiarando fin dall’inizio la meta di tutta la vicenda,
e risponde in modo diretto all’incarico affidatogli da Augusto di esaltare l’impero.
Nell'Eneide il mondo degli uomini e il mondo degli dei...
Nell’Eneide il mondo degli uomini e degli dei si intersecano.
In particolare si ha modo di vedere come gli dei decidano del destino degli umani,
alcuni curandosi della loro sorte, altri solo per ricordare il loro potere.
Ma al di sopra delle loro volontà vi è il fato ineluttabile che porterà i Troiani a fondare una stirpe gloriosa.
La percezione che questo viaggio verso il destino assegnato dal fato
sia un esilio dominato da una forza misteriosa e incombente
è presente fin dai versi iniziali del proemio, nell’espressione “fasto profugus”,
cioè esule, pellegrino, su di una via incerta.
Illustra la figura di Venere nel primo libro dell'Eneide.
Venere dimostra amore materno cercando di aiutare Enea in ogni situazione difficile inflittagli da Giunone.
In particolare Venere chiede a Giove perché Enea è perseguitato visto che è un uomo pio e devoto dei,
ma Giove la rassicura con una profezia
e le promette che un destino di gloria attende suo figlio e i suoi discendenti.
Il colloquio tra Giove e Venere sottolinea che Enea è uno strumento del Fato,
e che è destinato a dare vita alla stirpe che governerà il mondo.
Segue così la celebrazione di Roma e della gens Iulia, affidata alle parole di Giove,
che assumono la forma di “profezia post eventum”:
l’impero universale predetto da Giove è infatti una realtà.
Scaricato da Marianna Tallarico (mariaanna.tallarico@hotmail.it)
lOMoARcPSD|5715493
LEZIONE 28
Cosa unisce Enea e Didone?
La regina di Tiro Didone è una vedova, il cui marito viene ucciso dal fratello Pigmalione che voleva il
trono.Didone per evitare la guerra civile lascia Tiro
e guida un drappello di esuli lungo varie peregrinazioni (le tappe principali sono Cipro e Malta)
fino ad arrivare sulle coste libiche dove fonda una nuova patria (Cartagine).
Questa storia rappresenta un’analogia con il destino di Enea di fondare un nuovo impero.
Didone inoltre è presentata come una donna leale, sincera, innamorata, incapace di malvagità,
premessa proprio dello scoccare dell’amore con il pio Enea.
Cur dextrae iungere dextram non datur, ac veras audire et reddere?
Illustra e spiega questo verso di Virgilio.
Questo verso di trova nel libro I dell’Eneide.
La traduzione è:
” Perchè non mi è dato unire la mia alla tua mano, ascoltare e rispondere parole vere?”
Il brano narra dell’incontro tra Enea e la madre Venere avvenuto una volta approdato a Cartagine,
in cui Venere le si presenta sotto le sembianze di una cacciatrice per aiutarlo
raccontandogli la storia di Didone, regina del luogo, e lo invita ad andare a trovarlo.
Il figlio quando la riconosce, poco prima di andarsene,
le rivolge delle domande rimproverandola perché lei non si mostra mai per quello che è:
“perché deludi tuo figlio con immagini finte?”
e “perche non possiamo solo stringerci la mano in maniera sincera?”
LEZIONE 29
Quae regio in terris nostri non plena laboris? Commenta e contestualizza questa frase di Enea.
E’ una frase di Acate, scudiero di Enea, nel libro I.
La traduzione è: “Quale ragione sulla terra non piena del nostro affanno?”
Enea sta piangendo, nel tempio in costruzione a Cartagine,
sorpreso dalle raffigurazioni della sconfitta della sua città, Troia.
Il suo non è un pianto di disperazione, né è solo un pianto di dolore,
ma è una manifestazione di pietà, una commozione profonda di fronte al destino della propria patria.
Enea sorprende Acate sia perché soffre in modo violento,
sia perché è commosso dall’onore reso ai vinti troiani da quelle immagini
infatti Priamo viene immortalato nell’arte nel suo terribile dolore
ma ciò è testimonianza di un cuore capace di rendere onore a chi lo merita.
In che rapporto si pone Virgilio con l'epica omerica? Sostieni con esempi le tue affermazioni.
L’Eneide è un poema che nasce dal confronto con l’epica omerica e con la propaganda augustea.
Il confronto tra Virgilio e Omeno si risolve in tre punti:
-Contaminazione di Omero: Virgilio si ispira ai due poemi di Omero rovesciandoli:
il viaggio di Enea non è un ritorno a casa come quello di Ulisse ma un viaggio verso l’ignoto,
mentre la guerra di Enea non serva a distruggere una città ma a costruirne una nuova, Roma.
-Continuazione di Omero:
le imprese di Enea si modellano sull’Iliade
poiché nel II libro dell’Eneide Virgilio racconta l’ultima notte di Troia, che l’Iliade accennava solamente,
e si modella anche sull’Odissea
perché nel III libro Enea segue, in parte, il percorso di Ulisse, e affronta i suoi stessi pericoli.
-Ripetizione e superamento di Omero:
la guerra nel Lazio è una sorta di ripetizione della guerra di Troia ma con un esito rovesciato
poiché stavolta sono i Troiani a risultare vincitori
e Virgilio supera Omero nella concezione della guerra
poiché la guerra di Enea non porta alla distruzione ma alla costruzione di una nuova città.
Scaricato da Marianna Tallarico (mariaanna.tallarico@hotmail.it)
lOMoARcPSD|5715493
LEZIONE 30
Illustra le prime parole di Enea a Didone, al momento del loro incontro.
Il discorso di Enea mostra attenzione retorica e riferimento alle formule di tradizione epica e omerica
ma egli mostra un sincero interessamento e curiosità per Didone,
anche se le lodi alla sua città, Cartagine, possono apparire sinistre dal momento che il lettore di allora
conosceva la realtà storica della distruzione di Cartagine da parte dell’esercito romano.
Enea riconosce gratitudine per l’accoglienza della regina con un’iperbole che coinvolge la natura
dicendo che continuerà a tesserne l’elogio e le lodi
fino a che i fiumi che scorreranno, le ombre si rifugeranno nei monti e le stelle compariranno la notte,
ma vi è un eco del finale tragico del fato quando dice che lo farà in qualsiasi terra si troverà,
come se Enea già sapesse che i loro destini si sarebbero divisi.
Egli riconosce in lei un tratto che gli è peculiare, la pietas, il rispetto per gli altri e per il loro dolore.
All’interno di questi versi troviamo anche la concezione del divino di Virgilio,
un’aspirazione alla giustizia e alla lealtà degli dei nei confronti degli uomini.
Si qua pios respectant numina, si quid / usquam iustitia este et mens sibi conscia recti:
il concetto di divino in Virgilio.
Il verso è tratto dal Libro I dell’Eneide.
Enea vede in Didone la pietas e le rivolge queste parole:
“Gli dei ti offrano adeguate ricompense, se qualche divinità guarda i pii,
se mai c’è un che di giustizia ed una volontà cosciente del bene”.
Didone però non riconosce il sottointeso a tali parole:
ella si riferisce alla sua pietas in quanto partecipe del dolore altrui, in quanto ai rapporti umani,
ma per Virgilio lei è “pia” in quanto la sua accoglienza benevola favorisce la missione di Enea
ed è proprio per questo che deve ricevere riconoscenza dagli dei.
Scaricato da Marianna Tallarico (mariaanna.tallarico@hotmail.it)
lOMoARcPSD|5715493
Esame 13 Settembre 2019, domande+risposte
Lingua e letteratura latina (Università degli Studi di Bergamo)
StuDocu non è sponsorizzato o supportato da nessuna università o ateneo.
Scaricato da Marianna Tallarico (mariaanna.tallarico@hotmail.it)
lOMoARcPSD|5715493
LEZIONE 41
Il significato della lettura dell'Hortensius per Agostino.
Agostino lesse l’Hortensius di Cicerone,
dialogo dedicato da Cicerone al rivale e amico Ortensio, durante il suo percorso di studi,
e tale lettura lo fece appassionare all’eloquenza e alla retorica classica,
ma egli andò anche oltre lo stile e rimase affascinato anche dal contenuto
tanto che da questo momento sarà l’amore per la sapienza a divenire il principio ispiratore della sua opera.
Questo perché Cicerone in quest’opera non sosteneva questa o quella dottrina filosofica
ma sosteneva la necessità della ricerca, dell’indagine,
della filosofia intesa come impegno morale, orientamento di vita e possesso della sapienza.
Agostino inoltre lesse l’opera alla luce della sua formazione e dunque in una prospettiva cristiana:
vi trovò l’inquietudine della creatura che cerca il bene e trova anche il male, ma con un certo disappunto:
l’aiuto in questa ricerca interrotta non è rivolto a Cristo in quest’opera.
Nelle pagine dedicate all’Ortensio emerge come per Agostino
la cultura pagana (i ragionamenti di Cicerone) e gli insegnamenti della fede cattolica non siano in contrasto.
In questa fusione di mondi consiste la tradizione classica-giudaico-cristiana che fonda l’identità occidentale.
Quo dolore contenebratum est cor meum, et quicquid aspiciebam mors erat.
Contestualizza e commenta questo passo delle Confessioni.
La frase è del libro IV delle Confessioni in cui Agostino parla della morte dell’amico,
che si ammala e muore dopo essersi fatto battezzare,
e che fa cadere Agostino in uno stato di dolore e depressione:
“L’angoscia avviluppò di tenebre il mio cuore, ogni oggetto su cui posavo lo sguardo era la morte”.
L’incapacità di reagire a questa morte causerà in lui interrogativi
poiché egli dice a sé stesso di ricorrere alla fede ma non pare abbastanza
perché l’amico era una persona concreta che non c’è più
e il ricorso a un “Dio fantasma” non serviva per lenire la concretezza della sua perdita.
LEZIONE 42
Agostino e Ambrogio.
Quando Agostino ottiene un posto di insegnante di retorica a Milano, in quanto funzionario pubblico,
ha l'obbligo di andare dal vescovo Ambrogio per una visita di cortesia e viene accolto con gentilezza.
All'inizio Agostino frequenta Ambrogio non per imparare, ma per giudicare se merita la fama di cui gode. Pian piano
però le parole di sant'Ambrogio penetrano il cuore di Agostino,
e diverrà un maestro che con dolcezza e carisma ha coltivato la sua anima interiore
fino a condurlo ad una vita nuova, una vita di fede.
Il segno più duraturo dell’influenza di Ambrogio su Agostino
è la sua adesione al metodo utilizzato dal vescovo di Milano per l’interpretazione della Scrittura:
al centro di tutto doveva essersi la Parola di Dio.
Cosa non convince inizialmente Agostino delle Sacre Scritture
e cosa invece apprezza nella lettura dei classici?
Agostino ha studiato la cultura greca e romana, è stato maestro di grammatica e retorica
ed ha sostenuto l’importanza nell'educazione delle arti liberali (grammatica, retorica e logica)
e delle quattro discipline matematiche (aritmetica, geometria, musica, astronomia),
infatti la sua cultura classica permane anche dopo la sua conversione con frequenti citazioni.
In particolare nelle Confessioni ricorda come la lettura dell'Hortensius lo avesse condotto allo studio della filosofia
e a quella ricerca della saggezza che poi lo avrebbe spinto allo studio delle Sacre Scritture.
Il problema è che egli inizialmente affrontò la Parola di Dio con gli occhi del professore di retorica
e per questo restò deluso dallo stile semplice e scarno,
e dal fatto che non vi fossero narrate verità chiare e precise.
In questo senso torniamo al concetto di Confessione:
Agostino narra senza pudore i suoi errori, le sue cadute, anche l’iniziale disprezzo per la parola di Dio.
Solo dopo un lungo periodo e l’incontro con Ambrogio egli imparò a interpretare le Scritture correttamente
sostenendo che, nonostante il suo amore per la cultura classica,
un cristiano doveva essere convinto che ogni conoscenza ricavata dalla Scrittura
fosse superiore a qualsiasi testo filosofico pagano.
Scaricato da Marianna Tallarico (mariaanna.tallarico@hotmail.it)
lOMoARcPSD|5715493
LEZIONE 43
Le mani di Dio, le orecchie del cuore dell’uomo: personificazioni nello stile agostiniano
Agostino per descrivere l’amore di Dio e la sua sapienza usa delle personificazioni umane
dal momento che l’uomo è stato fatto a immagine e somiglianza di Dio.
Quando parla di orecchio del cuore dell’uomo fa riferimento al suo orecchio interiore,
ovviamente un cuore non ha delle vere orecchie, ma esso deve saper comunque ascoltare Dio;
quando parla delle mani di Dio non fa riferimento ovviamente a delle mani concrete,
in quanto Dio non si palesa, ma fa riferimento a Dio che aiuta l’uomo.
Commenta l'episodio delle Confessioni definito 'tolle, lege!'
Questa espressione, che significa “prendi e leggi”, riguarda il momento della conversione di Agostino.
Dopo che nei primi 8 libri Agostino descrive non solo la sua vita
ma anche il peccato, la sessualità, l’ambizione letteraria e filosofica,
avviene il momento della conversione sotto l’albero di fico,
che gli studiosi ancora non sanno come interpretare:
alcuni interpretano gli eventi come realmente accaduti,
altri interpretano il testo sottolineandone la letterarietà il valore simbolico e allegorico.
Il passo inizia con Agostino che piange sotto un albero di fico perché il suo animo è tormentato
ma poi sente una voce infantile che dice “prendi e leggi” che Agostino sente dalla casa accanto,
ma ben presto capisce che questa è una voce divina che lo esorta ad aprire il libro e a leggerne un passo,
così aprì il la Bibbia e lesse il primo versetto su cui caddero gli occhi,
e dopo questa lettura una luce gli penetrò nel cuore e ogni dubbio si dissipò.
LEZIONE 44
Lo stile di Agostino in relazione agli usi retorici dell'epoca.
Agostino, istruito alla cultura classica e professore di retorica, si converte.
Nelle Confessioni rimane evidente la sua conoscenza della retorica, di cui talvolta da sfoggio,
anzi ne riconosce l’utilità purché venga usata in difesa della verità,
e la sua conoscenza dei classici, con citazioni di Cicerone e filosofi neoplatonici.
Lo stile diventa però anche intimo e personale, sincero, ricco di pathos,
e vi è un ricorso straordinario alle espressioni, immagini, citazioni e allo stile delle Scritture.
Cos'è la 'voce delle creature' per Agostino?
Nelle Confessioni il libro X si apre con un’introduzione relativamente alla seconda parte dell’opera,
dopo la conclusione della narrazione del passato.
Se nei libri precedenti vi era una ricerca della verità, qui la Verità viene raggiunta
e la lode a Dio si esprime attraverso la ‘voce delle creature”:
ascoltando la voce delle cose che rimandano al loro artefice
l’anima rientra in sé stessa e incomincia un’ascesa all’uomo interiore.
Il testo va oltre parlando di una dottrina di Origene, ovvero la dottrina dei sensi spirituali,
ovvero del contatto indescrivibile e inenarrabile dell’anima con Dio.
Scaricato da Marianna Tallarico (mariaanna.tallarico@hotmail.it)
lOMoARcPSD|5715493
LEZIONE 45
Possiamo dire che troviamo nelle Confessioni elementi del topos della 'ricerca'
intesa come 'quête amorosa'?
La quête, la ricerca di Agostino dell’oggetto del suo amore,
è diretta inizialmente alla propria interiorità, alla memoria,
che è il ‘magazzino dell’anima’ in cui trovano posto le sensazioni, le percezioni, l’intelletto.
Ma poi la ricerca punta verso una dimensione infinita, che va oltre l’uomo e lo trascende.
Nella descrizione dell’incontro con Dio Agostino sceglie accuratamente le parole e le ricrea:
“Tardi ti amai, bellezza così antica e così nuova”.
Qui con pulchritudo Agostino sceglie una parola comune, bellezza,
e la investe di un concetto altissimo, ne fa l’espressione dell’immagine divina,
La bellezza è antica, perché portata da una tradizione giudaica antichissima,
ma anche nuova, perché rivoluzionaria e sconosciuta alle filosofie e dottrine precedenti.
Sero te amavi pulchritudo tam antiqua et tam nova, sero te amavi!
Analisi linquistica e stilistica dell'espressione di Agostino.
Nel libro X si dice: “Tardi ti amai, bellezza così antica e così nuova, tardi ti amai”.
Agostino rimpiange di non aver amato prima Dio,
infatti prima agostino peccava, era amato dal Signore ma non lo amava a sua volta,
e solo in un secondo momento, tardi appunto, ha scoperto Dio.
Il termine pulchritudo è un astratto per definire la divinità che Agostino ritrova nel Cantico dei cantici,
anche se esso è anche un termine classico (la bellezza delle divinità pagane) e del lessico erotico,
ma in questo caso non si tratta di bellezza esteriore
ma di una bellezza che tocca tutti i sensi e dona appagamento e pace.
Il termine “tanto antica quanto nuova” indica invece che la divinità è senza tempo.
LEZIONE 46
Dissilui in tempore: l'esperienza d'Agostino e dell'uomo.
Nel libro XI nelle Confessioni troviamo questa frase: “Io mi son dissipato nella successione dei tempi”.
Agostino ormai è vescovo e sta studiando la Bibbia:
con queste parole indica che l’uomo, anche l’uomo credente,
vive sempre una sorta di frantumazione interiore,
ed è solo la grazia di Dio che porterà all’unità quando lui lo chiamerà a sé.
Perché Agostino introduce il tema della creazione nelle Confessioni
e in che relazione è con il resto dell’opera?
Il tema dell’XI libro è quello del tempo.
Il punto di partenza è il racconto biblico della Creazione che a prima vista sembra avvenga nel tempo
come una successione di azioni e di eventi.
Agostino si chiede allora che cosa facesse Dio prima della creazione,
ma in realtà Dio è fuori dal tempo, è nell'eternità,
ed è solo con la Creazione che Dio ha creato anche il tempo, che non esisteva prima della creazione.
Agostino sostiene che il tempo esiste nella nostra anima: il passato come ricordo, il futuro come attesa.
Questo perché ciò che viene misurato dall' anima non sono le cose nel loro trascorrere,
ma l'affezione che esse lasciano e che permangono nella nostra anima anche quando esse sono trascorse.
Scaricato da Marianna Tallarico (mariaanna.tallarico@hotmail.it)
lOMoARcPSD|5715493
LEZIONE 47
Descrivi lo stile di Agostino nelle Confessioni.
Agostino nelle Confessioni utilizza uno stile vocativo rivolgendosi continuamente e direttamente a Dio,
fino a divenire un colloquio che talvolta diventa preghiera, talvolta ringraziamento, talvolta supplica,
in cui emerge sincerità, drammaticità e pathos.
Lo stile è elevato poiché si evincono le sue abilità retoriche e la sua precedente istruzione
ma fa anche larghissimo ricorso a stile, espressioni e citazioni delle Sacre Scritture.
Egli alterna inoltre espressioni concise a periodi articolati e complessi e utilizza molte figure retoriche.
Quali sono gli scopi che si prefigge Agostino con le Confessioni?
Agostino con le Confessioni vuole raccontare il passaggio dalla sua esperienza passata alla sua conversione:
egli già in precedenza cercava gioia e felicità, era come se cercasse Dio senza saperlo,
ma quando lo trova ogni suo desiderio verrà appagato.
Egli presenta inoltre i due aspetti della Confessio: la confessione dei peccati e la confessione di lode.
Nelle Ritrattazioni infatti Agostino parla delle sue opere
compiendone allo stesso tempo una critica e una difesa
e in merito alle Confessioni dice che esse servono per confessare i suoi peccati e lodare Dio.
Il suo scopo è espiare il male passato, purificarsi,
ma per far questo deve prima riconoscere i mali del passato e raccontarli:
solo così può lasciarselo alle spalle e vivere in serenità con Dio.
Il rapporto tra uomo e Dio in Agostino può dirsi simmetrico o asimmetrico? Giustifica la tua risposta
Il rapporto tra uomo e Dio in Agostino può dirsi simmetrico e speculare
poiché nella parte autobiografica dell’opera la Trinità si rivela progressivamente
attraverso la ricerca e il ricordo di Agostino, che vaga senza trovare un punto fermo,
mentre nell’ultima parte dell’opera la Trinità viene finalmente riconosciuta come la Verità eterna
che sorregge tutta la storia di Agostino e tutte le vicende degli uomini.
Ecco perché Agostino analizza la Creazione nella Genesi in relazione alla propria esistenza:
così come Dio ha creato il mondo,
così l’esistenza di Agostino ha avuto forma solo quando Dio l’ha creato e poi l’ha portato alla conversione.
Domine Deus, pacem da nobis - omnia enim praestitisti nobis - pacem quietis, pacem sabbati, pacem
sine vespera! Quando troviamo questo passo nelle Confessioni e cosa significa?
Questo passo si trova nel libro XIII, libro dedicato alla Trinità e libro più difficile,
poiché parla del tema dell’amore come base per la creazione del mondo.
Inizia con un’invocazione alla pace:
“Signore Dio, poiché tutto ci hai fornito,
donaci la pace, la pace del riposo, la pace del sabato, la pace senza tramonto”.
Agostino con questa invocazione a Dio allude al racconto della Creazione
continuando dicendo che tutto ha un inizio e una fine, tranne il settimo giorno della Creazione:
così come Dio il settimo giorno, dopo aver finito la creazione, si riposa,
così l’uomo, dopo aver compiuto le sue opere buone, riposerà nella vita eterna.
Scaricato da Marianna Tallarico (mariaanna.tallarico@hotmail.it)
lOMoARcPSD|5715493
LEZIONE 49
Cosa sono i fescennini?
I fescennini sono opere popolari di origini antichissime e di discendenza italica,
probabilmente dalla città etrusca di Fescennium,
nate da battute improvvisate che si scambiavano due cori opposti di contadini
prima durante le feste agricole, e poi che si diffusero anche in altre occasioni es. feste nozze
e che possono essere considerate una forma embrionale di teatro.
I temi erano licenziosi, osceni, insolenti e diffamatori.
Le parti comprendevano canto, musica e danza ma non erano ben definite.
Roma nell'età repubblicana:
lo sfondo storico, le istituzioni principali, le figure letterarie di maggior rilievo.
L’età repubblicana va dalla cacciata dell’ultimo re di Roma (509 a.C.)
al principato di Augusto (27 a.C.).
Per quest’arco di tempo lunghissimo il governo romano
fu esercitato dal Senato e da una coppia di magistrati annuali, i consoli,
che avevano funzione di “capi dello stato” e di supremi comandanti delle forze armate. Accanto a queste
figure esisteva una serie di magistrature minori
che garantivano l’amministrazione della cosa pubblica,
mentre i collegi sacerdotali erano preposti al corretto esercizio dei riti della tradizione.
Il sistema repubblicano si basava su un potere legislativo e deliberativo del Senato
e sul potere consultivo e deliberativo del popolo:
mentre i senatori erano esponenti di un gruppo sociale dominante, l’aristocrazia senatoria,
il popolo era caratterizzato dalla totalità dei cittadini aventi diritto di voto
e il suo potere consultivo si esprime attraverso i comizi.
Le figure letterarie di maggior rilievo furono Livio Andronico, Nevio, Plauto, Ennio, Stazio, Terenzio,
Catone, Lucrezio, Catullo, Varrone, Cesare, Sallustio e Cicerone.
Scaricato da Marianna Tallarico (mariaanna.tallarico@hotmail.it)
lOMoARcPSD|5715493
LEZIONE 50
Cosa significa «La letteratura romana in un certo senso nacque morta»,
affermazione dello storico tedesco B.G. Niebhur (1776-1831)?
Lo storico tedesco Niebhur parla del pregiudizio romantico
che condannava la letteratura latina in quanto “derivata” da quella greca.
La cultura romantica infatti,
alla ricerca delle origini di ogni nazione e affascinata da tutto ciò che appariva primitivo,
inchiodava la letteratura di Roma al suo “peccato originale”: il debito con il mondo greco.
Illustra le caratteristiche delle prime testimonianze
(nell'ambito della prosa e della poesia) in lingua latina.
Nell’età delle origini la distanza tra prosa e poesia è fluida
poiché la prosa era ritmica e con sezioni di testo legate da figure di suono.
A questa prosa ritmica che è difficile definire prosa o poesia si da il nome di Carmen,
che comprendeva preghiere, giuramenti, trattati.
Il genere più elevato dell’antica poesia romana
erano i Carmina religiosa e Carmina convivalia,
cioè narrazione di gesta di uomini illustri che dilettavano i partecipanti ai banchetti,
secondo la tradizione omerica dei rapsodi o aedi.
Il verso utilizzato è il saturnio che fu usato dai primi poeti latini Livio Andronico e Nevio
e che affonda le sue radici in epoca preletteraria.
Esso era usato per ogni genere di poesia: sacra, epica, popolare, scherzosa,
ma nulla ci rimane per tradizione diretta anche perché è una tradizione anonima
in quanto priva di scopi artistici e rispondente a necessità di vita quotidiana o religiosa.
Per quanto riguarda la prosa le prime attestazioni riguardano:
I testi giuridici.
Le leggi più antiche sono le Leges regiae e le Leggi delle XII tavole
scritte in una prosa ritmica vicina al carmen e con forti condizionamenti dell’oralità.
Annales.
La registrazione degli avvenimenti era affidata a Roma
a magistrati preposti e ai collegi sacerdotali.
In particolare il pontifex maximus ogni anno registrava gli avvenimenti significativi. Queste
tavole contenevano anno per anno i nomi magistrati e consoli e i fatti accaduti
ed erano chiamati Annales pontificales.
Fasti.
I Fasti consolari erano gli elenchi delle coppie di consoli
e i fasti sacerdotales erano gli elenchi delle autorità religiose.
L’oratoria.
Le famiglie nobili celebravano le glorie della loro casa con le laudationes funebres,
commemorazioni del cittadino illustre defunto
che un membro della loro famiglia pronunziava pubblicamente nel foro dinanzi al popolo.
Scaricato da Marianna Tallarico (mariaanna.tallarico@hotmail.it)
lOMoARcPSD|5715493
Esame 13 Settembre 2019, domande+risposte
Lingua e letteratura latina (Università degli Studi di Bergamo)
StuDocu non è sponsorizzato o supportato da nessuna università o ateneo.
Scaricato da Marianna Tallarico (mariaanna.tallarico@hotmail.it)
lOMoARcPSD|5715493
LEZIONE 51
Libera lingua loquemur ludis liberalibus. Traduci, contestualizza e commenta.
“Con libertà di parola parleremo durante le feste in onore di Libero”.
Questo è un verso di Nevio al tempo della seconda guerra punica (III sec. a.C.)
che egli combatte in quanto cittadino romano, nonostante fosse nato a Capua.
Egli è una delle poche voci che si levano ostili all’aristocrazia
e questo atteggiamento si trova nei pochi frammenti rimasti delle sue opere
come questo passo in cui rivendicava la libertà di parola
durante la festa religiosa in onore di Bacco (Libero era il suo antico nome).
Nevio: la sua importanza nella letteratura latina e perché si parla di impegno sociale e civile.
Si tratta di un atteggiamento comune nella letteratura latina?
Il teatro di Nevio attesta il suo impegno sociale e civile
infatti in esso sono presenti molte allusioni e frecciate ai potenti uomini politici
con una chiara rivendicazione del diritto alla libertà di parola nonostante la censura dei magistrati.
Egli è una delle poche voci che si leva contro l’aristocrazia.
Quali elementi dell'opera di Livio Andronico
denunciano il peso della cultura greca nella sua produzione letteraria?
Quasi tutte le opere di Livio derivavano da modelli greci
e avevano argomentazione e modelli greca:
-Le sue tragedie derivano dal repertorio greco
e si rifà alla tradizione greca poiché quel repertorio mitologico e leggendario
gli permetteva di allacciare le origini del popolo romano ad un’illustra tradizione
e di proiettare le recenti lotte contro i Grecis uno sfondo mitico.
-i testi drammatici seguono modelli greci,
anche se in campo teatrale i romani trasformarono i modelli con più libertà.
-l’epica parte con una traduzione del greco ma usando il metro della tradizione latina.
La traduzione dell'Odissea di Livio Andronico: limiti e conseguenze nella letteratura latina.
Livio ebbe l’iniziativa di tradurre in lingua latina e in metro italico (il saturnio) l’Odissea di Omero
e questa operazione sta all’origine della letteratura latina ed ebbe una portata enorme.
La traduzione di Livio rese disponibile ai Romani un testo fondamentale della cultura greca
(anche se le classi elevate romane, ampiamente ellenizzate, già leggevano Omero in greco),
ed ebbe anche molta fortuna anche come testo scolastico.
L’importanza di Livio sta nell’aver concepito la traduzione come operazione artistica:
costruzione di un testo che stia accanto all’originale,
sia fruibile come opera autonoma, sia capace di conservare le qualità espressive del modello.
Egli ebbe molta fama ma passò presto di moda:
in età classica le sue opere non vennero più apprezzate.
Scaricato da Marianna Tallarico (mariaanna.tallarico@hotmail.it)
lOMoARcPSD|5715493
LEZIONE 52
Illustra i personaggi della commedia plautina.
I personaggi di Plauto non sono caratteri individuali quanto piuttosto maschere fisse, tipi,
e per questo già noti al pubblico nel momento in cui si presentano sulla scena:
-L’adulescens: il giovane innamorato, ingenuo e sognatore e incapace di superare gli ostacoli.
Si esprime nei toni alti e patetici della tragedia, naturalmente con effetti comici e parodistici.
-Il senex: può essere il padre severo e perennemente beffato,
che cerca inutilmente di impedire i costosi amori degli adulescentes
oppure un ridicolo e grottesco concorrente del figlio in amore.
-La meretrix: il ruolo femminile più importante, la cortigiana,
figura sconosciuta in Roma prima che nascesse la Palliata, consueta invece nel mondo greco.
Nella "palliata" plautina possono essere sia libere che schiave,
e in quest’ultimo caso appartenere ad avidi e crudeli lenoni, che le mettono in vendita.
E’ previsto spesso il passaggio dalla condizione di amanti a quella di spose.
-Il leno: lenone, commerciante di schiave e sfruttatore di prostitute, sconosciuto presso i Romani.
E’ un tipo odioso, destinato alla sconfitta e alla beffa.
-La matrona: madre dell’adulescens e sposa del senex,
quasi sempre autoritaria e dispotica, soprattutto se ricca.
-Il parasitus: è uno dei tipi più buffi e curiosi della palliata,
caratterizzato dalla fame insaziabile e dall’ingordigia,
spesso fonte di rovina economica per il suo benefattore, che viene lodato e servito in ogni modo.
-Il miles gloriosus: il soldato mercenario che si mette al servizio di chi lo paga meglio,
figura consueta nei regni ellenistici ma sconosciuta in Roma. I
Solitamente è un millantatore che si vanta di imprese mai compiute, spacciandosi per seduttore.
-Il "servus": è la figura più geniale, orditore di incredibili inganni a favore dell’adulescens.
Illustra l'opera e l'importanza di Plauto.
Plauto è famoso soprattutto per aver coltivato un unico genere letterario
ovvero la commedia di argomento greco, detta Palliata, già nota in Livio Andronico e Nevio.
Alla sua morte si contano 130 sue commedie, tutte conservate tranne l’ultima in frammenti,
anche se Varrone ne riconosce solo 21autentiche.
E’ difficile capire la cronologia delle sue commedie
poiché scarsi sono i riferimenti alla realtà del suo tempo e a personaggi storici
in quanto egli vuole evitare l’impegno politico.
Questo però non significa che egli non avesse un occhio critico sul mondo:
nelle sue commedie emerge una società i cui valori sono ridicolizzati e l’apparenza messa in crisi.
Plauto è fondamentale per la lingua che utilizza tutti i registri linguistici:
dall’inno epico, al lirismo, al linguaggio grottesco ricco di doppi sensi, battute e giochi di parole.
Essa è dunque una lingua lontana dal purismo linguistico
e che è contaminata da una certa rusticitas di espressioni.
La sua lingua è molto importante tanto che oggi gli si riconosce un’importanza fondamentale
non solo per il teatro ma anche per l’innovazione e arricchimento lessicale del latino.
Plauto ha rielaborato le opere e i modelli greci.
Si tratta di un atteggiamento comune nella storia della letteratura latina,
oppure rappresenta una sua scelta personale?
Plauto traduce, adatta, riprende e rielabora commedie greche che noi non possediamo nel testo originale,
quindi da sempre la critica cerca di valutare in quale misura egli sia stato fedele agli originali
e quanto invece abbia innovato, modificato e ricreato liberamente.
Egli definisce la sua opera “vortere barbare” cioè “trasposizione in latino di opere di autori greci”.
Questa non è una prerogativa di Plauto:
prima di lui Livio Andronico e poi anche Terenzio si ispireranno a modelli greci anche se con esiti diversi.
Scaricato da Marianna Tallarico (mariaanna.tallarico@hotmail.it)
lOMoARcPSD|5715493
LEZIONE 53
Iudicavit inclitum iudicium: la profezia di Cassandra nel teatro enniano.
La profezia di Cassandra si trova nell’Alexander di Ennio.
Si tratta di un frammento riportato da Cicerone e riguarda le parole di Cassandra, figlia di Priamo,
sfortunata profetessa il cui destino era di non essere mai creduta.
La successione degli eventi che portano alla guerra e alla caduta di Troia viene invertita:
all’inizio è posta la fiaccola, il cui colore richiama il sangue:
è il fuoco dell’incendio che devasta Troia per mano dei Greci.
Poi, con un andamento a ritroso, si parla dell’allestimento della flotta che verrà ad assalire Troia.
Infine, la ‘causa’ originaria, cioè il giudizio di Paride che gli varrà Elena come premio:
dal ‘rapimento’ di Elena provocherà la spedizione dei Greci contro Troia.
L'invocazione alle muse in apertura degli Annales di Ennio, alter Homerus.
Nel proemio degli Annales Ennio si presenta come un poeta erede di Omero (alter Homerus),
infatti nell’invocazione alle Muse esse sono chiamate con il nome omerico
e descrive l’investitura poetica ricevuta.
Egli si vede appunto come l’erede di Omero
che adatta la lingua latina alla tradizione metrica dell’epica greca.
Nel proemio infatti Ennio narra che gli era apparso in sonno Omero
e gli aveva rivelato come la sua anima, dopo altre reincarnazioni,
si fosse infine reincarnata in Ennio stesso, che era dunque il nuovo Omero, l’Omero romano.
Sono dunque evidenti gli influssi ellenistici,
ma l’opera è anche profondamente radicata nella tradizione romana,
a partire dal titolo, Annales, che richiama gli Annali pontifici,
ma anche nella solennità e magniloquenza dello stile
con cui si lodano i personaggi storici, la grandezza di Roma e gli ideali etico-politici romani.
Perché gli Annales di Ennio sono definiti "grande poema nazionale romano"?
Gli Annales sono un poema epico scritto da Ennio
che raccontava, come suggerisce il titolo, la storia di Roma "anno per anno", dalle origini.
Ci sono pervenuti in forma incompleta a frammenti.
Questo poema celebrava la storia di Roma in ordine cronologico,
dalle origini leggendarie con l'arrivo di Enea, agli avvenimenti contemporanei alla vita del poeta.
Egli si propone di celebrare e glorificare i singoli esponenti dell’aristocrazia romana,
ma anche di esaltare il popolo romano, la cui grandezza era per lui frutto dell'intervento divino.
Tutto il poema è immerso in un'atmosfera eroica, ripresa dai poemi omerici,
infatti l’autore, afferma di essere la reincarnazione di Omero
e narra di essere stato trasportato in sogno sul Parnaso, dove gli appare l'ombra del grande Omero.
Questo ci fa capire quanta consapevolezza il poeta ebbe
della propria grandezza e della funzione della sua opera.
Scaricato da Marianna Tallarico (mariaanna.tallarico@hotmail.it)
lOMoARcPSD|5715493
LEZIONE 54
Un brano del Plocium di Cecilio Stazio
ci permette di verificare come ha trattato il modello greco:
illustra le scelte di Cecilio Stazio anche alla luce dell'atteggiamento di altri autori latini.
Stazio si colloca a metà strada tra la commedia comica grossolana di Plauto
e quella sentenziosa e moraleggiante di Terenzio.
E’ considerato un autore minore perché molte opere sono andate perdute
o forse per il confronto con i due sommi autori Plauto e Terenzio.
Egli si ispirò al commediografo greco Meneandro per le sue opere ma non si tratta di una traduzione
ma più di un rifacimento e una reinterpretazione sulla base della società e del gusto romano.
In particolare la commedia più conosciuta di Stazio è Plocium (la collana),
commedia che si ispira a Meandro, anche se Stazio la reinterpreta con libertà.
Oltre a Plauto, in età arcaica, quali altri autori di teatro ti sono noti
e quali sono le caratteristiche stilistiche che li accomunano?
Stazio, Pacuvio e Accio:
- sono poeti drammatici
-amanti dello stile difficile ma i cui testi sono sempre fatti per essere portati in scena
e che vogliono rappresentare terrore, paura, commozione.
-I loro modelli sono i classici greci.
-Essi sono figure di prestigio, sono anche poeti-filologi e grammatici.
Hai presente e sai dare la definizione di FABULA PRAETEXTA, FABULA COTHURNATA,
FABULA TOGATA, FABULA PALLIATA?
- Palliata (fabula palliata).
Era la commedia di ambientazione greca
che si ispirava ai testi degli autori della commedia nuova greca, soprattutto, Menandro,
dei quali assume intrecci, ambienti e personaggi.
Introdotta da Livio Andronico e da Nevio,
ebbe i maggiori interpreti in Stazio, Plauto e Terenzio.
All’inizio vi era un prologo in cui erano esposti l'antefatto, la trama,
e la richiesta agli spettatori di essere indulgenti,
poi seguiva uno svolgimento e un finale.
Vi erano parti recitate, cantate e suonate.
- Si estinse a causa dell'eccessiva uniformità degli intrecci.
- Togata (fabula togata ).
Era la commedia di ambientazione romana, così chiamata dalla toga.
Ebbe inizio dopo la scomparsa della Palliata.
Aveva un carattere più popolare della commedia greca:
metteva in scena il mondo degli umili, dei contadini, degli artigiani,
con grande varietà di tematiche, con intrecci meno complicati e con un meno personaggi.
Venne anche chiamata tabernaria, quando metteva in scena il mondo di osterie e botteghe.
- Coturnata ( fabula cothurnata ).
È la tragedia di ambientazione greca, che ha come modelli Eschilo,Sofocle e sopratt. Euripide. Il
nome deriva dal coturno, l'alto calzare a forma di stivaletto con spessa suola,
tipico degli attori greci.
- Pretesta (fabula praetexta ).
È la tragedia di ambientazione romana, di carattere patriottico e nazionale,
che esalta avvenimenti importanti o eminenti figure politiche.
Il termine deriva dal nome dell'abito indossato dai magistrati romani con una striscia di porpora.
Scaricato da Marianna Tallarico (mariaanna.tallarico@hotmail.it)
lOMoARcPSD|5715493
LEZIONE 55
Confronto tra Plauto e Terenzio: vita, opere, stile, finalità.
Plauto era un autore di autore di atellane poi divenuto autore di palliate,
commedie di argomento greco con maschere o tipi fissi.
Ebbe molto successo a Roma alla sua morte circolavano più di 130 commedie con il suo nome,
ma di cui solo 21 sono sicuramente da lui scritte.
Temi centrali:
-La beffa: solitamente il personaggio che si occupa dell’organizzazione della beffa è il servo.
-Tema del viaggio con protagonista un mercante e una schiava trovata in viaggio.
-Agnizione: un personaggio che stravolge la trama e risolve l’intereccio sul finale
-I sosia: vi sono due sosia a cui capitano eventi senza che essi sappiano di avere un sosia.
-Caricatura di personaggi della società (anche se rari perché cerca di evitare l’impegno politico)
La sua lingua usa molti registri linguistici: epico, lirico, grottesco,
dunque è lontano dal purismo linguistico.
Egli conia neologismi, usa molto la coordinazione al posto della subordinazione,
fa ampio ricorso alle figure retoriche.
Le sue palliate erano fatte da parti dette diverbia e parti cantate dette cantica.
Terenzio fece parte del circolo degli Scipioni,
un gruppo di intellettuali che apprezzavano l'entrata della cultura ellenistica in quella romana,
anche perché è in questo periodo che Roma conquista la Grecia,
aumentando gli scambi con essa e quindi le relazioni, anche culturali.
Parte del popolo romano però era contrario a questa mescolanza di culture,
poiché, secondo loro, la tradizione ellenistica poteva intaccare e rovinare il mos maiorum romano,
infatti la vicinanza di Terenzio al circolo degli Scipioni,
che promuoveva l'entrata della cultura greca a Roma, gli provocò diverse inimicizie personali.
Terenzio è sempre autore di Palliate
ma affronta temi molto diversi da quelli di Plauto, molto più seri e meditativi, psicologici,
e che proprio per questo non ebbero un successo immediato.
La lingua usata dai personaggi nelle commedie di Terenzio è aulica
e coincide con quella parlata dai ceti elevati della società,
ricca di una terminologia spesso complessa, astratta, difficili da comprendere dal popolo
che quindi preferiva commedie come quelle di Plauto.
Terenzio inoltre sopprime le parti dette cantica,
comuni nelle opere di Plauto, mantenendo solo i deverbia.
Terenzio dunque usava un genere fondamentalmente popolare
per comunicare una sensibilità e interessi nuovi
trasmessi dall’elite sociale e culturale degli Scipioni, ma che erano lontani dai gusti del popolo.
Scaricato da Marianna Tallarico (mariaanna.tallarico@hotmail.it)
lOMoARcPSD|5715493
Rapporto padre-figli in Terenzio.
Terenzio nell’Adelphoe ( i fratelli), tratta da una commedia di Meandro,parla di due fratelli:
Demea è rigido ed austero, Micione ha idee più moderne.
Demea ha ripensamenti sul suo modo di comportarsi nei confronti del figlio
che è un ribelle e ne combina di tutti i colori e decide di comportarsi in modo più liberale.
Questo tema dell’educazione e del rapporto padre-figlio è trattato più volte da Terenzio
e riflette il contrasto tra i rigidi sistemi educativi tradizionali
e il nuovo costume liberale diffuso nelle famiglie aristocratiche di tendenza ellenizzante.
Illustra il concetto di humanitas.
Il concetto di humanitas indica una sintesi originale dei valori greci e romani
destinati a diventare patrimonio dell’umanità
in quanto cultura, civiltà, tolleranza, comprensione, rispetto della dignità di ogni uomo.
E’ un processo lento che porta a una nuova sintesi di valori.
Terenzio, anche se con un linguaggio aristocratico, si fece portavoce di questi valori,
infatti molti dei suoi personaggi si concentrano sull’introspezione psicologica,
e molti di essi rivelano le contraddizioni della società romana e dei valori che affermava.
LEZIONE 56
In cosa consiste la reazione antiellenica di Catone?
Catone si professa come campione della romanità tradizionale:
in politica fu contro l’aristocrazia filoellenica
e in letteratura attaccava i modelli greci, in particolare quelli promossi dal Circolo degli Scipioni,
poiché vedeva la tradizione ellenistica come portatrice della corruzione del mos maiorum.
Tuttavia Catone non ignorava la cultura greca:
egli ostentò di ignorarla ma in realtà le sue opere mostrano una conoscenza della letteratura greca.
Illustra l'importanza del Circolo degli Scipioni e i valori da esso promossi.
Il Circolo degli Scipioni, sorto alla metà del II secolo a.C.,
fu creato da Scipione l’Africano e da suo fratello Scipione l’Asiatico.
Esso riuniva esponenti della nobiltà romana filoellenica e intellettuali greci.
Il contributo culturale più alto dei Circolo degli Scipioni
è l’affermarsi dell’ideale dell’humanitas (in greco philanthropìa),
una sintesi originale di elementi greci e romani, destinata a diventare patrimonio dell’Umanità
in quanto cultura, civiltà, rispetto della dignità di ogni uomo, comprensione e tolleranza.
Scaricato da Marianna Tallarico (mariaanna.tallarico@hotmail.it)
lOMoARcPSD|5715493
LEZIONE 57
Il circolo letterario di Lutazio Catulo è importante perché...
Nel circolo letterario di Lutazio Catulo
si crea una produzione con argomenti e forme della poesia ellenistica
e ha il merito di anticipare e preparare il circolo dei poeti novi (neoteroi).
Gli intellettuali di questo circolo sono accumunati da una tendenza all’indivisualismo;
prediligono l’isolamento personale e non sono impegnati socialmente
poiché la crisi della Repubblica li aveva allontanati dalle passioni civili
facendolo vivere in una dimensione estetica, intellettuale e artistica.
Vi è una grande ricerca stilistica e lessicale.
Homo sum, nihil humani a me alienum puto: questa massima ebbe molto successo nell'antichità.
Ne parlano Cicerone, Seneca, ma anche autori cristiani come Agostino ed Ambrogio.
Sapresti illustrarla e verificarne, secondo la tua opinione, l'attualità?
Traduzione:
“Sono un essere umano, non ritengo a me estraneo nulla di umano”,
cioè più semplicemente “Nulla che sia umano mi è estraneo”.
La frase è di Terenzio che la usò in una sua commedia,
in cui uno dei personaggi si impiccia dei fatti altrui, e quando viene invitato a non farlo,
risponde con queste parole come a dire:
"sono un essere umano, e tutte le cose umane sono affari miei".
Questa frase è stata ripresa da molti autori tra cui Cicerone, Seneca, Agostino e Ambrogio.
Essa oggi appare come una giustificazione alla curiosità dell’uomo
e per significare che l’uomo deve essere aperto a qualsiasi esperienza umana,
ma può anche significare che all’uomo non è estraneo né il male né il bene
e che può scegliere se cadere nel peccato o aspirare verso il bene.
Esempi di prosa oratoria nell'età di Cesare.
Nell’età di Cesare la prosa si afferma molto nell’attività letteraria e pubblica.
Esempi di prosa si possono trovare nell’autore Gaio Cracco nell’opera Orationes,
in particolare ci rimane un lungo frammento di un’orazione
pronunciata per impedire l’approvazione di una legge che proponeva
che andasse a Mitridate, re del Ponto, la refione della Frigia.
Un altro esempio è Cicerone, che pronunciò più di 100 orazioni, divise in due tipologie:
orazioni giudiziarie legate alla sua attività di avvocato
e orazioni deliberative legate alla sua attività legislativa.
In esse si riconosce la fede nella tradizione aristocratica e conservatrice repubblicana
e pagò con la sua vita per questo.
Scaricato da Marianna Tallarico (mariaanna.tallarico@hotmail.it)
lOMoARcPSD|5715493
LEZIONE 58
Illustra il concetto di religio in Lucrezio.
Lucrezio aderì all’epicureismo che vedeva la via per la felicità
nell’atarassia, nell’imperturbabilità, nell’isolamento dalla vita politica e dagli affanni del mondo;
al contrario erano importanti la meditazione, l’amicizia, il godimento dei piaceri della natura.
Essi credevano che la morte non doveva preoccupare, gli dei non si dovevano temere,
che il bene era facile da ottenere e che il male era facile da sopportare.
Tale dottrina però era criticata dagli esponenti della cultura tradizionale
sia perché distoglieva dall’impegno politico, sia perché portava alla dissoluzione morale,
sia infine perchè negava l’intervento divino degli affari umani
e dunque creava svantaggi nella classe dirigente
che non poteva più usare la religione come strumento di potere.
Egli sosteneva gli dei esistevano ma non si curavano del mondo e non lo reggevano,
dunque la religione doveva essere semplicemente inglobata all’interno dello studio della natura.
Che significato ha la presentazione della peste di Atene alla fine del poema di Lucrezio?
Nel De rerum Natura Lucrezio, ispirandosi a Ticidide,
narra la peste di Atene che scoppia durante l’ultima fase della guerra del Peloponneso:
il poeta attraverso una descrizione dei sintomi fisici e degli effetti nefasti a livello morale,
vede nell’epidemia un totale crollo dell'umanità.
In queste scene emerge il pessimismo di Lucrezio:
la morte non è che l’altra faccia della vita ma il timore che essa genera rende l’uomo “disumano”.
La peste inoltre chiude il libro VI, che tratta dei fenomeni naturali,
con questa scena che suggella la forze terribile e onnipotente della natura.
Il poema in realtà è uno strumento educativo affinchè l’uomo giunga all’atarassia
e rimanga imperturbabile di fronte alle paure, alle passioni, alla sofferenza.
Questo passo così diverso e pessimista sembra che egli voglia mostrare
come la vita diventerebbe senza gli insegnamenti di Epicuro:
Il trionfo della sofferenze, della disperazione e della morte.
Scaricato da Marianna Tallarico (mariaanna.tallarico@hotmail.it)
lOMoARcPSD|5715493
Commenta e illustra, individuando figure retoriche e particolarità linguistiche e stilistiche,
i seguenti versi di Lucrezio: Aeneadum genetrix, hominum diuumque uoluptas, / alma Venus,
caeli subter labentia signa / quae mare nauigerum, quae terras frugiferentis /concelebras, per
te quoniam genus omne animantum /concipitur uisitque exortum lumina solis.
Questo brano costituisce il proemio del poema epico-didascalico De Rerum Natura
con la quale voleva divulgare tra i romani la filosofia epicurea.
Conformemente ai canoni tradizionali dell’epica,
Lucrezio inizia il poema con una invocazione ad una divinità, Venere,
definita con una serie di vocativi (genetrix, voluta, alma Venus)
considendola dispensatrice di vita
e l’unica in grado di neutralizzare la forza distruttrice di Marte, Dio della guerra.
Egli le rivolge due preghiere:
nella prima le chiede di aiutarlo a persuadere i lettori attraverso il fascino delle sue parole;
nella seconda (di carattere politico e civile) la invita a creare un clima di pace e serenità
affinchè egli possa essere nella condizione di portare a termine la sua opera.
La forma metrica usata è l’esametro.
Vi è ampio uso di figure retoriche (anafore, anastrofi)
mentre dal punto di vista lessicale confluisce al testo magniloquenza con arcaismi e neologismi.
Quali sono gli scopi che si prefiggeva Lucrezio con il suo poema?
Il proposito di Lucrezio nel De Rerum Natura
era mostrare come solo la luce della scienza epicurea
può liberare l’uomo dallo stato di angoscia e ignoranza in cui soggiace.
Per ottenere ciò, la dottrina epicurea dimostra che sono vani il timore degli dei e della morte,
perché l’intero universo si svolge secondo meccaniche leggi fisiche,
in cui non ha spazio l’intervento di alcuna divinità, né l’anima sopravvive alla morte del corpo.
Quale significato hanno Venere e l'amore nel poema di Lucrezio?
Lucrezio invoca la dea Venere al posto delle muse che solitamente si invocavano.
Lucrezio considera Venere, divinità della natura e simbolo della nascita e della vita.
Egli vede in Venere sia il simbolo della forza vitale della natura
ma al tempo stesso l’immagine della contemplazione razionale della bellezza della natura,
dunque simbolo dell’edoné, della bellezza raggiunta con la saggezza.
Scaricato da Marianna Tallarico (mariaanna.tallarico@hotmail.it)
lOMoARcPSD|5715493
LEZIONE 59
Commenta e illustra, individuando figure retoriche e particolarità linguistiche e stilistiche,
il seguente componimento di Catullo: Nulli se dicit mulier me nubere malle / Quam mihi, non
si se Iuppiter ipse petat. / Dicit; sed mulier cupido quod dicit amanti / In vento et rapida
scribere oportet aqua
Catullo usa un’immagine per dire che non va dato peso alle promesse delle donne agli innamorati:
ciò che la donna dice a un amante sono parole che vanno scritte nel vento e nell’acqua rapida,
cioè a un’acqua che scorre e che le porta via velocemente.
Ovviamente Catullo sta parlando di Lesbia.
Chi sono e che significato hanno i neoteroi?
I neoteroi o poetae novi sono un gruppo di poeti
che rompe con la morale tradizionale e che mostra completo disinteresse per l’Impegno civile.
Loro precursori furono gli autori legati al circolo di Lutazio Catulo.
I loro ideali sono quelli della poesia alessandrina:
ripudio dell’epica e della poesia solenne e predilezione per una poesia breve, raffinata e ironica.
I generi trattati sono l’epigramma (impronta soggettiva),
l’elegia (narrazione di vicende mitologiche di soggetto amoroso)
e l’epillo (poemetto di soggetto mitico su vicende poco note).
Il loro stile è basato sul labor limae
cioè sul lungo esercizio alla rierca della perfezione formale e stilistica.
Essi vennero rinominati così con disprezzo da Cicerone
che criticava il loro disprezzo per la tradizione.
Commenta e illustra, individuando figure retoriche e particolarità linguistiche e stilistiche,
il seguente componimento: Odi et amo. Quare id faciam, fortasse requiris / Nescio, sed fieri
sentio et excrucior
“Odio e amo. Forse chiederai perché faccio questo.
Non lo so, ma sento che così accade e ne sno straziato”.
Con questi due soli versi Catullo rappresenta il dissidio interiore e la lacerazione dell’io:
la delusione in lui è tanto più forte poiché l’eros era divenuto per lui il centro dell’esistenza,
l’unica cosa che poteva dare senso alla vita.
Egli constata la drammatica compresenza di sentimenti contrapposti nel suo animo:
amore e odio, illusione e disillusione.
E’ un distico elegiaco breve ed essenziale come è tipico di questo genere letterario
che riesce a condensare in un epigramma di poche parole molti sentimenti,
infatti è un grande esempio di sintesi espressiva.
Scaricato da Marianna Tallarico (mariaanna.tallarico@hotmail.it)
lOMoARcPSD|5715493
Commenta e illustra, individuando figure retoriche e particolarità linguistiche e stilistiche,
i seguenti versi: Multa per gentes et multa per aequora vectus / Advenio has miseras, frater,
ad inferias, / ut te postremo donarem munere mortis / et mutam nequiquam alloquerer
cinererm
Il carme 101 è tra i più celebri di Catullo ed è un’elegia funebre.
Fu composto durante un viaggio in Bitinia
e narra della visita alla tomba del fratello per porgergli l’estremo saluto.
Il dolore per la perdita del fratello si unisce qui con i temi tipici della poesia sepolcrale greca.
E’ un distico elegiaco.
Vi sono metonimie, anafore, apostofe, ipallage, metafore e personificazioni.
Perché è corretto dire che Catullo, pur opponendosi alla tradizione,
ne ripropone i valori in campo amoroso?
Catullo si oppone alla tradizione ma fa dell’amore e della poesia l’unica ragione di vita,
poiché in lui amore e poesia coincidono.
La sua popolarità è legata alla stori d’amore con Lesbia,
che ricorda l’isola greca Lesbo, patria di questa poetessa.
E’ la prima volta che nella letteratura latina si affronta il tema di un amore reale,
descritta con termini fisici e realistici,
e molto intessuta di reminiscenze greche:
è infatti un rapporto nato come adulterio, come amore libero e basato sull’eros,
anche se per Catullo poi diviene un amore totalizzante e indissolubile.
Il tradimento però produce in Catullo una dissociazione
tra la componente sensuale e quella affettiva, fino ad allora intrecciate:
il desiderio sessuale resta forte ma l’affetto diminuisce man mano d’intensità.
Illustra i valori che stanno alla base del Liber catullianus
con riferimento anche alle scelte lessicali.
Il “Liber” di Catullo è costituito da 116 componimenti ordinati postumamente
in base ad un criterio metrico-formale, tipico dei grammatici.
- Primi 60: “nugae” (scherzi) e sono brevi poesie in metrica
dal tono leggero e ispirate alla vita quotidiana
- Carmi 61-68: “carmina docta”, ovvero componimenti colti, dotti, di tema mitologico,
di maggiore estensione, per lo più in esametri, molto elaborati stilisticamente.
- Carmi 69-116: sono gli “epigrammi” in distico elegiaco,
brevi e di carattere quotidiano e satirico come il primo gruppo.
LEZIONE 60-> no domande
Scaricato da Marianna Tallarico (mariaanna.tallarico@hotmail.it)
lOMoARcPSD|5715493
Esame 13 Settembre 2019, domande+risposte
Lingua e letteratura latina (Università degli Studi di Bergamo)
StuDocu non è sponsorizzato o supportato da nessuna università o ateneo.
Scaricato da Marianna Tallarico (mariaanna.tallarico@hotmail.it)
lOMoARcPSD|5715493
LEZIONE 61
Commenta e illustra, individuando particolarità linguistiche e stilistiche, il seguente brano di Cesare:
Gallia est omnis diuisa in partes tres, quarum unam incolunt Belgae, aliam Aquitani, tertiam qui
ipsorum lingua Celtae, nostra Galli appellantur. hi omnes lingua, institutis, legibus inter se differunt.
Questa frase è la prima parte dell’incipit del De Bello Gallico di Cesare in cui egli descrive la Gallia,
luogo dove stava seguendo le operazioni militari:
divisa in tre parti, la prima dove abitano i Belgi, l’altra dove abitano gli Aquitani, l’altra i Celti o Galli,
popoli che si differenziano per lingua, istituzioni e leggi.
E’ evidente come in questo proemio sia particolare:
non si indirizza al lettore, non c’è l’invocazione alla divinità, non giustifica la propria opera,
ma al suo posto si forniscono informazioni di tipo geografico,
mentre nella parte successiva si parla anche della pericolosità delle popolazioni che premono sui confini.
Il linguaggio è semplice e senza ornamenti retorici:
Cesare seguiva la corrente dell’atticismo che dava più importanza ai concetti che alla forma,
sceglieva attentamente le parole per rendere il contenuto pur con attenzione all’eleganza espositiva,
era uno stile scarno, severo, paratattico.
La posizione del narratore nelle opere di Cesare.
L’opera comunemente nota come De bello Gallico in realtà si chiama Commentari de bello Gallico,.
Il termine Commentari significa “appunti”,
e propongono una cronaca diretta senza abbellimenti letterari (diversamente dalle Historiae):
probabilmente derivano proprio dagli appunti dettati da Cesare ai suoi segretari durante le campagne militari
anche se l’opera ha una struttura troppo elaborata e uno stile troppo elevato per essere solo “appunti”
quindi probabilmente vi fu una rielaborazione successivamente dal suo ritorno dalla Gallia.
Una volta tornato Cesare infatti ricevette critiche per i sacrifici in denaro e sangue della guerra
e dunque nel testo Cesare vuole mostrare la guerra come una necessità storica
volta a evitare che i Germani, passato il Reno, invadessero quelle regioni.
Per farlo però non usa un tono polemico
ma lascia parlare i fatti, usa formule impersonali e narrazioni oggettive,
anche se i fatti sono presentati con uno specifico punto di vista: il suo,
ma il tutto nascosto usando la terza persona.
Cesare e il suo esercito: i personaggi del De bello Gallico.
I personaggi del De Bello Gallico (come nel De bello civili) sono Cesare e l’esercito,
e per volontà di dare una descrizione il più possibile precisa e dettagliata dei fatti
vengono citati anche nomi di soldati,
mentre quando parla di sé lo fa in terza persona,
anche se questo è solo un espediente per dare la sua versione dei fatti.
Nonostante le descrizioni il più possibili oggettive non si può imputare a Cesare mancanza di umanità:
egli celebra il valore dei soldati, la loro dedizione al comandante,
lo spirito di sacrificio e l’attaccamento ai compagni.
Da qui se ne deduce l’amore del generale Cesare per i suoi soldati,
tanto grande da non citare l’ammutinamento della nona legione a Piacenza.
Scaricato da Marianna Tallarico (mariaanna.tallarico@hotmail.it)
lOMoARcPSD|5715493
LEZIONE 62
Caratteristiche dello stile di Sallustio.
La scelta della monografia portò Sallustio ad elaborare un nuovo stile storiografico
il cui tratto più caratteristico è l’inconcinnitas (concinnitas era l’equilibrio armonico tipico di Cicerone)
ovvero il disequilibrio, il rifiuto di un discorso ampio e regolare, proporzionato,
prediligendo invece ellissi, antitesi, asimmetrie, variationes di costrutto.
Inoltre vi è un’economia dell’espressione (omissione di legami sintattici)
con un condensazione del discorso reso essenziale,
e all’estremo opposto un gusto per l’accumulo di parole.
Si parla perciò di arcaismo innovatore,
perché il suo andamento spezzato è del tutto anticonvenzionale
e perché lessico e sintassi contrastano quel processo di standardizzazione
che si stava verificando nel linguaggio letterario.
La prospettiva storica di Sallustio (le ragioni del fare storia).
Sallustio scrive due monografie storiche dedicate a Catilina e Giugurta.
La sua storiografia è una sorta di indagine sulla crisi della vita politica romana.
Egli in entrambe le sue opere vuole parlare dell’attività dell’intellettuale di fronte al popolo romano
fedele alla tradizione che “fare la storia” è più importante che scriverla.
Nei primi capitolo del Bellum Catilinarium infatti parla
della contrapposizione tra otium letterario e impegno politico:
egli sostiene che compiere imprese e narrarle sono entrambe attività degne.
Questo è ribadito nel Bellum Iugurthinum:
le azioni compiute dal corpo sono finite nel tempo e nello spazio
mentre quelle compiute dall’anima sono destinate a gloria eterna oltre la morte.
I ritratti dei personaggi in Sallustio.
Nelle opere di Sallustio il ritratto dei personaggi ha un ruolo fondamentale
per l'effetto finale che i testi dovevano suscitare,
egli infatti è il primo a sviluppare quella che sarà in seguito definita “tecnica fisiognomica”,
la quale consiste nel mettere in relazione i caratteri psichici con l'aspetto fisico,
fornendo un quadro di informazioni che permetta di visualizzare visivamente allo stesso tempo
la persona e la personalità descritte.
-Catilina è descritto con tinte forti e contrastanti:
intelligente, coraggioso ma al testo stesso malvagio:
per quanto figura sinistra questo lo rende affascinante e carismatico.
A questo carisma nemmeno Sallustio sa sottrarsi pur rimanendo l’esigenza moralistica:
egli descrive il personaggio ma al tempo stesso lo giudica.
-Cesare è un personaggio positivo per la sua liberalità e misericordia e mugnificentia.
-Catone è descritto positivamente con le virtù della tradizione: integritas, severitas, innocentia.
-Cicerone è descritto con un ruolo ridimensionato:
Sallustio gli riconosce di aver scoperto il complotto ma la sua figura non emerge
e a volte è descritta con ironia, dunque emerge poca simpatia nei suoi confronti.
Scaricato da Marianna Tallarico (mariaanna.tallarico@hotmail.it)
lOMoARcPSD|5715493
LEZIONE 63
L'ideale politico espresso nel De republica e il concetto di «costituzione mista».
Il De Repubblica è un’opera di 6 libri scritti sul modello del dialogo platonico
ambientata nella villa di Scipione l’Emiliano.
Lo scopo è argomentare sulla migliore forma di stato nella costituzione romana,
partendo dalla dottrina aristotelica delle tre forme di governo (monarchia, aristocrazia, democrazia)
e della loro degenerazione nelle forme estreme: tirannide, oligarchia, olocrazia (governo del popolo).
Secondo Scipione lo stato romano si salva dalla degenerazione perché è appunto a “costituzione mista”:
la monarchia espressa dal consolato, l’artistocrazia dal senato, la democrazia nei comizi
(stesso pensiero dello storico greco Polibio che considerava perfetta la forma di governo di Roma).
Cicerone delinea anche al figura del princeps, antitesi del tiranno:
egli pare pensare a un’elite di personaggi eminenti alla guida del senato,
dunque sembra non prefigurare l’avvento dell’impero
ma sembra voler mantenere il princeps all’interno dei limiti dello stato repubblicano.
Meriti e ruolo di Cicerone nella storia della filosofia.
Cicerone sosteneva che politica e filosofia fossero inseparabili:
la meditazione filosofica era alla base stava alla base della preparazione oratoria
che a sua volta era premessa delle scelte politiche del cittadino a servizio del bene comune.
Per questo motivo le sue opere filosofiche hanno lo stesso fine delle sue orazioni:
dare una solida base ideale, etica e politica a una classe dominante
che ha bisogno un ordine che non si traduca però in chiusura e ottusità,
che deve rispettare il mos maiorum senza impedire l’assorbimento della cultura greca,
che deve assolvere i suoi doveri verso lo stato senza eliminare l’otium di arti e letteratura.
Cicerone non si può definire un pensatore originale,
ma sicuramente cercò di ripensare metodi e teorie delle scuole filosofiche greche
per dargli una sistemazione che potesse essere punto di riferimento
per la classe dirigente romana e per la società in cambiamento.
Attraverso questo lavoro introdusse nel latino molti grecismi e neologismi
che poi sarebbero diventati patrimonio della tradizione intellettuale europea.
Egli rifiutava l’epicureismo, mentre mostrava punti di contatto con lo stoicismo
e soprattutto con il concetto di mediocritas, ovvero “giusto mezzo”, “moderazione”.
L’opera filosofica maggiore è il De Officis, trattato di etica che Cicerone dedica al figlio Marco,
e che ha come scopo la formazione etico-politica della gioventù
e il fornire un modello di comportamento in linea con le trasformazioni del tempo per la classe dirigente.
Nel trattato si esaminano doveri e virtù dell’uomo onesto
e in particolare emerge che il regolatore generale di istinti e virtù è la temperanza:
disprezzo per i beni terreni, onori, ricchezza e potere
e invece armonia di pensieri, gesti e parole -> concetto di decorum.
Sempre nell’opera si dice che le azioni e i comportamenti cambiano da persona a persona:
ognuno può prendere scelte di vita anche diverse da quelle tradizionali delle cariche pubbliche
purché non dimentichi i suoi doveri verso la collettività.
Scaricato da Marianna Tallarico (mariaanna.tallarico@hotmail.it)
lOMoARcPSD|5715493
Verrine, Catilinarie e Filippiche:
illustra le tappe del pensiero politico di Cicerone
partendo da queste opere.
LE VERRINAE (70a.C):
I siciliani proposero a Cicerone di sostenere l'accusa contro l'ex governatore Verre,
il quale aveva sfruttato la provincia con grande avidità.
Verre venne schiacciato dalle accuse e fu condannato in contumacia.
La vittoria su Ortensio, difensore di Verre, oltre che di grande prestigio politico,
fu anche una vittoria in campo letterario:
all'esasperato manierismo asiano di Ortensio
Cicerone oppose il suo stile asciutto caratterizzato da un periodare armonioso e da una sintassi duttile.
Cicerone dà prova della sua pungente ironia e conferma di essere un maestro nell'arte del ritratto,
attraverso il quale ridicolizza satiricamente i suoi avversari.
LE CATILINARIE (63aC):
Console nel 63aC, Cicerone soffocò la congiura che Catilina voleva ordire per operare un colpo di stato.
In quattro orazioni pronunciate di fronte al senato,
Cicerone svelò le trame sovversive che Catilina aveva organizzato
una volta vistosi sconfitto nella competizione elettorale,
lo costrinse a fuggire da Roma e giustificò la sua decisione di far giustiziare i suoi complici senza processo.
Sul piano artistico spicca la prima Catilinaria nella quale Cicerone attaccò Catilina di fronte al senato:
i toni soni sono veementi, minacciosi e ricchi di pathos.
Nella seconda Catilinaria è da ricordare invece il ritratto di Catilina
e dei suoi seguaci corrotti dal lusso e dal vizio.
LE FILIPPICHE (44aC): Dopo l'uccisione di Cesare, Cicerone decise di ritornare all'attività politica,
vedendo in Ottaviano, l'erede di Cesare, l'uomo con cui far ritornare i fasti della repubblica.
La manovra politica di Cicerone voleva staccare Ottaviano da Antonio
e riportare Ottaviano sotto la protezione del senato.
Per indurre il senato a dichiarare guerra ad Antonio e a farlo dichiarare nemico pubblico
Cicerone pronunciò contro Antonio le Filippiche, che si distinguono per i loro tono molto accesi e violenti,
ma il suo piano era destinato a fallire perché Ottaviano si sottrasse alla tutela del Senato
e fece un accordo con Lepido e Antonio (II Triumvirato) e Antonio pretese la testa di Cicerone.
Perché Cicerone viene mandato in esilio? Quando?
Cicerone sale al consolato nel 63 aC, anno della congiura di Catilina,
e proprio in quell’anno pronuncia le 4 Catilinarie e fa condannare a morte i congiurati,
mentre Catilina viene sconfitto e ucciso in battaglia.
Cicerone per i suoi meriti viene definito pater patriae,
ma poco dopo a causa del processo irregolare viene accusato e mandato in esilio nel 58aC,
esilio da cui verrà richiamato l’anno seguente, il 57aC.
Quali caratteristiche deve possedere l'oratore secondo Cicerone?
Individua almeno due ragioni per cui si può dire che nelle Verrine e nelle Catilinarie
Cicerone applichi appieno la sua teoria sull'oratore.
Cicerone stesso nel De oratore parla della formazione dell’oratore, che coincide con quella del politico:
cultura non specialistica ma vasta cultura generale
e profonda conoscenza della natura umana per padroneggiare l’arte della parola e persuadere gli ascoltatori.
Nell’Orator continua la sua descrizione delineando i 3 scopi dell’oratore:
probare (avere argomenti validi per la sua tesi),
delectare (produrre con le parole una piacevole impressione estetica)
flectere (muovere le emozioni con il pathos).
Infine nel dialogo Brutus Cicerone ribadisce che il criterio per valutare la riuscita stilistica
è il successo dell’oratore di fronte all’auditorio.
Le sue orazioni sono un modello di questo stile oratorio.
Scaricato da Marianna Tallarico (mariaanna.tallarico@hotmail.it)
lOMoARcPSD|5715493
LEZIONE 64
Perché si parla di una nuova età dell'oro per l'impero di Augusto?
-Il principato di Augusto si inserisce in un periodo di relativa stabilità e tranquillità:
dopo che lo stato romano era stato devastato dai decenni delle guerre civili,
la pace interna è riconquistata e la a sicurezza alle frontiere è ottenuta con campagne militari e accordi diplomatici.
-Il mantenimento formale delle forme repubblicane,
nelle quali si inseriva il nuovo concetto della personale auctoritas del princeps (primo fra pari),
permetteva di risolvere i conflitti per il potere vissuti nell'ultimo secolo della Repubblica.
- Elaborazione di una nuova cultura, di impronta classicistica,
che fondesse gli elementi tradizionali in nuove forme consone ai tempi,
In particolare in campo letterario importante fu il circolo di Mecenate,
committente e consigliere di poeti che raccolse attorno ad Augusto i maggiori autori dell’epoca,
anche se il circolo creò una sorta di egemonia sulle produzioni gestendole, vagliandole e censurandole.
-Il mito di Augusto come pacificatore e l’ammirazione nei suoi confronti
portarono alla rielaborazione del mito delle origini di Roma,
al voler dare a Roma una letteratura nazionale capace di gareggiare con quella dei greci
e a prefigurare una nuova età dell'oro.
LEZIONE 65
Cosa sono e di cosa trattano le Bucoliche?
Le Bucoliche sono 10 canti pastorali in esametri, noti anche come Egloghe,
il cui modello è il siracusano Teocrito e infatti il poeta invoca le muse siciliane,
rivendicando così il merito di aver trattato per primo un genere che la lett. latina non aveva mai trattato.
Egli si rende conto però che è un genere minore,
infatti la musa è Talia, musa della commedia, cioè della forma più bassa di poesia,
e usando anche il verbo ludere che indica un comporre per divertimento-
Il tema fondamentale è la sensibilità di Virgilio per la natura
e il rimpianto di qualcosa di perduto, che oppone un passato felice a un presente infelice.
L’ambiente è quello pastorale ma appare molto costruito,
infatti nonostante vi siano riferimenti a ricordi d’infanzia dell’autore esso manca di realismo.
I protagonisti sono pastori, mandriani, buteri,
e tutti sono avversi alla violenza e amano la vita tranquilla,
cosa significativa per chi aveva vissuto l’esperienza delle guerre civili:
Virgilio infatti non parla delle loro fatiche ma del loro otium e dei loro amori,
dunque si sente quasi vicino a un’atarassia epicurea.
I modelli di Virgilio.
In tutte le opere Virgilio fa riferimento a un modello greco
(Teocrito per le Bucoliche, Arato per le Georgiche, Omero per l’Eneide)
ma il suo rapporto con la tradizione greca è molto creativa:
a volte riprende un tema ma lo sviluppa in modo diverso;
a volte intreccia spunti e motivi di origine diversa;
a volte riassume; altre traduce direttamente dal greco.
In particolare nelle Bucoliche Virgilio si distacca dal realismo e dall’ironia di Teocrito;
nelle Georgiche il poeta si concentra soprattutto sul rapporto uomo-natura;
nell’Eneide trasforma le forme narrative del genere epico
passando da una narrazione oggettiva a soggettiva,
approfondendo la psicologia dei personaggi anche con i “commenti” dell’autore,
inserendo una pluralità di punti di vista.
Scaricato da Marianna Tallarico (mariaanna.tallarico@hotmail.it)
lOMoARcPSD|5715493
LEZIONE 66
Exegi monumentum aere perennius: commenta e illustra il carme e la poetica di Orazio
Quest’ode chiude il terzo libro dei Carmina di Orazio in cui egli si autocelebra
“Ho innalzato un monumento più duraturo”…
del bronzo e delle piramidi e che non potrà corrodere né la pioggia né il vento, né il tempo.
Lo scopo è quello di parlare della capacità della poesia di dare immortalità poiché essa resiste al tempo
e dunque il poeta continuerà a vivere nei suoi scritti e in coloro che leggeranno i suoi versi:
questo era importante perché l’epicureismo di Orazio lo portava a credere che tutto morisse, anche l’anima,
dunque l’unica possibilità di sopravvivenza stava nella gloria e della fama.
Un aspetto importante della sua opera è la soggettività in cui trovano spazio le sua paure esistenziali
che si possono notare nella poetica dell’angulus, piccolo spazio in cui rifugiarsi dai tormenti del mondo,
e nella poetica del modus, ovvero della misura e del limite, che porta alla vera sapienza;
anche se egli sa anche essere un poeta sociale che critica i costumi, esorta alla morale,
ma anche celebratore del potere garante della sicurezza e della tranquillità.
Lo stile varia a seconda del tipo di opere anche se vi è sempre un labor limae,
dunque tutte le opere sono il risultato di un attento lavoro formale:
-Le Odi hanno uno stile asciutto, rigoroso, pochi neologismi grecismi e arcaismi.
Esse sono caratterizzate dalla sapienza tecnica che si esprime nella callida iunctura,
cioè nell’accorta disposizione delle parole e articolazione del periodo,
e da un controllo di impresisoni e sentimenti
-Le Satire hanno una lingua semplice e misurata secondo i principi della medietas e brevitas,
le espressioni sono brevi ma incisive e colme di significato.
E’ un esempio di sermo cotidianus.
Il tema anche se leggero è sempre dettato da uno stile attento e formale.
-Negli Epodi vi sono volgarismi e espressioni del parlato.
Come abbiamo visto, lo stile è diverso, anche se rimane una costante:
massima economia e massima espressività.
Concezione della vita, della morte e dell'amore in Catullo e in Orazio.
Catullo
Amore
Catullo è l’autore del primo romanzo d’amore della letteratura latina
e il primo romanzo che parlasse di persone reali, ovvero sé stesso e l’amata Lesbia.
La storia è descritta con termini fisici e realistici:
è un amore nato da adulterio e un amore libero e basato sull’eros,
quindi vi sono delle riminescenze greche e anche un linguaggio erotico,
ma per Catullo esso è così importante da divenire anche un impegno morale e un vincolo.
Egli viene però tradito e si produce così in lui una dissociazione tra la componente sessuale ancora viva
e la componente affettiva che via via perde d’intensità.
Troviamo così i sentimenti contrapposti dell’amore: amore e odio, illusione e disillusione.
Vita e morte
All’inizio della relazione tra Catullo e Lesbia egli invita l’amato a vivere: “Viviamo Lesbia e amiamo”,
dunque c’è un invito a godere degli attimi e dei doni che la vita ha offerto
poiché essi non dureranno per sempre e sono dunque ancora più preziosi:
è un invito al carpe diem, a baciarlo, a non pensare a ciò che dice la gente.
Il tema della morte è affrontato in vece nella perdita del fratello,
visibile in particolare nel Carme 101, in cui narra del viaggio in Bitinia per dare l’estremo saluto al fratello,
come voluto dagli usi tradizionali, anche se egli sa che questo rito è inutile:
esso non riporterà in vita il fratello e non placherà il suo dolore.
Il componimento infatti si basa su questa opposizione tra le formalità del rito funebre tradizionale
e la necessità di avere un ultimo e impossibile contatto con il fratello.
Egli utilizza un’ipallage nel parlare delle “tristi offerte”: in realtà non solo le offerte ad esserlo ma il poeta.
Scaricato da Marianna Tallarico (mariaanna.tallarico@hotmail.it)
lOMoARcPSD|5715493
Orazio:
Vita e morte in Orazio possono riassumersi con il termine Carpe diem, riscontrabili nelle sue Odi,
in cui parla del tempo che scorre e della necessità di “afferrare l’oggi”
e “credere al domani il meno possibile”.
Valore fondante dell’epicureismo infatti era proprio quello di cogliere ogni istante
e Orazio fa proprio questo concetto mostrando la morte non come qualcosa di amaro, anzi,
la coscienza della morte, che per gli epicurei significa anche morte dell’anima,
fornisce all’uomo un nuovo modo per vivere cogliendo al meglio ogni istante.
Orazio parla della morte anche nei Carmina:
una parte di sé eviterà la morte grazie al fatto che egli è un poeta.
Nella dottrina epicurea tutto muore, anche l’anima,
e l’unico modo per sopravvivere al tempo è dunque essere ricordato per la propria scrittura.
Amore:
La dottrina epicurea porta a godere, finchè si è giovani, dell’amore,
infatti esso è un tema nella poesia di Orazio,
anche se esso, sempre secondo i dettami epicurei,non doveva degenerare in eccessi e turbamento passionale.
Orazio vede la donna come oggetto di desiderio:
di essa loda la bellezza e le doti fisiche, senza pensare all’identità, alla provenienza e alla condizione sociale,
ma l’idea che amore che trasmette non è passionale il che denota un controllo dei sentimenti.
Questo modo di vedere si ricollega da una parte all’amore libertino di Catullo,
ma risente anche dell’equilibrio di Orazio, fautore della mediocritas,
che escludeva la passionalità di Catullo e che gli impediva di vivere e rovinarsi per una donna.
Quali sono i temi trattati da Orazio nelle satire e nelle Epistolae?
Satire, tematiche:
-ricerca di una morale personale (una morale di autosufficienza e libertà interiore)
-l’analisi dei vizi umani
Essi sono proposti da Orazio come conversazioni tra amici appartenenti al raffinato circolo di Mecenate,
dunque l’ambientazione è quella cittadina.
Il tono si mantiene sul piano psicologico-umano e la polemica non è contro i vizi in sé ma contro l’eccesso.
Epistolae, tematiche:
- dolcezza della vita di campagna
-riflessione sul senso dell’esistenza
-ammonimento a conseguire la saggezza, unico rimedio ai mali dell’uomo
Essi sono proposti sotto forma di epistole in prosa e il paesaggio è la periferia agreste
anche se sono dirette a un pubblico ampio: umili e potenti, giovani e adulti.
Differenza tra Odi ed Epodi nella produzione di Orazio.
Epodi.
I termine epodo indica il verso più corto che segue a un verso più lungo, formando con esso un distico.
Alla composizione degli Epodi il poeta è spinto dalla povertà
e il suo scopo è impressionare e affermarsi, nonostante al tempo sconosciuto e di umili origini.
In essi domina la passionalità, il furore giovanile, il gusto per l'invettiva (volgarismi e espressioni del parlato)
che però solo talvolta sono espressione di sdegno e di rancore,
mentre più spesso è un raffinato gioco puramente letterario.
Egli si inveisce contro la vanità dei nuovi ricchi o dei cattivi poeti,
contro le oscenità di qualche vecchia lussuriosa,
e anche contro l'offerta inopportuna, fattagli da Mecenate, di una pietanza condita con troppo aglio.
Odi
Le odi sono componimenti della maturità, solo oltre 100 Odi (Carmina), distribuite in 4 libri.
I temi, i metri, il contenuto sono vari: si alternano temi politici e temi privati, di stile alto e stile leggero.
I modelli sono quelli dei poeti classici greci.
I temi principali sono la fugacità, la malinconia, l’amicizia, il gusto della compagnia, il controllo delle passioni,
ma anche l’adesione sincera alla politica augustea (odi romane).
Lo stile è freddo e asciutto, pochi neologismi grecismi e arcaismi,
e vi è un accorta disposizione delle parole e articolazione del periodo (callida iunctura ->definizione Orazio)
Scaricato da Marianna Tallarico (mariaanna.tallarico@hotmail.it)
lOMoARcPSD|5715493
LEZIONE 67
In che cosa il poeta elegiaco si avvicina e in che cosa si differenzia dal poeta neoterico?
L’elegia latina nasce sulla scia della tradizione greca ma:
-il tratto fondante il soggettivismo diventa artefatto e privo di sincerità.
-la poesia diventa più introspettiva e autobiografica
-si riprendono modelli, metri, tecniche, temi ma si cerca di trasporre in essi la propria esperienza di vita
-amore è il centro dell’esistenza nella vita dei poeti e la donna è in primo piano nel rapporto amoroso
-tema della campagna
Dal punto di vista formale la poesia elegiaca è composta da distici elegiaci,
metro nato dall’unione di esametro e pentametro.
I poeti neoteroi possono considerarsi i precursori dell’elegia latina:
essi rompevano con la morale tradizionale e mostravano disinteresse per l’impegno civile
e pertanto furono chiamati con disprezzo da Cicerone neoteroi o poeti novi.
Essi prediligevano una poesia breve e raffinata.
I generi sono l’epigramma, l’elegia e l’epillo.
Entrambe le forme sono comunque legate a una ripresa della cultura ellenistica
che assume però a Roma tratti peculiari e caratteristici, creativi e autonomi.
Entrambi utilizzano il genere dell’elegia,
ovvero la narrazione di vicende mitologiche a carattere amoroso e passionale.
Entrambi utilizzavano versi concisi.
Quello che cambia è che i poeti neoteroi propongono una poesia più leggera e con componimenti brevi
poiché solo opere le opere potevano essere preziose e raffinale,
al contrario l’elegia aveva un tono soggettivo e raccontava fantasie, passioni e sentimenti.
Illustra l'ideale di vita di Tibullo.
L’ideale di vita di Tibullo è legato al mondo agreste e alla vita domestica
e anche l’ideale del sentimento amoroso e della donna vi è legato.
Tipico dell’elegia solitamente è quello di costruirsi un mondo ideale e di evasione nel mondo del mito,
mentre per Tibullo il mondo del mito è assente ed è sostituito dal mondo agreste,
luogo dove si manifesta questo bisogno di rifugio, spazio intimo e tranquillo,
in cui coltivare gli affetti lontano dalle insidie della vita.
Nonostante questo dietro il mondo della campagna si rivela il suo carattere italico
con il suo patrimonio di antichi valori agresti
e anche la vita cittadina che è teatro di amori e intrighi, incontri furtivi e tradimenti.
Il mito dell'età dell'oro in Tibullo.
Il poeta Tibullo nella terza elegìa del primo libro
narra di aver lasciato Roma a malincuore per andare in Oriente.
Gravemente ammalatosi, il senso della solitudine e della lontananza
fa scattare l'appassionata rievocazione del tempo di Saturno, divinità romana dell’agricoltura,
che egli descrive come un’età dell’oro:
le navi e i marinai non si erano ancora messi in viaggio alla ricerca di guadagni,
le case non avevano porte, i campi non avevano confini, la terra dava buoni frutti perché era fertile,
non c’erano eserciti, odio e guerre e il fabbro non aveva ancora forgiato le armi.
Scaricato da Marianna Tallarico (mariaanna.tallarico@hotmail.it)
lOMoARcPSD|5715493
LEZIONE 68
Cosa significa poesia etiologica in riferimento alle metamorfosi di Ovidio?
La natura nelle Metamorfosi è animata, fatta di miti divenuti materia vivente,
partecipe in tutto, che si trasforma, che è archivio di storie,
in cui è possibile vedere la presenza di una creatura mitica in un albero, una fonte, un sacco.
In questo senso le Metamorfosi sono una poesia etiologica:
Nel senso che offre l’aition, la causa della natura.
Utilizzo del mito in Ovidio.
Tema dominante in Ovidio è il mito, spesso collegato ad una figura femminile,
anche se non vi è l'idealizzazione mitica della figura femminile (Heroides)
al contrario Ovidio umanizza le antiche eroine:
la donna del mito, resa umana, è trasformata in un insieme di impulsi e di sensazioni,
e grazie a questo Ovidio riesce anche a trattare di passioni scabrose e segreti inconfessabili.
Il mito non ha per Ovidio dunque la valenza religiosa:
Ovidio fa del mito un ornamento della vita quotidiana, il mondo per eccellenza delle finzioni poetiche.
Quale ritratto della società romana emerge dalla poesia di Ovidio?
Nelle opere di carattere erotico Ovidio è portavoce di una società galante, raffinata e spregiudicata
in cui emergono scene di vita, situazioni di incontro con una donna ma anche precetti d’amore.
Egli cerca di riconciliare la poesia elegiaca con la società:
la poesia elegiaca infatti si era contrapposta al sistema tradizionale dei valori sociali e culturali
ma secondo lui non era stato in grado di proporre modelli etici alternativi.
Nelle opere successive al suo abbandono di Roma egli invece è ormai lontano dalla società.
La poesia di Ovidio subisce un brusco cambiamento di toni,
condizionato dalle vicende biografiche dell'autore: spiega e illustra.
Prima dell’allontanamento da Roma Ovidio era famoso ed amato a Roma,
ma nell’8 d.C. è oggetto di un provvedimento punitivo di Augusto che relega il poeta nel mar Nero.
Esso è un esilio (che prevedeva la perdita dei diritti e la confisca dei beni), ma una relegatio,
che tuttavia costrinse il poeta a trascorrere il resto della sua vita in una terra selvaggia e inospitale.
Ovidio parla di due colpe che l'avrebbero perduto: carmen et error:
il carmen deve alludere all’Ars amatoria,
opera che dava consigli a uomini e donne sulla conquista e rivelava i segreti della seduzione,
che proprio in quell’anno venne ritirato dalle biblioteche pubbliche,
poiché esso era in contrasto con il programma augusteo di restaurazione morale dei costumi,
l’error era il suo coinvolgimento nello scandalo dell’adulterio di Giulia Minore, la nipote di Augusto,
infatti nello stesso anno pure Giulia minore fu relegata nelle isole Tremiti, accusata di adulterio.
Nella lontananza da Roma, separato ormai dalla società e dal pubblico
Ovidio scopre il dolore, la solitudine e la nostralgia.
Scaricato da Marianna Tallarico (mariaanna.tallarico@hotmail.it)
lOMoARcPSD|5715493
LEZIONE 69
Perché Livio intitola la sua opera Annales? In cosa è storico e in cosa annalista?
La sua opera storiografica Ab urbe condita tratta della storia di Roma dalla sua fondazione all’età di Livio.
Il titolo è tratto dai codici e dalle testimonianze antiche ma Livio talvolta la chiama Annales
poiché il metodo che segue è quello annalistico, anche se successivamente l’opera verrà divisa in decadi.
Del modello annalista ne rimane la forma, ovvero lo schema di spezzare la narrazione in anni,
ma la visione più ampia è quello di uno storico che mostra la parabola della civiltà romana
che ha il suo massimo punto nella vittoria su Cartagine e che trae qui il germe della futura decadenza.
Inoltre la prospettiva con cui riassume la storia di Roma è nuova:
egli vive nell’epoca di Augusto e quindi può vedere la storia da una prospettiva “pacificata”.
Dopo di lui nessun altro si rifarà alle origini, nessuno oserà misurarsi con la sua fama
e la storia diventerà piuttosto biografia dei singoli imperatori.
Quali sono le caratteristiche principali dell'opera di Livio e come intende Livio la storia?
Livio vede nella Storia di Roma un progressivo decadimento a partire da un passato perfetto
e per questo egli inizialmente non parteciperà entusiasticamente al regno di Augusto
tanto che verrà da lui accusato per questa simpatia per gli ideali repubblicani.
Solo in un secondo momento aderì al suo programma basato sulla restaurazione degli antichi valori:
si accorse che l’impero era una necessità e che il principe cercava di moderare il suo principato
con alcune concessioni basate su principi repubblicani.
La sua opera è animata da un amore profondo per Roma più che da una fede politica.
Dal punto di vista stilistico egli piega il suo stile alle esigenze del racconto:
nella prima deca è arcaizzante, nelle successive è più vicino al classicismo.
Egli sa usare tutte le risorse della poesia e dell’eloquenza senza mai cadere nella declamazione.
Tono solenne invece nel proemio in cui si presenta l’eroe protagonista: il popolo romano.
Perché l'opera di Livio è stata definita un epos in prosa?
L’opera di Livio può essere definita tale poiché è un poema epico a sfondo morale in prosa
in cui ampio spazio hanno gli elementi epici (eroismo, volontà degli dei, missione di Roma)
a scapito - spesso - dell’esame puntuale dei fatti.
La storia infatti nelle mani di Livio si trasforma in una narrazione drammatica e vivace,
ricca di particolari e suspance, rivelando spesso la psicologia dei personaggi:
egli fa parlare e agire i personaggi in modo che le loro azioni rivelino la loro psicologia
e dunque lascia ai lettori il giudizio sui protagonisti.
Scaricato da Marianna Tallarico (mariaanna.tallarico@hotmail.it)
lOMoARcPSD|5715493
LEZIONE 70
Significato di amore e poesia in Properzio.
Il primo libro della raccolta di Elegie di Properzio è dominato dal tema dell’amore per Cinzia,
motivo che ritorna anche nel secondo e nel terzo libro, ma in modo meno uniforme,
perché intrecciato dal progressivo deteriorarsi del rapporto fino al distacco alla fine del III libro.
Egli si dimostra fin da subito prigioniero della passione di questa donna,
una cortigiana ricca di cultura letteraria e musicale
che vive negli ambienti mondani frequentati da politici e letterati.
Ovviamente legarsi a una donna simile significa per Properzio compromettere la sua rispettabilità
ma egli cede ed è condannato a una vita dissipata e dedita all’otium per quasi 5 anni.
La donna poi morì ma il desiderio di lei si fecero ancora più acuti nella mente del poeta
quindi non ci fu mai una definitiva rottura nonostante il disdicium nel III libro e la sua morte.
Properzio rifiuta dunque il mos maiorum per un’esistenza totalmente dedita all’amore:
il suo legame con Cinzia per lui è un patto garantito dagli dei
e basato sui capisaldi dell’amore matrimoniale: castitas, pudor e fides.
La realtà però è diversa poiché il poeta elegiaco è lacerato
poiché sedotto dal fascino e dall’eleganza mondana della donna amata,
in cui al tempo stesso cerca semplicità, fedeltà, dedizione.
L’esistenza di Properzio dunque, amante e poeta, diventa un tutt’uno:
egli fa della sua vita e del suo amore materia della sua poesia.
La poesia elegiaca e i suoi rappresentanti nel panorama della letteratura latina.
A Roma l’elegia viene anticipata dal poeti novi che ne sono i precursori,
e viene poi portata ai suoi massimi con Cornelio Gallo, Tibullo, Ovidio, Properzio.
Essa si distingue per ispirarsi alla tradizione greca anche se poi i latini la modificarono fortemente
dandogli tratti autonomi e creativi.
I poeti della poesia elegiaca cantavano i propri sentimenti
dissociandosi, in parte, dalla vira politica di Roma.
Gallo ne è considerato l’iniziatore.
Tibullo è legato soprattutto al mondo agreste e della vita domestica
e anche la donna è vista all’interno di questo panorama.
Prevale la visione del luogo agreste come spazio intimo e tranquillo dove coltivare i propri affetti.
Ovidio cercò invece di conciliare la poesia elegiaca con la società:
l’ambiente non è più la campagna ma la città e la società galante e raffinata.
Properzio passò dall’elegia d’amore dedicata alla donna amata, Cinzia,
all’elogio degli ideali augustei e di Mecenate, passaggio visibile dal libro III:
la sua poesia diventa più impegnata e celebra la romanitas secondo il volere di Augusto.
In che termini e con quali esiti Properzio aderisce alla politica augustea in ambito culturale?
Properzio nelle Elegie parla dell’amore a Cinzia ma non solo:
dal III libro, che si concluderà con l’addio a Cinzia,
compaiono anche motivi legati alle fortune e all’ideologia augustea,
con un’attenzione nuova per la moralità antica
e una maggiore disponibilità verso i temi graditi agli ambienti ufficiali,
il che è un chiaro indizio del percorso che Properzio stava compiendo
verso la sua difficile integrazio e nel regime.
Scaricato da Marianna Tallarico (mariaanna.tallarico@hotmail.it)
lOMoARcPSD|5715493
Da questo momento Properzio svingola l’elegia dall’eros e ne fa un genere autonomo:
studierà e canterà le origini dei nomi, dei miti, dei culti di Roma.
Illustra il topos della recusatio e accenna ad alcuni autori latini che ne furono coinvolti.
I poeti di questo periodo, amanti dell’elegia,
rifiutano la poesia alta attraverso la cosiddetta Recusatio,
un rifiuto che parte da una loro confessione di inferiorità:
essi compongono poesie d’amore in quanto si dichiarano incapaci di comporne altre di diverso tipo.
Probabilmente adottarono tale espediente per evitare la censura, trovandosi in epoca Augustea.
Oltre a Properzio altri poeti che la praticarono furono Lucilioe Orazio.
Nel caso di Properzio, egli venne notato da Mecenate che tentò di trascinarlo nella cerchia augustea,
ma Properzio appunto inizialmente rispose con una recusatio,
ancora legato alla poesia elegiaca e amorosa.
Questo rifiuto in realtà non era così convinto poiché nella recusatio
dice che se dovesse cantare le gesta di qualcuno sarebbero quelle di Augusto e poi di Mecenate.
Già dal III libro, infatti, che termina con l’addio a Cinzia,
l’autore inizia a interessarsi a tematiche tipiche della moralità antica
e nel VI libro approda alla poesia impegnata che diventa un compromesso:
continua a praticare il genere dell’elegia ma solo come metro, mentre i contenuti sono più impegnati,
celebrando la romanitas e le sua radici secondo il valore di Augusto,
pur non dimenticando del tutto l’amore e infatti spesso racconta miti romani ma d’amore,
anche perché intende anche celebrare l’amore coniugale imposto da Augusto con le sue leggi.
Scaricato da Marianna Tallarico (mariaanna.tallarico@hotmail.it)
lOMoARcPSD|5715493
Esame 13 Settembre 2019, domande+risposte
Lingua e letteratura latina (Università degli Studi di Bergamo)
StuDocu non è sponsorizzato o supportato da nessuna università o ateneo.
Scaricato da Marianna Tallarico (mariaanna.tallarico@hotmail.it)
lOMoARcPSD|5715493
LEZIONE 71
Quali posizioni dal punto di vista della lingua assunsero i letterati dell'età imperiale?
La letteratura in età imperiale, sotto l’influsso delle scuole di retorica, fu anticlassica e anticiceroniana:
arte tormentata, con tinte cupe e violente, incline al pathos, esuberanza espressiva.
Gli autori di questo periodo (Seneca, Lucano, Persio, Petronio)
provengono da luoghi diversi e hanno gusti diversi, il che ha ricadute anche sul piano linguistico:
da un lato la lingua si arricchisce,
dall’altro perde la sua dimensione italica e il senso di misura tipico della classicità
acquisendo una dimensione sovranazionale e universale.
Fedro è un’eccezione: nelle sue favole egli usa una lingua semplice, precisa, caratteruzzata dalla brevitas,
anche se quest’ultima rende l’atmosfera fredda e manca l’approfondimento psicologico.
Inoltre usa sostantivi astratti per nominare gli animali (avidità per volpe) oppure il concreto per l’astratto.
Come muta il rapporto tra intellettuali e potere in età imperiale rispetto all’età di Augusto?
In età giulio-claudia con Tiberio e Claudio
l’assolutismo del principe si traduce in una letteratura conformistica o neutra
(erudizione, opere grammaticale), ad eccezione di Fedro che offre una voce originale:
nelle sue Favole egli riflette il punto di vista delle classi subalterne della società
dando voce al mondo degli schiavi e degli emarginati promuovendoli a oggetto letterario
e critica violentemente alcuni uomini e regole della società
allo scopo non solo di divertire ma anche di istruire.
Con Nerone si assiste a un rinnovamento nelle lettere
soprattutto negli anni in cui Seneca al potere assicurò una certa libertà intellettuale agli artisti.
Nell’età dei Flavi il potere assoluto assume forme sempre più dispotiche
e lo stesso vale per l’attività letteraria che diventa sempre più conformistica e accademica.
Nell’età degli Antonini vi è un dispotismo illuminato che porta a una rinascita letteraria
anche se vi è una generale crisi di ideali.
LEZIONE 72
Caratteri della storiografia in età imperiale.
In età imperiale vari autori si occuparono di storiografia
-Seneca il Vecchio (padre di Seneca) scrisse un’opera storica
che andava dall’inizio delle guerre civili alla sua morte.
-Pompeo Trogo scrisse Historiae Philippicae, la prima storia universale in lingua latina,
che parlava delle vicende dei singoli popoli e dei loro domini in età molto remote,
e che prestava attenzione al momento in cui dalle rovine dell’impero di Alessandro nacque Roma,
in perenne lotta con i Parti a cui Roma era destinata a soccombere.
Non c’è universalismo, la posizione rimane secondaria e marginale.
-Velleio Patercolo nelle sue Historie narra la storia dalla guerra di Troia fino al 30dC,
ma l’opera ha un andamento ineguale:
egli passa in modo rapido dai tempi più remoti a quelli più vicini
e si sofferma sui tempi di Tiberio fino a farne un vero e proprio panigirico, di cui ne vanta le lodi militari.
Più che di un’esposizione dei fatti sembrano susseguirsi ritratti di personaggi con vizi e virtù
con interventi diretti dell’autore e considerazioni proprie.
-Valerio Massimo scrive una raccolta di aneddoti tratti da fonti storiche grece e romane
relativi a religione, istituzioni politiche, vita morale, vita culturale.
E’ una raccolta di exempla.
-Curzio Rufo scrive una storia romanzata in cui emerge una figura di Alessandro Magno contraddittoria
fatta di generosità e crudeltà.
Da Patercolo in poi, dunque, la storia si riduce a una successione di ritratti.
Scaricato da Marianna Tallarico (mariaanna.tallarico@hotmail.it)
lOMoARcPSD|5715493
Come evolve l’atteggiamento nei confronti della storia in età imperiale?
Vedi sopra
Opere scientifiche in età imperiale: esempi, caratteri e funzioni.
-Marco Manilio scrive Astronomica,
un poema didascalico in esametri in cui parla delle costellazioni
e dell’influsso degli astri sul destino degli uomini, posizione che si rifà a credenze orientali.
Il suo scopo è rendere i concetti dell’astrologia in chiave poetica per avvicinare la scienza agli uomini
con versi raffinati, tendenza alla brevitas e qualche costrutto del parlato.
-Cornelio Celso scrisse l’opera enciclopedica Artes che tratta di vari argomenti tar cui la Medicina
che è una preziosa testimonianza linguistica perché documenta il linguaggio tecnico medico
che mirava ad esattezza e comprensibilità.
-Lucio Giunio Colmella ha scritto un trattato di agricoltura, De rustica,
che parla di agricoltura, allevamento e della decadenza dell’agricoltura in Italia
dovuto al disinteresse dei proprietari, sfruttamento inadeguato dei latifondi
e alla mancanza di preparazione scientifica in materia.
-Pomponio fu il primo geografo con la su Chorograohia in cui descrive la terra
ed è la più antica opera geografica in latino giunta sino a noi,
in cui descrive le regioni del mondo basandosi su fonti greche.
Essa offre un repertorio di notizie etnografiche e geoclimatiche interessanti soprattutto di regioni lontane.
-Marco Apicio fu autore di un trattato gastronomico.
LEZIONE 73
Che rapporto ha Persio con i suoi modelli Orazio e Lucrezio.
Il primo modello di Persio è Orazio:
come lui crede in una poesia più umile e più aderente alla realtà, la poesia del genere satirico.
La satira di Orazio però risulta diversa, più bonaria e ironica,
anche se Persio ne muta immagini ed espressioni
come ad esempio il tema dell’angulus, il luogo lontano in cui ritirarsi per sfuggire alla ricchezza.
Orazio aveva però raccomandato la callida iunctura,
al contrario Persio ricorre alla iunctura acris, ovvero asprezza nel suono e nella semantica:
la lingua dunque è quella della quotidianità ma lo stile è difficile
e questo perché vuole che i lettori meditino sul suo messaggio.
Ovviamente però il destinatario a questo punto non può essere l’uomo comune ma un pubblico colto.
Sempre Orazio inoltre aveva proposto una satira come modo di insegnare
con un rapporto paritetico tra poeta (maestro) e alunno (lettore):
al contrario Persio non mette in parità chi ascolta
ma diventa un predicatore arrabbiato e volgare che inveisce e depreca il vizio,
il che no gli concede una risposta positiva nell’ascoltatore.
Altro riferimento, anche se estraneo all’ambito saritico, è Lucrezio.
Grazie a Lucrezio infatti erano stati importati nella letteratura delle ambizioni educative
dunque il poeta entrava in contatto con il destinatario, lo provocava e lo coinvolgeva.
Persio fa lo stesso ma con atteggiamento aspro e aggressivo
al fine di superare l’indifferenza degli ascoltatori.
In che senso si afferma che Persio è il poeta dell'interiorità?
Dato il tono aggressivo, in Persio si indebolisce il rapporto con il destinatario tipico di Orazio,
e così sviluppa un “linguaggio dell’interiorità”, un monologo confessionale, un esame di coscienza.
A questo punto l’intenzione di insegnare non è più proiettata sugli altri ma su di sé:
la filosofia stoica a cui aderiva, del resto, insisteva sul raccoglimento interiore
e sull’essere impassibile a passioni e vizi.
Scaricato da Marianna Tallarico (mariaanna.tallarico@hotmail.it)
lOMoARcPSD|5715493
LEZIONE 74
Delinea i rapporti tra Seneca e gli imperatori sotto i quali visse: Caligola, Claudio e Nerone,
facendo riferimento alle opere in cui si rispecchiano direttamente le vicende della dinastia Giulio-claudia.
Seneca oltre ad essere poeta ed oratore
fu anche uomo politico nel periodo in cui al potere vi furono Caligola, Claudio e Nerone,
esercitando la funzione di questore, senatore e console.
-Il suo successo gli procurerà l’ostilità di Caligola, che lo condannerà a morte, anche se poi venne graziato.
-Claudio lo esilierà per intrighi di palazzo
ed egli sarà richiamato a Roma solo dalla nuova moglie di Claudio, Agrippina,
che lo vorrà come precettore del figlio Nerone.
Sotto il regno di Claudio scrive Apocolocyntosis,
componimento che narra della morte di Claudio e dell’ascesa all’Olimpo
e della sua vana pretesa di essere accolto tra gli dei,
i quali condannano invece a scendere negli inferi come tutti gli altri mortali,
dove finisce schiavo del nipote Caligola e in mano al suo liberto
come condanna di contrappasso perché aveva fama di aver vissuto in mano ai suoi potenti liberti.
Claudio è dunque tratteggiato con accanimento.
Il titolo opera il cui riferimento alla “zucca”, emblema della stupidità,
sarebbe una parodia della divinizzazione di Claudio decretata dal Senato dopo la sua morte,
oppure da intendersi come “deificazione di una zuccone”.
-A Nerone, di cui era precettore, è invece dedicato il trattato De Clementia,
poiché Seneca voleva plasmare il giovane principe sul modello del sovrano illuminato:
egli non metteva in discussione la legittimità del principato
ma era importante la formazione del sovrano assoluto e la loro educazione
poiché la filosofia era garante e ispiratrice della direzione politica dello stato.
Dopo l’uccisione di Agrippina però Seneca perderà l’influsso su Nerone,
e quando sarà sospettato di complicità nella congiura contro Nerone verrà costretto al suicidio.
Caratteri delle tragedie di Seneca.
Le 9 tragedie sono tutte di soggetto mitologico greco.
Esse sono importanti sia perché sono le uniche tragedie latine ad esserci giunte in forma non frammentaria
sia perché testimoniano la ripresa del teatro latino-greco:
nell’età giulio-claudia, infatti, le élite si rivolgevano al teatro tragico
come alla forma letteraria più idonea ad esprimere la propria opposizione al regime.
Seneca nelle sue tragedie si ispira a tre grandi tragici greci (Eschilo, Sofocle e Euripide)
ma anche ad Ovidio e ad altri autori latini,
anche se vi è un’operazione di contaminazione e ristrutturazione dei modelli in base al gusto latino.
Esse hanno uno stile basato su sfoggio di erudizione e enfasi retorica
ma sono dominate da toni cupi e atroci, con forze maligne, gusto dell’orrido e del macabro.
I temi sono la lotta tra bene e male che ha dimensione sia individuale ma anche universale
(es. la figura del tiranno in cui si annida il male e che è bramoso di potere)
e la lotta tra ragione e passione.
Le epistulae ad Lucilium di Seneca: caratteri, temi, importanza.
Le Epistole a Lucillo sono l’opera filosofica più impegnata di Seneca, scritte alla fine della sua vita,
in cui riassume la sua filosofia, saggezza, esperienza e dolore.
Il destinatario è un personaggio reale ma la forma epistolare è soprattutto in pretesto,
infatti molto si dibatte se l’epistolario sia reale o fittizio.
I modelli sono Platone e Epicuro.
Egli insiste sul fatto che lo scambio di lettere
permette di istituire un colloquio con l’amico, un’intimità quotidiana e di vita vissuta,
e dunque ben si presta alla pratica quotidiana della filosofia.
Le lettere si intendono infatti come uno strumento di crescita morale che,
fornendo un esempio di vita, sono più efficaci di un insegnamento dottrinale,
ma anche uno strumento esortativo, che vuole invitare al bene.
Scaricato da Marianna Tallarico (mariaanna.tallarico@hotmail.it)
lOMoARcPSD|5715493
Utque solet pariter totis se effondere signis / Corycii pressura croci, sic omnia membra / Emisere simul rutilum
pro sanguine virus. / Sanguis erant lacrimae; quaecumque foramina novit / Umor, ab his largus manat cruor.
Alla luce dell'espressionismo rappresentativo di Lucano, si contestualizzi il passo.
Il passo si riferisce al libro IX della Pharsalia.
Morto Pompeo, il comando delle truppe repubblicane viene assunto da Catone e Bruto,
mentre Catone sbarca in Africa, rende onore a Pompeo e si incontra con i famigliari di lui, e quindi si avventura in un
pericoloso viaggio attraverso la Libia in cui affronta tempeste di sabbia, rettili, fame, sete, deserto
e descrive il patimento dei suoi soldati.
Intanto a Cesare, giunto in Egitto, viene mostrato il capo di Pompeo,
e Lucano racconta le false lacrime e l’ipocrisia di Cesare che, secondo la descrizione del poeta,
prova invece una grande gioia per l’uccisone del suo antagonista.
Inizia la frase con un riferimento alle essenze profumate (come lo zafferano)
che spesso nel Circo venivano diffuse tramite un sistema di condotti messo all’interno delle statue.
Infatti dice che, come è solito cospargere sulle statue lo zafferano,
allo stesso modo da ogni parte del corpo usciva sangue, anche le lacrime erano sangue.
In questo passo è evidente il suo espressionismo e drammaticità
poiché volutamente descrive la situazione in modo macabro.
Lucano e Virgilio: perché Lucano è stato definito 'anti-virgilio'?
Si parla di «anti-Virgilio» perchè Lucano sembra proporre una confutazione del modello
mediante una sorta di ribaltamento delle sue affermazioni,
una ripresa in chiave polemica di espressioni e situazioni virgiliane.
C’è anche un tono di risentita indignatio nei confronti del modello:
è come se Virgilio, nell’Eneide, avesse perpetrato un inganno,
coprendo con un velo di mistificazioni la fine delle libertà romana
e la trasformazione dell’antica res publica in tirannide.
Lucano sembra prefiggersi il compito di smascherare l’inganno,
di scrivere un poema che non giustifichi il potere del principe ricorrendo ad antiche favole religiose,
ma mostri, invece, come il regime sia nata dalle ceneri della libera res publica.
Emerge inoltre un anti-mito di Roma: la sua decadenza e il suo tracollo
si oppongono al modello di Virgilio dell’ascesa della città da umili origini.
Vi sono sempre come nell’Eneide una serie di profezie
ma esse non si rivelano le future glorie di Roma ma la rovina.
Il personaggio che interpreta l’anti-Enea è invece Cesare:
Enea voleva far rivivere Troia a Roma, Cesare vuole il contrario, disfando ciò che ha fatto Enea.
Personaggi della Pharsalia: Pompeo, Cesare, Catone.
La Pharsalia tratta della guerra civile tra Cesare e Pompeo
condannando l’autorità imperiale e esaltando l’antica libertà repubblicana.
La realtà dei fatti viene dunque sacrificata a fini ideologici:
talvolta alcuni avvenimenti sono solo coloriti, alte volte inventati.
-Pompeo è un personaggio in declino, ormai vecchio dal punto di vista politico e militare.
Egli è una figura tragica ed è l’unica che nel piena subisce un’evoluzione psicologica:
alla perdita di autorevolezza in campo politico, infatti, si accompagna un ripiegamento nella sfera privata
andando in contro a una sorta di “purificazione”
capendo che la morte in onore di una giusta causa è l’unica via di riscatto morale.
E’ lui, lo sconfitto, e non Cesare, il vincitore, l’eroe del poema.
-Catone è il personaggio in cui si consuma la crisi dello stoicismo,
che garantiva la provvidenza divina nella storia:
di fronte alla malvagità del fato che cerca in ogni modo la distruzione di Roma
per Catone diviene impossibile l’adesione volontaria al destino che lo stoicismo pretendeva
e capisce dunque che il criterio della giustizia ormai va ricercato altrove, non più ne volere del cielo,
dunque ci impegna nella guerra civile con tutta la consapevolezza di andare incontro a una sconfitta
e di conseguenza anche di doversi dare la morte, unico modo per continuare ad affermare il diritto e la libertà.
La figura di Cesare è deformata rispetto alla realtà storica:
egli è descritto in una malefica grandezza che si scaglia contro Roma
e che porta i tratti tipici del tiranno come l’ira, il furore e l’impazienza.
Scaricato da Marianna Tallarico (mariaanna.tallarico@hotmail.it)
lOMoARcPSD|5715493
LEZIONE 76
Perché possiamo dire che il Satyricon si avvicina alla Satira menippea?
Il Satyticon pur essendo un romanzo per certi versi se ne distacca avvicinandosi ad altri generi
come quello della satira manippea che prevedeva grande libertà di temi e forme,
tradizione a cui si era richiamato anche Seneca nel suo Apokolokyntosis:
inserì nel testo in prosa brani poetici, citazioni di autori classici parodiate e distorte,
rielaborazioni di moduli poetici tradizionali,
il tutto con una raffinata tecnica compositiva.
Ci sono però delle differenze:
l’opera di Seneca era un libello di attacco personale contro Claudio,
in Petronio invece non si intravede un chiaro disegno polemico unificante.
Quale è la funzione delle fabulae nel Satyricon?
Petronio usò molto la letteratura novellistica caratterizzata da situazioni comiche, piccanti, amorali.
In particolare un genere importante fu quello della Fabula Milesia, importata dal greco,
i cui temi sono quasi “boccacceschi”, con uomini sciocchi e donne pronte a cedere,
il tutto narrato con un realismo vivo e lontano dal romanzo greco e con argomenti scabrosi e piccanti.
Nel Satyricon vi sono varie milesie che hanno lo scopo di reintrodurre nella cultura latina
un genere che era stato escluso in quanto scandaloso.
Eros e thanatos (amore e morte) in Petronio: illustra i concetti riferendoti a passi dell'opera.
Nella tradizione del romanzo greco l’amore è trattato con pudicizia, come una passione seria e esclusiva:
molta suspense della storia sta nei modi avventurosi con cui l’eroina serba fino in fondo la sua castità.
Nel romanzo di Petronio, invece, l’amore è visto in modo diverso:
amore etero o omosessuale, non c’è spazio per la castità, nessun personaggio è portatore di valori morali,
il sesso è trattato esplicitamente ed è visto come una continua fonte di situazioni comiche.
Un altro tema dominante, che permane nel sottofondo dell’intera opera, è invece quello della morte.
L’ossessionante ricorrere del tema della morte
va ricollegato alla volontà di affermazione e successo di Trimalcione e dei sui commensali:
Trimalchione, e con lui tutti gli altri liberti, si vantano infatti della avvenuta ascesa economico-sociale
e parlano con fierezza delle loro occupazioni,
sentono tutte le potenzialità di miglioramento offerte dalla condizione libertina,
ma riconoscono anche il ruolo determinante della Fortuna.
Il tema emerge bene dopo il naufragio dell’imbarcazione su cui viaggava Enclopio e i compagni che,
una volta giunti sulla spiaggia trovano il cadavere del comandante della nave:
qui vi è un momento di commozione e riflessione sulla caducità della vita,
espressa bene nella frase di Enclopio: “dappertutto ti minaccia un naufragio”.
LEZIONE 77
Scaricato da Marianna Tallarico (mariaanna.tallarico@hotmail.it)
lOMoARcPSD|5715493
Sum fateor, semperque fui, Callistrate, pauper: Marziale e la povertà.
“Sono povero, lo so, Callistato, e lo sono sempre stato”.
Con queste parole Marziale parla della povertà che obbliga il poeta a guardare alla sua condizione di cliente
come a una necessità imposta dalla situazione economica e sociale dei suoi tempi
facendo emergere la visione dell’intellettuale senza mezzi di sostentamento
e che deve dunque adulare il principe e conformarsi alla censura.
Egli infatti, per quanto persona onesta e di poche ambizioni
dovette rinunciare alla sua indipendenza e scendere fino all’adulazione dei potenti
anche se questo lo mette in disagio.
Alcuni temi infatti della sa poesia sono:
-i “miserabili” della società, ovvero potenti pieni di denaro a cui lui era costretto ad elemosinare
che vengono rappresentati con nomi di finzione
-malattia, vecchiaia, miseria.
Lasciva est nobis pagina, vita proba: questa filosofia di vita espressa da Marziale ha altri sostenitori
nella letteratura latina?
Con questo componimento di carattere Marziale si rivolge a Domiziano
illustando la propria opera e giustificando il carattere scherzoso dei suoi versi
parlando di una netta distinzione tra lo stile di vita e ciò che si scrive.
Inizia infatti così: “Se per caso ti capiteranno in mano i nostri librriccini”….
e poi spiega che le sue poesie Domiziano deve leggerle “a fronte distesa”, come quando si va a teatro,
e che il suo giudizio deve lasciar correre su alcuni scherzi che non fanno male a nessuno,
poiché se le sue poesie sono oscene, la sua vita è onesta.
Scaricato da Marianna Tallarico (mariaanna.tallarico@hotmail.it)
lOMoARcPSD|5715493
LEZIONE 78
La Tebaide e le Silvae di Stazio.
Tebaide
La Tebaide è un poema epico dedicato a Domiziano che parla della conquista della città di Tebe
e che ha come modello Virgilio e l’Eneide.
Egli utilizza il tema mitologico e non vi sono riferimenti diretti con l’attualità
dal momento che la poesia e la letteratura erano ormai lontane dall’impegno politico,
ma non mancano alcuni riferimenti:
una guerra civile vista come scontro tra tiranni uguali,
la degenerazione di una famiglia regnante in dispotismo fanatico,
il problema di vivere sotto i tiranni rispettando comunque una regola morale.
Le divinità sono svuotate o appiattite e lo stesso vale per le figure umane
che hanno poche sfumature psicologiche: ogni figura è vista da fuori.
Nonostante questo lo stile è dominato dal gusto dell’eccessivo e dell’orrido
con evocazione di morti, apparizione di mostri, azioni raccapriccianti, descrizioni di carneficine
il che rende molto distante Stazio dal suo modello Virgilio.
Silvae
Le Sylvae sono un poema lirico di carattere colto e ricco di riferimenti mitologici e eruditi.
Sono componimenti in esametri di diversa lunghezza ognuno preceduto da un’epistola dedicatoria in prosa.
Il tono è quello della tenera poesia sentimentale che aspira ad essere un buon ritratto della società imperiale
anche se vi è il sospetto dell’artificio:
al tempo vi erano gare di poesia con premi e pubbliche declamazioni
che servivano a mantenere un controllo sulla pubblica emotività
e che premiavano componimenti miranti alla restaurazione civile e morale
e l’esaltazione dei valori letterari e tradizionali.
Nonostante ciò il fulcro della loro ispirazione è la vita reale.
Imitatori di Virgilio in età imperiale: le Argonautiche e i Punica
Argonautiche
Valerio Flacco dedicò il suo poema epico Argonautiche a Vespasiano
esaltato poiché aveva aperto le rotte nautiche oceaniche alla flotta romana con la spedizione in Britannia.
L’evento è ripreso nel mito della spedizione di Giasone alla ricerca del vello d’oro sulla nave Argo.
Egli riprende il racconto già narrato da Apollonio Rodio ma la struttura è quella bipartita dell’Eneide:
alla narrazione del viaggio segue la guerra.
Egli dunque non riprende in toto il modello greco:ma vi sono sintesi, aggiunte,
modifiche nella psicologia dei personaggi e nel modo di concepire l’intervento divino.
Punica
Silio Italico scrive i Punica, poema epico sulla II guerra punica.
Le fonti utilizzate sono:
la terza deca di Tito Livio, a cui si rifà per la linea annalistica,
e Virgilio, che imita nella lingua, stile, immagini, apparato mitologico-divino,
anche se la sua imitazione si limita all’aspetto formale.
Ruolo fondamentale nel poema ha Giove:
egli vuole imporre ai romani una dura prova al fine di dimostrare il loro valore
e dimostrare di potere aspirare al dominio sugli altri popoli.
Scaricato da Marianna Tallarico (mariaanna.tallarico@hotmail.it)
lOMoARcPSD|5715493
LEZIONE 79
Visione dell’uomo e della natura in Plinio il Vecchio.
Plinio eredita dallo stoicismo la fede nelle risorse della natura e dell’uomo
e nelle sue possibilità di progresso civile.
La sua opera infatti, Naturalis Historiae, mira a fornire un’indagine su tutto ciò che esiste in natura
partendo dalla centralità dell’essere umano.
Nell’elogio della Terra presente della sua Naturalis Historiae
rappresenta un elogio della natura e dei suoi meriti straordinari.
La natura e la terra sono degli uomini, così come il cielo è della divinità,
e lei ci accoglie dal momento della nostra nascita, ci tiene con sé come una madre,
e nonostante la brevità dell’esistenza essa porta avanti il nostro ricordo.
Nell’elogio all’uomo, Plinio dice che la natura ha generato tutto per l’uomo,
ma in cambio l’uomo ha dovuto pagare un prezzo alto e crudele,
dunque si pone un interrogativo: è stata una buona madre o una crudele matrigna?
L’uomo infatti è l’unico essere vivente che deve procacciarsi qualcosa per ripararsi e vestirsi
poiché viene gettato nel mondo nudo al momento della nascita,
abbandonato sin dall’inizio al pianto e alle lacrime,
mentre la risata appare solo dal 40esimo giorno.
In quali circostanze morì Plinio il vecchio? Cosa sai dire dell'avvenimento?
Quale ne è la fonte principale?
Plinio il Giovane, nipote di Plinio il Vecchio,
descrisse la morte di suo zio in una lettera indirizzata allo storico latino Tacito, trent’anni dopo l’accaduto,
sperando che così la sua morte avesse fama immortale.
Qui egli narra dell’eruzione del Vesuvio del 79dC nella quale Plinio il Vecchio morì.
Plinio in quel momento comandava la flotta a Miseno e durante l’eruzione tutti scappavano
mentre lui si avvicinava sempre più alla nube per esaminarlo dal punto di vista scientifico.
Riceve inoltre una lettera con la quale lo si implorava di prestare aiuto dunque egli partì in nave.
Viene descritta la nave ormai sempre più carica di cenere e pietre nere bruciate dal fuoco
e la paura degli altri che vedevano lingue di fuoco
anche se lui li rassicurava dicendo che erano fuochi lasciati accesi dai contadini mentre scappavano.
Egli probabilmente morì soffocato sulla riva del mare
e quando riapparve il sole erano passati ormai tre giorni:
il suo cadavere era intatto e illeso, sembrava stesse dormendo e non che fosse morto.
Illustra i caratteri della Naturalis Historia di Plinio.
La Naturalis Historiae (Scienza naturale) è un’opera enciclopedica di grandi dimensioni
che si proponeva di rappresentare tutto quanto esistesse in natura ,
dunque una summa di tutto il sapere reperibile fino a quel momento da autori greci e latini.
Dopo un’introduzione con un’epistola dedicata al futuro imperatore Tito e una bibliografia
(grande novità questa nel mondo antico) inizia a trattare i vari argomenti libro per libro:
cosmologia e astronomia, geografia, antropologia, zoologia, botanica, medicina, metallurgia e mineralogia
+ un excursus sull’arte antica con attenzione a scultura, pittura e architettura.
Il suo intento è mettere ordine in una materia vasta e immensa attingendo a più di 500 autori:
la novità sta nel disegno però, e non nel contenuto.
Infatti il limite è che, come al resto della cultura latina,
gli manca la capacità di riconoscere ciò che è scientifico e ciò che non lo è,
non vengono vagliati scientificamente i dati desunti dall’esperienza,
rimangono delle credenze superstizione,
e tutto questo è visibile nella scelta dei modello: a volte veri scienziati, altre pseudo-scienziati.
Scaricato da Marianna Tallarico (mariaanna.tallarico@hotmail.it)
lOMoARcPSD|5715493
LEZIONE 80
Illustra lo stile di Quintiliano e i suoi modelli.
Il suo modello è Cicerone,che viene rivisto per cercare un’ideale compromesso tra asciuttezza e ampollosità,
anche se il suo stile non risulta ampio e simmetrico come quello di Cicerone
ma pare condizionato dalla prosa di Seneca,
presentandone tratti caratteristici per le scelte lessicali, per la collocazione dei termini e per la sintassi.
Egli ricorre spesso a similitudini e metafore tipici della poesia
poiché in quest’epoca postclassica i tratti di lingua e prosa si avvicinano.
Rapporto tra intellettuale e potere secondo Quintiliano.
Quintilliano si schiera fra quegli intellettuali che accettavano il principato come una necessità.
L’oratore per Quintilliano non pone certo in discussione il regime,
ma le doti morali che deve possedere sono utili, prima che al principe, alla società in generale.
Tuttavia l’ideale propugnato da Quintiliano di un oratore che sia ancora,
secondo l’antico modello catoniano, guida al senato e al popolo romano,
è un’illusione del tutto infondata, quasi una negazione fatta alla realtà storica dell’Impero.
Cosa rappresenta il ritorno al classicismo propugnato da Quintiliano?
L’ondata anticlassicista proposta da Seneca si esaurì con il programma della Dinastia Flavia,
imperniato sulla ricerca di un nuovo equilibrio che rivelava un’impostazione conservatrice:
politicamente vi è un riavvicinamento al Senato
e culturalmente un programma di ritorno agli antichi in cui si favorì il ritorno al classicismo.
Questo ritorno al classicismo trovò in Quintilliano uno dei massimi esponenti,
infatti egli riprende Cicerone convinto che ciò sia sinonimo di un ritorno alla saldezza dei costumi
e dunque insiste sulle doti morali dell’oratore
a cui affida il compito di porsi al servizio della res pubblica e della società,
senza però rendersi conto che le condizioni politiche erano mutate e che ciò non era possibile.
Scaricato da Marianna Tallarico (mariaanna.tallarico@hotmail.it)
lOMoARcPSD|5715493
Esame 13 Settembre 2019, domande+risposte
Lingua e letteratura latina (Università degli Studi di Bergamo)
StuDocu non è sponsorizzato o supportato da nessuna università o ateneo.
Scaricato da Marianna Tallarico (mariaanna.tallarico@hotmail.it)
lOMoARcPSD|5715493
LEZIONE 81
Tendenze Ciceroniane e anticiceroniane nella letteratura di età imperiale
Due tendenze caratterizzano la letteratura latina di età imperiale:
quella ciceroniana delle Epistole di Plinio il Giovane
e quella anticeroniana nell’opera matura di Tacito.
All’epoca dei Flavi non c’è più mecenatismo e ossequio
perché essi non sono interessati alla cultura come lo era la dinastia Claudia.
In questo periodo si riscopre il classicismo
e i modelli divennero Virgilio per la poesia e Cicerone per la prosa.
Con Quintilliano e il suo trattato sull’oratoria prese avvio la canonizzazione di Cicerone
sul piano del gusto linguistico e retorico:
egli infatti si rifà a Cicerone a Demostene adattandoli alla diversa realtà sociale
poiché la retorica nella sue epoca è usata come mediazione tra principe e società
affinché si mantenga la cultura.
Importante anche Plinio il Giovane poiché nelle sue Epistole fa riferimento al modello di Cicerone;
inoltre il suo Panigirico a Traiano è l’unico esempio di orazione giuntoci sin dai tempi di Cicerone.
Al contrario lo storico Tacito segue Tacito nel suo trattato sull’oratoria,
nelle sue opera tarde e storiche è anticiceroniano e usa invece come modello Sallustio.
In quali termini Giovenale innova la tradizione satirica?
La novità di Giovenale nella satira è questa:
in precedenza la satira avendo come oggetto la realtà quotidiana
aveva adottato uno stile umile e un tono familiare e senza pretese (il sermo),
ora invece Giovenale decide di usare uno stile simile a quello dell’epica e della tragedia.
Così facendo Giovenale trasforma il codice formale del genere satirico,
recidendo ogni legame con la commedia e accostando la satira alla tragedia per contenuti e stile.
Per farlo egli spesso, proprio in coincidenza con i contenuti più bassi e volgari,
utilizza le solenni movenze epico-tragiche,
mentre tratteggiando scene di violenza e crudezza usa un lessico crudo e brutale
ma anche neologismi e interrogazioni retoriche.
Il tema predominante è la corruzione dei costumi descritta con pessimismo:
nella sua realtà vede solo il male, non vede nulla di buono e nemmeno il futuro offre speranza.
Bersaglio privilegiato sono le donne emancipate e libere,
che si muovono disinvolte per la societa e che sono per il poeta lo scempio del pudore
dunque potremmo trovare in lui una certa misoginia.
Inoltre egli protesta contro l’oppressione e la miseria,
cosa che ha patto parlare di atteggiamento “democratico” ma così non è:
il suo atteggiamento verso il volgo e gli indotti è solo disprezzo.
Egli scrive spinto dunque dall’indignatio,
ma non crede che la poesia possa influire sul comportamento degli uomini,
giudicati prede irrimediabili della corruzione.
Scaricato da Marianna Tallarico (mariaanna.tallarico@hotmail.it)
lOMoARcPSD|5715493
Si natura negat, fecit indignatio versum: significato di questo verso di Giovenale.
Gli scrittori precedenti di satira giustificavano la loro poesia
o con la loro inclinazione verso tale genere oppure con l’impossibilità di trattare un genere più alto,
al contrario Giovenale sceglie consapevolmente il genere satirico
poiché questa per lui è una necessità dettatta dall’ipocrisia e dai vizi che lo circondano,
dunque è la sua indignatio a spingerlo a questa forma di poesia:
“se anche la natura lo negasse è lo sdegno che produce questo verso”.
Egli scrive spinto dunque dall’indignatio,
ma non crede che la poesia possa influire sul comportamento degli uomini,
giudicati prede irrimediabili della corruzione.
Si metta a confronto la satira di Persio con la satira di Giovenale.
Persio e Giovenale hanno in comune diverse caratteristiche:
-entrambi si ricollegano stilisticamente e spiritualmente alla poetica di Lucilio e di Orazio.
-hanno il merito di rivoluzionare la satira come genere letterario:
Orazio e Lucilio indirizzavano le loro opere a una ristretta cerchia di amici letterati,
mentre Persio e Giovenale scrivevano satire dirette a un pubblico generico di lettori-ascoltatori,
di fronte ai quali il poeta si comporta come un moralizzatore
-la satira di Orazio, seppur prevedendo la critica dei cattivi costumi,
era indulgente verso le debolezze dell’essere umano e vedeva tutto con un sorriso autoironico.
Al contrario con Persio e Giovenale vi è un rigido sistema valoriale stoico contro i vitia.
-dal punto di vista linguistico, entrambi le satire utilizzavano il sermocotidianus.
Scaricato da Marianna Tallarico (mariaanna.tallarico@hotmail.it)
lOMoARcPSD|5715493
LEZIONE 82
Cause del decadimento dell'eloquenza per Quintiliano e per Tacito.
Quintilliano sostiene che il motivo dell’eloquenza sia la mancanza di libertà.
Sotto il principato di Nerone i poteri passano sempre più dal Senato all’imperatore
e la perdita di libertas porta alla perdita anche del vigore e della passione dell’oratoria:
L’oratoria si ripiega ad essere parte dell’istruzione superiore di intellettuali e funzionari di stato
e non più atta alla formazione dell’oratore che poi avrebbe dato prova di sé nel foro.
Inoltre ormai l’eloquenza stava diventando anche corruzione:
erano sempre di più i maestri corrotti che usavano l’eloquenza come ricatto materiale e morale.
Tacito nel Dialogus de oratoribus propone un dialogo fittizio tra alcuni oratori e retori dell’epoca
esaminando i motivi della decadenza dell’eloquenza e si conclude con la posizione di Tacito:
una grande oratoria era possibile solo con la libertà e l’anarchia che regnava durante la Repubblica,
quando vi era il fervore dei tumulti e delle guerre civili,
mentre ora è anacronistica e non più praticabile poiché la società è tranquilla e ordinata.
La posizione di Tacito dunque è questa:
la perdita di libertà è il prezzo da pagare per la conquista della pace.
Tuttavia non è da confondere la visione di Tacito riguardo la decadenza dell'oratoria
con un dissenso nei confronti del potere:
il principato, seppur non garantiva la libertà,era secondo Tacito l'unica forma di governo che assicurava la pace.
Sebbene in parte la posizione dei due autori coincida, in Tacito è molto più forte il dato politico,
in Quintilliano quello legato alla decadenza della scuola.
In che modo i Germani sono visti da Tacito?
La Germania è la prima opera latina interamente dedicata a una popolazione barbarica.
Sicuramente Tacito mette gli interessi etnografici al centro della sua opera
anche se le notizie contenute probabilmente non derivano da osservazioni dirette ma da fonti scritte.
Nei primi capitolo è descritta la Germiania (suolo, clima, abitanti, costumi,religioni,leggi,vizi, virtù)
mentre la seconda parte contiene notizie sui diversi popoli.
Sugli scopi di Tacito sono state avanzate due posizioni:
-una etica, che esalta una civiltà ingenua e primordiale, non ancora corrotta dai vizi raffinati di una civiltà decadente
-un intento sia politico, legato alla tattica di difesa dei confini al nord dell’Impero:
col mettere in rilievo la pericolosità di quei barbari, Tacito avrebbe assecondato i piani di Traiano.
Importanza dell’opera di Tacito.
Diversamente da come si intende oggi il termine "storico",
per i romani la storia fu un genere letterario su argomenti realmente accaduti,
che seguiva determinate regole compositive ed era soprattutto oratoria (inno alla patria e alle virtù)
e che considerava più importante il fine artistico a quello storiografico e scientifico.
Essa dunque non si preoccupava di vagliare attentamente le fonti o controllarne la veridicità
ed era sempre orientata secondo le personali convinzioni degli autori o da criteri moralistici.
Tacito cambia prospettiva:
-si concentra sull’obiettività e su fatti reali
e vi è uno studio scrupoloso delle fonti, delle cause e degli avvenimenti,
infatti sia nelle "Historiae" che negli "Annales",
-afferma di voler essere imparziale e di indagare sui fatti, lontano dai sentimenti e dalle simpatie,
anche se in realtà questa sembra più una giustificazione
a certe accuse di parzialità che avrebbero potuto muovergli.
In realtà infatti Tacito non si accontenta di una descrizione asettica degli avvenimenti,
ma fornisce un giudizio su ciò che narra.
Perché si può parlare di stile drammatico in Tacito?
Tacito, oltre ad essere uno storico, è un grande artista drammatico che usa con grande abilità la lingua:
-vuole capire la psicologia dei personaggi per portarne alla luce le ambiguità
dunque mette l’uomo al centro e ne studia passioni e virtù
-descrizioni particolareggiate di morti tragiche, catastrofi, sciagure
-uso di discorsi dei personaggi storici
-pessimismo.
Scaricato da Marianna Tallarico (mariaanna.tallarico@hotmail.it)
lOMoARcPSD|5715493
LEZIONE 83
Le Epistulae di Plinio il giovane
Le lettere dell’epistolario di Plinio il giovane sono dedicate ciascuna a un singolo tema
e disposte in ordine casuale per evitare la monotonia.
Il modello è l’epistolario di Cicerone,
ma quello di Cicerone era più un documento autobiografico e dettato dall’urgenza di comunicazione
mentre quello di Plinio è una cronaca elegante, mondana e frivola a puro scopo di intrattenimento.
Esso è composto da brevi saggi di cronaca sulla vita mondana, intellettuale e civile
in cui elogia diversi personaggi, soprattutto poeti,
e in cui lui è osservatore privilegiato della società
vista la sua posizione di fama letteraria e posizione politica.
Lo stile dunque è elegante, con reminiscenze di Virgilio, Cicerone e spunti di Stazio e Marziale.
Il X libro delle epistole contiene lo scambio epistolare con l’imperatore Traiano
e qui emerge la natura del loro rapporto:
Plinio si comporta come funzionario scrupoloso e reale, ma anche indeciso,
infatti informa Traiano di vari problemi attendendosi da lui dei consigli e delle direttive,
anche se Traiano tal volta appare infastidito.
In particolare importante l’atteggiamento di Traiano verso i cristiani:
in mancanza di una legislazione precisa in materia
dice a Plinio di non procedere contro di loro quando ci sono denunce anonime.
Intellettuali e potere nell’età di Traiano e Adriano
Dopo la tirannide di Domiziano,
con l’avvento di Traiano gli intellettuali iniziarono a sentirsi meno condizionati e più liberi di esprimersi
poiché propose l’immagine del principe buono e illuminato che riacquisisce il consenso della nobilitas
tipica del principato augusteo.
Questo clima di tolleranza ebbe benefici sulla cultura e sulla letteratura
anche se non si trattò di un’autentica libertà perché fu comunque sempre controllata dal principe:
fu più che altro un’illusione di aver conseguito, dopo anni di asservimento, la libertà di espressione.
Adriano è il primo imperatore della dinastia antonina:
letterato, bilingue, cosmopolita, studioso, viaggiatore,
contribuì alla difesa dello stato ma che, a differenza del suo predecessore,
optò per una politica puramente difensiva.
Sempre tra gli antonini importante Marco Aurelio, imperatore filosofo.
In questo periodo la stasi sociale si ripercuote anche sulla cultura:
-formalismo ed erudizione
-“seconda sofistica” cioè movimento greco ispirato alla retorica
-arcaismo che ripropose gli autori più antichi
-affermazione dell’Africa come provincia più ricca di talenti letterari
-bilinguismo correlato con la natura cosmopolita dell’impero.
Scaricato da Marianna Tallarico (mariaanna.tallarico@hotmail.it)
lOMoARcPSD|5715493
LEZIONE 84
Arcaisti e storici in età imperiale
L’arcaista più famoso del periodo è Frontone, a capo del movimento frontoniano o arcaizzante,
ovvero un cenacolo di amici, discepoli, colleghi e ammiratori
che si rifacevano come lui ai modelli preclassici, agli arcaici.
Da un corpus di lettere ritrovato si evince il suo ritratto di maestro affettuoso e amico caro,
ma offrono anche un esempio di genus siccum, cioè di uno stile asciutto e essenziale ispirato all’atticismo
che usa un lessico ricercato e riesuma arcaismi adattandoli ai nuovi significati.
Per quanto riguarda gli storici il maggiore è sicuramente Tacito,
che vagheggiava un ritorno ai valori della società repubblicana
pur nella consapevolezza che il principato era l’unico modo per mantenere la pace.
Sempre secondo Tacito da Augusto in poi termina la tradizione storiografica veritiera.
Nonostante questo vi furono vari storici nell’età imperiale
che trattarono il tema del passaggio dalla repubblica al principato,
anche se essi furono soprattutto di estrazione senatoria
e dunque descrissero gli eventi dal punto di vista di un elite estromessa dal potere
(ad eccezione di Livio che era estraneo alla nobilitas).
Questa storiografia non è trionfale, ha impianto solitamente annalistico,
e parla della libertà perduta e della nostalgia per l’età repubblicana
tanto che molte di esse vennero censurate e quasi tutte sono perdute.
Le biografie di Svetonio: fonti, scelte e caratteri della produzione storica in tarda età imperiale
Svetonio nelle sue biografie, genere letterario di derivazione greca,
rinuncia alla trattazione cronologica e sceglie un criterio per categorie
che trattano singolarmente i vari aspetti delle personalità di cui sta parlando.
Le fonti per reperire materiale: materiale d’archivio, tradizione letteraria, elogia, laudationes funebres.
Per le biografie di grammatici e retori presenti nel De viris illustribus egli offre brevi informazioni su:
origini, insegnamento esercitato, interessi principali, opere composte, carattere.
Per quanto riguarda invece Vite dei Cesari,
qui descrive gli imperatori sempre con uno schema simile
ma mostrando molta attenzione sulla loro vita privata e sui loro eccessi o particolari scandalistici
che viene interpretata oggi come volontà di mostrare un ritratto generale del personaggio.
Lo stile è semplice, chiaro, sobrio, essenziale,
si caratterizza in senso realistico e si ispira a modelli colloquiali
infatti vi sono frequenti neologismi, grecismi e termini astratti come era d’uso nel linguaggio del tempo.
Non vi sono artifici retorici, non c’è pathos, il periodare è paratattico.
Scaricato da Marianna Tallarico (mariaanna.tallarico@hotmail.it)
lOMoARcPSD|5715493
LEZIONE 85
Apuleio e l'Asino d'oro.
L’asino d’Oro, o Metamorfosi, documenta in modo inequivocabile l’interesse di Apuleio per la magia,
infatti è narrata in prima persona la trasformazione di un giovane, Lucio, in asino,
e il suo ritorno, dopo mille peripezie, alla forma umana.
La trama principale è inframmezzata da racconti e novelle, fra cui lunghissima, quella di Amore e Psiche, che occupa
la parte centrale dell’opera.
L’originalità di Apuleio nell’arte di narrare alternando comico e serio, licenzioso e mistico,
evocando sempre uno sfondo fiabesco o mistico.
Che tipo di movimento culturale va sotto il nome di Seconda sofistica?
Tra il II ed il IV secolo d.C. si sviluppò la seconda sofistica (o neosofistica).
Il neosofista, formatosi tra le esercitazioni delle scuole di grammatica e retorica,
è un uomo dotato di una cultura enciclopedica
capace di improvvisare discorsi che affascinano l'uditorio per il linguaggio forbito e lo stile musicale.
Apuleio ne era uno dei portavoci.
Che significato ha la bella fabella di Amore e Psiche nel romanzo di Apuleio?
Nel corpo delle Metamorfosi sono inserite diverse favole,
ma quella di maggior rilievo, per estensione e significato, è senz’altro la favola di Amore e Psiche.
La trama racconta che la figlia del re è bellissima e suscita le ire di Venere che prega il dio Amore
di instillarle nel cuore una passione disonorevole,
ma Cupido, dio dell’amore, se ne innamora e la sposa,
con l’unica condizione che lei non potrà mai vedere il suo amante altrimenti verrà separata da lui.
Psiche però tradisce il divieto e spia Cupido mentre dorme
quindi verrà il distacco tra i due e una penosa espiazione a cui Psiche si sottoporrà
per poi finire positivamente quando Psiche viene assunta a dea e i due si ricongiungono.
La successione degli avvenimenti della novella riprende quella delle vicende del romanzo:
prima un'avventura erotica, poi la curiositas punita con la perdita della condizione beata,
quindi le peripezie e le sofferenze, che vengono concluse dall'azione salvifica della divinità.
La favola rappresenterebbe il destino dell'anima, che, per aver commesso il peccato di tracotanza
tentando di penetrare un mistero che non le era consentito di svelare,
deve scontare la sua colpa con umiliazioni ed affanni di ogni genere
prima di rendersi degna di ricongiungersi al dio.
Gli scrittori cristiani interpretarono la favola come mito dell’incontro tra l’Anima e il Desiderio.
La favola è fondamentale perché senza di essa non si riuscirebbe a decodificare l’intero romanzo:
tocca infatti a questo racconto secondario rendere più complessa la prima lettura del romanzo
attivando una seconda linea tematica, quella religiosa e mistica,
altrimenti si tratterebbe solo di un superficiale romanzo d’avventura.
Confronto tra Apuleio e Petronio: temi, struttura, stile, protagonisti, atteggiamento dell'autore.
Sia Petronio sia Apuleio compongono un romanzo: il Satyricon e l’Asino d’oro.
Il romanzo antico ha origine in Grecia
mentre nel mondo antico non esisteva il “romanzo” che conosciamo oggi
anche se esistevano alcune opere che ne presentavano alcune caratteristiche
e che sono stati denominati tali a posteriori.
Entambe le opere sono una letteratura d’evasione e di finzione, scritta in prosa,
che fanno riferimento a temi comuni come il sesso e l’amore
anche Apuleio in più si concentra molto sul tema della magia.
In entrambi inoltre vicende e toni variano fortemente poiché vi sono moltissimi racconti diversi.
Nel Satyricon però la realtà raccontata è quella di un’umanità degradata e senza riscatto
mentre nell’Asino d’oro le prove affrontate sono un rito di purificazione per creare un uomo nuovo.
Lo stile di Petronio è una mimesi del linguaggio parlato, domina il registo medio-basso,
vi è una polemica contro i retori e lo stile asiano,
mentre lo stile di Apuleio è contraddistinto dal pluristilismo, con un linguaggio ibrido ma arificioso.
Scaricato da Marianna Tallarico (mariaanna.tallarico@hotmail.it)
lOMoARcPSD|5715493
Quale relazione ha Apuleio con la magia e quanto essa influenza le sue opere?
Uno dei temi fondamentali della prima parte delle Metamorfosi è costituito dalla magia,
che è la più arcaica forma di conoscenza e controllo sul mondo naturale.
In questo senso essa ha caratteri di contiguità sia con la scienza, sia con la religione.
In un’epoca di destabilizzazione culturale come il II sec. d.C., epoca di crisi della fede nella ragione,
si rivitalizzano le forme irrazionali del pensiero, e le esperienze mistiche, religiose, magiche.
In questo contesto il successo delle religioni orientali,
fra le quali sarà il cristianesimo ad ottenere la diffusione maggiore, è enorme,
ma lo è anche di un recupero della magia, relegata fino ad allora a forme di incantesimi per gli ignoranti.
Apuleio è un testimone significativo di questo carattere dell’epoca:
lui retore, erede della tradizione classica, filosofo platonico, si occupa di magia,
tanto che accusato di aver ottenuto la mano di una ricca vedova con incantesimi e filtri magici
si deve difendere con l’Apologia o De magia.
Nell’orazione giudiziaria emerge l’abilità avvocatesca per il modo in cui affronta i capi d’accusa
presentandoli come assurde fantasticherie poiché si presenta non come mago ma come filosofo,
e sempre con punti di ironia, da cui traspare la sicurezza della vittoria.
LEZIONE 86
Caratteristiche dello stile di Tertulliano
Tertulliano è il più grande apologista della cristianità greco-latina
e il primo a proporre un linguaggio fatto per il trionfo di nuove idee.
Nell’Apologeticum, con un’orazione si rivolge ai governanti delle province:
i cristiani non hanno commesso alcun crimine dunque non possono essere perseguitati per il loro nome.
Egli respinge le accuse di sacrilegio e attività contro la società romana e illustra il vero stile di vita cristiano.
Inoltre, sostiene che “il sangue dei cristiani è un seme”
cioè versarlo significa portare nuove conversioni sulla spinta del loro eroismo.
Egli ribalta le accuse inoltre contro i pagani:
sono essi che conducono una vita immorale e praticano una religiosità assurda e crudele.
Il suo stile è incalzante e usa una satira tagliente ma il tutto è infarcito di retorica, artifici e sofismi.
La lingua è innovativa nel lessico
poiché vi sono termini liturgici presi dal greco, tecnicismi giuridici, popolarismi.
Le prime traduzioni della Bibbia: Vetus Itala e Vetus Africa
Dal II sec dC si sentì l’esigenza di una Bibbia in latino
da cui derivano le prime traduzioni effettuate in Italia e in Africa,
La Vetus Itala o Latina e la Vetus Afra (Vecchia rispetto a quella di Girolamo che poi diventerà ufficiale).
Queste non furono un’unica traduzione
ma opere occasionali di ministri di culto anonimi e senza pretese letterarie
il che spiega le differenze tra i testi italici e africani,
anche se anche all’interno delle due aree geografiche le traduzioni furono più di una e discordanti tra loro.
Queste prime bibbie in latino ebbero importanza sulla lingua dei primi letterati cristiani
poiché essi vennero resi alla lettera per non alterare il Verbo di Dio
dunque si crearono calci e costrutti sintattici alla greca, ebraismi, tecnicismi lessicali e nuove espressioni.
Scaricato da Marianna Tallarico (mariaanna.tallarico@hotmail.it)
lOMoARcPSD|5715493
LEZIONE 87
Lo stile di Tertulliano e Cipriano a confronto
Cipriano ammira Tertulliano,
ma ha uno stile classicheggiante, armonioso, con una prosa incline all’asianesimo
poiché vuole conferire efficacia e prestigio alla sua predicazione attraverso una nobiltà di forma.
Cambiano anche i toni:
Cipriano è pacato, anche quando tratteggia quadri vivi della decadenza della società imperiale.
mentre Tertulliano era tormentato, aspro, aggressivo.
Che rapporto c’è tra i primi autori cristiani (Tertulliano, Lattanzio, Cipriano)
e la cultura classica pagana?
La cultura cristiana e la Chiesa garantiranno la sopravvivenza della lingua e della cultura classica
tramite la copiatura dei classici nei monasteri, garantendone la sopravvivenza.
I cristiani dotti però avevano atteggiamenti diversi nei confronti della cultura classico pagana:
alcuni le condannavano a priori poiché lontane dal dogma cristiano e quindi via di peccato,
altri si erano formati su quei testi e non li rinnegarono ma ne subirono il fascino.
Lattanzio è un’esponente dell’intellettualità pagana che si sentì attirato dal cristianesimo
per esigenze soprattutto di rigore morale
dunque sentiva l’urgenza di confrontarsi con la moralità e la cultura pagane.
Egli però è molto legato agli schemi argomentativi e teorici della cultura classica
e la sua formazione cristiana aveva troppe lacune
quindi non riesce nel suo ambizioso progetto
in cui si nota approssimazione dottrinale e scarsa sensibilità scritturistica.
Egli riesce bene invece nella trattazione di temi morali
in cui la filosofia classica armonizza bene con la dottrina evangelica nella comune esaltazione della giustizia
che, nella religione cristiana, era raggiungibile solo con la sapienza.
Il suo più grande merito comunque è l’aver aperto il cristianesimo ai valori della tradizione classica:
per Lattanzio lo studio del mondo classico è un valido mezzo per arrivare alla verità cristiana
dunque gli ecclesiastici devono essere esperti di retorica e lettere classiche.
Tertulliano è intriso di cultura classica e filosofica
ma critica e condanna i filosofi pagani e cerca di ribaltare le accuse rivolte ai cristiani contro i pagani:
sono essi che conducono una vita immorale e praticano una religiosità assurda e crudele.
Egli inoltre li accusa della curiosità,
che secondo lui dopo la scoperta di Cristo e del Vangelo non ha più motivo di esistere.
Anche Cipriano studia grammatica e retorica e diviene retore, e rimane infatti lo stile classicheggiante,
ma dopo il battesimo cambia completamente vita e nelle sue opere mostra interesse solo pastorale
scrivendo testi contro la vita dissipata di chi non si è convertito,
e raccolte di versi biblici dedicati ai giudei per mostrare loro che la legge di Mosè
è stata superata con l’avvento del Cristianesimo.
Scaricato da Marianna Tallarico (mariaanna.tallarico@hotmail.it)
lOMoARcPSD|5715493
LEZIONE 88
La rinascita pagana del IV d.C.
Nel IV sec dC il cristianesimo è ormai penetrato in tutte le classi sociali
ma appare ancora un pericolo per l’aristocrazia senatoria
quindi ne deriva una rinascita della cultura pagana promossa sia a Oriente che Occidente
anche se il predominio del greco nelle classi colte occidentali va scemando e viene studiato sempre meno
e la rinascita della cultura pagana occidentali
si baserà sui valori tradizionali della romanità e della cultura latina.
In particolare nelle scuole negli ultimi anni di Costantino si afferma una sensibilità verso i classici:
gli allievi apprendono la mitologia politeista e le dottrine filosofiche della cultura pagana
mentre l’insegnamento cristiano non trova posto nell’insegnamento tradizionale,
nonostante molti insegnanti fossero cristiani.
Inoltre vi è una grande fioritura di opere grammaticali, erudite e enciclopediche.
Che significato ha la disputa tra Ambrogio e Simmaco a proposito dell’altare della Vittoria?
Simmaco fu un oratore e retore che si levò per difendere il paganesimo,
in particolare è importante lo scontro con Ambrogio testimoniato in una lettera:
Simmaco voleva ricollocare nella curia romana l’antica ara della Vittoria
che era stata fatta togliere dall’imperatore Graziano,
poiché sosteneva la necessità di non abbandonare una tradizione
che aveva dimostrato di proteggere lo stato e garantire la grandezza di Roma,
ma anche poiché voleva mostrare la possibilità di convivenza di due culture diverse
poiché secondo lui “ognuno cercava la verità a suo modo”.
Si opponeva Ambrogio, vescovo di Milano,
e chiedeva all’imperatore, in nome della fede cristiana, di non considerare tale richiesta,
poiché: “quella verità che tu non conosci noi l’abbiamo appresa direttamente da Dio”.
Inizialmente il discorso di Simmaco pare impressionare l’imperatore ma poi interviene Ambrogio che ebbe la meglio.
Funzione della scuola nell’Impero romano, soprattutto in età imperiale
Nel IV secolo il programma di riorganizzazione dell’impero promossa da Diocleziano
porta e un crescente intervento dello stato in ogni ambito e a una potente aristocrazia
che si andava formando nelle scuole di retorica che riacquisirono prestigio.
Appunto nelle scuole si afferma ora, verso la metà del IV secolo, una sensibilità nuova verso i classici:
il risveglio della letteratura latina pagana si manifesta
sia con una grande fioritura di opere grammaticali, erudite, enciclopediche
sia con l’insegnamento impartito nelle scuole di retorica che è basato sullo studio degli autori classici:
gli allievi apprendono la mitologia politeistica e le dottrine morali e filosofiche della cultura pagana
mentre la dottrina cristiana non trova posto nell’insegnamento tradizionale.
Quali sono gli autori della rinascita pagana del IV secolo e in che contesto si colloca questo movimento?
Nel IV sec dC il cristianesimo è ormai penetrato in tutte le classi sociali
ma appare ancora un pericolo per l’aristocrazia senatoria
quindi ne deriva una rinascita della cultura pagana promossa sia a Oriente che Occidente
anche se il predominio del greco nelle classi colte occidentali va scemando e viene studiato sempre meno
e la rinascita della cultura pagana occidentali si baserà sui valori tradizionali della romanità e della cultura latina.
Gli autori principali sono:
-i grammatici Elio donato e Servio
- Simmaco, autore di 900 lettere, di cui famosa è quella per il ripristino dell’Altare della Vittoria
-Lucio Settimo e Eutropio scrissero di storia ma con carattere aneddotico e inattendibilità delle notizie
-Scriptores Historiae Augustae, autore/i sconosciuto, raccolta di 30 biografie d’imperatori o pretendenti,
che offre un racconto avvincente ma con molti anacronismi e contraddizioni
-Ammiano Marcellino scrive Rerum gestarum libri proseguendo le storie di Tacito
e dando molta importanza soprattutto al periodo contemporaneo.
Di Tacito riprende sia la trattazione annalistica, sia la metodologia:
Scaricato da Marianna Tallarico (mariaanna.tallarico@hotmail.it)
lOMoARcPSD|5715493
tratta sia le vicende politiche e la vita interna allo stato, sia gli intrighi di corte, sia le guerre esterne,
offrendo un quadro storico unitario.
LEZIONE 89
Padri della Chiesa e letteratura patristica: caratteri, finalità e stile
I Padri della Chiesa sono gli scrittori cristiani dell’antichità
che hanno contribuito all’elaborazione dottrinale del cristianesimo
e la cui opera è stata accettata e fatta propria dalla Chiesa.
Questo periodo si divide in:
-apologistica (sino al 200 dC circa)-> difesa del cristianesimo vs avversari pagani e gnostici
-patristica (200-450 dC circa)->formulazione dottrinale delle credenze cristiane
-dopo il 450 rielaborazione e sistemazione delle dottrine già formulate.
Essi si giovarono in gran parte delle dottrine filosofiche pagane, soprattutto quella stoica,
per rappresentare il cristianesimo come l’ultima e più compiuta manifestazione della filosofia greca.
La retorica però è guardata con diffidenza in quanto esempio della cura della forma fine a sé stessa
mentre essi fanno presa sul valore educativo dei contenuti.
Illustra la figura di Ambrogio vescovo di Milano
Ambrogio si impegna sia all’interno della chiesa
(questioni pastorali e ecclesiali, culto, dottrina, morale, interpretazione dei testi)
ma interviene anche all’esterno in questioni non direttamente di sua competenza
in quanto la sua posizione di vescovo di Milano è autorevole
poiché Milano era a quel tempo la principale sede imperiale.
Egli era infatti convinto che il potere imperiale “è all’interno della Chiesa e non al di sopra di essa”
dunque esercita il suo potere sull’imperatore Graziano che rinuncia alla carica di pontifex maximus,
prerogativa imperiale del tempo di Augusto,
mentre costringerà Teodosio a una penitenza pubblica e lo escluderà dai sacramenti
dopo che egli aveva ordinato una rappresaglia contro gli abitanti di Tessalonica.
Infine si erge ai protettore dei poveri cristiani dai tribuni militari che vessavano le popolazioni.
Opere:
-Opere esegetiche in cui segue il modello allegorico adottato dai maestri orientali,
infatti spesso nelle sue opere si vede il tentativo di riprendere gli schemi della tradizione classica
ma trasformandoli in senso cristiano.
- Inni che erano concepiti come strumento di catechesi
poiché facilitavano la comunicazione da parte del vescovo e l’apprendimento degli ascoltatori.
-opere ascetiche e morali dedicate alla verginità e alla vita monastica
-opere per la formazione del clero
-discorsi in cui celebra dei personaggi cogliendo l’occasione per riflettere sulla morte
o su valori che sono esemplari nella vita di chi viene elogiato
-lettere molto varie con questioni dottrinarie, esegetiche, personali, politiche.
Tra le più note quelle relativa all’Ara della Vittoria.
La sua prosa è limpida ed elegante, modellata su forme classica, la cui influenza è fortissima,
anche se ad essi si mescola lo stile biblico,
mentre la retorica è guardata con diffidenza poiché è una cura della forma fine a sé stessa
mentre ciò che conta per l’estetica cristiana sono i contenuti.
A chi si rivolgono le opere degli autori cristiani? Quale è il pubblico e come questo ne influenza caratteri e stili?
Il pubblico cristiano non ha una classe sociale:
sebbene il cristianesimo si originò tra le classi umili, finì presto per estendersi ad ogni strato sociale
compresa l’élite letteraria, senatoria e gli imperatori stessi.
La letteratura cristiana dunque dovette adattarsi al suo pubblico componendo testi diversi:
l’esegesi biblica era rivolto a un pubblico colto di religiosi,
gli Inni, come quelli di Ambrogio, erano rivolti invece a tutti ed erano un ottimo metodo di catechesi,
le opere ascetiche erano destinate ai monaci o a chi voleva darsi alla monacazione.
Scaricato da Marianna Tallarico (mariaanna.tallarico@hotmail.it)
lOMoARcPSD|5715493
LEZIONE 90
Importanza di Girolamo come scrittore cristiano e come Padre della Chiesa.
San Girolamo è importante per diversi aspetti ma soprattutto per la sua attività di filologo.
Egli infatti, di fronte all’insoddisfazione generale nei confronti della rozzezza delle traduzioni della Bibbia,
decide di fare una traduzione della Bibbia chiamata Vulgata condotta sul testo ebraico:
egli inizia a interpretare il Verbum in maniera meno letterale
e garantirà a tutta la Chiesa occidentale un testo unitario e stilisticamente pregevole
tanto da divenire la versione ufficiale della Chiesa raccomandata dal Concilio di Trento.
Per fare questo lavoro fece la revisione (non la traduzione ex novo) del testo latino dei vangeli
e tramite il confronto con l’originale greco.
Successivamente si rivolse all’Antico Testamento,
dove insoddisfatto della traduzione greca dei Settanta decise di attingere al testo ebraico.
A fianco della Vulgata nascono opere di compendio per farne comprendere il testo al pubblico.
E’ importante anche perché con il De Viris Illustribus fornirà le biografie degli autori cristiani
aprendo così una riflessione sulla storia letteraria degli autori cristiani
e le sue Vitae di santi eremiti.
Nel suo epistolario invece, che ha modello Cicerone non per la lingua ma per l’espressività,
si scaglia spesso contro nemici o avversari,
poiché incline a vedere nella realtà circostante la degenerazione degli ideali in cui crede.
Il dilemma Ciceroniano aut Christianus in Girolamo a cosa fa riferimento?
L’entusiasmo di Gerolamo per la cultura cristiana ha un rapporto dialettico con la cultura classica:
egli stesso racconta un episodio accaduto ai tempi del suo primo viaggio a Gerusalemme:
colpito da una grave febbre tanto che si stava già preparando il suo funerale,
gli sembrò di essere rapito e portato davanti al Giudice Supremo,
che lo interrogava sulla sua identità e gli rimproverava di essere un ciceroniano e non un cristiano,
a causa dell’interesse da sempre nutrito per gli autori pagani.
Da quell’episodio il suo atteggiamento mutò e l’attenzione fu tutta per le Sacre Scritture.
Evidentemente la qualifica di ciceroniano rinfacciatagli da giudice nel sogno della lettera 22
ha un valore culturale (equivale a ‘pagano’) e non letterario.
In effetti Gerolamo ha acquisito i classici durante la sua formazione scolastica e sono un modello.
Nonostante si scagli contro il culto della forma tipica dei classici
la sua prosa in realtà si rifà a tali modelli.
Girolamo è un ciceroniano ma non per la lingua,
ma lo è perché è capace della stessa grandiosità espressiva e dello spirito.
Con la sua opera de viris illustribus Girolamo ha un intento ben chiaro:
Con l’opera Viris illustribus Gerolamo, che riprende il titolo di Svetonio,
si ripropone si fare un’opera analoga ma orientata nel mondo cristiano,
infatti raccoglie biografie di scrittori cristiani greci e latini, compreso lui stesso.
L’opera è fondamentale perché nessuno mai priva aveva riflettuto sulla storia letteraria degli autori cristiani.
Si illustri il differente punto di vista di Agostino e Girolamo a proposito della grandezza di Roma.
Girolamo rimase profondamento colpito dalle notizie del sacco di Roma
poiché vede la città di Roma, che aveva prima conquistato tutto il mondo, che viene conquistata,
che cade sotto le armi e ancor prima per la fame,
il che costringe gli affamati a mangiarsi l’un l’altro,
e una madre a mangiare il figlio appena partorito.
Da queste immagini si denota che egli è attaccato all’impero romano,
Scaricato da Marianna Tallarico (mariaanna.tallarico@hotmail.it)
lOMoARcPSD|5715493
che identifica con il mondo civile e con lo stesso mondo cristiano.
S. Agostino invece crede che Roma non sia finita,
è stata colpita ma non annientata poiché la grandezza di Roma è nei Romani,
ed essi non moriranno se acconsentiranno a lodare Dio,
mentre la loro perdita è certa se continuano a bestemmiarlo.
Scaricato da Marianna Tallarico (mariaanna.tallarico@hotmail.it)
lOMoARcPSD|5715493
Esame 13 Settembre 2019, domande+risposte
Lingua e letteratura latina (Università degli Studi di Bergamo)
StuDocu non è sponsorizzato o supportato da nessuna università o ateneo.
Scaricato da Marianna Tallarico (mariaanna.tallarico@hotmail.it)
lOMoARcPSD|5715493
LEZIONE 91
Il rapporto di Agostino con la tradizione letteraria pagana
Agostino è attratto dalla filosofia sin dalla giovinezza e questo è fondamentale nella sua conversione:
egli infatti vede avvalorate dalla fede cristiana le tendenze culturali della sua giovinezza.
Agostino riconosce il valore della letteratura pagana,
ne presuppone i contenuti e ne accetta il loro insegnamento nei primi gradi della formazione scolare
ma nello stesso tempo ne sottolinea il definitivo superamento in senso cristiano.
Quali opere riflettono maggiormente la sua formazione retorica classica?
L’opera che più riflette la sua formazione retorica classica, pur evidente in ogni testo,
è De doctrina cristiana, in cui Agostino teorizza la figura del nuovo oratore cristiano.
L’oratore cristiano certo ha alle spalle una tradizione pagana che egli riconosce
ma crede anche che essa sia superata in senso cristiano
dunque utilizza come riferimento invece lo stile di S. Paolo, Ambrogio e Cipriano.
Egli con questo tentativo vuole fondare su basi teoriche la dottrina e la cultura del cristianesimo
emancipandola dalla cultura pagana per scopo, materia e tradizione di riferimento.
L’altra opera è il De Civitate Dei. (vedi sotto)
Il De Civitate Dei: occasione compositiva, contenuto, stile
Il De Civitate Dei è il primo saggio sistematico di filosofia della cultura occidentale.
L’occasione per il trattato è fornita alla notizia del Sacco di Roma del 410
poiché è un evento che venne sfruttato dalla propaganda pagana
che cercava di addossare la colpa ai cristiani e all’abbandono della religione tradizionale.
Essa è una sintesi che assume i caratteri di un’opera enciclopedica
nella quale confluisce tutta la sapienza precedente,
in cui contrappone la “città di Dio”, la patria spirituale del vero cristiano, alla “città degli uomini”, Roma,
viste come contrasto tra bene e male.
Questa immagine di due civitates contrapposte appartiene alla tradizione pagana
dunque egli si lascia affascinare da questo doppio oppositivo di stampo pagano
che aveva opposto tenebre e luce, peccato e virtù, errore e verità.
La lingua usata è quella classicista destinata a un pubblico colto con periodi ampi e ipotattici.
I poeti dell’età cristiana
Commodiano è il primo poeta cristiano, autore Istructiones, divise in due libri,
uno con poesie dedicate a pagani ed ebrei con lo scopo di convertirli,
l’altro dedicato a confermare la fede di chi è già cristiano.
Prudenzio era un retore e funzionario imperiale convertito in età adulta,
che scrive un libro di inni da dedicare a vari momenti della giornata
o a particolari momenti o feste della vita cristiana,
mentre un'altra raccolta di inni è dedicata ai martiri.
Egli è un poeta doctus in cui confluiscono il linguaggio lirico e le formule narrative dell’epica.
Ausonio è professore di grammatica e retorica, famoso per il componimento Mosella.
Polino da Nola, di famiglia aristocratica e sposato,
decide di vendere i propri beni a vantaggio dei poveri, battezzarsi,
e morta la moglie diventa vescovo di Nola.
Egli è importante per una raccolta di carmi mostra l’opera di “traduttore” del materiale classico in linguaggio cristiano.
Scaricato da Marianna Tallarico (mariaanna.tallarico@hotmail.it)
lOMoARcPSD|5715493
LEZIONE 92
Scaricato da Marianna Tallarico (mariaanna.tallarico@hotmail.it)
lOMoARcPSD|5715493
Esame 13 Settembre 2019, domande+risposte
Lingua e letteratura latina (Università degli Studi di Bergamo)
StuDocu non è sponsorizzato o supportato da nessuna università o ateneo.
Scaricato da Marianna Tallarico (mariaanna.tallarico@hotmail.it)
lOMoARcPSD|5715493
LEZIONE 31
Perché diciamo che la descrizione del banchetto rientra tra i topi dell'epica?
Quali altri esempi ti vengono in mente?
La descrizione del banchetto regale rientra tra i topoi dell’epica
per la presenza di servi e serve, i focolari, i ragazzetti che corrono per rendersi utili, gli arazzi e i tappeti, e
soprattutto la musica e il canto di Iopa, anche se vi è una differenza rispetto al precedente epico:
inon si tratta di un aedo che dipana la vicenda della guerra di Troia,
cosa che sarebbe risultata priva di tatto ed eccessivamente dolorosa,
ma i temi del canto rimandano piuttosto alla poesia alessandrina ed sono ricchi di simbolismo,
ricchi di questioni naturalistiche e sulle misteriose opere dell’Universo.
Con quale tramite Venere fa nascere l'amore di Didone verso Enea?
Venere per far nascere l’amore tra Enea e Didone si servirà di Cupido,
che scenderà sulla terra assumendo le sembianze di Ascanio, il figlioletto di Enea,
e una volta preso in braccio da Didone “gli cancellerà dal cuore l’immagine del marito Sicheo”.
Nella leggenda Cupido scocca una freccia per far innamorare Didone ed Enea.
Da quali affermazioni capiamo che Didone si sta innamorando di Enea?
Didone si confida con la sorella dicendole che dopo l’uccisione del marito
più nessun uomo aveva scosso i suoi sensi,
ma ora parlando di Enea dice di “riconoscere i segni dell’antica fiamma”
e ne elenca le qualità: fierezza, coraggio, qualità morali, la gloria della sua stirpe.
Nonostante questo Didone cerca di opporre resistenza al suo sentimento
perché ha giurato fedeltà al marito e sulla sua tomba ha giurato di non risposarmi mai più
e afferma dunque che preferirebbe morire piuttosto di macchiare la sua integrità morale.
La regina Didone: storia e personalità.
Didone, regina di Tiro, diventa vedova quanto il marito Sicheo viene ucciso da suo fratello Pigmalione.
Ella per non causare una guerra civile inizia una peregrinazione che la porterà a Cartagine
dove conoscerà e si innamorerà di Enea che riconosce in lei le sue stesse doti di “pietas”.
Didone è una donna bella, intelligente, benevola e di buon cuore,
che dopo la sua resistenza iniziare a tradire la fedeltà al marito deceduto,
si innamora di Enea di un amore forte e impetuoso,
anche se tanto forte è questo amore quanto lo sarà la sua delusione quando Enea la abbandonerà,
il che farà trasformare questo affetto in disprezzo, rabbia e odio,
e così, pervasa da una cieca brama di autodistruzione,
invoca gli dei affinché scenda su Enea la maledizione del cielo e dell’inferno
e si augura che nasca tra le loro stirpi un odio eterno.
Infine si getta sulla punta della spada avuta in dono da Enea
e muore tra le fiamme del rogo che ella stessa si è costruita sulla più alta loggia della reggia.
Scaricato da Marianna Tallarico (mariaanna.tallarico@hotmail.it)
lOMoARcPSD|5715493
LEZIONE 32
I Dialoghi di Seneca: alla luce del testo esaminato in quali termini va intesa la forma dialogica?
I Dialogi di Seneca sono 12 libri,
ma di questi solo il De Tranquillitate animi è realmente idealogico (dialogo tra Seneca e l’amico Sereno)
mentre gli altri sono trattazioni di specifici temi in cui Seneca parla in prima persona
rivolgendosi a un interlocutore di volta in volta distinto che però non interviene in forma diretta.
In che senso lo stile di Seneca, che procede per frasi spezzate riflette la realtà storica, secondo Traina?
Traina afferma che lo stile di Seneca è basato sulla frase o sententia.
Egli sostiene che il suo stile sia un riflesso della società e del tempo:
l’avvento dell’Impero segna una frattura
poiché è un periodo in cui il problema non è più l’inserimento del singolo nella società e nello stato
ma il suo significato nel cosmo,
pertanto a livello stilistico ciò si riproduce in molte frasi e molte pause.
Diversa la situazione degli autori precedenti Cesare e Cicerone:
pur nella loro diversità per temperamento, interessi e ideali, essi utilizzavano molti nessi logici,
il che era dato da una società ben organizzata, un equilibrio di valori morali, politici e religiosi.
LEZIONE 33
L'inquietudine di Sereno: cause e rimedi proposti da Seneca.
Sereno si mostra incerto tra una vita privata e il desiderio di partecipare alla vita pubblica, tra ozio e azione.
Seneca risponde che ognuno deve partecipare ai propri doveri sociali seguendo la propria indole:
chi ha una disposizione all’azione deve partecipare alla politica,ma essendo consapevoli dei rischi che corre,
anche se lo stato ideale sarebbe l’atarassia cioè la pace dell’anima.
Le passioni per Seneca dunque non vanno annullate ma moderate
e la propria energia va reindirizzata per migliorare la società.
In privato publicum negotium agit: la 'versione' romana del ritiro stoico.
Illustra la posizione di Seneca
La frase significa “costui in privato svolge un ruolo pubblico”.
Seneca rispondendo ai quesiti di Sereno circa la scelta tra vita privata e vita pubblica
poiché Sereno si era convertito dall’epicureismo allo stoicismo, due scuole che avevano idee contrapposte:
secondo l’epicureismo il saggio non doveva occuparsi di questioni pubbliche
poiché gli impegni civili allontanavano il saggio dall’atarassia,
al contrario per gli stoici il saggio doveva prendere parte attiva nella vita politica
poiché con il suo operato poteva essere d’esempio ad altri cittadini.
Seneca, di fronte a questo dissidio, suggerisce una mediazione tra i due estremi,
e in questa frase spiega a Sereno che anche in privato è possibile per il saggio svolgere un ruolo pubblico
quando con la sua saggezza e intelligenza esorta i giovani alle virtù
e sa trattenere coloro che invece si gettano nel denaro e nel consumo sfrenato.
Scaricato da Marianna Tallarico (mariaanna.tallarico@hotmail.it)
lOMoARcPSD|5715493
LEZIONE 34
Perché lo stile di Seneca viene definito fortemente 'condensato'?
Il suo stile è ispirato alla sintesi, alla condensazione, è basato sulla sententia.
E’ uno stile paratattico fatto di una prosa spezzettata, fatto di frasi una accanto all’altra ma staccate tra loro,
in cui mancano le congiunzioni e lascia al lettore la libertà di intendere il nesso tra le proposizioni.
Alcune di queste frasi hanno più forza di altre,
diventano frasi ad effetto che riescono a condensare il significato di un intero discorso
prendendo la forza di aforismi.
Illustra la metafora del medico nel De tranquillitate animi di Seneca
Seneca nei confronti di Sereno è una sorta di “medico dell’anima”
anche se quella di Sereno è una profonda insicurezza e non una vera malattia.
Proposito educativo del filosofo è quindi quello di far raggiungere all’amico una stabilità emotiva,
frutto di un duro lavoro sulla propria interiorità, che permette di raggiungere l’equilibrio e la moderazione.
LEZIONE 35
Il sermo e la vita in Seneca: contraddizioni, coerenze, coazioni.
Nell’opera di Seneca sono intrecciate la dicotomia sermo (parola) e vita, che egli voleva in accordo,
e di qui dunque la sua insistenza a tramutare le sue parole in azioni
e a censurare coloro che seguivano norma diverse da quelle che insegnavano.
Egli assimila il suo discorso al sermo, ovvero ad una conversazione familiare o informale fra amici,
poiché il suo scopo è incoraggiare l’amico Sereno,
pur utilizzando anche talvolta un tono esortativo
poiché egli è convinto che i principi teorici vadano tradotti in azione.
Otium e Negotium in Seneca.
Il problema di Otium e Negotium è affrontato in Seneca sia nel Tranquillitate animi sia nel De Otio.
Per Otium si intende la vita contemplativa dedicata agli studi
e per Negotium la partecipazione diretta alla vita politica.
Nel De Tranquillitate animi Seneca mostra posizione di compromesso
sostenendo che la natura dispone l’uomo sia alla vita contemplativa sia alla vita attiva
e dice dunque che il saggio può comunque fare del bene comune anche nel suo stato di ritiro.
Anche nel De Otio Seneca dice che va riscoperto il valore politico della vita privata,
poiché il saggio anche se non agisce direttamente in politica
può agire nella collettività umana svolgendo la funzione dell’insegnamento.
Scaricato da Marianna Tallarico (mariaanna.tallarico@hotmail.it)
lOMoARcPSD|5715493
LEZIONE 36
Caratteri dello stile e della lingua di Seneca.
Seneca rifiuta il complesso periodo di cicerone basato sull’ipotassi
e propone una prosa spezzata, dall’andamento paratattico,
composta da frasi concise e ciascuna dotata di autonomia espressiva.
Sul piano della lingua fa molto uso di metafore e termini tratti dai linguaggi tecnici
(medico, militare, agricolo, politico, giuridico, …),
ma agisce anche attribuendo significati nuovi a parole comuni.
Illustra con esempi il linguaggio dell'interiorità di Seneca.
Il “linguaggio dell’interiorità’ di Seneca è basato sull’uso di un tono intimo e mistico-religioso.
Egli infatti è il primo scrittore antico a dare spazio così ampio all’appello alla vita interiore
e dunque anche il suo linguaggio s’interiorizza e si spiritualizza,
infatti utilizzò la metafora dell’interiorità del possesso e dell’interiorità come rifugio.
Per il linguaggio dell’interiorità come possesso Seneca ricorre alla lingua giuridica e al termine vindicare,
cioè rivendicare qualcosa togliendola al legittimo proprietario
per poi essere pienamente in possesso di tutti i diritti su di sé.
Questo è espresso tramite l’uso del riflessivo diretto e indiretto
che indica un ripiegarsi continuo del soggetto su di sé.
Per interiorità come rifugio si intende l’anima che si arrocca in sé stessa
e l’interiorità che diventa possesso stabile.
Per renderlo usa il riflessivo indiretto.
LEZIONE 37
Perché si parla per Seneca di linguaggio della predicazione
Il linguaggio della predicazione è il linguaggio che va dall’interno all’esterno, quello dell’insegnamento,
poiché per Seneca la parola deve tradursi in azione e non essere solo una riflessione teorica,
e dunque egli studia il proprio stile affinché sia incisivo.
E’ un linguaggio che predilige la paratassi, le frasi spezzate, sono eliminate le parole vuote.
Ogni frase è dotata si un significato ed ha risalto, ognuna è studiata con cura e con esressività.
Cosa significa l'espressione 'Linguaggio dell'interiorità' riferita a Seneca?
Vedi sopra
Scaricato da Marianna Tallarico (mariaanna.tallarico@hotmail.it)
lOMoARcPSD|5715493
LEZIONE 38
Seneca, in aderenza con la filosofia storica, respinge totalmente la vita attiva?
Seneca non respinge totalmente la vita attiva ma cerca una mediazione tra otium e negotium
poiché la tranquillità dell’anima è frutto dell’equilibrio tra vita contemplativa e vita attiva.
Di fronte all’inquietudine dell’amico Sereno tra una vita isolata e parsimoniosa e una attiva e nel lusso,
Seneca dice che l’unico rimedio sarebbe l’atarassia, il totale distacco di fronte alle vicende della vita,
ma essendo questa non praticabile nella realtà serve trovare un compromesso:
le passioni umane non vanno eliminate ma serve imparare a controllarle,
e serve vivere in modo operoso per il bene della comunità pur senza rinunciare a momenti di meditazione.
Neminem flebo laetum, neminem flentem.
Partendo da questa frase si illustri stile e pensiero di Seneca.
“Non piangerò nessuno che sia lieto” è una frase del De Tranquillitate Animi.
In questo passo del capitolo XIV Seneca parla della morte, che non si deve temere,
e fa alcuni esempi di uomini che non temettero la morte, in particolare quello di Giulio Cano,
uomo descritto come eccellente e che sapeva che Caligola aveva dato ordine di ucciderlo
ma nonostante questo passò i dieci giorni prima della morte senza turbamenti.
Riflettendo su questo Seneca sostiene che la sorte dei buoni e dei migliori spesso è crudele,
ma non bisogna abbattersi per questo,
al contrario serve osservare come essi hanno vissuto la loro morte:
se morirono con valore è bene,
ma se morirono da femmine o vigliacchi e hanno cercato di sottrarsi ad essa essi sono da biasimare.
E’ a questo punto che vi è la frase: “Non piangerò nessuno che sia lieto, nessuno che pianga:
quello asciuga le mie lacrime, questo con le sue si rende indegno di qualsiasi compianto”.
Non serve il compianto di questi grandi uomini (Ercole, Catone) e per come sono morti
poiché con il loro sacrificio sono divenuti eterni e morendo sono divenuti immortali.
LEZIONE 39
Inisi intenta et assidua cura circumit animum labentem.
Quando troviamo questa affermazione di Seneca e cosa significa?
Queste parole si trovano alla fine dell’ultimo libro, il libro XVI, del De Tranquillitate animi.
Dopo aver dato molti consigli all’amico Sereno,
Seneca chiude dicendo che egli gli ha fornito vari rimedi
per conservare la tranquillità, per ritrovarla e per resistere ai mali, ma lo mette in guardia:
nessuno di questi rimedi è così efficace per salvare un bene così fragile
“se un’attenta e continua cura non circondi l’animo sempre pronto a cadere”.
Queste parole dunque e ci lasciano con l’immagine dell’animo sempre in bilico:
è l’eterno dramma dell’uomo tra il bene e il male.
Modelli della forma del Dialogo nella prosa filosofica.
Nei Dialoghi di Seneca l’interlocutore appare come un mero destinatario, talora del tutto impersonale.
Secondo la maggior parte degli studiosi, infatti,
nel De tranquillitate animi il destinatario non sarebbe nient’altro che la cornice di sfondo,
rimanendo il trattato un monologo,
anche se è vero però che Sereno è un interlocutore vivo e con ansie reali,
e l’amicizia dei due è qualcosa di storicamente accertato.
Seneca, pur aderendo allo stoicismo,
sa anche prenderne le distanze e adattare le posizioni filosofiche alla sua esperienza e visione della vita:
il messaggio viene interiorizzato e adattato al particolare contesto,
acquistando uno spessore di sincerità e di corrispondenza con un reale vissuto.
Scaricato da Marianna Tallarico (mariaanna.tallarico@hotmail.it)
lOMoARcPSD|5715493
LEZIONE 40
Commenta e illustra, individuando figure retoriche e particolarità linguistiche e stilistiche,
il seguente passo delle confessioni di Agostino: Sed tamen sine me loqui apud misericordiam tuam,
terram, et cinerem, sine tamen loqui, quoniam ecce misericordia tua est, non homo, inrisor meus, cui
loquor. et tu fortasse inrides me, sed conuersus misereberris mei, quid enim est quod uolo deicere,
domine, nisi quia nescio, unde uenerim huc, in istam dico uitam mortalem an mortem uitalem?
Questo è un passo del libro I delle Confessioni di Agostino,
in particolare la parte dedicata a Nascita e Infanzia in cui parla del mistero dell’origine dell’uomo.
Agostino si rivolge a Dio e alla sua misericordia confessando di non sapere nulla sulla propria origine,
ma anche di sapere che è stato amato da Dio sin dal principio tramite l’amore dei suoi genitori
poiché dietro ad ogni bene e attenzione per quel bambino sa che vi era la mano di Dio.
Egli usa anche un riferimento alla Genesi quando confessa di essere “terra e cenere”.
Linguisticamente si nota lo stile fitto di ripetizioni, la sinteticità del discorso,
ma anche la retorica finale in “vita mortale/morte vitale”.
Magnus es Domine, et laudabilis valde: commenta e illustra
Si tratta della prima frase di apertura delle Confessioni in cui Agostino si rivolge a Dio dicendo:
“Tu sei grande, Signore, e ben degno di lode”.
Continua dicendo che l’uomo mortale e che si porta dietro un peccato, piccola particella del Creato,
vuole lodare Dio ma non sa come invocarlo.
Questa è una sorta di preghiera sotto forma di confessio
in cui l’autore si pone in secondo piano rispetto al destinatario: Dio.
Questo brano è fortemente influenzata dai passi della Scrittura, soprattutto dai Salmi.
E' corretto affermare che nelle Confessioni
gli ultimi libri rappresentano un corpo distinto e mal connesso al resto dell'opera?
L’opera è composta da 13 libri o capitoli:
i primi 9 raccontano la vita di Agostino fino alla conversione e al battesimo
e il 10 racconta il presente di Agostino già vescovo di Ippona,
quindi possono dirsi tutti autobiografici,
mentre gli ultimi 3 libri sono testi di esegesi che interpretano parti della Genesi
(l’11 la creazione del mondo, il 12 gli angeli, il 13 lo Spirito Santo).
La struttura dell’opera non è squilibrata o casuale,
e la novità sta soprattutto nell’autobiografia all’interno di un’opera di teologia:
Agostino racconta la sua vita precedente ma poi scorge una forza di conversione che è la Grazia divina,
e solo una volta che approda alla conversione definitiva e al battesimo, e addirittura al ruolo di vescovo,
è in grado di cantare le lodi della creazione nell’ultima parte dell’opera,
fino alla definizione della dottrina della verità divina,
e cioè di un Dio che è creatore, redentore e Spirito (ultimo libro)
che ha creato il mondo e che sottrae Agostino dal peccato e lo conduce alla salvezza.
Cosa sai dire sul significato del titolo Confessiones?
Le Confessioni vengono scritte alla fine del IV secolo: intorno al 400 gran parte dell’opera era stata scritta.
Il titolo è Confessiones, termine latino che non ha il significato moderno, che evoca il sacramento cristiano, ma che
indica invece tre cose:
-confessio laudis/ “confessione di lode”,
-confessio peccati/“confessione di peccato”
-confessio fidei/“confessione della fede”
Il titolo dunque unisce la confessione del peccato dell’uomo,
la Grazia di Dio senza la quale in peccato non sarebbe confessabile e la misericordia di Dio che perdona.
Il fine delle Confessioni è la lode di Dio, presente sin dall’inizio del primo libro:
“Tu sei grande Signore e ben degno di lode”.
Scaricato da Marianna Tallarico (mariaanna.tallarico@hotmail.it)
lOMoARcPSD|5715493
Scaricato da Marianna Tallarico (mariaanna.tallarico@hotmail.it)
lOMoARcPSD|5715493
Esame 13 Settembre 2019, domande+risposte
Lingua e letteratura latina (Università degli Studi di Bergamo)
StuDocu non è sponsorizzato o supportato da nessuna università o ateneo.
Scaricato da Marianna Tallarico (mariaanna.tallarico@hotmail.it)
lOMoARcPSD|5715493
LEZIONE 1
Analisi linguistica in prospettiva diacronica e sincronica:
caratteristiche, finalità e differenze.
La prospettiva diacronica riguarda lo sviluppo della lingua nel tempo, il che permette di “tagliare” il
latino in una successione di strati: latino arcaico, latino classico, latino imperiale, latino volgare.
La prospettiva sincronica permette di distinguere latino parlato, latino letterario e latino tecnico.
Sostrato e superstrato:
illustra i termini in riferimento alla lingua latina e alla sua evoluzione
- SOSTRATO: lingua della popolazione autoctona su cui si diffonde la lingua dei dominatori,
(es. il latino che si impone sull’etrusco).
- SUPERSTRATO: su una lingua dominante di sovrappone uno strato linguistico
che non si impone sulla lingua, ma la influenza (es. il germanico sul latino nel Medioevo)
Diffusione del latino.
Dopo la caduta dell’Impero romano la latinizzazione linguistica continuò con la Chiesa.
La latinizzazione dell’Irlanda e di vaste regioni dell’Europa dell’est
avvenne mediante l’evangelizzazione dei monaci che diffondevo il cristianesimo in latino.
La Chiesa inoltre portò avanti un’azione di recupero, trasmissione e salvataggio
non solo della lingua latina, ma anche dei testi letterari che la veicolavano
nonostante il fatto che si trattasse di una tradizione pagana.
Nello stesso tempo, la perdita di unità politica e culturale
portò un’evoluzione linguistica autonoma nelle varie regioni europee
portando il latino a trasformarsi in lingue diverse tuttora parlate,
non solo in Europa ma anche in stati extra-europei.
Cosa sono le lingue indoeuropee?
Il latino discende da una lingua scomparsa, detta Indoeuropeo,
che non conosciamo attraverso testimonianze dirette, ma attraverso la linguistica comparativa.
All’inizio dell’Ottocento però i grammatici si resero conto
che non solo il latino e il greco avevano un’origine comune
ma che una certa affinità collegava anche altre lingue europee e asiatiche,
permettendo di delineare una ‘lingua madre’ cui venne dato il nome di Indoeuropeo.
L’indoeuropeo è dunque un insieme di dialetti parlati da varie tribù,
situate originariamente in una zona continentale dell’Asia,
che poi si diffusero in vaste regioni di India ed Europa,
andando a fondersi con le lingue parlate dalle popolazioni indigene e generando:
sanscrito, iranico, armeno, ittita, slavo, baltico, greco, germanico, italico, latino, celtico.
Perché possiamo definire il latino lingua franca?
Il latino dopo la caduta dell’Impero romano rimane per tutto il Medioevo e fino al 700
la lingua della comunità scientifica e dei dotti.
Poi, dall’800 rimarrà la lingua ufficiale, come lo è anche oggi, dello Stato del Vaticano,
che ancora oggi redige le encicliche in latino.
Il latino poi continuò a essere imparato artificialmente a scuola
anche in aree dove non si era mai parlato (Germania,G. Bretagna,Irlanda,Scandinavia,America).
Scaricato da Marianna Tallarico (mariaanna.tallarico@hotmail.it)
lOMoARcPSD|5715493
LEZIONE 2.
Cosa sai dire della Fibula prenestina?
La Fibula prenestina è una spilla in oro lunga 10,7 cm della metà del VII secolo a.C.,
ritrovata a Preneste (sud di Roma) e che reca un'iscrizione in latino arcaico
considerata il più antico documento scritto in lingua latina.
L'autenticità dell'iscrizione è stata a lungo oggetto di dibattito ma nel 2011 è stata accertata.
L’l'iscrizione, che va da destra a sinistra, corrisponde al latino classico:
« Manius me fecit Numasio ».
Cosa è il vaso di Dueno e perché è importante?
Il vaso di Dueno è un manufatto trovato nel 1880 tra Viminale e Quirinale
formato da tre recipienti conglobati, ma non comunicanti tra loro, e disposti a triangolo,
fatto risalire alla prima metà del VI sec a.C.
Le iscrizioni procedono da destra a sinistra in scriptio continua.
Vi è incisa una scritta che in latino classico corrisponde a “Duenos me fecit”,
e per molto tempo si pensò a Duenos come il nome dell’artigiano che l’aveva fabbricato,
ma in realtà si tratta della forma arcaica di “bonus”, quindi indica la qualità dell’oggetto.
Esso è probabilmente un oggetto che riporta le istruzioni per l’uso del contenuto,
forse una pozione magica per conquistare l’amore di una ragazza.
Le prime testimonianze epigrafiche in lingua latina (lapis niger, iscrizione da Satricum ):
perché sono importanti e quale latino testimoniano.
Il Lapis Niger è cippo in tufo scoperto nel 1899 durante degli scavi nel foro romano
che era sovrastato da una lastra in marmo nero detta “lapis niger”,
in cui si legge un’iscrizione in quattro lati che va dall’alto al basso e viceversa
e che, sebbene di difficile traduzione, pare collegata a un passo dello scrittore Festo
in cui parla di una pietra nera che corrisponderebbe alla toma di Romolo.
Esso è il più antico documento in alfabeto latino trovato nella valle del Tevere.
L’iscrizione da Satricum è un'iscrizione incisa su una pietra che faceva da base a un dono votivo
che reca due righe con una dedica per il dio Marte
composte in una lingua a metà strada tra latino, volsco e sabino.
Essa è stata rinvenuta nell’antica città Satricum nel Lazio negli anni 70
ed è datata tra la fine del VI e gli inizi del V secolo a.C.
Scaricato da Marianna Tallarico (mariaanna.tallarico@hotmail.it)
lOMoARcPSD|5715493
LEZIONE 3
Musae, quae pedibus magnum pulsatis Olympum:
caratteri della lingua di Musae Ennio
Questo è il primo verso degli Annales di Ennio,
poema che si apre con un’invocazione alle muse
in cui compaiono i grecismi “Musae” e “Olympus”
fondersi con la tradizione latina dell’allitterazione
(ripetizione di suono uguale: musae e magnus, pedibus e pulsatis).
Caratteri linguistici del latino arcaico
Il latino arcaico comprende il periodo il periodo tra il III e il I sec a.C,
(anche se la data ufficiale dell’inizio della letteratura latina è il 240 a.C).
Caratteri linguistici:
-Fonetici-> spesso si mantiene il dittongo AI, OI, OU, anche per la pronuncia.
->consonanti finali –m e –s tendono ad essere tralasciate.
-Alfabeto->Introdotto segno grafico sulla C per distinguere suono sordo e sonoro(C/G)
->Rimane l’indifferenziazione di U vocale e V consonante
->Regola dell’accento governata dalla quantità della penultima sillaba:
se è lunga ha l’accento, se è breve l’accento cade sulla terz’ultima sillaba.
-Sintassi-> prevale la paratassi, anche se ci sono esempi di ipotassi con il sistema della consecutio temporum
Importanza di Plauto dal punto di vista linguistico.
La lingua di Plauto è attestata nelle 21 commedie conservate.
La sua lingua è molto creativa e comprende:
-molti grecismi, che compaiono non solo in bocca ai dotti,
il che permette di accertare l’estensione del fenomeno a vari strati linguistici;
-ricorso ai composti che può configurarsi ancora come grecismo
poiché le parole sono latine ma la tecnica di associazione è greca;
-figure di suono che possono dare l’idea della pronuncia del latino;
-ipotassi (subordinazione) eccessiva per portare a un effetto comico;
-ampio ricorso al pronome dimostrativo ille, illa, illud,
poi destinato a diventare l’articolo nelle lingue romanze.
Scaricato da Marianna Tallarico (mariaanna.tallarico@hotmail.it)
lOMoARcPSD|5715493
LEZIONE 4
Modalità di penetrazione e diffusione della lingua latina
Una forma tipica di penetrazione latina, che è culturale e anche linguistica,
è quella attuata attraverso le campagne militari e la politica espansionistica di Roma,
con la creazione di colonie e province,
che si esplica attraverso l’amministrazione militare, giudiziaria e finanziaria.
Anche il sistema viario romano era veicolo potente di scambi commerciali e culturali
e dunque anche linguistici.
La penetrazione del latino ebbe esiti diversi:
-in alcuni casi vi fu l’assimilazione al latino;
-in altri casi alcune lingue prelatine resistettero e si conservarono es.Etrusco.
Il sistema vocalico latino: aspetti quantitativi, i dittonghi, evoluzione generale
In latino, diversamente dall’italiano,
la differenza di quantità della vocale non è solo fonetica ma anche fonologica:
a seconda che una vocale sia lunga o breve cambia il valore sintattico o semantico.
La successione di due vocali forma il dittongo.
In latino i dittonghi sono sempre discendenti:
la prima delle due vocali rappresenta il nucleo del suono vocalico,
la seconda è d’appoggio, in funzione semivocalica.
In epoca arcaica vi era la tendenza alla monottongazione dei dittonghi AE e AU,
che poi si estese anche agli strati più umili della popolazione
e poi via via alla lingua d’uso,
trasformando così l’opposizione tra lingua urbana/lingua rustica
in lingua letteraria/lingua parlata.
Cosa è la teoria linguistica dei generi letterari?
Nel mondo latino l’urbanitas, il modello della lingua di Roma,
ha sempre esercitato la sua forza centripeta, impedendo la creazione di dialetti,
ma è diffusa una differenziazione della lingua letteraria non solo dalla lingua parlata,
ma in base ai generi letterari:
all’epica e alla tragedia spetta uno stile alto, alla poesia e all’elegia uno stile medio,
alla commedia uno stile basso -> teoria linguistica dei generi.
Scaricato da Marianna Tallarico (mariaanna.tallarico@hotmail.it)
lOMoARcPSD|5715493
LEZIONE 6
Influenza e azione della lingua greca sulla lingua latina, nel tempo.
I grecismi si contraddistinguono non tanto per quantità, bensì per la qualità,
ma la teoria linguistica li condanna
poiché la lingua letteraria è improntato al purismo, e dunque all’esclusione.
La lingua letteraria tuttavia non può rinunciarvi, e allora spesso ricorre al calco:
parola latina creata su un modello greco oppure adattata a valori lessicali greci.
Anche nel lessico constatiamo lo stesso atteggiamento,
con la creazione di una serie di parole composte latine che ricalcano modelli greci.
Ad un altro livello, quello della lingua parata,
rimane il valore del grecismo come tratto dell’affettività.
Illustra il concetto di purismo in relazione alla formazione
della lingua letteraria latina
Il purismo linguistico si affermò sempre di più
perché tutti i personaggi importanti sentivano l’obbligo il mostrare la propria cultura,
che non era più relegata in circoli esclusivi come quello degli Scipioni,
poiché l’impero romano ormai, almeno per quanto riguarda le classi colte,
possedeva una lingua uniforme e comune.
Esempi di arcaismo linguistico e loro funzione nella lingua letteraria
Il colorito arcaico non è un fattore positivo, non è (ancora) una componente di una
lingua letteraria nobile e alta: in quest’epoca è ancora limitato alle lingue tecniche,
come il linguaggio giuridico. Nel concreto, forme come optumus, maxumus ecc.,
benché sempre possibili e frequenti, assunsero valore di arcaismi. Ugualmente sono
considerati arcaismi la desinenza del perfetto in –ere, gli astratti in –men, gli infiniti
in –ier. In ambito sintattico, la paratassi, lo scarso ricorso al participio. L’ampia
presenza di figure retoriche di suono, quali l’allitterazione, e la contrapposizione
simmetrica di sintagmi.
Illustra le dottrine grammaticali dell'analogia e dell'anomalia
Le dottrine grammaticali dell’epoca si basano su due scuole ellenistiche
che si dibattono tra loro:
-la dottrina dell’analogia della scuola di Alessandria d'Egitto
che sosteneva che la lingua fosse un prodotto razionale e non naturale
e che il suo uso corretto si fonda su regole grammaticali fisse, senza noelogismi;
-la dottrina dell’anomalia della scuola di Pergamo, in Asia.
che sosteneva che lingua fosse un fatto spontaneo, condizionato dal suo uso vivo
e che dunque si modifica con il passare delle generazioni e delle idee,
quindi era ammessa ampia libertà di espressione personale e neologismi.
Entrambe le dottrine sono illustrate da Varrone che assume una posizione intermedia.
Scaricato da Marianna Tallarico (mariaanna.tallarico@hotmail.it)
lOMoARcPSD|5715493
LEZIONE 7
La lingua di Virgilio
La posizione di Virgilio, che pochi anni dopo la sua morte era già assurto al ruolo di
classico, studiato a scuola. L’allitterazione, cara alla tradizione linguistica latina, è
mantenuta, non la voce onomatopeica, ritenuta eccessivamente rozza. In Virgilio
riscontriamo i fenomeni osservati in cui la lingua greca agisce all’interno della poesia
scardinando lievemente l’equilibrio della prosa classica. Vi è l’elevazione a livello
letterario di un costrutto in cui l’influenza del greco e l’uso popolare si rafforzano
reciprocamente: in pratica la grandezza della manipolazione linguistica consiste nel
fatto di sposare elementi provenienti dall’esterno con pulsioni tutte interne alla lingua
per creare qualcosa di unico.
Quale età è definita aurea nel mondo latino e perchè
L’età aurea è l’età di Augusto (I sec. d. C.)
ed è l’età in cui si impone lo standard del latino classico
con le opere di Virgilio, Orazio, Tibullo, Properzio, Ovidio e Livio
che riscossero un immediato successo
andando a definire un modello non solo formale, ma anche linguistico.
Il successo di tali autori poi continuò nel tempo,
soprattutto tra gli intellettuali cristiani che copiavano i testi negli scriptoria monastici.
La grande attenzione per il purismo e la misura prosegue durante l’età d’Augusto, che
benché meno erudito di Cesare è un grande protettore delle arti
e raccomanda uno stile elegante ottenuto con sobrietà
e senza ricercare forme antiquate, desuete o straniere.
Le scelte linguistiche e lo stile di Livio
La lingua di Livio cambia a seconda del tempo:
nella parte iniziale si rifà a modelli più arcaici, vicini alla tragedia e all’epica arcaica,
più avanti l’autore si adegua allo stile ciceroniano.
Questo conferisce a Livio un gusto per la variatio
ritrovando un connubio tra arcaismo –inteso come lingua d’uso e semplice-
e nello stesso tempo volontà di adesione agli standard della classicità.
Dal punto di vista della lingua,
Orazio e Catullo operano scelte in parte differenti in parte coincidenti: illustrale
L’obiettivo di Orazio è una lingua colta e raffinata,
libera da tracce di origini umili o agresti,
ma che tuttavia corrisponda alla realtà,
infatti si riscontrano anche popolarismi (soprattutto nelle satire e nelle epistole).
La lingua di Catullo rispecchia vari livelli linguistici
che corrispondono all’ampia la gamma di sentimenti presenti nella sua opera.
E’ una lingua ricercatissima che tuttavia non disdegna i popolarismi.
Scaricato da Marianna Tallarico (mariaanna.tallarico@hotmail.it)
lOMoARcPSD|5715493
LEZIONE 8
Ubi solitudinem faciunt pacem appellant: cosa significa questa frase di Tacito?
Traduzione: Laddove fanno il deserto, lo chiamano pace.
E’ una locuzione latina tratta dall'Agricola di Publio Cornelio Tacito.
L'autore la fa pronunciare al generale calèdone Calgaco,
quando cerca di infondere coraggio alle truppe
poiché di fronte ai romani ci sono due alternative: libertà o morte.
Illustra il concetto di anticlassicismo
Nell’età argentea (14-117 d. C) si distruggono i vecchi modelli
legati a una classicità ormai trascorsa, morta, irraggiungibile,
e si cerca di creare una nuova tradizione con nuovi modello
ma il risultato è la creazione di una lingua formale, colta, scritta,
completamente avulsa dalla realtà del parlato.
E’ proprio in quest’epoca che infatti comincia a diventare notevole
la distanza tra il latino parlato e il latino scritto,
sottoposto al purismo dei grammatici e alle imposizioni della retorica
La lingua di Apuleio
In Apuleio troviamo gli esempi più evidenti
della dissoluzione della tradizione linguistica letteraria,
realizzata piegando la lingua ad effetti esteriori
e del tutto avulsi dal naturale sviluppo linguistico del latino.
Nella sua lingua vi sono un’abbondanza di arcaismi e di volgarismi.
Vi è inoltre un uso esagerato di diminutivi, in cui il valore affettivo è ormai perduto,
e verbi composti in cui il prefisso ha solo valore impressionistico e non semantico.
Tutto ciò serve per creare enfasi e esagerazione letteraria.
Rapporto tra poesia e prosa nell'età argentea
Il confine tra le due tradizioni letterarie di prosa e poesia viene ad assottigliarsi,
poiché la lingua poetica attinge dal linguaggio parlato, delle classi umili,
mentre la prosa, secondo le disposizioni delle scuole di retorica e oratoria,
acquisisce un carattere sempre più artefatto e controllato
Scaricato da Marianna Tallarico (mariaanna.tallarico@hotmail.it)
lOMoARcPSD|5715493
LEZIONE 9
Diffusione del latino in tarda età imperiale.
Il latino in tarda età imperiale
si diffonde tramite le legioni militar e le vie del commercio,
soprattutto la via Appia (Roma-Brindisi);
la via Popilia (fino allo stretto di Messina per arrivare in Africa);
la Via Aurelia (conduceva in Spagna attraverso la Gallia);
la Via Postumia (attraverso le Alpi per arrivare nelle zone danubiane).
In particolare:
-in Spagna la latinizzazione fu radicata e profonda
vista la lontananza dall’Italia e dunque al lungo soggiorno delle legioni
e solo nella regione a nord, chiusa tra i Pirenei, sopravvive la lingua dei Baschi.
-In Gallia la romanizzazione avviene solo nella seconda metà del I sec. a. C.,
tramite la fondazione di colonie di veterani,
ma benché il latino sia diffuso dal commercio, dall’amministrazione e dalle scuole la
lingua gallica sopravvive in luoghi appartati e in ristrette classi sociali.
Nel mondo greco entrano le parole latine ma non la lingua.
Fenomeni linguistici della tarda età imperiale
nel lessico, nella sintassi, nella fonetica e nel ritmo
Lessico.
Nel III sec. d.C. la lingua d’uso ha caratteri unitari e costanti,
diffusi fino agli estremi limiti dell’Impero dagli scambi commerciali,
dall’apparato amministrativo e dalla trasmissione di una cultura uniforme.
Sintassi.
Ampio uso dell’aggettivo ille che segna la nascita dell’articolo;
rafforzamento di pronomi/agg. dimostrativi facendoli precedere dall’avverbio eccum;
decadono via via i casi.
Fonetica.
Un gran numero di fenomeni fonetici
sono collegati al mutamento della natura dell’accento
es. sincope di vocale interna atone o l’allungamento di vocali toniche
Ritmo.
Si scontrano l’accusa di una pronuncia ‘pesante’ e rozza dell’accento tonico e
l’accusa nei confronti di un latino ‘cantato’, come una cantilena,
che si riferisce all’accento quantitativo proprio delle espressioni elevate e letterarie.
Scaricato da Marianna Tallarico (mariaanna.tallarico@hotmail.it)
lOMoARcPSD|5715493
LEZIONE 10
Le istanze alla base della formazione di un latino dei Cristiani sono...
Per la lingua l’età cristiana comincia molto prima
del riconoscimento del Cristianesimo come religione di stato.
La prima penetrazione cristiana non ha caratteri né di latinità né di romanità,
anzi, dal punto di vista linguistico appare del tutto estranea,
e si configura come un insieme di termini stranieri di origine greca ed orientale
che si propongono come corrispondenti di una lingua ebraica
in funzione di termini tecnici della liturgia.
Illustra il latino dei Cristiani alla luce dello stile
di Tertulliano, Agostino, la Peregrinatio Aetheriae
Tertulliano ci offre un esempio antico di latino cristiano,
senza che vi si ritrovino non vi fenomeni molto innovativi:
-l’ipotassi di stampo classico si alleggerisce;
-il verbo habere in funzione di ausiliare è ormai comune;
-nel lessico troviamo le novità di maggior rilievo,
non solo per l’uso diffuso di aggettivi sostantivati,
ma anche per l’innovativa creazione di un gran numero di parole nuove.
Agostino va fatta una distinzione tra gli scritti ante e post conversione. Riconosciamo nella sua
lingua alcune novità.
-La costruzione accusativo + infinito
già da decenni era insidiata dalla subordinata esplicita introdotta da quod.
Questo ci permette di capire che il costrutto dell’infinitiva
non era tanto un classicismo pagano,
quanto un artificio retorico inammissibile in contesto di lingua diretta, affettiva.
-La posizione tradizionale del verbo in latino è alla fine,
mentre lo stile della Bibbia sposta il verbo in posizione iniziale.
Agostino osserva la tradizione nelle opere dogmatiche e dottrinali,
mentre nelle Confessioni o nelle lettere accetta il nuovo tratto di modernità
-Nelle Confessioni prevale la paratassi, nel de Civitate Dei l’ipotassi.
La Peregrinatio Aetheriae è il racconto di un viaggio in Terrasanta
condotto alla fine del sec. V da una dama gallica, Eteria,
che nonostante gli sforzi letterari, ci attesta gli usi di una lingua vicina al parlato.
- La voluta letterarietà è rivelata da fenomeni di ipercorrettismo
- Interessante l’evoluzione del termine che indica l’ultima parte del giorno: la sera.
L’esigenza di una parola nuova che indichi questa parte del giorno
nasce dal fatto che il termine classico, vesper,
è stato sottratto all’uso quotidiano dal suo passaggio alla liturgia
e dunque dal suo assorbimento dalla lingua ecclesiastica.
- Alcune comuni parole greche entrano nel vocabolario latino
Scaricato da Marianna Tallarico (mariaanna.tallarico@hotmail.it)
lOMoARcPSD|5715493
Come agisce il Cristianesimo dal punto di vista linguistico?
Porta alcuni esempi e commentali
Il latino dei Cristiani agisce sulla lingua latina a diversi livelli.
Da una parte vi è un nucleo di tecnicismi,
connessi alle parole della dottrina e del rito,
e di fronte a questi si poteva:
-individuare una parola latina corrispondente (deus)
-fare un calco di una parola latina in corrispondenza del termine greco o ebraico (salvator)
-adottare la parola greca (ecclesia)
-adottare la parola ebraica (Pasqua, Osanna e i nomi propri).
Sempre a tal proposito la forma di propaganda dottrinale colta
userà un linguaggio dotato di molta raffinatezza stilistica
da cui nascerà la lingua letteraria cristiana, il cui primo testimone è Tertulliano.
Dall’altra va ricordato che il Cristianesimo non è dottrina destinata ai dotti,
ma si rivolge alle masse, attraverso una predicazione diffusa,
quindi accanto ai tecnicismi si configura un linguaggio comune e piano
basato sui principi del cristianesimo: affettività, partecipazione..
Il latino dei Cristiani: lingua, diffusione, stile
La lingua dei Cristiani si diffonde soprattutto attraverso la predicazione,
con un lessico non tecnico e condizionato dai temi cristiani(affettività,partecipazione).
La predicazione però è rivolta anche ai dotti, nella forma di propaganda dottrinale e colta,
che ricorre ad un linguaggio letterario e non è esente da raffinatezze stilistiche.
Da qui nascerà la lingua letteraria cristiana, il cui primo testimone è Tertulliano.
Dal punto di vista storico due tappe fondamentali per la diffusione nel sec. IV d.C:
-nel 313 con l’editto di Milano l’imperatore Costantino riconosce il Cristianesimo come religione
degna di essere praticata al pari delle altre del mondo antico.
-nel 380 d.C l’imperatore Teodosio con l’editto di Tessalonica
eleva il Cristianesimo a religione ufficiale dell’Impero.
Le novità lessicali sono molteplici
e destinate ad entrare non solo nel tessuto linguistico latino, ma anche romanzo.
Le esigenze sono:
- lingua tecnica in grado di esprimere i concetti dottrinali della nuova religione;
- lingua che sappia trascinare le masse,
e che riesca a veicolare il messaggio di una religione che è individuale e personale, che parla di un
dio vicino, che piange, che soffre: una lingua affettiva ed emotiva;
-messaggio è destinato a tutti gli strati sociali, non solo quelli più umili e modesti,
quindi dev’essere una lingua in grado di reggere il confronto
con le produzioni filosofiche e letterarie del paganesimo,
un linguaggio che non susciti derisione e disprezzo da parte delle classi colte,
e dunque, una lingua letteraria.
Scaricato da Marianna Tallarico (mariaanna.tallarico@hotmail.it)
Potrebbero piacerti anche
- Riassunto Nuovi Lineamenti Di Grammatica Storica Dellitaliano Patota PDFDocumento28 pagineRiassunto Nuovi Lineamenti Di Grammatica Storica Dellitaliano Patota PDFFederica GalloriniNessuna valutazione finora
- N. Machiavelli - Il Principe - Riscrittura di Sebastiano CutrupiDa EverandN. Machiavelli - Il Principe - Riscrittura di Sebastiano CutrupiNessuna valutazione finora
- Lezioni Sul Testo Nuovi Lineamenti Di Grammatica Storica PatotaDocumento15 pagineLezioni Sul Testo Nuovi Lineamenti Di Grammatica Storica PatotaMarco SuraceNessuna valutazione finora
- Il Latino nella secondaria di primo grado: Atti del Seminario per Docenti della Scuola secondaria Liceo Scientifico “Enrico Fermi” di PadovaDa EverandIl Latino nella secondaria di primo grado: Atti del Seminario per Docenti della Scuola secondaria Liceo Scientifico “Enrico Fermi” di PadovaNessuna valutazione finora
- Breve Storia Della Linguistica Di Giorgio Graffi PDFDocumento9 pagineBreve Storia Della Linguistica Di Giorgio Graffi PDFPatrick Gallinotti0% (1)
- Stalingrado. Il polittico di Vasilij Grossman.: Memorie plurali e memoria di StatoDa EverandStalingrado. Il polittico di Vasilij Grossman.: Memorie plurali e memoria di StatoNessuna valutazione finora
- Esercitazione Enea Lezione 24Documento2 pagineEsercitazione Enea Lezione 24Cristian Crisafulli100% (1)
- Appunti Lingua e Letteratura LatinaDocumento11 pagineAppunti Lingua e Letteratura LatinaElisaNessuna valutazione finora
- Lisabetta Da Messina Per MedieDocumento13 pagineLisabetta Da Messina Per MediesaroNessuna valutazione finora
- Linguistica Romanza (1) - 2Documento30 pagineLinguistica Romanza (1) - 2Marianna BenincasaNessuna valutazione finora
- Cronologia VergaDocumento31 pagineCronologia VergaKarl Heinz StottenbakerNessuna valutazione finora
- LetteraturaDocumento93 pagineLetteraturaP CNessuna valutazione finora
- Paniere D'esame Storia ContemporaneaDocumento28 paginePaniere D'esame Storia ContemporaneaAlessandro Farina100% (1)
- Il Giappone Di Marinetti-LibreDocumento48 pagineIl Giappone Di Marinetti-LibreancutaNessuna valutazione finora
- Questione Della LinguaDocumento5 pagineQuestione Della LinguagvnmfkrfNessuna valutazione finora
- SOCIOLINGUISTICADocumento6 pagineSOCIOLINGUISTICAGeorge PoulopoulosNessuna valutazione finora
- Ledizione Critica Del Testo Letterario PDFDocumento9 pagineLedizione Critica Del Testo Letterario PDFRaGnanaNessuna valutazione finora
- Analisi Linguistica Dei TestiDocumento30 pagineAnalisi Linguistica Dei TestiLuciaCapillaroNessuna valutazione finora
- SonettoDocumento5 pagineSonettohyjjyNessuna valutazione finora
- Capitolo 9 MengaldoDocumento12 pagineCapitolo 9 MengaldoAlessandro Astorino100% (1)
- IliadeDocumento27 pagineIliadeFrancesco SeneseNessuna valutazione finora
- Fadda, Tradizioni Manoscritte e Critica Del Testo Nel Medioevo (Riassunto)Documento75 pagineFadda, Tradizioni Manoscritte e Critica Del Testo Nel Medioevo (Riassunto)Hannah Laxis-TamNessuna valutazione finora
- Di Girolamo L'EpicaDocumento8 pagineDi Girolamo L'EpicaUnigeStudentNessuna valutazione finora
- Il Gotico in ItaliaDocumento19 pagineIl Gotico in ItaliaAlessandra Di MariniNessuna valutazione finora
- BRESSLAU, Manuale Di Diplomatica OcrDocumento754 pagineBRESSLAU, Manuale Di Diplomatica OcrAlexander100% (1)
- Il NovecentoDocumento23 pagineIl NovecentoAndroixNessuna valutazione finora
- Zamborlin C. - Didattica Dell'Italiano in Giappone. Un'Avventura Contrastativa Sul Piano Linguistico e PedagogicoDocumento17 pagineZamborlin C. - Didattica Dell'Italiano in Giappone. Un'Avventura Contrastativa Sul Piano Linguistico e PedagogicoChiaretaFranklinNessuna valutazione finora
- Gabriella Alfieri - Verga - RiassuntoDocumento60 pagineGabriella Alfieri - Verga - RiassuntoGiusy StagnittiNessuna valutazione finora
- Storia - Laboratorio GiulianoDocumento30 pagineStoria - Laboratorio GiulianoCaruso GiovanniNessuna valutazione finora
- Linguistica RomanzaDocumento13 pagineLinguistica RomanzamiladuranNessuna valutazione finora
- Il Decameron Di Boccaccio: Struttura Dell'opera, Contesto Storico e LetterarioDocumento13 pagineIl Decameron Di Boccaccio: Struttura Dell'opera, Contesto Storico e LetterarioRaffaele MorelliNessuna valutazione finora
- Insegnare La Letteratura in Lingua StranDocumento49 pagineInsegnare La Letteratura in Lingua StranFabio MagarottoNessuna valutazione finora
- Luraghi SchemiDocumento15 pagineLuraghi SchemiCassandra MorisettiNessuna valutazione finora
- 01 Fresu LinguisticaItaliana A.a.-2015-2016Documento17 pagine01 Fresu LinguisticaItaliana A.a.-2015-2016Frederic Francois ChopinNessuna valutazione finora
- Domande Aperte Della CorteDocumento19 pagineDomande Aperte Della CorteFrancesca clemeno100% (1)
- Novecento, Lingua Del - Sabatini - 967-971 PDFDocumento5 pagineNovecento, Lingua Del - Sabatini - 967-971 PDFGian Vittorio CermelliNessuna valutazione finora
- Storia Medievale RiassuntoDocumento15 pagineStoria Medievale RiassuntoCarolina Laconi Luca CammareriNessuna valutazione finora
- Morfologia2 RFPDocumento14 pagineMorfologia2 RFPGiuseppe PruitiNessuna valutazione finora
- Poesia CRDocumento5 paginePoesia CRmilošNessuna valutazione finora
- Dieci Modi Di Sognare Il Medioevo - Umberto EcoDocumento6 pagineDieci Modi Di Sognare Il Medioevo - Umberto EcolkkkhjNessuna valutazione finora
- Ari Chieti - Storia Del ComuneDocumento12 pagineAri Chieti - Storia Del ComuneSilvia De AlejandroNessuna valutazione finora
- Castelli e Fortezze PDFDocumento364 pagineCastelli e Fortezze PDFVirginio MantessoNessuna valutazione finora
- Concorso Docenti 2016 AD04 (A012-A022) Candidata Alessandra CozziDocumento33 pagineConcorso Docenti 2016 AD04 (A012-A022) Candidata Alessandra CozzisaroNessuna valutazione finora
- PetrarcaDocumento54 paginePetrarcaJelena Djurdjevic100% (1)
- Nuovi Fondamenti Di Linguistica RiassuntoDocumento56 pagineNuovi Fondamenti Di Linguistica RiassuntoFederica Di Chio100% (1)
- Dal Latino Al VolgareDocumento7 pagineDal Latino Al VolgareCaro Repetto RamírezNessuna valutazione finora
- TESI - La Lingua Italiana Come L2 Nella Scuola Del Primo CicloDocumento56 pagineTESI - La Lingua Italiana Come L2 Nella Scuola Del Primo CicloAndreea CiubotariuNessuna valutazione finora
- La Forbice e Il VentaglioDocumento203 pagineLa Forbice e Il VentaglioDanilo BormaniNessuna valutazione finora
- IL DUECENTO Quadro Di SintesiDocumento4 pagineIL DUECENTO Quadro Di SintesiAndrea CarrieroNessuna valutazione finora
- Il PreromanticismoDocumento19 pagineIl PreromanticismosaroNessuna valutazione finora
- Muljacic Genesi Lingue Dalmato RomanzeDocumento9 pagineMuljacic Genesi Lingue Dalmato RomanzeBosko DenonaNessuna valutazione finora
- Letteratura PersianaDocumento8 pagineLetteratura PersianaCarolina MarescottiNessuna valutazione finora
- L'Arte RomanaDocumento12 pagineL'Arte RomanaFrancesco MunafóNessuna valutazione finora
- Il NovecentoDocumento19 pagineIl NovecentoMichela AnnoniNessuna valutazione finora
- Vol. Linguistica 32 PDFDocumento250 pagineVol. Linguistica 32 PDFGian Vittorio CermelliNessuna valutazione finora
- Breve Manuale Di Geografia Umana, Minca C., Colombino A.Documento47 pagineBreve Manuale Di Geografia Umana, Minca C., Colombino A.Denis ScottNessuna valutazione finora
- Paniere Storia Contemporanea EcampusDocumento30 paginePaniere Storia Contemporanea EcampusdheannainsugradhNessuna valutazione finora
- Sintesi SociolinguisticaDocumento46 pagineSintesi SociolinguisticaGiulio Chinaski LevoratoNessuna valutazione finora
- Formazione Delle ParoleDocumento18 pagineFormazione Delle ParoleMartina VilharNessuna valutazione finora
- Paniere Linguistica DefinitivoDocumento133 paginePaniere Linguistica Definitivoenrica100% (2)
- Domande Chiuse Lingua e Letteratura LatinoDocumento57 pagineDomande Chiuse Lingua e Letteratura LatinoValentina Mancuso100% (2)
- Paniere Svolto Let Latina 2Documento50 paginePaniere Svolto Let Latina 2Valentina MancusoNessuna valutazione finora
- Paniere Domande AperteDocumento93 paginePaniere Domande AperteValentina Mancuso100% (1)
- Paniere Domande AperteDocumento93 paginePaniere Domande AperteValentina Mancuso100% (1)
- Pasolini e L Esperienza FriulanaDocumento227 paginePasolini e L Esperienza FriulanaDiego BentivegnaNessuna valutazione finora
- Maurizio Vitale - L'officina Linguistica Del Tasso EpicoDocumento75 pagineMaurizio Vitale - L'officina Linguistica Del Tasso EpicoAdriano MeisNessuna valutazione finora
- Ricercar, Trasumanar / Poesia Indigena e Traduzione: I Ricercari Nowau Di Giancarlo ScodittiDocumento4 pagineRicercar, Trasumanar / Poesia Indigena e Traduzione: I Ricercari Nowau Di Giancarlo ScodittiValerio FusiNessuna valutazione finora
- I NovissimiDocumento26 pagineI NovissimiOblique StudioNessuna valutazione finora
- Movesi Il Vecchierel Canuto e Bianc1Documento2 pagineMovesi Il Vecchierel Canuto e Bianc1Elisabetta PalmeriNessuna valutazione finora
- La RomanzaDocumento5 pagineLa RomanzaLizzieNessuna valutazione finora
- Cromatismi Nella Lirica TrobadoricaDocumento26 pagineCromatismi Nella Lirica TrobadoricaMarco Di CaprioNessuna valutazione finora
- Metrica1 2 3 NBDocumento70 pagineMetrica1 2 3 NBAlberto BorinoNessuna valutazione finora
- Buffalo WordDocumento2 pagineBuffalo WordaliceNessuna valutazione finora
- The Inferno of Dante: A New Verse Translation, Bilingual EditionDa EverandThe Inferno of Dante: A New Verse Translation, Bilingual EditionValutazione: 4 su 5 stelle4/5 (65)
- Tutte le poesie (La via del rifugio, I colloqui, Le farfalle, Poesie sparse)Da EverandTutte le poesie (La via del rifugio, I colloqui, Le farfalle, Poesie sparse)Nessuna valutazione finora
- L’arte di persuadere - Il ragionamento argomentativo: strutture e strategieDa EverandL’arte di persuadere - Il ragionamento argomentativo: strutture e strategieNessuna valutazione finora
- Scuola 2020: Manuale per il concorso a cattedre: Secondaria di II grado. Latino A-11Da EverandScuola 2020: Manuale per il concorso a cattedre: Secondaria di II grado. Latino A-11Nessuna valutazione finora