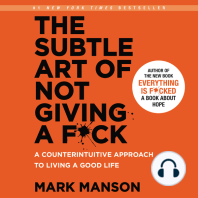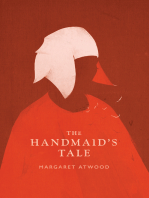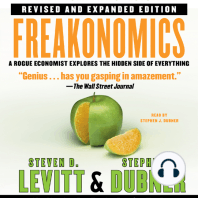Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
Filologia Cenni Storici
Caricato da
Euridice0 valutazioniIl 0% ha trovato utile questo documento (0 voti)
9 visualizzazioni1 paginafilologia cenni storici
Titolo originale
filologia cenni storici
Copyright
© © All Rights Reserved
Formati disponibili
DOCX, PDF, TXT o leggi online da Scribd
Condividi questo documento
Condividi o incorpora il documento
Hai trovato utile questo documento?
Questo contenuto è inappropriato?
Segnala questo documentofilologia cenni storici
Copyright:
© All Rights Reserved
Formati disponibili
Scarica in formato DOCX, PDF, TXT o leggi online su Scribd
0 valutazioniIl 0% ha trovato utile questo documento (0 voti)
9 visualizzazioni1 paginaFilologia Cenni Storici
Caricato da
Euridicefilologia cenni storici
Copyright:
© All Rights Reserved
Formati disponibili
Scarica in formato DOCX, PDF, TXT o leggi online su Scribd
Sei sulla pagina 1di 1
Cenni storici
Dopo le prime ricerche filologiche compiute
nell’ambiente peripatetico, culla della f. può essere
considerata, nel 3° sec. a.C., Alessandria d’Egitto,
con la sua biblioteca e la sua celebre scuola di
dotti (Zenodoto, Callimaco, Apollonio Rodio,
Eratostene, Aristofane di Bisanzio, Aristarco di
Samotracia) volti alla ricostruzione e al commento
dei testi letterari più antichi. Accanto alla scuola
di Alessandria fiorì quella di Pergamo di impronta
stoica (Cratete di Mallo). Sotto influsso
ellenistico, e specialmente di Cratete di Mallo che
fu a Roma nel 168 a.C., nasce anche la f. latina, i
cui più importanti rappresentanti furono M. Terenzio
Varrone, Nigidio Figulo, Verrio Flacco, Aulo Gellio
e, nei secoli della decadenza della filologia greca,
Censorino, Nonio Marcello, Macrobio, Marziano
Capella, Prisciano ecc. La raccolta e lo studio
continuano (6°-14° sec. d.C.) nel mondo bizantino; ma
già nel 6° sec. Cassiodoro aveva fondato in Calabria
una grande scuola intesa a salvare e a restaurare le
opere dell’antichità; e nei secoli seguenti, i
conventi irlandesi, anglosassoni, carolingi, italiani
sono i depositari di questa tradizione. I conventi
sono appunto il grande campo di esplorazione della
riscoperta umanistica; e le università la sede della
parallela restaurazione e interpretazione dei testi.
Potrebbero piacerti anche
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeDa EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeValutazione: 4 su 5 stelle4/5 (5795)
- The 7 Habits of Highly Effective PeopleDa EverandThe 7 Habits of Highly Effective PeopleValutazione: 4 su 5 stelle4/5 (353)
- The Iliad: The Fitzgerald TranslationDa EverandThe Iliad: The Fitzgerald TranslationValutazione: 4 su 5 stelle4/5 (5646)
- The Odyssey: (The Stephen Mitchell Translation)Da EverandThe Odyssey: (The Stephen Mitchell Translation)Valutazione: 4 su 5 stelle4/5 (7770)
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeDa EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeValutazione: 4.5 su 5 stelle4.5/5 (20025)
- Pride and Prejudice: Bestsellers and famous BooksDa EverandPride and Prejudice: Bestsellers and famous BooksValutazione: 4.5 su 5 stelle4.5/5 (19653)
- Wuthering Heights Complete Text with ExtrasDa EverandWuthering Heights Complete Text with ExtrasValutazione: 4 su 5 stelle4/5 (9929)
- Art of War: The Definitive Interpretation of Sun Tzu's Classic Book of StrategyDa EverandArt of War: The Definitive Interpretation of Sun Tzu's Classic Book of StrategyValutazione: 4 su 5 stelle4/5 (3321)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItDa EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItValutazione: 4.5 su 5 stelle4.5/5 (3278)
- The Picture of Dorian Gray (The Original 1890 Uncensored Edition + The Expanded and Revised 1891 Edition)Da EverandThe Picture of Dorian Gray (The Original 1890 Uncensored Edition + The Expanded and Revised 1891 Edition)Valutazione: 4 su 5 stelle4/5 (9054)
- Habit 1 Be Proactive: The Habit of ChoiceDa EverandHabit 1 Be Proactive: The Habit of ChoiceValutazione: 4 su 5 stelle4/5 (2556)
- The 7 Habits of Highly Effective People: The Infographics EditionDa EverandThe 7 Habits of Highly Effective People: The Infographics EditionValutazione: 4 su 5 stelle4/5 (2475)
- The Picture of Dorian Gray: Classic Tales EditionDa EverandThe Picture of Dorian Gray: Classic Tales EditionValutazione: 4 su 5 stelle4/5 (9756)
- American Gods: The Tenth Anniversary EditionDa EverandAmerican Gods: The Tenth Anniversary EditionValutazione: 4 su 5 stelle4/5 (12947)
- Habit 3 Put First Things First: The Habit of Integrity and ExecutionDa EverandHabit 3 Put First Things First: The Habit of Integrity and ExecutionValutazione: 4 su 5 stelle4/5 (2507)
- Wuthering Heights (Seasons Edition -- Winter)Da EverandWuthering Heights (Seasons Edition -- Winter)Valutazione: 4 su 5 stelle4/5 (9486)
- How To Win Friends And Influence PeopleDa EverandHow To Win Friends And Influence PeopleValutazione: 4.5 su 5 stelle4.5/5 (6521)
- The 7 Habits of Highly Effective PeopleDa EverandThe 7 Habits of Highly Effective PeopleValutazione: 4 su 5 stelle4/5 (2567)
- The Iliad: A New Translation by Caroline AlexanderDa EverandThe Iliad: A New Translation by Caroline AlexanderValutazione: 4 su 5 stelle4/5 (5718)
- Habit 6 Synergize: The Habit of Creative CooperationDa EverandHabit 6 Synergize: The Habit of Creative CooperationValutazione: 4 su 5 stelle4/5 (2499)