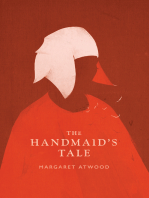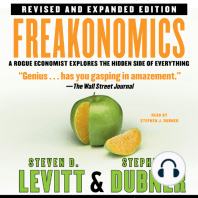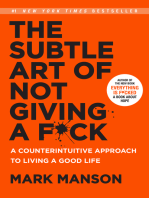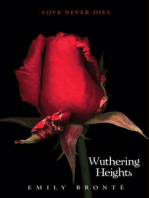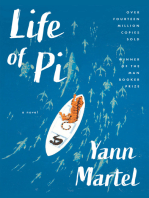Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
Santuari Villaggi Centri Fortificati e P
Caricato da
quoechTitolo originale
Copyright
Formati disponibili
Condividi questo documento
Condividi o incorpora il documento
Hai trovato utile questo documento?
Questo contenuto è inappropriato?
Segnala questo documentoCopyright:
Formati disponibili
Santuari Villaggi Centri Fortificati e P
Caricato da
quoechCopyright:
Formati disponibili
Introduzione filone critico che ha spinto a dubitare anche di altri
aspetti convenzionalmente attribuiti alle colonie,
L’interazione tra il mondo sannitico e l’espansioni- specialmente per quanto riguarda il periodo medio-
smo romano ha da sempre sollecitato grande inte- repubblicano. In particolare sono da menzionare
resse tra studiosi e pubblico generale. L’immagine il modello di insediamento coloniale ed il modello
fornitaci da Livio nella sua narrazione delle Guerre socio-economico e socio-politico ad esso correla-
Sannitiche, in particolar modo, ha contribuito forte- to. Nonostante una lunga serie di importanti criti-
mente alla formazione di un contrasto percepito tra che mosse ai modelli convenzionali, è solo da poco
il mondo sannitico, tribale e guerriero, da un lato, e tempo che gli studiosi si trovano nella posizione di
SANTUARI, VILLAGGI,
tra il mondo romano, civile ed urbanizzato, dall’al- poter accettare questa sfida interpretativa, ripren-
tro. Le moderne ricerche, archeologiche e storio- dendo in mano i dati archeologici per confermare o
grafiche, da tempo, hanno corretto e sfumato questa smentire vecchie e nuove ipotesi.
immagine dicotomica. Soprattutto dagli anni ‘60 in Per rispondere a queste tematiche essenziali, il
poi, si è preso coscienza di come il mondo sannitico ricco paesaggio archeologico del Molise risulta un
CENTRI FORTIFICATI E
fosse ben più strutturato e complesso di quanto non perfetto caso di studio. Qui, infatti, si può indaga-
si pensasse precedentemente. Rimane però ancora re come, nella pratica, le comunità sannitiche e le
molto da capire circa le modalità di organizzazione nuove comunità coloniali romane si organizzarono
delle comunità sannitiche, in senso socio-politico, e svilupparono su un difficile territorio montano e
economico, demografico e culturale. Ad esempio, collinare. Le interazioni tra “Sanniti montani” e
PRIMA URBANIZZAZIONE
è ormai divenuto chiaro come centri fortificati e “Romani coloni” ed i processi di centralizzazione
santuari rivestissero un ruolo di grande rilevanza e urbanizzazione, sia in contesto sannitico sia in
nell’organizzazione insediativa e socio-politica del contesto coloniale romano, possono essere studiati
Sannio antico. Il funzionamento di tali modelli di materialmente in Molise.
TRA SANNITI E ROMANI:
insediamento e di organizzazione sociale sul ter- Lo studio di tali processi storici, in sintesi, è lo scopo
ritorio, così come le modalità secondo le quali tali di una combinazione di diversi progetti archeologici
modelli si confrontavano ed integravano – cioè la e geomorfologici che dal 2004 il nostro gruppo in-
relazione tra comunità, santuari, villaggi e centri ternazionale di ricerca porta avanti in diverse aree
fortificati – restano argomenti ancora molto poco del Molise. Tale equipe di ricerca, composta da stu-
esplorati seppur aspetti di grande importanza per diosi di più di 15 diverse nazionalità (olandesi, italia-
Nuove ricerche archeologiche nell’Alta Valle del Tappino, comprendere i caratteri del mondo osco.
Allo stesso tempo, nel dibattito recente, anche il ca-
rattere dell’espansionismo romano di epoca repub-
ni - tra cui molisani - spagnoli, americani, francesi,
tedeschi ed altri ancora) associati al Centro Didat-
tico Internazionale di Studi Archeologici di Jelsi, è
nel territorio della colonia latina di Aesernia e in quello blicana è stato ampiamente messo in discussione.
Sulla base della lettura delle fonti antiche e dell’e-
patrocinato da una durevole e fruttuosa collabora-
zione tra l’Università di Leiden, il Reale Istituto Ne-
della città frentana di Larinum laborazione di pregiudizi propri del colonialismo
moderno, l’espansione romana è stata tradizional-
erlandese a Roma e la Soprintendenza Archeologia
del Molise. Le nostre ricerche vengono supportate
mente interpretata nei termini di una vittoria del- e finanziate da diverse borse universitarie, dall’Isti-
DI TESSE D. STEK*, JEREMIA PELGROM**, ANITA CASAROTTO*, JESÚS GARCIA SANCHEZ*, la cultura sulla barbarie. In questo immaginario, è tuto Nazionale Olandese per la Ricerca (NWO), da
LISA GÖTZ*, ARTHUR HAMEL*, KETTY IANNANTUONO*, ROGIER A.A. KALKERS*, MARLEEN K. stato fortemente ribadito come Roma, attraverso fondi Europei (FP7) e dall’aiuto pratico e logistico
TERMEER*, JITTE WAAGEN* la colonizzazione, avesse introdotto nelle aree tri- fornito da vari Comuni del Molise, tra i quali Jelsi,
bali un nuovo modello insediativo, quello urbano. Castelpetroso, S. Giovanni in Galdo, Campodipietra
* FACOLTÀ DI ARCHEOLOGIA, UNIVERSITÀ DI LEIDEN La conquista romana del territorio italico, inoltre, e Gildone.
** REALE ISTITUTO NEERLANDESE A ROMA avrebbe portato con sé l’introduzione di innova- In questo breve articolo tenteremo di offrire una
zioni nell’assetto socio-politico e nei modelli eco- prospettiva generale su questi progetti nel loro in-
nomici, in primis, l’introduzione dell’agricoltura sieme. Le diverse aree di ricerca, dall‘Alta Valle del
organizzata in singoli allottamenti di terreno asse- Tappino al territorio della colonia di Aesernia, a
gnati equamente a coloni-soldati. Tuttavia, studi quello della città italica di Larinum, hanno cono-
recenti condotti in vari ambiti disciplinari hanno sciuto percorsi diversi rispetto alle ricerche storiche
messo in dubbio, anche in questo campo, una serie ed archeologiche che sono state condotte in queste
di assiomi fondamentali. A cominciare dalla critica aree (Fig. 1). Le zone oggetto di studio sono localiz-
dell’idea delle colonie latine e romane quali piccole zate in paesaggi anche molto differenziati e pecu-
copie della città di Roma, si è andato sviluppando un liari. Ciò ha permesso di adottare metodi di ricerca
24 Santuari, villaggi, centri fortificati e prima urbanizzazione tra Sanniti e Romani 25
pire vari importanti sviluppi storici in- ed erudito jelsese Vincenzo D’Amico Nell'altra pagina:
tervenuti nel Sannio in epoca classica- aveva documentato l’esistenza di un Fig. 1. Aree di ricerca in
Molise. In rosso le aree
ellenistica e romana. santuario già negli anni ’30. indagate dal gruppo
Per contribuire a risolvere queste do- Attraverso ricerche di ricognizione internazionale associato
all’Università di Leiden
mande di ricerca, dal 2004 abbiamo archeologica tese a mappare tutti gli ed il Centro di Jelsi
iniziato a mappare in dettaglio tutti i affioramenti di materiale archeologi- (elaborazione grafica: R.
A.A. Kalkers).
siti archeologici presenti nel territo- co in superficie, si è potuto ricostru-
rio, anche quelli piccoli ed effimeri, ri- ire l’antico modello di insediamento In basso:
conoscibili attraverso alcune concen- in epoca pre-romana e romana nelle Fig. 2. Area di frammenti
fittili individuata durante
trazioni di reperti in superficie (Fig. 2), aree intorno ai due noti santuari. Di il field survey (foto: J.
oppure visibili tramite fotografie aree. primaria importanza per le nostre ri- Garcia Sanchez).
L’area prescelta per questo tipo di ri- cerche è la ricognizione archeologica
cerca, denominato inizialmente Sacred condotta a piedi (Fig. 4). Squadre di
Landscape Project, era l’Alta Valle del 5-6 studenti, a circa 10 m di distanza
Tappino, coincidente con i territori co- l’uno dall’altro, raccolgono e documen-
munali di Jelsi, Gildone, Campodipie- tano ogni singolo reperto archeologico
tra, Toro, S. Giovanni in Galdo e Riccia che trovano; tali reperti vengono poi
(Fig. 3). In effetti, ricerche precedenti, schedati e studiati. Una tale metodolo-
proprio in questa zona, avevano docu- gia di ricerca, cosiddetta offsite survey
mentato e messo in luce due santuari: (differente da progetti che mappano
uno in località Colle Rimontato a S. solo siti molto visibili ed estesi, come
Giovanni in Galdo, scavato negli anni ad esempio quello della Biferno Valley
specifici opportunamente selezionati a seconda sia a livello pratico, della quotidianità, sia a livello ’70 dalla dott.ssa Angela Di Niro, fun- Survey, condotta da Graeme Barker in
delle caratteristiche del territorio e delle particolari politico-amministrativo. zionario della Soprintendenza, e uno in Molise negli anni ’70 e molti altri pro-
sfide conoscitive locali. Le diverse metodologie ar- Molte ipotesi sono state proposte in merito. Si trat- località Cupa a Gildone, dove il medico getti di ricognizione di superficie, che
cheologiche utilizzate nell’ambito di questi progetti tava di santuari lontani, posti alle frontiere delle di-
di ricerca, come vedremo brevemente in seguito, verse comunità che vivevano principalmente in cen-
sono in massima parte di carattere non-invasivo e tri fortificati, come è stato proposto anche per altre
non-distruttivo: ricognizioni di superficie, fotogra- zone d’Italia? Oppure si trattava di siti funzionali ai
fia area tramite piccoli droni, prospezioni geofisiche percorsi della transumanza, luoghi di sosta per viag-
nel sottosuolo. Cercheremo di proporre qualche giatori, commercianti e pastori, che attraversavano
conclusione, da considerarsi, però, frutto prelimi- le colline e le montagne del Sannio per andare dalle
nare dell’analisi di dati provenienti dai vari progetti Puglie all’Abruzzo e viceversa?
tuttora in corso. La grande quantità di nuovi dati Uno dei problemi principali per capire la funzione
emersi da questo ricco territorio, al momento costi- di questi santuari è il loro apparente isolamento nel
tuisce il risultato più importante dei nostri lavori, da paesaggio. Resti di santuari monumentali sono da
condividere e considerare anche come importante tempo noti. Spesso, invece, mancano informazioni
strumento nella documentazione e tutela di un pa- su altri tipi di siti ed insediamenti, come strade, tom-
trimonio archeologico in pericolo. be, fattorie, villaggi, di solito meno visibili proprio
poiché raramente monumentali. In qualche modo,
Santuari, villaggi, centri fortificati: il si potrebbe affermare che l’interpretazione dei san-
Sannio interno nella valle del Tappino tuari del Sannio come luoghi di culto rurali, in ef-
fetti, sia stata influenzata dall’apparente moderno
isolamento di queste “cattedrali nel deserto”.
È noto come, nel mondo sannitico, fossero i santua- Altro problema cruciale è poi, quello relativo alla
ri rurali e non, invece, i centri urbani “classici”, a cronologia dei luoghi di culto rispetto alle diverse
svolgere un ruolo di grande importanza: il numero dinamiche demografiche nel territorio. In altre pa-
impressionante di luoghi di culto, monumentaliz- role, la relazione causa-effetto tra l’istallazione (ed
zati in pietra, che sono documentati nel paesaggio eventuale monumentalizzazione) dei santuari ed il
molisano, ne costituisce testimonianza. Importanti relativo modello di insediamento che si costituisce
aspetti della funzione precisa di questi santuari per nel territorio risulta ancora poco esplorata. Questo
la popolazione sannitica restano, però, poco chiari, rapporto, d’altronde, è di grande importanza per ca-
26 Santuari, villaggi, centri fortificati e prima urbanizzazione tra Sanniti e Romani 27
In basso: si avvalgono della metodologia cosid- lato, ma fosse, bensì, inserito in un’a-
Fig. 3. Area di ricerca detta site survey), permette di studia- rea densamente abitata, già in epoca
nell’Alta Valle del Tappino
(elaborazione grafica: A. re il paesaggio archeologico come un precedente rispetto all’istallazione del
Hamel). continuum, invece di vederlo come un santuario. Quest’ultima, infatti, coin-
quadro costituito da singoli siti isolati cide invece con l’espansione demo-
Nell'altra pagina:
Fig. 4. Squadra di l’uno dall’altro. grafica, avvenuta in epoca ellenistica,
studenti sul campo (foto: Pur risultando molto intensiva in del primo nucleo di insediamento già
T. D. Stek).
termini di lavoro e di tempo, questa presente dall’età del Ferro. Lo studio
metodologia ha tuttavia l’importante dei materiali di ricognizione, insieme
vantaggio di rendere possibile la do- al riesame dei materiali provenienti
cumentazione anche di quei siti che di dallo scavo diretto dalla Soprinten-
solito non vengono rilevati. In alcuni denza, inoltre, indica come non ci si-
casi, grazie all’analisi dei dati prove- ano grandi differenze nelle tipologie
nienti dall’offsite survey, la presenza di di ceramica e vasellame utilizzate nel
siti nel territorio può essere addirittura santuario rispetto a quelle rinvenute
ricostruita tramite parametri preditti- negli insediamenti circostanti. Ciò sot-
vi, procedura che abbiamo potuto veri- tolinea la funzione del santuario quale
ficare proprio nell’Alta Valle del Tappi- nucleo di riferimento della comunità
no (Fig. 5). insediata localmente. Per capire me-
Per quanto riguarda i risultati a livello glio lo sviluppo storico del santuario di
storico-interpretativo, di grande inte- Colle Rimontato, dal 2011 in poi, sono
resse è stato, senz’altro, il ritrovamento stati effettuati alcuni saggi di scavo in
di un villaggio protostorico-sannitico e punti mirati dell’area sacra, tesi ad evi-
di una zona di tombe, situati nelle vi- denziare le diverse fasi della struttura
cinanze del tempio italico di Colle Ri- templare. Di particolare interesse, ad
montato (Fig. 6). Tali siti, insieme ad esempio, è la fase, finora poco studia-
una generale densa concentrazione ta, di epoca romana-imperiale del sito.
dell’insediamento nella zona, hanno L’obiettivo principale di tali indagini,
portato a comprendere come il san- che istituiscono un confronto diretto
tuario, in epoca antica, non fosse iso- tra materiali di scavo e materiali rinve-
nuti in superficie nel territorio circostante, è quello documentato, invece, a S. Giovanni in Galdo. Questa
della ricostruzione della storia del santuario in una possibile relazione tra santuario e centro fortifica-
prospettiva di lunga durata (Fig. 7). to, in anni più recenti, è diventata oggetto principale
Una situazione per certi versi simile a questa, è quel- dei nostri studi nel territorio di Gildone. Tra i risul-
la del santuario di località Cupa, a Gildone, dove si tati più interessanti di queste ricerche, vanno men-
CB è potuto documentare una densità di insediamenti, zionati i dati Lidar. Per siti come i centri fortificati,
IS altrettanto alta, posti nell’area gravitante attorno al spesso coperti da fitta vegetazione e localizzati, per
luogo di culto. Diversa, però, sembra essere in questo definizione, in porzioni del paesaggio difficilmente
caso la relazione con il vicino centro fortificato (cioè accessibili, la tecnologia Lidar, la quale fornisce la
quello della Montagna di Gildone), elemento non possibilità di ‘vedere’ strutture nascoste persino at-
28 Santuari, villaggi, centri fortificati e prima urbanizzazione tra Sanniti e Romani 29
Nell’altra pagina: traverso le foglie degli alberi, è senz’al- sarebbe stata altrimenti impossibile
Fig. 5. Esempio di tro di grande aiuto. In questo modo, si da evidenziare. Altrettanto importan-
analisi GIS dei reperti di
superficie (elaborazione è potuto ricostruire meglio l’aspetto del te per i nostri tentativi di registrare
grafica: J. Waagen). sito con l’articolazione sia delle mura siti poco o affatto visibili, è stato l’uso
sia del suo interno (Fig. 8). Attraverso di piccoli droni UAV. Attraverso il loro
In basso:
Fig. 6. Densità di siti operazioni di pulizia della vegetazione utilizzo, in alcuni casi, è stato possibile
riconosciuti in superficie condotte in zone selezionate all’inter- documentare fotograficamente la pre-
intorno al santuario
italico di S. Giovanni in no dell’area del centro fortificato, stu- senza di resti archeologici sepolti. La
Galdo, Colle Rimontato denti di varie università internazionali, metodologia della fotografia aerea ar-
(elaborazione grafica: J.
Waagen). coordinati e diretti da ricercatori del cheologica, come è noto, si basa sull’in-
Centro Didattico di Jelsi, hanno po- dividuazione di colorazioni differenti
tuto documentare concentrazioni di e/o leggere differenze nella crescita
ceramica in superficie la cui presenza della vegetazione dovute alla presenza
30 Santuari, villaggi, centri fortificati e prima urbanizzazione tra Sanniti e Romani 31
di eventuali strutture archeologiche versi casi, come ad esempio la colonia
(Fig. 9). Fotografando dall’alto, al mo- latina di Cosa e di Alba Fucens, quanto
mento opportuno e con la giusta ango- l’immagine della colonia quale picco-
lazione, mediante fotocamere normali la Roma, caratterizzata da un centro
e fotocamere ad infrarossi, si è potuta urbano definito a controllo di un pae-
documentare una serie di strutture ar- saggio regolare, centuriato e coltivato
cheologiche, anche piuttosto imponen- da coloni-soldati, non possa essere una
ti, presenti nel sottosuolo molisano e ricostruzione automaticamente accet-
invisibili in superficie (Fig. 10). tabile. Sembra possibile, al contrario,
Le ricerche nella zona dell’Alta Valle che l’impatto romano, in questo perio-
del Tappino, finora, hanno contribui- do repubblicano di massimo espansio-
to a definire con maggiore precisione nismo, si esplicasse in forme diverse
il modello di insediamento di epoca a rispetto all’imposizione del modello
sannitico-romana, documentando ideale della città-stato ai territori con-
oltre 100 nuovi siti. La densità e la di- quistati. Il territorio dell’antica colonia
stribuzione dei siti, ai quali da poco si è latina di Aesernia, alla luce di tali con-
aggiunto almeno un terzo luogo di cul- siderazioni e nuove domande di ricer-
to, hanno implicazioni importanti per ca, si configura come un’area partico-
la nostra comprensione del modello larmente adatta quale banco di prova
socio-politico sannitico e della demo- per vecchie ipotesi e recenti critiche.
grafia antica del Sannio. Le ricerche ar- Mentre il centro urbano coloniale, con
cheologiche condotte in quest’area, dal le sue mura ed i suoi templi centrali,
2013 sotto la denominazione di Tappi- era stato relativamente ben studiato,
no Area Archaeology Project, grazie alla il territorio circostante risultava poco
rinnovata collaborazione tra l’Univer- conosciuto dal punto di vista archeo-
sità di Leiden e la Soprintendenza Ar- b
logico. Proprio lo studio approfondito
cheologia del Molise, avranno modo di di tale territorio - in particolare di una
proseguire, nel territorio e nella base vasta area attorno al centro urbano di
logistica costituita dal Centro Didatti- Isernia, ha costituito l’oggetto princi-
co Internazionale di Studi Archeologici pale delle ricerche intraprese nel 2011
di Jelsi (Convento di Santa Maria delle con il Colonial Landscape Project.
Grazie), anche nei prossimi anni. Scopo principale di tale progetto è
quello di mappare le evidenze arche-
La colonizzazione romana ologiche di questa porzione di territo-
nel Sannio: il territorio della rio, riservando particolare attenzione
colonia latina di Aesernia a quelle riferibili al periodo sannitico-
romano, nel tentativo di offrire una
Dalla lettura delle fonti antiche, sap- visione complessiva della realtà della
piamo che, dopo le Guerre Sanniti- state interpretate come l’esempio più In alto: colonia e del suo impatto sul paesag-
c
che, la zona dell’odierna Isernia venne forte di questo impatto esercitato da Fig. 7. Scavi al santuario gio circostante. Attraverso successive
italico di S. Giovanni in
conquistata ed incorporata da Roma Roma sulle realtà insediative indigene. Galdo, Colle Rimontato campagne di ricognizione archeologi-
e che una colonia latina fu stabilita Tra i promotori di tale interpretazio- (foto: R. Kalkers). ca di superficie condotte - a piedi - da
in quest’area nel 263 a.C. Come ab- ne si annoverano, ad esempio, Arnold squadre di ricercatori e studenti, se-
Nell'altra pagina:
biamo accennato precedentemente, Toynbee ed Edward Togo Salmon. In Fig. 8. Immagine di dati condo le modalità precedentemente
la colonizzazione romana viene tra- anni più recenti, però, ci si è resi conto Lidar dalla Regione descritte per l’area dell’Alta Valle del
Molise, elaborati per
dizionalmente immaginata come un di come, per il periodo medio-repub- mettere in rilievo le Tappino, è stata campionata una area di
capovolgimento radicale del modello blicano – quello cioè della conquista tracce archeologiche ca. 120 km². Queste ricognizioni svolte
(elaborazione grafica: J.
insediativo e dell’assetto territoriale e colonizzazione romana del Sannio Garcia Sanchez). in autunno, quando le condizioni di vi-
precedente, sconvolto dall’introduzio- –, i dati storici ed archeologici, in re- sibilità archeologica risultano ottimali
ne del modello della città-stato. È inte- altà, siano molto scarsi. Nuove analisi per le particolari caratteristiche topo-
ressante come proprio le aree “tribali” della documentazione archeologica grafiche del territorio isernino, hanno
e abitate “per villaggi” del Sannio siano disponibile, hanno dimostrato, in di- finora condotto alla documentazione di
d
32 Santuari, villaggi, centri fortificati e prima urbanizzazione tra Sanniti e Romani 33
oltre 100 nuovi siti (Fig. 11). In basso: paiono tanto esegui nel territorio, sia A sinistra:
Una delle sfide più grandi che il terri- Fig. 9. Il principio di piuttosto il risultato di un difetto me- Fig. 10. Foto scattata da
archeologia aerea un drone (foto: T. D. Stek).
torio di Isernia ci ha posto innanzi, è (elaborazione grafica: A. todologico della ricerca archeologica
costituita proprio dalla sua particolare Hamel). stessa, il quale porterebbe al mancato
conformazione paesaggistica e geo- ritrovamento di siti effettivamente esi-
morfologica, aspramente montana in stenti, o della distruzione del patrimo-
numerose aree, fittamente ricoperta da nio archeologico, avvenuto a causa di
vegetazione boschiva e comunque for- effetti geomorfologici (come erosione)
temente frammentata. Tale paesaggio, oppure antropici (come lavori di agri-
d’altra parte, si combina perfettamente coltura pesante o cementificazione).
con la precisa domanda storica circa le Tutti questi fattori, sicuramente, gio-
modalità insediative e le dinamiche di cano un ruolo di primaria importanza
trasformazione generate dalla coloniz- nella definizione del paesaggio arche-
zazione romana, rendendo il territorio ologico del territorio di Isernia, forte-
di Aesernia un caso di studio emblema- mente minacciato da processi degene-
tico. La ricostruzione tradizionale del- rativi sia naturali sia antropici. È stato
le tipologie di insediamenti introdotte pertanto condotto uno studio integra-
dai romani nei territori conquistati, to del paesaggio storico-archeologico
prevede, oltre al centro urbano, la pre- che prendesse in considerazione tali
senza di piccole fattorie regolarmente importanti aspetti di tipo geologico e
distribuite nel territorio, convenzio- geomorfologico, al fine di valutare lo
nalmente le abitazioni dei coloni-sol- stato di conservazione della stratigra- è potuta registrare pare una strategia si potrà arrivare ad una ricostruzione
dati. Finora, però, per il primo periodo fia archeologica e di poter approntare insediativa molto più diversificata ed più precisa del modello di insediamen-
coloniale, in nessuna colonia indagata specifiche metodologie di ricerca, a se- organica in rapporto alla complessa to preromano della zona e dell’impatto
in Italia queste fattorie sono state do- conda della tipologia di suoli indagati. geomorfologia del territorio. Ricerche esercitato dalla conquista romana su
cumentate in numero sufficiente per Insieme alla raccolta dei dati per l’e- più approfondite, condotte solo in al- di esso.
poter confermare una tale ricostruzio- laborazione di una carta archeologica cune aree, in particolare attraverso Nell’ambito del progetto più ampio,
ne storica. Resta valida, va sottolineato, della zona, stiamo quindi collaborando prospezioni geofisiche non-invasive, denominato Landscapes of Early Ro-
la possibilità che la scarsa attestazione con geologi e pedologi per la stesura di hanno messo in luce siti talvolta ben man Colonization, coordinato dall’U-
archeologica di questo tipo di siti, che una carta geologico-pedologica dell’a- conservati. I risultati di tali indagini niversità di Leiden, dal Reale Istituto
rea di Isernia. Entrambe le carte costi- geofisiche indicano non tanto l’esisten- Neerlandese a Roma, sotto il patroci-
tuiscono uno strumento fondamentale za di singole strutture disperse nel ter- nio della Soprintendenza Archeologia
per la valutazione delle aree a rischio ritorio, quanto quella di siti elaborati e del Molise, inoltre, abbiamo istituito
e/o potenziale archeologico presenti complessi, talvolta collegati alla viabi- un confronto diretto tra la situazione
nel territorio. lità locale, caratterizzati da una mol- documentabile per Isernia con quella
Per quanto riguarda l’interpretazione teplicità di strutture reciprocamente presente nella colonia latina di Ve-
storica, è interessante notare come, connesse (Fig. 12). nusia, l’attuale Venosa in Basilicata,
anche se un considerevole numero dei Argomento di particolare interesse per fondata nel 291 a. C. Nel territorio lu-
siti rinvenuti può essere datato all’epo- la comprensione delle dinamiche stori- cano, si è pertanto avviata una colla-
ca dell’istituzione della colonia, non è che relative all’area di Aesernia, è inol- borazione con l’Università di Foggia e
stato possibile documentare il model- tre quello relativo alla sorte dei centri la Soprintendenza Archeologia della
lo convenzionalmente atteso. Le cam- fortificati presenti nell’area dopo la Basilicata. Il confronto tra il territorio
pagne di ricognizione effettuate nel colonizzazione romana. Per questa ra- coloniale di Aesernia e quello di Venu-
territorio di Aesernia hanno pertanto gione, sono stati indagati in dettaglio la sia risulta ancor più interessante alla
documentato la stessa mancata corri- cronologia e la funzione dei siti d’altura luce delle loro profonde differenze ge-
spondenza censita negli altri territori del territorio isernino, come quello di omorfologiche e paesaggistiche: questa
coloniali esaminati, registrando una Castelromano, applicando una meto- area del territorio lucano, dolcemente
situazione ben diversa da quella corri- dologia di ricognizione di superficie collinare e caratterizzata da valli ben
spondente con un alto numero di fat- iper-intensiva. Mettendo insieme i dati più aperte, infatti, offre una prospetti-
torie coloniali equamente distribuite provenienti da questo tipo di ricogni- va sulla colonizzazione romana molto
in un paesaggio regolarmente ordinato zioni, i dati ottenuti dalle prospezioni diversa da quella aspramente montana
e centuriato. Al contrario, quella che si geofisiche e dell’analisi delle foto aree, del territorio isernino (Fig. 13).
34 Santuari, villaggi, centri fortificati e prima urbanizzazione tra Sanniti e Romani 35
Centralizzazione e della carta archeologica per la serie In basso:
urbanizzazione in ambito della Forma Italiae, progetti intrapre- Fig. 11. Area di ricerca
intorno alla colonia di
sannitico: il territorio di si negli anni ‘70 e ‘80 del secolo scorso Aesernia (elaborazione
Larinum (Fig. 14). Nel contesto di un progetto grafica: A. Hamel).
di tutela più ampio, promosso dalla
Nell’altra pagina:
Altro progetto di ricerca di particolare Soprintendenza Archeologia del Moli- Fig. 12. Esempio di
rilevanza, è quello relativo al territo- se, al fine di valutare la condizione e la immagine georadar
(elaborazione grafica: R.
rio di Larino. Essendo uno dei pochi caratterizzazione dei siti archeologici A.A. Kalkers).
centri urbanizzati italici noti nel San- già noti nel territorio, si è proceduto
nio, il caso di Larinum è di enorme ad una loro rianalisi, condotta su due
interesse sia per il paragone con la livelli di ricerca principali. Dal 2008 è
situazione insediativa del Sannio più stato eseguito un programma di rivisi-
interno, come l’Alta Valle del Tappino, ta e ricognizione di superficie dei siti
ma anche altrove, sia per il confronto noti, nel tentativo di integrare i dati
con la situazione di Aesernia, spesso dei progetti precedenti. In seguito si è
interpretata come diretto risultato di proceduto allo studio di tutti i materia-
una forzata urbanizzazione introdotta li provenienti da questi siti, sia di quelli
dalla conquista romana. La storia delle già documentati sia di quelli rinvenuti
ricerche nell’area di Larino è diversa durante le nuove ricognizioni, allo sco-
rispetto alle altre zone del Molise, in po di definire con più precisione il loro
quanto oggetto di ben due progetti di quadro cronologico e la loro funzione.
archeologia del paesaggio, quello della La conoscenza dei materiali ceramici,
citata Biferno Valley Survey, e quello nei decenni tra la conclusione dei pro-
getti precedenti ed oggi, si è grandemente affinata e, tutto il materiale ceramico a vernice nera.
ora, anche tramite nuove tecnologie, siamo in grado In questo modo, senza bisogno di intraprendere
di datare e valutare con maggior dettaglio i materiali nuovi scavi o altre ricerche invasive e distruttive,
rinvenuti. Attraverso un’attenta disamina di tutti i è stato possibile recuperare un grande numero di
frammenti di ceramica a vernice nera (particolar- informazioni dai dati già raccolti da progetti pre-
mente indicativa per il periodo ellenistico-repubbli- cedenti, informazioni che possono dare importanti
cano) proveniente dalle ricognizioni e dai materiali indizi sull’interpretazione della realtà storico-ar-
editi precedentemente, abbiamo potuto formare cheologica dell’area (Fig. 15).
un compendio delle forme della ceramica a vernice
nera diffuse in Molise, strumento che speriamo pos- Conclusioni: dalla carta archeologica
sa risultare utile a tutti gli studiosi che si occupano alla tutela
della regione e delle zone confinanti. In proposito,
si desidera ringraziare il fondamentale contributo Nello stesso spirito dei vari progetti precedenti,
della dott.ssa Sheila Cherubini e della dott.ssa Helga quello della Forma Italiae intrapreso nel 1926, o di
Di Giuseppe, le quali si sono occupate dell’analisi di quelli diretti dalle scuole straniere a Roma nel ‘900,
36 Santuari, villaggi, centri fortificati e prima urbanizzazione tra Sanniti e Romani 37
In questa pagina, dal basso uno degli scopi fondamentali delle no- è proprio la presa di coscienza di quan- mente eroso. Solamente attraverso metodologie di
verso l'alto: stre ricerche è quello di documentare to il paesaggio archeologico molisano ricerca molto intensive e l’istituzione di collabora- Per approfondire
Fig. 14. Area di ricerca
intorno a Larinum e salvaguardare il ricco e, purtroppo, sia a grande rischio. I risultati prelimi- zioni interdisciplinari, le tracce più effimere degli
Cherubini, S, Di Giuseppe, H, Pelgrom J, Stek, TD
(elaborazione grafica: A. fortemente minacciato patrimonio nari, effettivamente, documentano in insediamenti antichi possono essere ancora indivi-
Hamel). 2016, Repertorio della ceramica a vernice nera
culturale del Molise. In effetti, va con- modo chiaro il preoccupante degrado duate. Parte di esse è destinata a non essere più rin- diffusa in Molise, Scienze e Lettere, in press.
Fig. 15. Reperti ceramici
a vernice nera rinvenuti
statato come uno degli esiti delle no- del repertorio archeologico di super- tracciabile. Questa considerazione, frutto della no-
in superficie (foto: M. K. stre indagini di ricognizione e rivaluta- ficie. Il paesaggio archeologico visibile stra esperienza di ricerca nel territorio molisano, si Pelgrom, J & Stek, TD 2010, ‘A landscape
Termeer). archaeological perspective on the functioning of a
zione dei siti noti e stesura della carta ai ricercatori degli anni ’70 e ‘80, oggi aggancia ad altre recenti prognosi circa il patrimo-
rural cult place in Samnium: field surveys around the
pedologico-archeologica del territorio risulta in gran parte dissolto o forte- nio archeologico di superficie italiano in generale, la sanctuary of S. Giovanni in Galdo (Molise)’, Rivista di
maggior parte del quale, secondo tali stime, tra due Topografia Antica / Journal of Ancient Topography,
generazioni sarà irrimediabilmente distrutto da 20, pp. 41-102.
processi d’erosione, antropici e naturali. L’urgenza
di recuperare e documentare quante più informa- Stek, TD 2016, ‘Drones over Mediterranean
zioni possibili in tempi brevi, per poter studiare e landscapes. The potential of small UAV’s (drones)
comprendere la ricca storia del Sannio anche nel fu- for site detection and heritage management in
archaeological survey projects: a case-study from
turo, risulta quindi inderogabile proprio per questa
Le Pianelle in the Tappino Valley, Molise (Italy)’,
nostra generazione. D’altro canto, si può constata- Journal of Cultural Heritage, in press.
re come nuove opportunità di supporto alla salva-
guardia del patrimonio archeologico stiano emer- Stek, TD 2015, ‘The Importance of Rural Sanctuaries
gendo sempre più numerose. Al di là dei numerosi in Structuring Non-Urban Society in Ancient
sistemi innovativi messi in campo dagli operatori Samnium: Approaches from Architecture and
del settore per l’individuazione di nuove eviden- Landscape’ Oxford Journal of Archaeology, 34.4,
pp. 397-406.
ze archeologiche e per il loro monitoraggio, grazie
all’introduzione di varie tecnologie digitali, i nuovi Stek, TD 2009, Cult places and cultural change in
inventari di reperti archeologici vengono ormai re- Republican Italy. A contextual approach to religious
aspects of rural society after the Roman conquest,
alizzati principalmente nella qualità di banche dati,
Amsterdam Archaeological Series, Amsterdam.
le quali possono essere combinate con altri sistemi
informativi e formare, in tal modo, strumenti vitali Stek, TD, Modrall, EB, Kalkers, RAA, van Otterloo,
per la catalogazione e la conoscenza del patrimonio RH, Sevink, J 2015, ‘An early Roman colonial
archeologico. In questo senso, la conoscenza com- landscape in the Apennine mountains: landscape
plessiva della storia evolutiva del paesaggio storico- archaeological research in the territory of Aesernia
archeologico di un determinato territorio, acquisita (Central-Southern Italy)’, Analysis Archaeologica.
da progetti di ricerca condotti in collaborazione con An International Journal of Western Mediterranean
Archaeology, 1, pp. 229-282.
le Soprintendenze archeologiche locali, possono
tradursi nell’elaborazione di carte del rischio o del
Stek, TD & Pelgrom, J (eds) 2014, Roman Republican
potenziale archeologico. Tali carte risultano non Colonization. New perspectives from archaeology
solo elementi necessari per un’organica raccolta and ancient history, Papers of the Royal Netherlands
delle informazioni disponibili ma anche vitali stru- Institute in Rome, 62, Palombi Editori, Roma.
menti da utilizzare per la pianificazione urbanistica
e territoriale. Stek, TD & Pelgrom, J 2005, ‘Samnite sanctuaries
surveyed: preliminary report of the sacred landscape
project 2004’, BABESCH, 80, pp. 65-71.
Waagen, J 2014, ‘Evaluating background noise:
Assessing off-site data from field surveys around
the Italic sanctuary of S. Giovanni in Galdo, Molise,
Italy’, Journal of Field Archaeology, 39(4), pp. 417-
429.
È in preparazione un volume dal titolo “Lo stato dei
IS CB Sanniti/ The state of the Samnites”, con gli atti del
convegno tenutosi presso l’istituto olandese a Roma
il 28-30 gennaio 2016.
38 Santuari, villaggi, centri fortificati e prima urbanizzazione tra Sanniti e Romani 39
Potrebbero piacerti anche
- Pride and Prejudice: Bestsellers and famous BooksDa EverandPride and Prejudice: Bestsellers and famous BooksValutazione: 4.5 su 5 stelle4.5/5 (19653)
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeDa EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeValutazione: 4.5 su 5 stelle4.5/5 (20018)
- Art of War: The Definitive Interpretation of Sun Tzu's Classic Book of StrategyDa EverandArt of War: The Definitive Interpretation of Sun Tzu's Classic Book of StrategyValutazione: 4 su 5 stelle4/5 (3321)
- The 7 Habits of Highly Effective People: The Infographics EditionDa EverandThe 7 Habits of Highly Effective People: The Infographics EditionValutazione: 4 su 5 stelle4/5 (2475)
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeDa EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeValutazione: 4 su 5 stelle4/5 (5794)
- The 7 Habits of Highly Effective PeopleDa EverandThe 7 Habits of Highly Effective PeopleValutazione: 4 su 5 stelle4/5 (353)
- Wuthering Heights (Seasons Edition -- Winter)Da EverandWuthering Heights (Seasons Edition -- Winter)Valutazione: 4 su 5 stelle4/5 (9486)
- How To Win Friends And Influence PeopleDa EverandHow To Win Friends And Influence PeopleValutazione: 4.5 su 5 stelle4.5/5 (6520)
- Habit 1 Be Proactive: The Habit of ChoiceDa EverandHabit 1 Be Proactive: The Habit of ChoiceValutazione: 4 su 5 stelle4/5 (2556)
- Habit 3 Put First Things First: The Habit of Integrity and ExecutionDa EverandHabit 3 Put First Things First: The Habit of Integrity and ExecutionValutazione: 4 su 5 stelle4/5 (2507)
- The Iliad: A New Translation by Caroline AlexanderDa EverandThe Iliad: A New Translation by Caroline AlexanderValutazione: 4 su 5 stelle4/5 (5718)
- American Gods: The Tenth Anniversary EditionDa EverandAmerican Gods: The Tenth Anniversary EditionValutazione: 4 su 5 stelle4/5 (12945)
- The 7 Habits of Highly Effective PeopleDa EverandThe 7 Habits of Highly Effective PeopleValutazione: 4 su 5 stelle4/5 (2566)
- Habit 6 Synergize: The Habit of Creative CooperationDa EverandHabit 6 Synergize: The Habit of Creative CooperationValutazione: 4 su 5 stelle4/5 (2499)
- The Picture of Dorian Gray: Classic Tales EditionDa EverandThe Picture of Dorian Gray: Classic Tales EditionValutazione: 4 su 5 stelle4/5 (9756)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItDa EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItValutazione: 4.5 su 5 stelle4.5/5 (3275)
- The Iliad: The Fitzgerald TranslationDa EverandThe Iliad: The Fitzgerald TranslationValutazione: 4 su 5 stelle4/5 (5646)
- Wuthering Heights Complete Text with ExtrasDa EverandWuthering Heights Complete Text with ExtrasValutazione: 4 su 5 stelle4/5 (9929)
- The Picture of Dorian Gray (The Original 1890 Uncensored Edition + The Expanded and Revised 1891 Edition)Da EverandThe Picture of Dorian Gray (The Original 1890 Uncensored Edition + The Expanded and Revised 1891 Edition)Valutazione: 4 su 5 stelle4/5 (9054)
- The Odyssey: (The Stephen Mitchell Translation)Da EverandThe Odyssey: (The Stephen Mitchell Translation)Valutazione: 4 su 5 stelle4/5 (7770)