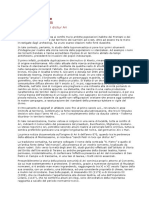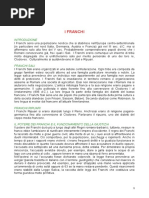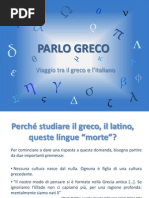0 valutazioniIl 0% ha trovato utile questo documento (0 voti)
242 visualizzazioni24 pagine1 - Grammatica Italiana PDF
Caricato da
CamieCopyright
© © All Rights Reserved
Per noi i diritti sui contenuti sono una cosa seria. Se sospetti che questo contenuto sia tuo, rivendicalo qui.
Formati disponibili
Scarica in formato PDF o leggi online su Scribd
0 valutazioniIl 0% ha trovato utile questo documento (0 voti)
242 visualizzazioni24 pagine1 - Grammatica Italiana PDF
Caricato da
CamieCopyright
© © All Rights Reserved
Per noi i diritti sui contenuti sono una cosa seria. Se sospetti che questo contenuto sia tuo, rivendicalo qui.
Formati disponibili
Scarica in formato PDF o leggi online su Scribd
AIRA - R. MAURIZ;
F, PIAZZI €
- GRAMMATICA ITALIANA
Gisella Ravera Aira
Rina Maurizzi
Francesco Piazzi
GRAMMATICA ITALIANA
ad uso delle Scuole Medie Superiori
NUOVA EDIZIONE
PACCAGNELLA
EDITORE S.p.A.
BOLOGNA
PREFAZIONE
| presupposti metodologici di questa nuova grammatica sono vari e non
suscettibiti di essere ricondotti ad un modeflo epistemologico assolutamente
coerente. Legittima potrebbe risu/tare pertanto /a perplessita di chi, sfoglian-
do queste pagine, vede coesistere in buona armonia un impianto-base di
tradizione classificatoria con procedimenti “avanzati”, tipici della nuova fin-
guistica funzionale. Per non dire della coesistenza di “‘raccamandazioni” che
sembrano ispirarsi ad una concezione in certo senso ancora ingiuntivo-norma-
tiva dell’insegnamento della lingua con aperture nella direzione di un descrit-
tivismo scientifico, che trova i suoi fondamenti nella specutazione linguistica
post-saussuriana.
Vogliamo subito dissipare i! sospetto che tale promiscuita di coordinate
metodologiche abbia una sotterranea motivazione opportunistica, quella di
rispondere all’ormai abusata forrnula editoriale di accontentare “modernisti”
e “tradizionalisti” ad un tempo: é dimostrato che siffatti espedienti, oltre a
non avere alcuna giustificazione sul piano docimologico, piuttosto che accon-
tentare tutti scontentano tutti. La verita é che noi siamo convinti che certe
lita” istituzionalizzate perdano rilevanza, quando ci si cala con
umilta e realismo dall’Empireo della “scienza pura” af terreno pit concreto
della quotidiana prassi didattica. Per fare un esempio, André Martinet (auto-
revolissimo esponente dello strutturalismo praghese e del cui contributo
scientifico abbiamo ampiamente tenuto conto nef nostro fibro), all’inizio dei
suoi famosissimi “Elementi di linguistica generale”, esordisce in questi termi-
ni: “La linguistica é lo studio scientifico del linguaggio umano. Uno studio si
dice scientifico quando si basa sull’osservazione dei fatti e si astiene dal
proporre una scelta fra i fatti in nome di certi principi estetici o morali.
Scientifico si oppone dunque a prescrittivo. f.. .) Conseguentemente ii! lingui-
sta contemporaneo di fronte a espressioni come ai miei amici fo alla mia
amica) gli (o ci) ho detto, la cosa che ti ho parlato, spero che viene, non
prova la virtuosa indignazione del purista. I linguista vede soltanto dei fatti
che vanno notati e spiegati nel quadro degli usi in cui compaiono”. Parole
sacrosante, queste, che potrebbero essere sottoscritte da chiunque abbia
anche sofo una pallida idea dei fondamenti epistemologici della scienza
contemporanea. Ma Martinet sta parlando di “Linguistica”, e non di “insegna-
mento della lingua”; sta introducendo un corso di lezioni che terra alla
Sorbona, @ non in un‘aula delle nostre scuole medie; inoltre, egli é perfetta-
mente sicuro che i! pubblico universitario di laureandi e colleghi, che lo
stanno ascoltando, non incorrera mai in infrazioni alle regole del codice della
lingua d’uso grossofane come quelle che adduce ad esempio. Se perd avesse
Vawventura di riscontrare quotidianamente, come aceade alf’insegnante di
scuola media, negli scritti dei suoi studenti una quantita enorme di siffatte
deroghe aila norma (“deragliamenti” non sempre necessariamente poetici! ), 6
possibile che cominciasse, pur senza provare la virtuosa indignazione del
purista, a entrare nell’ordine di idee che I“opposizione scientifico/prescrittivo
vale in linea di principio, ma non sempre in linea di prassi. Non foss‘altro in
ossequio alla propria definizione di lingua: “essenzialmente uno strumento di
comunicazione”, al quale, perché possa funzionare, bisognera pure garantire
un minimo di stabilité sincronica.
Queste considerazioni, per giustificare quanto di “prescrittivo” si potra
rinvenire, particolarmente nella trattazione della morfologia e della sintassi:
che sono poi le parti della grammatica, alla searsa “competenza” delle quali é
soprattutto imputabile i! maggior numero di usi devianti del codice linguisti-
co.
Ma, laddove ta necessité prescrittiva ci é parsa meno impellente, come
nella fonologia (si pud convenire con Tullio De Mauro sulla competenza
fonologica di uno studente detle scuole medie superiori, nel senso che si pud
presumere che, a quell’eta, il sistema fonetico della lingua naturale sia stato
assimilato), non abbiamo avuto riserve aprioristiche nei confronti di una
presentazione “descrittiva” dei fenomeni, in termini di linguistica opposizio-
nate. Né, quando lo abbiamo ritenuto opportune, abbiamo avuto alcuna
preclusione nei confronti di alcune scoperte importanti del pensiero lingui-
stico moderno. Alla grammatica funzionale s’ispirano gli esercizi lessicali che
recano il titolo di “Parole alla griglia’, oltre che numerosissime pagine di
riflessione ed approfondimento dei meccanismi linguistici.
Ad un modelio di estetica strutturale con aperture nella direzione di un
discorso semiologico s‘ispira la trattazione della stilistica, intesa non come
astratta precettistica ancorata ad una concezione retorico-ottocentesca, si
come scienza deile modalita espressive dei vari settori detla vita sociale: in tal
senso abbiamo introdotto un‘apposita sezione che esemplitica i vari “‘registri
Jinguistici”, nella convinzfone che lapprendimento di strutture e stilemi di
codici settoriali sia indispensabile alla partecipazione critica e consapevole
dell’alunno alla vita del proprio tempo. Ad un modello antropologico-struttu-
rale s‘ispirano altresi numerose pagine di approfondimento grammaticale e
che invitano aiunno ad un confronto tra strutture linguistiche fe quindi
mentali) dell‘italiano e quelle di altri popoli o di particotari contesti socio-
eulturali: operazione questa che riteniamo sia di notevole rilevanza pedagogi-
¢a, in quanto solo attraverso la comparazione di vari codici linguistici (e
quindi di forme diverse di analisi della realta) & possibile approdare ad un
autentico approfondimento della propria cultura, nel rispetto di quella altrui:
cid che, in ultima analisi, pud essere definito insegnamento alla democrazia.
La lunga appendice finale dedicata all’analisi dei vari tipi di approccio al
fatto letterario, oltre a rappresentare la pil corretta conclusfone di un
discorso di stilistica condotto secondo i presupposti enunciati sopra, vuole
dare una risposta ad una delle esigenze piti sentite da docenti e studenti della
scuola media superiore: quella di analizeare il messaggio estetico con un
minimo di strumenti ermeneutici qualificati: @ inutile nascondersi che nelle
nostre scuole /‘opera letteraria @ esaminata troppo spesso in una forma
impresstonistica che favorisce la fruizione estetica projettiva, una madalita di
fettura che forza il messaggio poetico ad essere quello che non vuol essere,
prevaricandolo e scontandone él valore informativo. Oppure, nel migliore dei
casi, I'approccio & condotto in termini di “storicismo istintivo”, secondo una
prassi critica di neutralizzazione della specificita dell’opera letteraria nell‘ex-
tratesto “sociologico”’, che & quanto dire di riduzione dell‘opera letteraria a
documento storico.
GLI AUTORI
STORIA DELLA TRASMISSIONE SCRITTA
DEL PENSIERO
La decifrazione delle scritture dell’antichita
Gia nelle eta preistoriche troviamo pitture e incisioni rupestri che, in
parte almeno, hanno anche lo scopo di trasmettere il pensiero. Certo non é
facile dire quando inizia la differenziazione fra un tipo di rappresentazione
magica ed artistico-estetica e un tipo di rappresentazione a carattere prevalen-
temente comunicativo. In ogni caso non é sostenibile l’ipotesi che le pitture
o le incisioni rupestri preistoriche abbiano a che fare con un sistema fisso e
preciso, come un vero e proprio sistema di scrittura.
Nella pitt parte dei casi é@ assai difficile distinguere fra tentativi di
incisione o di pittura come espressione magica o artistica degli autori e la
pittografia come espressione del pensiero da comunicarsi al prossimo.
Proponiamo, a puro titolo esemplificativo, aleune incisioni rupestri afri-
cane, senza la minima pretesa di addentrarci nell’intricato problema dell’inter-
pretazione del valore simbolico, comunicative o rituale dei segni. Del resto,
per molti di essi, la pura interpretazione grafica non ti risultera difficile: é
facile individuare figure di animali, alcune tracciate con pregevole abilita
espressionistica, e scene di guerra.
rt 70 eg we
Se | Ny
A? eo
Nee
Cc US a vee iy
Particolarmente diffusa nell’Asia anteriore fu la scrittura a caratteri
cuneiformi, cosi detta dalla forma a cuneo dei suoi segni. Questi segni
venivano impressi nell’argilla molle a mezzo di uno stilo di canna: in eta pit
antica i cunei sono piii stretti e pid profondi; in eta successiva appaiono pitt
larghi e pid superficiali. Si seriveva tenendo lo stilo nel pugno e premendolo
nell’argilla: i cunei sono quindi a tre dimensioni, e dovendo viprodurli su
carta, si adoperano segni pil o meno convenzionali.
La deeifrazione di questa scrittura, ormai alfabetica e¢ non pitt solo
sillabiea, avvenne nel 1802 ad opera di un giovane professore di ginnasio di
Gottinga: Georg Friedrich Grotenfeld. Nella figura che segue diamo un
esempio di scrittura cuneiforme con relativa trascrizione in persiano antico
(dinastia degli Achemenidi) e traduzione italiana, quale risulta dalle pid
moderne ricerche
WM Ele EG & an @ OH eK TOK
SE PVE Na @ me HIE SN KX A
KNOT in =C IW OT TICK OK 3
in €< Ke GES i Wet WK Wm IE OE ee
Br Nh Ge NCEC IT mW ETT APE AT eC
Ke Si ntl Cent fe Er Sin Gi eC HK
(1) Darayvaus (2) xsayathiya (3) vazrka (4) xsayathiya (5) xsayathiyanam (6) xsayathiya
(7) dahyunam (8) Vistaspahya (9) puca (10) Haxamanisiya (11) hya (12) imam (13)
taearam (14) akunaus
Dario, il gran re, il re dei re, il re delle nazioni, figlio di Istaspe, l'Achemenide (2 colui)
che costrut questo palazzo,
I principali popoli che si sono serviti dei cuneiformi come mezzo di
scrittura sono: i Sumeri, popolo della Mesopotamia; gli Accadi (Babilonesi —
Assiri); gli Elamiti della Persia; gli antichi Armeni; i Persiani dell’epoca
achemenide; gli Hittiti, gli Huri, i Mitanni ed altre popolazioni della Cappado-
cia,
Dopo l’interpretazione della scrittura cuneiforme, la decifrazione pit
clamorosa delle scritture dell’antichita riguarda l’antico egiziano, i cui segni
ideografici (cioe segni che, a somiglianza di quelli dei grafiti preistorici,
danno una rappresentazione grafica, non lessicale, delle idee) detti geroglifici,
furono interpretati nel 1822 dal francese Jean Francois Champollion, Gia dal
1799 era stata ritrovata in Egitto, durante le campagne napoleoniche, la
famosa stele di Rosetta, che conteneva un testo del 196 a.C. in egiziano
antieo, in caratteri geroglifici e demotici, e con una sottostante traduzione in
lingua greca.
Ma questa pietra famosa
(figura accanto) che I'In-
ghilterra pretese come
bottino di guerra e depo-
sité al British Museum di
Londra, dove ancora si
conserva, non sveld subi-
to il mistero della scrit-
tura egiziana, nonostante
calchi e copie litografi-
che fossero stati distri-
buiti in tutta Europa.
Champollion, fondandosi
sulla conoscenza gia
acquisita, che i nomi di
stirpe reale erano inclusi
in una specie di “cartel-
lo” (cartouche), riusei a
decifrare, in un obelisco
portato da Philae dal
Bankes, il nome di
“Cleopatra”, che si trova-
va anche nella parte greca
dell’obelisco stesso:
Nello stesso obelisco di Philae si trovava anche il nome di “Tolomeo”
scritto in modo identico a quello della stele di Rosetta, e precisamente:
NAM At=
Le due scritte (quella del nome di Tolomeo e quella del nome di
Cleopatra) si confermavano e si integravano a vicenda, perché alcuni segni
alfabetici erano comuni, ad esempio: p =O in prima sede per “Ptolomaios”
e in quinta sede per “Kleopatra”; / =2-Din quarta sede in Ptolomaios ed in
seconda in Kleopatra, ecc:
os MHS WP ees f=) GRIP ReoR Ss
Ma cid non era ancora sufficiente: con questo sistema ben presto
Champollion lesse i nomi di altri sovrani; si trattava pero sempre di valori
alfabetici che si pensava che i geroglifici avessero solo per la trascrizione di
nomi propri. Il vero valore della serittura geroglifica, come fusione di ideo-
grammi e di segni con valore alfabetico, gli apparve la mattina del 14
settembre del 1822, quando, in un nuovo cartello di una iscrizione di un
tempio di “Abu Simbel”, vide il segno con cui ancora oggi nei calendari si
rappresenta il sole: ©) seguito da un segno di cui ignorava il valore, e quindi
da due segni che gid sapeva corrispondere a s. Sapendo che in egizio il sole &
detto ra egli provd a leggere la parolaO MM (T= Ra-? -s(e)s, ¢ integrando il
segno sconosciuto con m, immagind fosse il nome di Rams(e)s = Ramsete,di
un noto faraone. La mancanza di un segno per indicare la vocale e non
comprometteva la attendibilita della decifrazione, in quanto anche la scrittura
alfabetica semitica, che servira di base a quella greca, prevedeva segni solo per
i suoni consonantici ¢ la vocale che precedeva o seguiva la consonante era
sempre sottintesa,
La prova dell’esattezza del-
la sua supposizione gli venne po-
chi minuti dopo, quando, in un
altro cartello, trovd I’Ibis sacro
al dio Thout seguito dal segno
incerto, da lui integrato con m,¢
da un s MP: leggendo
Thout il primo simbolo e ms i
due seguenti, ottenne agevol-
mente Thout-ms = Toutmose,
ben noto nome di un faraone
della XVIII dinastia. In tal mo-
do scoccd la scintilla della sco-
perta.
Nel frammento di stele egi-
zia (proveniente dalla tomba di
Horemheb) raffigurante un di-
gnitario che impartisce ordini a
schiavi negri, noterai_ sulla
sinistra _e nella parte superiore
un’ampia iscrizione geroglifica
incisa (foto a lato).
E’ probabile che il conte-
nuto dell'iscrizione sia una sorta
di didascalia alla scena rappre-
sentata.
10
La serittura appatve a Creta fin dal Minoico Antico (intorno al 2000
a.C.) in forma di segni incisi su sigilli reali: in pratica, si tratta di simboli che
alludono ideograficamente (cio, rappresentando una cosa o un’idea con una
figura) a determinati oggetti facilmente ri-
conoscibili, a prescindere dai complessi si-
gnificati ideologico-politico-rituali che do-
vevano assumere in quel contesto cultura-
le. La doppia ascia, il vaso a becco, il
palazzo, la stella del mattino, la mezzalu-
na, la montagna, riportati nella figura ac-
canto, sono alcuni di questi simboli, inter-
pretati da Evans, il maggiore studioso del-
le iscrizioni cretesi.
Solo a partire dal Minoico Medio (in-
torno al 1900 a.C.) apparve a Creta un
tipo di serittura con segni stilizzati, nota
tra gli studiosi col nome di Lineare A, Si
tratta di un complesso di 85 segni, presu-
mibilmente con valore fonetico-sillabico
(nel senso che, a differenza dei nostri alfa-
beti moderni nei quali ad ogni segno corri-
sponde un suono, ad ogni segno doveva
corrispondere una sillaba, cioé un gruppo
di suoni) piti una serie di ideogrammi
(cioé, di disegni del tipo di quelli esamina-
ti sopra per il Minoico Antico). Tracciati
con una punta sull’argilla fresca, o realiz-
zati con particolari inchiostri, i segni del
Lineare A furono usati in tutta Creta e
probabilmente nelle Cicladi (Tera, Melos
ecc.). Riproduciamo a fianco un esempio
di Lineare A proveniente da una tavoletta
di Cnosso.
Intorno alla seconda fase del Minoico
Recente (1450-1375 a.C.), a Cnosso, si
comincid ad impiegare una nuova scrittu-
ra, il Lineare B, che comprende ideogram-
mi e 88 segni sillabici, dei quali alcuni
presentano notevoli affinita con quelli del
Lineare A. Questa nuova scrittura di Cnos-
doppia ascia
vaso a becco
palazzo
stella del mattino
mezzaluna
montagna
so @ inoltre largamente rappresentata nel continente: tavolette di Pilo, di
Micene, di Tebe, vasi con iscrizioni di Orcomeno, Eleusi,ecc.
1
Gia Evans era riuscito ad identificare i segni rappresentanti i numeri e
ad interpretare alcuni ideogrammi. Ma solo nel 1952-1953 due inglesi, l’archi-
tetto Michael Ventris e il linguista John Chadwick trovarono la “chiave” del
Lineare B.
Sarebbe troppo complesso illustrare in questa sede il procedimento
seguito dai due studiosi per la decifrazione, peraltro parziale e ancora assai
problematica, di questi segni, che, secondo le congetture del Ventris, trascri-
vevano una forma di greco alquanto arcaica.
Le perduranti difficolta di decifrazione sono in parte anche dovute alla
particolare natura dei testi pervenutici: si tratta di inventari, di conti, insom-
ma di documenti nei quali sono rarissime le sequenze di frasi o parole. E”
probabile che i Cretesi abbiano utilizzato il Lineare B anche per testi di altra
natura, ma probabilmente scritti su legno, scorza d’albero, foglie, papiri, e
quindi tutti distrutti durante l’incendio del palazzo di Cnosso. Al contrario le
fiamme hanno risparmiato, “cuocendoli”, gli inventari e i conti annuali
pertinenti l’amministrazione della corte, incisi su argilla. Ecco, di seguito,un
bell’esempio di Lineare B (tavoletta di “carro da guerra” di Cnosso).
Vi Dt.
yea
PRL AANA
at AM
Y
AYE Y
La lingua degli Etruschi, con ogni probabilita non indoeuropea ',non é
mai stata completamente decifrata. Dell’alfabeto etrusco, strettamente impa-
rentato con quello greco e con quello latino, si conoscono le lettere ed é
quindi possibile leggere le iscrizioni, ma il significato delle parole rimane per
lo pili oscuro. I testi originali etruschi giunti fino a noi sono circa diecimila,
numero solo apparentemente elevato, in quanto si tratta per lo pid di
brevissime iscrizioni sepolcrali nelle quali é menzionato il nome del defunto,
la sua parentela, l’eta in cui é morto. Come giustamente osserva il maggiore
studioso vivente di etruscologia, Massimo Pallottino, per la decifrazione
dell’etrusco “una soluzione decisiva e totale sarebbe possibile soltanto se
esistesse una chiave, cioé un qualsiasi mezzo di illuminazione esterna, come
una lingua conosciuta, cosi vicina all’etrusco da spiegarne automaticamente le
radici e le forme, o vocabolari o documenti bilingui, simili a quelli che
consentirono l’interpretazione dell’egiziano antico”: ricorderai infatti che il
successo della decifrazione dell’egiziano é dovuto in gran parte al fatto che
Champollion lavorava su documenti bilingui, come la stele di Rosetta. “Lo
studio dell’etrusco — continua T’illustre studioso — resta dunque, almeno allo
stato attuale delle cose, basato sopra una progressiva serie di nuove acquisi-
zioni di materiali, piuttosto che sull’attesa di rivelazioni miracolistiche”.
1. Per questo problema cfr. pag. 25.
12
Sarebbe lungo spiegare in questa sede le ragioni storiche e linguistiche
dell’isolamento di questa misteriosa civilta nel mondo antico. Ci limiteremo a
produrre l’unico documento linguistico trovato fuori d'Italia, che presenta
una notevolissima affinita con l’etru-
sco, per quanto concerne la scrittura,
la cosiddetta stele di Lemno (figura a
lato), reperto che potrebbe solo atte-
stare legami commerciali tra gli Etru-
schi e il mondo dell’Egeo, ma che
potrebbe anche significare una predo-
minanza esercitata dalla civilta etru-
sca in tutto il bacino del Mediterra-
neo in eta anteriore alle invasioni dei
popoli indoeuropei.
Riproduciamo, sotto a_sinistra,
una stele sepolcrale arcaica di un
guerriero etrusco armato di bipenne,
nel cui bordo noterai l’iscrizione in
caratteri etruschi, leggibile da destra
a sinistra. A destra: il disegno di un
modellino di bronzo del fegato di
una pecora, con nomi di divinita se-
gnati in caselle: probabile strumento
per la pratica dell’aruspicina (dottrina
divinatoria riguardante V’interpretazio-
\LA
4AM 1AIA’
OIA PYRELLARIS 8
aod 3tce}l4
2
BOL vie Linus
De fefo 5 $177.5)
poli
ELL: WbXPI-LIL cao ki
nae SHAIYIS Fy iy
=
iS
z
2
a
ie
2
MoV Uo LEYI-EL
byovtiy
ne dei fenomeni naturali mediante l’osservazione delle viscere degli animali).
cB
ER,
VT
Ky
2. L’alfabeto latino dalle sue origini alla sua affermazio-
ne universale
Il cosiddetto alfabeto latino, nella misura in cui diventd la scrittura
ufficiale dell’impero romano, e piti particolarmente dell’impero romano occi-
dentale, venne poi accettato come scrittura della Chiesa di Roma e di tutti i
popoli che da Roma ricevettero la loro religione. In termini approssimativi si
puo affermare che l’alfabeto latino deriva da quello etrusco, ma non é facile
seguire i primi passi della sua introduzione a Roma, in quanto, del periodo
pitt antico non ci sono pervenute che pochissime epigrafi: Ja fibula aui
Preneste (VII sec. a.C.), coll’iscrizione Manios med fefaked Numasic
Manius me fecit Numerio, attesta, sia per l’arcaicita dei caratteri, sia per
Vandamento sinistrorso (ricorda che gli Etruschi leggevano da destra a sini-
stra), la fase di passaggio:
E’ soltanto dalla fine dell’epoca repubblicana e particolarmente dal
periodo imperiale che ci é pervenuto un numero enorme di epigrafi latine. Ne
diamo qualche saggio nelle figure seguenti:
14
In linea generale possiamo considerare l’evoluzione dell’alfabeto latino
come la continuazione dell’alfabeto greco-etrusco: qualche lettera non fu
accolta, qualche altra fu aggiunta, ma nell’insieme, la base rimase quasi
sempre invariata. Il primo alfabeto latino consisteva di 21 segni: per il suono
v veniva utilizzato lo stesso segno dell’u (come puoi notare nella prima delle
iscrizioni riportate sopra, in POBLICIVS e in MODESTINVS si ha V per U;
mentre nella quarta, in basso a destra, in ALVIO, V rappresenta il suo
attuale valore fonetico). Nel sec. III a.C. la zeta (I) venne scartata, pero il
numero delle lettere rimase sempre uguale, perché con un trattino aggiunto
alla C, venne creata una nuova lettera (G), che consentiva di distinguere i
valori fonetici k e g. Nel I sec. a.C. si riprese dall’alfabeto greco la zeta, ma
nella forma di Z, e si accolse anche il segno ypsilon (Y): ma ambedue i segni,
essendo gli ultimi ad aggiungersi, furono messi alla fine dell’alfabeto e furono
adoperati solo per la trascrizione di suoni greci, cosicché lalfabeto latino,
costantemente usato nell’epoca imperiale, contava 23 lettere. Anche la forma
delle lettere si mantenne costante, pur diventando sempre pil regolare,
simmetrica ed elegante (capitale elegante).
Accanto a questa scrittura, detta monumentale, lapidaria, quadrata o
capitale, che in sostanza si é conservata a tutt’oggi nelle maiuscole della
stampa moderna, venivano adoperate alcune scritture tendenti pitt o meno al
corsivo, derivate direttamente dalla scrittura monumentale. Queste erano: la
serittura capitale rustica, meno regolare, ma piu agile, adoperata principal-
mente per gli atti pubblici, trascritti con inchiostro su tavole, su muri, papiri
ece. Ecco, di seguito,alcuni esempi di scrittura capitale rustica:
[IATIBICONTINGANT
ny ee
GonguIsuITV Hoe ISELIN Sue] eayerreameaamice
SNRVMNON VIOUS MECINEZ AMR yy i
la capitale semicorsiva lapidaria e libraria, scrittura con caratteri misti, ossia
con alcune lettere corsive 0 quasi corsive; la semionciale arcaica (III, IV sec.),
diritta 0 rotonda, usata nelle iscrizioni, manoscritti ecc., anch’essa scrittura
mista, e precisamente di lettere capitali, di onciali e di minuscole; ecco,
nell’ordine, un esempio per ciascuno dei due tipi di scritture sunnominate:
= “ma, lines *
CIBOFAS TIDE ROE Tysyanvuasycr iy
i : e des 5 he.
RAHITURQUIEL DE se scutperin,
a aouaie :
WOO COR, Semicon
SSINTITATARNIDC GT olsun sFiunven A,
15
Dalla semionciale arcaica derivd la scrittura onciale, usata comunemente
nei documenti dell’epoca imperiale a cominciare dal III sec. d.C., e nei
manoscritti: anzi si pud dire che é la principale scrittura libraria antica fino
al secolo IX:
sarsaseewe ,. UMaltra scrittura principalmente _libraria,
TP OEENY orivata (tra il IV © il V sec.) dalla semionciah,
Ubcien; soueiupreribear atcaica, ma sotto Vintluenza della minuseola con.
Monaasbout'orulonecenin siva é la serittura semionciale (detta anche minu.
Keurnalexanideia cscvont scola antica 0 minuscola): é scrittura mista, con
ausuredmutrum BreawAat Ptevalenza di lettere minuscole (vedi figura’a la-
to.
aueurcumulzum breut
Contemporaneamente alle varieta di scrittura suddette era in uso la
serittura corsiva propriamente detta, adoperata nelle tavolette cerate, nei
graffiti, sui muri, pareti, vasi ecc. Spesso la lettura della scrittura corsiva é
resa difficile dalle legature di due, tre ed anche quattro lettere. Eccone alcuni
esempi:
SUE Ree are Aryraclehdornto lr spiyty meentotdoe papers ne
Pan een easement rl iagkornut ren 3 ne fabranenue cmt
‘Set freticincenatirinesorse Ahir YLUT YU 7FOT oem lanom ford flour Voieum
= fisit coiemirlierie valent
Dalla scrittura minuscola corsiva si sviluppo la scrittura diplomatica o
cancelleresca della cancelleria imperiale d’Italia e di Francia. Alla fine del sec.
VIII si forms, in Francia, la minuscola carolina, la cui introduzione é forse
dovuta all’azione diretta di Carlo Magno e, in genere, alla rinascenza letteraria
ed artistica carolingia. La minuscola carolina divenne ben presto scrittura
libraria quasi universale:
16
Hinman te fama permaceney =
pe
Oe ever ese re ethers te infaands |
< ANTICUM GRA DUM oe
fed rss SUM OM His QUAL DICEASWAgTARIME:
Da questa scrittura corsiva, bella e chiara, si svilupparono diverse serittu-
re: la serittura gotica (secoli XII-XIV) negli ambienti germanici, e la scrittura
umanistica italiana, sorta probabilmente a Firenze nel sec. XV. Si veda,
rispettivamente da sinistra a destra, un esempio dei due tipi di serittura:
fi Seve lt
rant nae fe,
“De pasiserie alent leon
fe Kop fame fore Soufort
Re oufeecmen cteffor jacn
Hipsre afer en,
Gear ce fiat prompt juan Gas
Da esse derivarono i cosiddetti caratteri gotici minuscoli, i quali, con
certe modificazioni, si sono conservati quasi fino ad oggi nella stampa
tedesca, anche per il fatto che, essendo in uso nell’epoca dell’invenzione della
stampa, vennero adoperati dal Gutemberg per le prime tirature; la cosiddetta
antiqua, la quale da una parte diventd il moderno alfabeto latino minuscolo
usato nella stampa, e dall’altra parte, a mezzo di una forma pit corsiva,
evolutasi nel periodo rinascimentale, diede origine alla odierna minuscola
latina corsiva.
Queste ultime due (con numerosissime, ma lievissime varianti, e che in
ogni caso non interessano pit lo storico delle scritture, ma il tecnico grafico,
il cartellonista, il tipografo ecc.) vengono adoperate oggi dalla quasi totalita
dei popoli civili dell’Europa, dell’America, dell’Africa meridionale, dell’Au-
stralia.
17
La geografia del linguaggio
Gli oltre quattro miliardi di individui che popolano il mondo sono sparsi,
in modo assai diseguale, su tutta la superficie terrestre. Le lingue del mondo
sono distribuite in maniera ancor pit diseguale.
Si € calcolato che la popolazione del globo parli 2796 idiomi diversi, senza
tener conto dei dialetti, il cui censimento non é stato mai condotto a termine in
modo soddisfacente. Se ciascuna lingua avesse una quota di parlanti pari a
quella delle altre, si dovrebbe assegnare a ogni singolo idioma quasi due milioni
di individui, Naturalmente, non esiste una proporzione del genere. L'inglese é
parlato da 220 milioni di statunitensi e da 90 milioni di individui nel Regno
Unito e nei suoi ex Domini di razza bianca. Al sud degli Stati Uniti c’é I’ Ameri-
ca Latina, la cui popolazione é molto vicina ai 220 milioni della repubblica
stellata, e anche non contando i 100 milioni di brasiliani (che parlano portoghe-
se), sta di fatto che lo spagnolo rimane sempre la lingua di circa 160 milioni di
persone nell’emisfero occidentale. La popolazione dell’ Unione Sovietica si avvi-
cina ai 300 milioni, e se é vero che non tutti parlano russo, @ pur vero che
esso é la lingua di una buona meta di quella popolazione. Si calcola che i
Cinesi siano 750 milioni e quasi tutti parlino uno dei tanti dialetti cinesi.
All’altro estremo vi sono lingue che contano meno di quei due milioni di
parlanti 2 cui avrebbero diritto se si dovesse equamente dividere fra tutti gli
idiomi l'intera popolazione del globo. Pit: di 1200 delle 2796 lingue del mondo
sono parlate da tribU indiane d’America, la maggior parte delle quali conta
poche migliaia o in certi casi addirittura poche centinaia di anime. Altre 500
lingue e pitt sono usate dai gruppi negri africani, molti dei quali sono estrema-
mente esigui. Altre 500 appartengono ai nativi dell’ Australia, della Tasmania,
della Nuova Guinea e delle isole del Pacifico. Altre centinaia di lingue sono
parlate da modestissimi gruppi asiatici.
Di lingue con 60 milioni o pit di parlanti ce ne sono soltanto tredici, che
sono, in ordine d'importanza numerica, cinese, inglese, russo, indostano, spa-
gnolo, lingue maleo-polinesiache, portoghese, tedesco, giapponese, francese,
arabo, italiano, bengalico,
La loro distribuzione geografica varia notevolmente. Fra le lingue asiati-
che, il cinese (750 milioni) & in gran parte limitato alla Cina e alla Manciuria,
mentre |'indostano (180 milioni) e i! bengalico (70 milioni) hanno scarsa circo-
lazione fuori dell'India. |I giapponese (115 milioni) é la lingua delle isole nippo-
niche ed @ parlato in certo grado anche nella Corea e nelle zone finitime del
continente asiatico.
Il malese (150 milioni) é parlato nell’ Indonesia e nella Malesia britannica
e viene compreso fino alle Filippine. L’arabo (100 milioni) si estende su un
immenso territorio che, attraversando |’Africa a Nord del Tropico del Cancro
da Casablanca al Cairo, si spinge in Palestina, Siria, Irak ed Arabia, ed é
largamente compreso dovunque é giunta la religione mussulmana; per altro,
esso € quasi dappertutto mescolato con lingue diverse, se Pure molto spesso
affini (per esempio il berbero e I’ebraico).
18
L'inglese (310 milioni), sia come madrelingua sia come lingua ufficiale
per gli abitanti delle colonie, copre un quinto della superficie terrestre,
dominando pressoché incontrastato nelle Isole Britanniche, negli Stati Uniti
d’America, nel Canada, nell’ Australia, nella Nuova Zelanda e in parte del Sud
Africa, ed 8 di uso corrente in tutti gli ex possedimenti inglesi e americani.
Esso & parlato da oltre 320 milioni di persone nell’emisfero occidentale, oltre
100 milioni in Europa, oltre 50 milioni in Asia, oltre 10 milioni in Africa e
quasi 20 milioni in Oceania, comprese I’Australia e la Nuova Zelanda; 20
milioni di persone nell’Europa continentale parlano inglese oltre che la
propria lingua nazionale.
Il russo (300 milioni) domina un sesto della superficie terrestre, essendo
la lingua che prevale 0, come dicono i Sovieti, che lega insieme tutti i popoli
dell'immensa Unione Sovietica. Ma poco piti della meta di questi 300 milioni
ha il russo come lingua madre; il resto della popolazione parla 145 lingue
diverse, fra cui I’ucraino, il georgiano e numerosissime lingue di ceppo turco.
Lo spagnolo (160 milioni) @ parlato nella Spagna peninsulare, nelle
Canarie, e nelle ex colonie spagnole, ma tutti questi territori comprendono
meno di un quarto degli individui di lingua spagnola; gli altri tre quarti si
trovano nell’emisfero occidentale, dove lo spagnolo é secondo solo all’inglese,
occupando il Messico, I’America Centrale, Cuba, Porto Rico, la Repubblica
Dominicana e tutta l'America del Sud ad eccezione del Brasile e delle
Guiane.
Il portoghese (130 milioni) & la lingua del Portogallo, delle Azzorre, di
Madera, delle isole del Capo Verde, degli ex possedimenti portoghesi in
Africa, Asia e nel Pacifico, nonché del Brasile, paese la cui area é maggiore di
quella continentale degli Stati Uniti.
II tedesco (120 milioni) @ parlato esclusivamente in Europa, non solo dagli
abitanti della Germania, dell’ Austria e di molta parte della Svizzera, ma anche
da circa 20 milioni di persone nei paesi finitimi dell’ Europa centrale (Cecoslo-
vacchia, Polonia, Ungheria, Jugoslavia,ecc.).
Il francese (110 milioni) é la lingua della Francia, di parte della Svizzera e
del Belgio, nonché degli ex imperi coloniali belga e francese, il secondo dei
quali, detto dai Francesi /a France d’Outre-mer, ha un'area parecchie volte
maggiore della Francia metropolitana e una popolazione quasi doppia di quella
della madrepatria; il francese & anche parlato nell’emisfero occidentale, e preci-
samente nella repubblica di Haiti e nella provincia canadese del Quebec, ed é
inoltre usato come lingua di cultura in Europa, in Asia, in Africa e nell’ America
Latina.
Liitaliano (80 milioni) @ anche la lingua del Canton Ticino ed @ di uso
corrente nelle ex colonie italiane (Eritrea, Somalia, Libia e Cirenaica); esso
parlato inoltre da circa 10 milioni di italiani emigrati in vari paesi mediterra-
nei, negli Stati Uniti, in Argentina, nel Brasile, nel Cile, nell'Uruguay ed altri.
Le lingue germaniche, che comprendono inglese, tedesco, olandese e
idiomi scandinavi (svedese, norvegese, danese e islandese); contano dunque
quasi 470 milioni di parlanti, mentre quelle neolatine (italiano, francese,
19
spagnolo, portoghese, romeno e romancio) ne contano pit di 500 milioni. Le
lingue slave, la pit importante delle quali é il russo, superano i 400 milioni,
di cui pid della meta spettano appunto al russo, 40 ciascuno al polacco ¢
all’ucraino; circa 18 ciascuno al ceco unitamente con lo slovacco, e al
serbocroato, nonché 10 al bulgaro.
1 600 milioni di abitanti dell’India parlano 33 lingue principali, con una
miriade di lingue meno importanti e di dialetti. Al primo posto sono I’indosta-
no (180 milioni) e i! bengalico (70 milioni).
La “lingua nazionale” cinese, fondata sul dialetto mandarino settentriona-
le, 6 parlata da circa due terzi dell’intera popolazione, che si aggira sui 750
milioni di abitanti. Gli altri parlano vari dialetti, come i! cantonese che tanto
frequentemente si sente negli Stati Uniti.
Uralo-altaico & i] nome di una famiglia linguistica che copre un‘area
vastissima nell’Asia settentrionale e centrale, ma i cui parlanti non sono pil
di 80 milioni. Queste lingue asiatiche hanno parecchie avanguardie in Europa,
fra cui il finnico, I’ungherese e il turco.
20
Le lingue maleo-polinesiache, tra cui va annoverato il malese, una delle
tredici lingue mondiali pit’ importanti, si estendono dal Madagascar, al largo
della costa orientale dell’Africa, sino all’Isola di Pasqua, al largo della costa
occidentale sudamericana, attraversando |’oceano Indiano e il Pacifico. Esse
comprendono la Malesia, I’Indonesia, le Filippine, le isole della Melanesia,
della Micronesia e della Polinesia, la Nuova Zelanda e le Hawaii, con circa
150 milioni di parlanti.
E’ curioso che il russo, che si classifica numericamente al terzo posto
nella graduatoria mondiale, non sia la lingua pid importante del rispettivo
continente: infatti, trovandosi a dividere i suoi parlanti fra Asia e Europa, 8
battuto nel vecchio continente dai 120 milioni di individui che parlano
tedesco.
L'inglese @ in testa nel Nord America e nell’Oceania, lo spagnolo
nell’America Latina e in quella Centrale, mentre I’arabo @ al primo posto in
Africa,
La stragrande maggioranza dei 220 milioni di abitanti degli Stati Uniti
parla inglese. Nella repubblica stellata, per altro, ci sono circa 30 milioni di
persone la cui lingua materna non @ I'inglese, bensi il tedesco (circa 10
milioni), italiano (7 milioni), il francese (4 milioni), lo svedese (3 milioni), il
norvegese, il ceco o il russo (queste ultime tre lingue con quasi due milioni
ciascuna).
E’ interessante notare che parlano italiano pit. persone a Nuova York
che a Roma,
3. Storia dei linguaggi
Leggiamo nella Genesi che :“La terra era tutta d’una sola lingua e d’una
sola parlata”. Nonostante il legittimo scetticismo che la pit parte degli
studiosi nutre circa il valore scientifico delle affermazioni bibliche (afferma-
zioni che, anche dal credente, non debbono essere intese alla lettera, ma
allegoricamente, cioé come espressione di una verita di fede sottesa al
significato pit ovvio e immediato delle parole), da lungo tempo certi linguisti
vagheggiano di poter ricondurre tutte le lingue a un’unica fonte comune. I
tentativi in questo senso sono risultati in gran parte infruttuo:
Tuttavia si ¢ potuto dimostrare che una fondamentale unita, che denota
il comune lignaggio, sta alla base di lingue tanto diverse come italiano,
Vinglese, il russo, il greco, l’albanese, l’armeno, il persiano e l’indostano. Esse
appartengono a una famiglia denominata indoeuropea per il fatto che si
estende sulla maggior parte dell’Europa, spingendosi verso est fino all’India
settentrionale. I linguisti tedeschi preferiscono il termine “indogermanico”,
perfettamente sinonimo, perché (a parte considerazioni di orgoglio nazionale)
esso indica le propaggini estreme di questa famiglia, a oriente e a occidente.
Nella maggior parte delle lingue indoeuropee, i numeri da uno a dieci e i
nomi che designano i pit immediati rapporti di parentela (padre, madre,
21
fratello, sorella, ece.), come pure moltissime altre parole fondamentali, tradi-
scono con grande evidenza la loro comune origine. “Fratello”, per esempio, 6
chiaramente riconoscibile nel latino frater, nel greco phrater, nelVirico bhra-
thair, nel persiano biradar, nel tedesco Bruder, nel sanscrito brhata e nel
russo brat.
Gia nel sedicesimo secolo, Vitaliano Sassetti, visitando India, aveva
rilevato delle stupefacenti rassomiglianze tra italiano e sanscrito (una delle
tante lingue parlate nella penisola indiana), per esempio tra sei, sette, otto,
nove, dio, serpe e le corrispondenti parole sanserite sas, sapta, astau, nava,
deva, sarpa. Molto prima, nel secolo primo a.C., il grammatico romano Marco
Terenzio Varrone aveva rilevato delle somiglianze fra latino e greco, giungen-
do perd all’erronea supposizione che quest’ultimo fosse la lingua madre e che
il latino ne fosse il discendente. Spettava a Bopp e ai fratelli Grimm, ai primi
del secolo decimonono, il merito di creare il “metodo comparativo” con cui
si poté definitivamente stabilire la precisa natura della-parentela fra le varie
lingue indoeuropee.
Nell’ambito della famiglia indoeuropea (che, si noti, comprende quasi la
meti della popolazione del globo) si distinguono dei sottogruppi linguistici,
aleuni dei quali sono parlati da varie centinaia di milioni di persone (per
esempio: il germanico, il romanzo, lo slavo e lindoiranico), mentre altri sono
estremamente esigui per estensione e numero di parlanti (per esempio: il
celtico, il greco, l’albanese e l’armeno).
La ragione di questi sottogruppi é evidente. Lingue come il francese, lo
spagnolo e Vitaliano, derivate strettamente, in epoca storica, da un unico
antenato comune, il latino, sono molto pit simili fra loro di quanto siano ad
altre lingue parenti, ma pitt lontane, come il tedesco, il gallese o V’indostano.
Si suppone che in eta preistorica, prima dell’apparizione della scrittura,
coloro che parlavano Voriginaria lingua madre indoeuropea formassero un
assieme ben compatto, da cui si sarebbero poi staccati, in successive ondate
migratorie, diversi gruppi che si sarebbero cosi allontanati dalla comunita ¢
dalla patria primitiva, prendendo contatto con gli altri gruppi e facendo si
che la loro parlata si evolvesse fino a diventare inevitabilmente un dialetto
dell’idioma originario, sempre caratterizzato dall’impronta dell’origine comu-
he, ma sempre piti lontano dalla sua fonte col trascorrere dei secoli, Tanto
che oggi, per esempio, un fiorentino non potrebbe sospettare che la sua
lingua e quelle che si parlano a Nuova York, Mosca e Teheran erano un
tempo lo stesso idioma. E’ interessante, notare che questo proceso di
migrazione e di differenziazione (naturalmente su scala molto pid vasta e in
periodi piti lunghi) @ postulato anche da coloro che eredono alla comune
origine di tutte le lingue del globo. L’idioma modemo che si ritiene pit
Vicino alla lingua madre indoeuropea @ il lituano, parlato sulle sponde del
Baltico.
Le lingue romanze (dette anche neolatine) sono cosi chiamate perché
derivano direttamente dal latino, cioé dalla lingua dei Romani, Comprendono
Vitaliano, il francese, lo spagnolo, il portoghese e il romeno. nonché lingue
22
non ufficiali come il provenzale, il catalano, il sardo e il romancio della
Svizzera. Il latino ebbe almeno due parenti nell’antichita: l’osco e l'umbro,
coi quali formava il ramo italico dell’indoeuropeo e che assorbi nel corso
del’espansione romana. Il logudorese, parlato nella Sardegna centrale, 6 oggi
di gran lunga il pid vicino al latino fra tutti gli idiomi romanzi, sebbene
questo onore sia spesso reclamato, a torto, dal romeno e dal romancio.
“Romania” é un termine introdotto nel quinto secolo per indicare quelle
parti del defunto impero romano in cui il latino era diventato e continuava
ad essere lingua parlata dal popolo. I Romeni, separati dai fratelli latini
d’occidente in seguito all’invasione slava dei Balcani, conservarono questo
nome. Il romeno 6, si, discendente del latino che portarono in Dacia i
legionari di Traiano verso il 200 a.C., ma si differenzia dalle lingue romanze
occidentali per larghe infiltrazioni di parole e costruzioni slave.
Delle lingue germaniche, la pit importante per diffusione é certamente
Vinglese. L’anglosassone che forma l’ossatura dell’inglese, specialmente di
quello parlato, era un tempo assai vicino ai dialetti delle aree costiere
olandese e tedesca del Mare del Nord. Ma, in seguito alla conquista normanna
dell’Inghilterra nel 1066, esso accolse un tale afflusso di parole e forme
grammaticali francesi e latine da potersi definire oggi come una lingua
essenzialmente germanica con un’imponente sovrastruttura romanza. L’idioma
nazionale che gli é pid stretto parente é l’olandese, con la sua varieta belga
(fiammingo) e la sua varieta sudafricana (I’afrikaans). Poi viene il tedesco,
mentre le lingue scandinave sono un po’ pid lontane. Il frisio, una varieta
dell’olandese parlata lungo la costa tedesca e olandese del Mare del Nord, é la
lingua straniera pit simile all’inglese moderno.
Liislandese, cioé l’idioma portato dai navigatori vichinghi nella terra dei
geysers e parlato oggi da meno di centomila persone, ha subito pochi
cambiamenti ed é la lingua moderna che pitt assomiglia all’anglosassone
parlato ai tempi di re Alfredo.
Dato che inglese, tedesco, scandinavo e frisio si possono far risalire
senza soluzioni di continuita al settimo od ottavo secolo, e dato che quanto
pid risaliamo nel tempo, tanto maggiori sono le loro reciproche affinita, é
ragionevole supporre l’esistenza di una primitiva lingua germanica dissoltasi
negli idiomi a noi noti non molto prima dell’epoca a cui appartengono le pitt
antiche attestazioni di questi ultimi. Questo germanico primitivo, a sua volta,
si sara staccato dal comune ceppo indoeuropeo a una data che non si pud
precisare.
Le lingue slave sono legate tra loro da affinita forse maggiori di quelle
che intercorrono fra gli idiomi di quasi tutti gli altri sottogruppi indoeuropei.
Un Italiano e uno Spagnolo, oppure uno Spagnolo e un Portoghese, s’inten-
deranno senza eccessiva difficolta, parlando ciascuno la propria lingua. Non
comprenderanno pero un Francese 0 un Romeno senza un minimo di
preparazione linguistica; un Tedesco, un Inglese e uno Svedese non. si capitan-
no se ciascuno di loro vorra parlare la propria lingua. Invece un Russo, un
Bulgaro, un Polacco e uno Jugoslavo potranno arrangiarsi discretamente.
23
Le lingue slave sono talvolta raggruppate con le lingue baltiche (lituano
e lettone) in un unico gruppo balto-slavo, ma mentre lituano e lettone sono
abbastanza simili tra loro, sono relativamente lontani dagli idiomi slavi.
Le lingue celtiche si dividono in due rami: il ramo gaelico, che compren-
de Vitico (0 irlandese), il gaclico scozzese e la parlata dell’isola di Man; il
xamo britannico, che comprende il gallese e il bretone. Un terzo ramo celtico
era il gallico un tempo assai diffuso sul continente e perfino in Asia Minore
(San Gerolamo notava nel quarto secolo che i Galati parlavano come i Galli)
ma oggi estinto. Nomi come quello della Galizia, nella Spagna, attestano le
migrazioni galliche.
Greco, armeno e albanese costituiscono dei rami separati dell’indoeuro-
peo. La propaggine orientale della famiglia indoeuropea é l’indoiranico, che
comprende il persiano dell’Iran, il pushtu dell’ Afganistan e una selva di lingue
e dialetti dell’India settentrionale e centrale, dall’antico sanscrito, attraverso i
pracriti medioevali ¢ il pali, fino ai moderni indostano, bengalese, oriya,
rajasthano, pungibese, maratti,ecc. Non meno di trecento milioni di persone
parlano ogi lingue indoiraniche.
Di eguale importanza storica, se non numerica, sono le lingue della
famiglia camito-semitica, parlate nell’Africa settentrionale e nel vicino Orien-
te. La pid diffusa delle lingue semitiche é l’arabo, la piti importante per la
storia della civilta ¢ lebraico. Il ramo camitico comprende, fra [altro,
Vantico egizio delle iscrizioni geroglifiche, il copto medioevale che ne é
derivato, le lingue berbere che si mescolano con ’arabo del Nord Africa e le
lingue cuscitiche dell’Etiopia.
L'uralo-altaico comprende lingue come il finnico, estone, Pungherese, il
turco, il mongolo.
Le lingue sino-tibetane dell’Asia sud-orientale (cinese, siamese, birmano,
tibetano) hanno la caratteristica di essere parlate dal maggior numero di
persone dopo quelle indoeuropee.
A parte si sogliono classificare giapponese e coreano, le lingue caucasi-
che, le lingue dravidiche dell’India meridionale, le lingue maleo-polinesiache
del Pacifico, mentre per gli idiomi dei negri africani, degli indiani dell’ Ameri-
ca settentrionale e meridionale e degli indigeni dell’Australia e della Papuasia
la classificazione 8 ancora difficile e incompleta.
E” possibile migliorare l’attuale classificazione delle lingue?
Certo che i rapporti di parentela linguistica si fanno sempre pid chiari
quanto pil materiale viene alla luce, Pud anche darsi che un giorno si avveri
il sogno di molti linguisti e che tutti gli idiomi risultino derivati da un’unica
fonte comune. Perd, prima di accogliere un’ipotesi, per quanto seducente, lo
scienziato esige prove al di sopra di ogni dubbio. Il nostro attuale sistema di
classificazione verri sicuramente modificato e migliorato con V’andare del
tempo. Piti di questo, per ora, non é lecito promettere.
(Riduzione e adattamento da: Mario [Link], La storia del linguaggio, Sansoni Editore)
24
Le lingue indoeuropee
La classificazione delle lingue in famiglie é basata sul fatto che alcune di
esse possono essere considerate come continuazioni diversificate di una lingua
sostanzialmente una: cosi I'italiano, il francese, lo spagnolo, il rumeno (lingue
neolatine) rispetto al latino. A sua volta il latino ha in comune con il greco,
Vindiano, Miranico, i! tocarico (Turkestan orientale), l'ittito (Asia Minore),
l'armeno, |’albanese, le lingue baltiche, le lingue slave, le lingue germaniche, il
celtico, un tal numero di elementi lessicali e funzionali, che é giocoforza
raggruppare quello e tutte queste lingue in una pi ampia famiglia, che
definiamo indoeuropea. La lingua madre’ originaria (ma pili che una lingua,
doveva trattarsi di idiomi vari nello spazio e nel tempo), parlata presumibil-
mente duemila anni a.C., mancando qualsiasi documentazione epigrafica, é
ricostruibile solo per ipotesi, attraverso le concordanze che si riscontrano
nelle lingue derivate. Ma vediamo, con alcuni esempi, come una base semanti-
ca originaria pud essersi mantenuta, senza eccessive variazioni fonetiche, in
alcune delle pit! note “figlie’’ del gruppo indoeuropeo. || termine “fratello”
assume nelle lingue indoeuropee contemporanee al latino le seguenti forme:
latino antico inglese antico tedesco greco sanscrito antico slavo
frater brotar bruodar phratéer bhrata bratu
La somiglianza delle varie voci é evidentissima. Attraverso |’esame com-
parativo di questi termini, il linguista risale poi, seguendo criteri che non é
possibile esporre in questo breve sunto, ad una forma * bhrater (\’asterisco
indica che si tratta di una forma ricostruita, non documentata), che indica
come in “indoeuropeo” si doveva dire “‘fratello’’.
Facciamo un altro esempio per il nome “madre”.
latino antico inglese antico tedesco greco sanscrito antico slavo
mater modhir muoter meter = mata mati
Anche in tal caso, il linguista é in grado di risalire al termine indoeuro-
peo: * mater. Naturalmente, le concordanze che abbiamo esemplificato sopra
sono riscontrabili in molti altri termini, soprattutto in quelli che colgono
aspetti strutturali della vita di una comunita, come appunto quelli designanti
i componenti della famiglia, cellula della societa indoeuropea, le varie divini-
ta, i fatti della natura ecc. E’ logico che se estendessimo la comparazione a
nomi designanti aspetti voluttuari della vita, suscettibili di mutare designazio-
ne col passare delle mode e in seguito al contatto con altri popoli, non
potremmo pretendere di cogliere concordanze parimenti significative.
Queste considerazioni circa la possibilita di ricostruire con metodi com-
parativi la primitiva lingua indoeuropea, ci spinge a postulare lesistenza di
comunita, con caratteri somatici, psichici,. culturali relativamente unitari,
parlanti quella lingua. Secondo G. Devoto, in un preciso momento storico,
25
vari gruppi di parlanti indoeuropeo si allontanarono dalla sede originaria con
andamento centrifugo: la separazione di tali gruppi ha poi inevitabilmente
determinato il progressivo differenziarsi della lingua comune, sia per evoluzio-
ne interna del linguaggio, sia per influssi dovuti ai contatti che ciascuna delle
comunita separate venne ad avere con altre comunita linguistiche. A questo
comune ceppo indoeuropeo risalgono tutti quei popoli che, in etd protostori-
ca_e storica, si trovano stabiliti da conquistatori in sedi precedentemente
abitate da genti non indoeuropee. Tra i pit noti: gli Elleni, stanziati sui resti
della civilta minoica, gli Indoiranici, i Celti, i Germani, le popolazioni italiche.
Le genti non indoeuropee, che definiremo genericamente “mediterranee”’,
travolte dall’ondata vincitrice indoeuropea, sono state sottomesse e cultural-
mente assimilate. Assai pil raramente hanno saputo mantenersi differenziate
linguisticamente, culturalmente, politicamente: & questo il caso degli Etru-
schi, residuo di un substrato mediterraneo arcaico non indoeuropeo, respinto
verso ovest dagli invasori indoeuropei. Da notare che pure Sardi, Baschi,
Liguri, Reti, popoli siculi occidentali rappresentano altrettanti gruppi non
indoeuropei: cid confermerebbe la nozione di una gravitazione occidentale di
questi gruppi indigeni mediterranei, soprattutto in seguito alla pressione di
genti provenienti da est. Abbiamo detto da est, senza impegnarci a definire
una sia pur approssimativa area di derivazione. Ma da dove venivano allora
questi indoeuropei?
Pil. che definire geograficamente |’area di provenienza indoeuropea, vorrem-
mo brevemente dare un‘idea di come, da osservazioni sul lessico delle lingue
indoeuropee, si possano trarre informazioni di ordine geografico.
Ciascuno di noi sperimenta attraverso i dialetti, se non attraverso le
lingue di cultura, come la costituzione di un vocabolario risenta dell’ambiente
@ come un dialetto alpino sia ricco di elementi che si riferiscone alla vita dei
Pastori, ai fenomeni naturali, e come la terminologia della neve, delle rocce,
della fauna e flora montane manchi in un dialetto del mezzogiorno. Ad
esempio, nessuno saprebbe trovare termini relativi alla navigazione nel dialet-
to bolognese, mentre sarebbe facilissimo riscontrare in esso un nutritissimo
patrimonio lessicale concernente la vita agricola.
Si @ dunque cercato, nel tesoro lessicale dei popoli indoeuropei, se
Cerano elementi comuni che fossero eloquenti per la loro presenza costante,
in opposizione ad altri che fossero presumibilmente assenti. Fra gli animali,
Vorso, il lupo, il castoro, il cervo sono chiamati con nomi che sono diffusi
nella _maggior parte delle lingue indoeuropee, ed hanno una struttura dal
punto di vista indoeuropeo normale. Viceversa il leone, la tigre, il cammello
hanno nomi forestieri: questi sono penetrati soltanto in alcune lingue, venute
in contatto, soltanto per vicende storiche successive, con regioni in cui questi
animali erano noti. Il vocabolario indoeuropeo sembra dunque condurci verso
regioni con fauna piuttosto settentrionale che meridionale. Attraverso nume-
rose deduzioni analoghe e, naturalmente, utilizzando altresi i dati archeologi-
ci a disposizione, si pud riuscire a localizzare la “Urheimat” (terra originaria)
in una vasta zona dell’ Europa centro-settentrionale.
26
Potrebbero piacerti anche
- Riassunto Litaliano Varietà Testi Strumenti0% (1)Riassunto Litaliano Varietà Testi Strumenti47 pagine
- La Scoperta Della Lingua Italiana-Italiano ContemporaneoNessuna valutazione finoraLa Scoperta Della Lingua Italiana-Italiano Contemporaneo37 pagine
- Scheda Di Analisi Di Un Testo NarrativoNessuna valutazione finoraScheda Di Analisi Di Un Testo Narrativo2 pagine
- Grassi Sobrero - Introduzione Alla Dialettologia Italiana - OdtNessuna valutazione finoraGrassi Sobrero - Introduzione Alla Dialettologia Italiana - Odt1 pagina
- Riassunto Filologia Della Letteratura ItalianaNessuna valutazione finoraRiassunto Filologia Della Letteratura Italiana45 pagine
- Guida All'Uso Delle Parole - Semiotica - Tullio de MauroNessuna valutazione finoraGuida All'Uso Delle Parole - Semiotica - Tullio de Mauro9 pagine
- ATL4LaVariazioneLinguistica - Diafasica - Diatopica-Diamesica PDFNessuna valutazione finoraATL4LaVariazioneLinguistica - Diafasica - Diatopica-Diamesica PDF26 pagine
- Letteratura Italiana Moderna e ContemporaneaNessuna valutazione finoraLetteratura Italiana Moderna e Contemporanea84 pagine
- Lezioni Di Didattica Del Greco - Prof. AlvoniNessuna valutazione finoraLezioni Di Didattica Del Greco - Prof. Alvoni34 pagine
- Linguistica Tedesca I Di Claudio Di MeolaNessuna valutazione finoraLinguistica Tedesca I Di Claudio Di Meola25 pagine
- Erodoto - Discussione Sulle Forme Di Governo (Storie, III, 80-82)100% (2)Erodoto - Discussione Sulle Forme Di Governo (Storie, III, 80-82)3 pagine
- Linguistica & Sociolinguistica, E-Campus 2022.Nessuna valutazione finoraLinguistica & Sociolinguistica, E-Campus 2022.9 pagine
- STORIA DELLA LINGUA ITALIANA UnisalentoNessuna valutazione finoraSTORIA DELLA LINGUA ITALIANA Unisalento36 pagine
- Riassunto - Breve Storia Della Lingua Italianan - Claudio MarazziniNessuna valutazione finoraRiassunto - Breve Storia Della Lingua Italianan - Claudio Marazzini13 pagine
- Esercitazioni Di Filologia RomanzaNessuna valutazione finoraEsercitazioni Di Filologia Romanza93 pagine
- La Legge Di Grimm e La Legge Di VernerNessuna valutazione finoraLa Legge Di Grimm e La Legge Di Verner8 pagine
- Letteratura Greca - Dall'Età Arcaica Alla Letteratura - Dario Del Corno - 2 - Ed, Milano, 1995 - Casa Editrice Giuseppe Principato Spa - 9788841627495 - Anna's ArchiveNessuna valutazione finoraLetteratura Greca - Dall'Età Arcaica Alla Letteratura - Dario Del Corno - 2 - Ed, Milano, 1995 - Casa Editrice Giuseppe Principato Spa - 9788841627495 - Anna's Archive660 pagine
- Baratter - Guida Grammatica ValenzialeNessuna valutazione finoraBaratter - Guida Grammatica Valenziale64 pagine
- Lezioni Di Storia Della Lingua ItalianaNessuna valutazione finoraLezioni Di Storia Della Lingua Italiana25 pagine
- Dizionario Della Lingua Etrusca PDFNessuna valutazione finoraDizionario Della Lingua Etrusca PDF4 pagine
- Docsity L Italiano Varieta Testi Strumenti Chiara de Caprio Francesco Montuori Patricia BianchiNessuna valutazione finoraDocsity L Italiano Varieta Testi Strumenti Chiara de Caprio Francesco Montuori Patricia Bianchi200 pagine
- Riassunto Nuovi Lineamenti Di Grammatica Storica Dellitaliano Patota PDFNessuna valutazione finoraRiassunto Nuovi Lineamenti Di Grammatica Storica Dellitaliano Patota PDF28 pagine
- 05 de Bonis - L'Apofonia, Caratteristiche Generali PDFNessuna valutazione finora05 de Bonis - L'Apofonia, Caratteristiche Generali PDF5 pagine
- Riassunto Breve Storia Della LinguisticaNessuna valutazione finoraRiassunto Breve Storia Della Linguistica62 pagine
- Yule, Introduzione Alla LinguisticaNessuna valutazione finoraYule, Introduzione Alla Linguistica36 pagine
- Come Nasce La Glottodidattica: EmmiaiiNessuna valutazione finoraCome Nasce La Glottodidattica: Emmiaii46 pagine