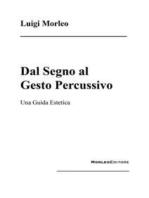Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
Typologie Rev
Caricato da
Alexandre PiretCopyright
Formati disponibili
Condividi questo documento
Condividi o incorpora il documento
Hai trovato utile questo documento?
Questo contenuto è inappropriato?
Segnala questo documentoCopyright:
Formati disponibili
Typologie Rev
Caricato da
Alexandre PiretCopyright:
Formati disponibili
CONCERTATI NELL'OPERA BUFFA DI G.
PAISIELLO 235
to, la cui attività in campo comico, estesa nell'arco di trentaquattro
anni, dal 1764 al 1798, attraversa tutta la seconda metà del secolo,
TIPOLOGIA MUSICALE DEI CONCERTATI riassumendo sotto molti aspetti la storia dell'intero genere.4 L'inda
NELL'OPERA BUFFA DI GIOVANNI PAISIELLO gine - condotta sul ricco corpus di partiture manoscritte paisiellia
ne, in massima parte autografe, conservate presso la Biblioteca del
Conservatorio di Napoli -5 ha preso in considerazione una tren
tina di lavori. Pur tenendo conto della sostanziale unità stilistica dei
« [...la regina] mi fece presentare lo spartito del 'Re Teodoro concertati paisielliani, s'è ritenuto opportuno, per comodità di trat
in Venezia ' di Paisiello, suo favorito; sonai l'overtura; poi sedutasi tazione, suddividere la vasta materia in base alle tre differenti cate
ella alla mia dritta, accompagnai e cantai seco, e coi cavalieri e colle gorie di brani d'assieme: introduzioni, concertati intermedi e finali
dame della sua corte, i pezzi concertati, e i due finali superbi di d'atto; questi ultimi, per ampiezza e complessità, si pongono come il
quell'opera che sapevano già a mente [...] ». Così scrive l'allievo di nodo centrale del discorso: in essi infatti confluiscono e trovano
Paisiello Giacomo Ferrari nelle sue memorie.1 L'aneddoto, relativo a
un soggiorno parigino del 1787, testimonia non solo della larga
fortuna europea della musica di Paisiello, ma anche della grande Robinson ha dedicato all'evoluzione dei finali d'atto nel corso del Settecento, nel
suo volume Naples and Neapolitan Opera, Oxford, Clarendon 1972.
attenzione che il pubblico settecentesco riservava ai brani d'assieme
4 Per quanto riguarda il catalogo e la dotazione delle opere di Paisiello si
come ad un momento particolarmente significativo della sua produ vedano il volume di E. Faustini-Fasini, Opere teatrali, oratori e cantate di
zione.2 Nelle pagine che seguono si tenterà dunque di chiarire come Giovanni Paisiello, Bari, Laterza 1940 e la ' voce ' Paisiello a cura di Michael
Robinson in The new Grove. Dictionary of music and musicians, XIV, Londra,
la forma del concertato, d'importanza decisiva per i destini dell'ope Macmillan 1980, pp. 97-102.
ra buffa,3 sia stata trattata da uno dei massimi operisti del Settecen 5 Diamo qui l'elenco delle partiture consultate, con la relativa segnatura (cfr.
Guido Gasperini - Franca Gallo, Città di Napoli, Biblioteca del R. Conservatorio di
musica S. Pietro a Majella, Parma, Associazione dei Musicologi Italiani 1934). La
data accanto al titolo si riferisce alla prima rappresentazione dell'opera: L'amore in
1 G. G. Ferrari, Aneddoti piacevoli e interessanti, Londra 1830 (edizione mo ballo (1765), Rari 3.3.13/14, olim 14.1.35/36; La vedova di bel genio (1766), Rari
derna a cura di Salvatore Di Giacomo, Milano, Sandron s.d., p. 215). 2.7.17/18, olim 16.5.7/8; Il Marchese di Tulipano (1767), Rari 2.8.14/15, olim
2 Attenzione ancora viva all'inizio del secolo successivo: il corrispondente pari 16.6.11/12; L'idolo cinese (1767), Rari 3.2.18/19, olim 16.7.31/32; Il furbo malac
gino dell'« Allgemeine Musikalische Zeitung » scrive nel maggio del 1802, a proposi corto (1767), Rari 3.2.11/12/13, olim 16.7.24/25/26; L'osteria di Marechiaro (1768),
to d'una rappresentazione degli Zingari in fiera·. « Ciò che ha decretato il successo Rari 2.9.9/10, olim 16.6.24/25; Don Chisciotte della Mancia (1769), Rari 2.10.4/5,
dell'opera sono stati i finali, molto belli ». Sulla stessa rivista, nel novembre del olim 16.7.3/4; L'arabo cortese (1769), Rari 3.1.16/17, olim 16.8.16/17; La Zelmira
1813, in occasione d'una ripresa viennese del Re Teodoro in Venezia, viene lodato (1770), Rari 2.7.19/20, olim 16.5.9/10; Le trame per amore (1770), Rari 2.7.13/14,
il finale primo che, a detta dell'articolista, « fa ancora il suo effetto ». Cfr. olim 16.5.3/4; I scherzi d'amore e di fortuna (1771), Rari 2.9.13/14, olim
« Allgemeine Musikalische Zeitung », ristampa anastatica, Amsterdam, Israel e Knuf, 16.6.28/29; La Dardanè (1772), Rari 3.3.11/12, olim 16.8.30/31; Il tamburo (1773),
1964, IV, p. 573 e XV, p. 770. Rari 2.7.11/12, olim 16.5.1/2; Il duello (1774), Rari 2.10.3, olim 16.7.7; Il credulo
3 Nonostante l'importanza dell'argomento, la bibliografia relativa alla forma del deluso (1774), Rari 3.3.9/10, olim 16.8.28/29; La frascatana (1774), Rari 3.2.9/10,
concertato nell'opera buffa è estremamente povera. Dopo il vecchio e notissimo olim 16.7.22/23; Le astuzie amorose (1775), Rari 3.2.7/8, olim 16.7.20/21; Socrate
articolo di E. Dent, Ensembles and finales in ISth century Italian Opera, « Sam immaginario (1775), Rari 3.2.3/4, olim 15.1.5/6; Le due contesse (1776), Rari
melbande der internationalen Musikgesellschaft », XI, 1909-10, pp. 543-569; XII, 1910
2.10.6/7, olim 17.7.5/6-, Il matrimonio inaspettato (1779), Rari 2.8.16, olim 16.6.13;
11, pp. 112-138, e la dissertazione di M. Fuchs, Die Entwicklung des Finales in der Il barbiere di Siviglia (1782), Rari 3.3.3/4, olim 16.8.22/23; Il mondo della luna
italienischen Opera buffa vor Mozart, Wien, 1932, non si sono avuti studi specifici (1782), Rari 2.8.19/20, olim 16.6.16/17; Il re Teodoro in Venezia (1784), Rari
fino al recente lavoro di D. Heartz, The création of the buffo finale in 3.2.1/2, olim 15.1.3/4; La grotta di Trofonio (1785), Rari 3.2.16/17, olim
Italian Opera, « Proceedings of the Royal Music Association », CIV, 1977-78, pp. 16.7.29/30; Le gare generose (1786), Rari 3.2.14/15, olim 16.7.27/28; La modista
67-78. Importanti, per ampiezza di documentazione, sono le pagine che Michael raggiratrice (1787), Rari 3.2.5/6, olim 15.2.10/11; L'amor contrastato (1789), Rari
3.1.3/4, olim 16.8.3/4; I zingari in fiera (1789), Rari 2.9.3/4, olim 16.5.13/14; Le
vane gelosie (1790), Rari 2.7.15/16, olim 10.5.5/6; La locanda (1791), Rari 2.8.5/6,
olim 16.6.3/4; L'inganno felice (1798), Rari 3.3.1/2, olim 16.7.33/34. Per quanto
riguarda gli Astrologi immaginari (1779), è stata consultata l'edizione moderna per
canto e pianoforte, a cura di B. Rigacci, Siena, Accademia musicale chigiana 1966.
236 FRANCESCO BLANCHETTI CONCERTATI NELL'OPERA BUFFA DI G. PAISIELLO 237
pieno sviluppo tutte le caratteristiche musicali Un e teatrali
primo dei brani dai brani di carattere sostanzi
tipo è rappresentato
precedenti. statico, con la funzione di descrivere l'ambiente in cui la com
La consuetudine di comporre « un'apertura dell'opera avrà luogo: è sempre il caso dell'invocazionea alla luna di Ecclitic
più voci e chiassosa »6 sembra affermarsi proprio finti discepoli all'epoca
nel Credulo dell'e deluso? Altrove s'incontrano pic
sordio di Paisiello. Le opere di quest'ultimo dri cominciano
di genere, a metà quasi strada sem tra un realismo corposo e un'ag
pre con un brano d'assieme, più raramente con stilizzazione.
un duetto Così, d'azione
nell'Osteria di Marechiaro (1768) e nella
(L'amore in ballo, del 1765, La Frascatana, (1770)
This content downloaded from 193.204.40.97 on Fri, 11 Jan 2019 07:22:20 UTC
del 1774).
i richiamiNell'Idolo della ragazza che vende la frutta e degli o
This content downloaded from 193.204.40.97 on Fri, 11 Jan 2019 07:22:20 UTC
cinese (1767) All use subjecttroviamo,
to https://about.jstor.org/terms è vero, un'aria del soprano,
invitano ima clientinel
All use prosie
a tavola
subject to si traducono in ripetuti salti di qu
https://about.jstor.org/terms
guo del brano entrano in scena due altri personaggi, grida della un stradatenore vengono e un poi sovrapposte alle frasi degli a
basso, le cui voci si sovrappongono a quella già sonaggi - i lamentiSolo
presente. d'amore neldel nobile Federico nell'Ost
Barbiere di Siviglia, rappresentato a Pietroburgo Marechiaro,
nel 1782, e del pescatore il brano Antuono nella Zelmira - con l'i
d'apertura è affidato ad un'unica voce, quella di del Conte
ricreare d'Almaviva
la vita in tutti i suoi aspetti e di assicurare a
(tenore) appostato sotto la finestra di Rosina. stesso L'insolita
la massima rinuncia
varietà scenica al e musicale. Un tono più m
concertato introduttivo trae origine in questo caso
come dal desiderio
di presepio, contraddistingue di invece le introduzioni d
non discostarsi dalla fonte francese.7 me per amore e degli Scherzi d'amore e di fortuna (1771
Le introduzioni paisielliane sono concepite indifferentemente l'ambiente e i personaggiin agresti (Vitantonio, « rustico dell
uno ο più movimenti (spesso tre ο quattro).cata La chemaggiorva cantando parte con ladi cetra », nella prima opera; C
esse non ha una struttura chiaramente definita, Rosaavvicinandosi
e Lisetta che fanno tutt'al
il formaggio, nella seconda) comp
più alla forma del rondò per il ricorrere di figurazioni, l'adozione di tempi soprattutto come il 6/8 ο il 12/8, dalla connotazi
strumentali, senza tuttavia un ordine rigoroso. camente
Non ' mancano pastorale ', e, negli Scherzi, l'impiego dell'oboe
però
esempi di forme ternarie, di tipo A-B-A', come unaavviene
melodia danel Credulo
pifferata natalizia.
deluso (1774), nel Socrate immaginario (1775) e Al nellecapo Due opposto contesse
stanno le introduzioni che immettono s
(1776); oppure forme strofiche, come nel quintetto nel vivointroduttivo
dell'azione, diffuse del soprattutto nelle opere della m
le Trame per amore (1770), in cui le frasi del ma contadino
presenti anche Vitantonio,
nei primissimi lavori. Nell'Amore in ballo
che canta una canzone popolare per divertire la i compagni,
prima scena coglie vengono i personaggi di Monsù e di Lisetta,
alternate ai ritornelli omoritmici delle altre voci. riera, inGli episodi
un attimo polifo
di smarrimento, mentre sentono salire i cre
nici, comunque, sono quasi sempre concentratiper le scale
nella parte di casa; conclusivanon c'è neppure il tempo per un pr
dei brani, costituendo una sorta di coda. orchestrale, giacché la voce del tenore entra dopo appena sei
Estremamente vario è il contenuto teatrale delle introduzioni.8 sillabando « Dove nascondersi se sopra vengono », su un
moto di biscrome dei violini. Numerose, negli anni successiv
le introduzioni caratterizzate, come questa, da un ritmo teat
6 G.B. Lorenzi, Opere teatrali, prefazione editoriale al tomo II, Napoli, s.e. bito serrato e incalzante: la lite di caccia nel Don Chisciotte della
1813, p. iv.
7 Le Barbier de Seville, s'apre appunto con un monologo del Conte. La
Mancia (1769), l'apparizione di un fantasma nel Tamburo (1773), il
commedia di Beaumarchais aveva ottenuto a Pietroburgo singolare favore; fu questo contrasto fra moglie e marito nel Socrate immaginario (1775); anco
il motivo che indusse Paisiello a scegliere il soggetto francese per una nuova opera
(cfr. A. Della Corte, Paisiello, Torino, Bocca 1922, pp. 74-75).
ra situazioni conflittuali nella Modista raggiratrice (1787) e negli
8 Già H. Abert (Paisiellos Buffokunst und ihre Beziebungeti zu Mozart, in
Gesammelte Schriften und Vortrdge, Halle, Niemeyer 1929, p. 387) aveva operato
una distinzione fra le introduzioni che conducono subito nel vivo della vicenda e 9 II libretto del Credulo deluso è un adattamento del Mondo della luna di
quelle in cui si ha, invece, una più lenta ambientazione. Goldoni, realizzato nel 1774 per le scene napoletane.
238 FRANCESCO BLANCHETTI CONCERTATI NELL'OPERA BUFFA DI G. PAISIELLO 239
Zìngari in fiera (1789). Occasioni per rendere sillabatoestremamente
in luogo della pomposamovi scansione dell'accordo di ton
mentata la scena iniziale non mancano certo nelle opere
corrispondente dal soggetto
alle precedenti frasi rituali.
romanzesco, tanto in voga negli anni Sessanta Spicca talvolta,
e Settantanelle introduzioni,
del secolo; l'abilità di Paisiello nel de
se ne ha esempio in opere come II furbo malaccorto
neare i caratteri, ο quantomeno (1767)
i tipi comiciο in gioco fin dal l
L'Arabo cortese (1769), le quali s'aprono, primorispettivamente,
manifestarsi. Esempio tra icon un
più significativi in questo sen
combattimento tra le milizie del Conte e una banda di « masnadie il sestetto del Socrate immaginario, nel quale si vede Don Tamm
ri » e con un naufragio in prossimità dell'« isola d'Isura ». cadere dalle scale, inseguito dalla moglie, Donna Rosa, armat
Può accadere, poi, che gli elementi dinamici convivano con quel bastone, mentre la gente di casa tenta di far cessare la lite. Il b
li contemplativi, dando origine, come nei finali d'atto, ad un susse è basato sulla contrapposizione di due incisi melodici, affidati
guirsi di situazioni teatrali diverse e contrastanti. È il caso di buona coppia dei protagonisti: da un lato l'impulsività della moglie, p
parte delle introduzioni suddivise in più movimenti, come il terzet propensa a sopportare le manie grecizzanti del marito (ma il mo
to iniziale dell'Idolo cinese, già ricordato, oppure l'altro terzetto con del contrasto si conoscerà soltanto in seguito), resa mediante u
cui ha inizio il Marchese di Tulipano (1767): nel primo movimento, tipica figurazione paisielliana che fa perno sulla ripetizione insist
un « Andantino » in 3/8, due soprani, Lenina e Lisetta, si effondo del salto di quarta; 10 dall'altro, la pazienza socratica di Don Ta
no in vocalizzi a distanza di una terza, mentre prendono il fresco maro, espressa con ridicola solennità. Anche nel Tamburo i per
sulla porta di casa (« Bello è veder nel prato / spuntar l'erbetta e i naggi vengono subito nettamente differenziati e dotati di una preci
fiori »), ma sono presto interrotte da Giorgino, tenore, che canta fisionomia musicale: la melodia espansa e ricca di fioriture di Ri
una frase in sillabato sulle parole « Non me ne importa un corno / do, parte seria, e la scorrevole parlantina delle parti buffe, Do
andatevene al diavolo »; quindi, ad un brevissimo « Largo » in 4/4 Polissena e Don Taddeo. L'opera, composta nel 1773 su libret
fa seguito un Andante, ancora in 4/4, in cui i tre litigano aperta Giambattista Lorenzi e tratta dalla commedia The drummer di
mente, con le voci contrapposte in stretta alternanza, le due ragazze seph Addison, narra la vicenda del barone di Sassofrasso, che t
insieme e Giorgino da solo. Quarto ed ultimo movimento un « Al credono morto in guerra.11 In casa sua si sono stabiliti diversi
legro » in 6/8, che vede il fuggi fuggi generale causato dall'arrivo simanti della presunta vedova, la baronessa Violante; uno di qu
del Marchese. Un analogo effetto di concitazione crescente si ritrova Riccardo, istigato dalla zia Donna Polissena, si nasconde ogni n
nella Dardanè, opera composta nel 1772, su libretto di Francesco e suona un tamburo militare per far credere ai rivali che lo spe
Cerlone e ambientata in Arabia. Nel corso del terzetto con coro inizia del barone s'aggiri per la casa. Nel quintetto introduttivo il gr
le si assiste al divorzio fra Dardanè e Muzafer: dapprima il « Coro sco balbettio di semicrome di Don Taddeo (« Io son morto e va
d'Iman e testimoni secondo l'arabo costume » canta un passo imita via / che il tamburo, gioia bella / già m'entrò nelle budella /
tivo a quattro voci («Andante», in 3/4), su un testo in lingua quel suo tarappatà »), cui fanno eco le espressioni di panico
pseudo-araba; il preludio serve a preparare l'azione vera e propria altri personaggi in omoritmia >(« Ma sto guajo, sto fraciello »)
presentandone la cornice. Nel successivo « Allegro non tanto » in terna a ricorrenti rintocchi dei timpani, accompagnati da in
2/4, intervengono i personaggi di Dardanè, di Muzafer e del Cadì, accordali di oboi e corni. Il riferimento al tamburo è dunque i
pronunciando, uno dopo l'altro, le formule rituali di ripudio previ
ste dal Corano, ma la cerimonia degenera in una lite, a cui prende
10 Incisi identici a questo di Donna Rosa si ritrovano anche in altri lavor
parte anche il Cadì, seccato per la confusione suscitata in sua pre Bardane, aria di Zafira, I, 3; Il Re Teodoro in Venezia, aria di Lisetta, II, 6;
senza. Il trattamento musicale asseconda il precipitare della situazio Scherzi d'amore e di fortuna, finale secondo, II, 18), sempre legati ad espres
d'ira e di rabbia.
ne mediante l'accelerazione ritmica prodotta dal mutamento di tem
11 La commedia inglese era già servita da modello al Conte Caramella di
po, da 2/4 a 3/8, e all'immissione nelle parti vocali di un rapido Goldoni, musicato da Galuppi nel 1749.
240 FRANCESCO BLANCHETTI CONCERTATI NELL'OPERA BUFFA DI G. PAISIELLO 241
retto: Paisiello, infatti, non prende alla lettera ra 14 (secondo le atto),
didascalie costituito da del tre estese sezioni, ognuna co
libretto, come farà invece nel primo finale, intempo,
prio una quasi scena analoga,
un finale di dimensioni minori. Vario è il nu
prescrivendo l'impiego di un vero e proprio delle tamburo.
voci: nella maggior Qui parte la dei pre casi si tratta di terzetti, qua
senza dei timpani sembra indicare la ricerca ο quintetti,
di un effetto ma non mancano comico le occasioni in cui i personaggi
più sottile, quasi a voler alludere non al rumore volti sono stesso,sei e persino ma nove al suo (nel secondo atto degli Scherzi d
riflesso nell'animo dei personaggi. L'impressione re, deltrova 1771). conferma nel
le This
differenti indicazioni dinamiche, ora forte,Quasi
content downloaded from 193.204.40.97 on Fri, 11 Jan 2019 07:22:20 UTC
oratutti piano, i concertati
segnate hannoin un contenuto teatrale d'azio
This content downloaded from 193.204.40.97 on Fri, 11 Jan 2019 07:22:20 UTC
corrispondenza degli incisivi strumentali (dei
All use subject to https://about.jstor.org/terms presentano
timpani situazioni
esubject
All use dei sceniche
fiati), intricate,
in
to https://about.jstor.org/terms colme di equivoci ed i
modo che il loro battito risulti di volta in volta rimbombante ο ni, con personaggi nascosti, travestiti ο comunque colti in atte
insinuante.12 menti inconsueti.15 I librettisti e il compositore cercano dunq
Se si considerano le opere buffe composte da Paisiello nel primo evidenziare i nodi della vicenda incorporandoli nei pezzi ch
periodo napoletano della sua carriera,13 uno degli aspetti che colpisce sottraendoli così alla povertà musicale del recitativo secco. Fa
maggiormente l'attenzione è la graduale diffusione dei brani d'assie eccezione alcuni brani di carattere prevalentemente statico, qu
me situati nelle zone centrali degli atti. Se nelle primissime partiture quartetto del brindisi nel secondo atto delle Trame per a
non si hanno altri concertati oltre alle introduzioni e ai finali d'atto, (1770) ο il quintetto della rappacificazione delle Due cont
già nel 1767, con l'Idolo cinese, troviamo un quartetto dei perso (1776), sempre nel secondo atto e ancora il terzetto degli Zinga
naggi principali inserito nel secondo atto. Nelle opere immediata fiera (1789), con gli zingari che gozzovigliano sulla piazza del p
mente successive le voci sono riunite almeno una volta prima dei costruiti tutti in forma strofica, risultante dall'alternanza di
finali, indifferentemente nel primo ο nel secondo atto, più raramente solistiche con ritornelli di tutte le voci in omoritmia, così
nel terzo. All'inizio degli anni Settanta del Settecento, poi, la pre avviene - lo si vedrà più avanti - per le festose celebrazion
senza di un concertato per ognuno dei primi due atti dell'opera è finali del terzo atto. Forme più libere prevalgono invece nei co
ormai un fatto acquisito e può accadere, anzi, che il numero di tali tati d'azione, in cui gli eventuali ritorni di materiale tematic
brani aumenti ulteriormente, fino a quattro, come nella Bardane, del seconda dei casi, vocale ο strumentale, ο l'uno e l'altro ins
1772. Certo, alcuni di essi sono ancora piuttosto brevi e non emer sembrano dettati dal desiderio di evidenziare il movimento d
gono con sufficiente evidenza dalla consueta sequela di arie e recita sonaggi in scena, più che dall'applicazione di astratti schemi m
tivi, ma in molte occasioni la loro importanza musicale e teatrale li. Ciò non significa che le strutture nettamente definite sian
appare rilevante. Nel corso degli anni i concertati a metà atto ten tutto assenti: il quartetto dell'Idolo cinese, composto secon
dono ad espandersi e formano talvolta complessi scenico-musicali di schema canonico del rondò, sta a dimostrare, anzi, come una f
notevole ampiezza, come nel caso del grande sestetto della Molina musicale precostituita possa trovare validissimi punti d'incontr
l'azione teatrale. Il brano raggruppa in scena i quattro person
principali della commedia: Tuberone, napoletano capitato molti
addietro in Cina, è stato elevato dagli abitanti di quel pa
12 In modo non dissimile Leporello (Don Giovanni, II, 14) verrà ad annunciare
al padrone l'arrivo dell'« uom di sasso »; la sua allusione al battito della porta
(« ta, ta, ta, ta ») sarà allora cantata piano, accompagnata da rintocchi dei corni. 14 II titolo di Molinara con cui l'opera è universalmente conosciuta, non
13 Terminati nel 1763 gli studi al conservatorio napoletano di S. Onofrio a sponde a quello della prima rappresentazione: essa fu infatti presentata al teat
Capuana, Paisiello trascorse tre anni d'apprendistato nell'Italia settentrionale; quindi, Fiorentini in Napoli, nel 1789, come L'amor contrastato (cfr. M. Robinson, art
nel 1766, fece ritorno a Napoli, dove rimase fino al 1776, anno della partenza per p. 101).
la Russia. Cfr. A. Della Corte, op. cit., pp. 8-41 e J. L. Hunt, Giovanni 15 Un paio d'esempi: quattro personaggi pietrificati ad opera d'un folletto, nel
Paisiello: his Life as an opera Composer, si., National opera association 1975, pp. quintetto dell'Osteria di Marechiaro-, il dialogo fra Dardanè e Don Frasconio, nel
1-14. terzetto della Dardanè, con Zafira nascosta e armata di pistola.
242 FRANCESCO BIANCHETTI CONCERTATI NELL'OPERA BUFFA DI G. PAISIELLO 243
rango di sacerdote del dio Kam; accanto a lui compare un altro
personaggio dialettale, il marinaio Pilottola, scambiato dai cinesi per
la divinità incarnata in forme mortali. All'inizio del quartetto si
Quando, nel 1763, Paisiello esce dal conservatorio napoletano
vede appunto il giovane napoletano nei panni dell'idolo, seduto in
S. Onofrio a Capuana per intraprendere la carriera di composit
una nicchia, mentre Tuberone gli si avvicina bruciando incenso e lo
teatrale, i finali d'atto hanno ormai acquistato in seno all'o
interroga circa l'opportunità che il proprio figlio Liconatte sposi la
buffa grandissimo peso. Sulla scia di Piccinni, che nella Furba b
principessa straniera Ergilla. I due innamorati, nascosti dietro la
ta del 1760 ha introdotto « la novità di finali lunghi e con v
nicchia, minacciano Pilottola con un pugnale perché dia un responso
zioni di tempi, e di metri e di motivi a somiglianza di quelli
a loro favorevole. Il falso idolo tenta di guadagnare tempo e Tube
correvano per la Lombardia »,16 Paisiello compone, già nei prim
rone lo incalza affinché pronunci l'oracolo: la frase ricorrente del
anni d'attività, finali di notevole estensione (di media quattroce
sacerdote (« Si Kamme sbrigate »), in La maggiore, tonalità d'im
battute, destinate ad aumentare con gli anni), suddivisi in più s
pianto, funge da tema del rondò, alternandosi a quelle
ni, secondo delle
la struttura che altre
Hermann Abert ha definito a caten
voci, che costituiscono gli episodi secondari, nelle tonalità della do
Fanno eccezione i finali degli atti terzi, quasi sempre brani in
minante e della sottodominante. Una coda « a unico movimento,18 nel corso al
quattro » conduce dei quali i personaggi si riuniscon
termine, con la fuga del falso idolo dalla scomoda posizione.
festeggiare il congiungimento delle varie coppie e a cantare il m
Anche nei concertati a metà atto, come nei finali,
conclusivol'impiego
della commedia: della
l'invenzione è sovente povera e sbri
scrittura polifonica corrisponde in genere a versi
va (casi limite: il finale terzocol
di commento, della Frascatana, che si esaurisce
locati al termine dell'azione vera e propria. Così, nel terzo
sole diciotto battute;atto
quellidegli
del Furbo malaccorto e àeWArabo c
Scherzi d'amore, dopo essersi fronteggiati tese,
spada
che nealla mano,
contano i tre
una trentina), con le voci sovrapposte q
personaggi aristocratici - Don Placido, Don esclusivamente
Giacinto in e omoritmia.
Donna Mar A partire dagli anni Ottanta del S
zia - s'arrestano e uniscono le loro voci in cento,
un episodio a ad
con la tendenza canone
eliminare il terzo atto dai libretti d'op
(« Ah che trattengo appena / la rabbia ed il furor
buffa, »), in
la funzione cui si fa
di celebrazione festosa del finale terzo passa a
ampio sfoggio di virtuosismi belcantistici. Altrove sono
tima sezione dellazzi
finale onoma
secondo; solo allora Paisiello riserva
topeici (« Ho nel capo un rio martello / che mimoralebatte e fa un
della favola tàtrattamento
tà », musicale più ricco, costrue
nel quintetto della Frascatana, 1774) ο espressioni di disorientamen
sulle stereotipate sentenze conclusive amplissimi episodi polifoni
to (« Oh Dio, oh Dio, la testa / mi salta qua Diverso
e là », è ilnel quartetto
discorso per i finali del primo e del secondo att
della Modista raggiratrice, 1787) a fornire il pretesto per teatrali
grandi organismi dar vita a
e musicali coincidenti quasi sempre c
momenti culminanti
costruzioni musicali autonome, nelle quali le componenti della vicenda, in omaggio alle consuetudini
descrittive
(il rapido moto di semicrome sui fonemi « tempo.tà tà Vi»,
si trova, come auspicava Lorenzo Da Ponte, « ogni ge
la ripetizione
meccanica degli intervalli di terza e di quartare di acanto »20 considerando
rendere l'ideanon delsolo la varietà agogica, ma anc
' salto ') instaurano un clima di rumorosa eccitazione ritmica. In que
16 P. Napoli-Signorelli, Ricerche sul sistema melodrammatico, Napoli, Acc
sto senso le code polifoniche dei concertati racchiudono
mia pontaniana 1812, p. in 65. sé, sia
pure in dimensioni ridotte, quel principio di puro divertimento
17 H. Abert, art. cit., p. 388. mu
sicale, che s'impone in modo macroscopico nei grandi episodi
18 Solo nel Don Chisciotte della con
Mancia e nel Tamburo si ha un finale del
terzo atto dotato d'una certa estensione e articolato in più movimenti.
trappuntistici dei finali d'atto.
19 Così nel Re Teodoro in Venezia e nelle Gare generose (vedi qui a p. 258 sg.).
20 L. Da Ponte, Memorie, New York 1823. Edizione moderna, a cura di C.
Pagnini, Milano, Longanesi 1971, p. 147.
244 FRANCESCO BLANCHETTI CONCERTATI NELL'OPERA BUFFA DI G. PAISIELLO 245
continuo mutare del clima espressivo, dai nelmomenti
tempo: con ilpiù
loro schiettamen
carattere di perpetuum mobile, arricch
te comici a quelli patetico-sentimentali ο di maggior
dall'andamento vigore
modulante dramma
verso le tonalità vicine, gli ostinat
tico. Alla successione di momenti teatrali mentali
diversi corrisponde, come
si dimostrano infatti un mezzo efficacissimo per far p
s'è detto, l'articolazione in differenti sezioni, mediamente
re l'azione,23 cinqueun'elementare
garantendo nel contempo ο unità all
sei, ognuna delle quali costituisce un brano gole sezioni a deiséfinali. stante, con la
propria struttura interna; le architetture a Se larghe
l'orchestra campate,
assume dunque in cui le
un'importanza fondamentale,
varie sezioni vengono ricondotte ad un più
This content downloaded from 193.204.40.97 on Fri, 11 Jan 2019 07:22:20 UTC
ampio
per This
questo disegno
le parti
content downloaded vocali rinunciano
from 193.204.40.97
costrutti al ruolo
on Fri, 11 Jan 2019 07:22:20 UTC tradizionale di g
vo, sono invece
All use piuttosto rare, limitate ad
subject to https://about.jstor.org/terms alcune
melodica: anche eccezioni,
All use quando
subject l'impiego qualidi ostinati
to https://about.jstor.org/terms i violinistici semb
finali del primo atto della Vedova di bel genio
lontanarle sullo(1766)
sfondo, nei e puntidel cruciali Don del dialogo esse riem
Chisciotte (1769) ο il secondo finale della no conDardanè
la massima evidenza, (1772). Anche
riportando in primo piano la fision
all'interno dei singoli movimenti Paisiello preferisce
musicale d'ogni personaggio. in genere Notevolissima ri è l'abilità di Paisiell
nunciare ad un rigoroso impianto strutturale in favore
dare concreto risalto alle di figure forme dellapiùcommedia, cogliendo co
libere e per questo più adatte a seguiredisegno l'evolversi
estremamente dellasintetico vicenda.
i lati peculiari del loro caratter
Come nelle introduzioni e nei concertati, nei anche
limiti delle qui tipizzazioni
si hanno sovente
convenzionali dell'opera buffa.24 Tr
ciclici ritorni di episodi musicali, non regolati, mo, dunque, tuttavia,
la vitalità ritmica da un delleordiparti buffe, espressione
ne preciso. I rari casi di struttura regolare ricorrono soprattutto
n'incontenibile vena comica; i melismi e gli ampi salti interv in
corrispondenza di momenti statici, quali delle arie partiο duetti
serie; oppure amorosi,
gli improvvisi pa ripiegamenti su tonalit
rentesi liriche in un contesto narrativo dominato nori di alcuni personaggi da episodi femminilid'azio appartenenti alla sfera del ten
ne: ne è esempio la scena dell'assopimento di Donna
e del sentimentale. Marzia
La caratterizzazione nel
sommaria che deriva da una
finale primo degli Scherzi d'amore e di fortuna,
simile trattata
ripartizione dei personaggi come
in categorie prestabilite, acquista
un'aria in forma tripartita. Diffusissima nei in tutta
finali la
un'efficacia produzione
particolare, pai
poiché i differenti registri espressi
sielliana21 è l'abitudine di costruire intere sezioni dei finali basan vi, sottratti all'isolamento delle arie, vengono posti a stretto contat
dosi sulla ripetizione continua di incisi strumentali, eseguiti per le to l'uno con l'altro, senza mediazioni. La stessa appartenenza di un
più dai violini primi, in evidenza rispetto alle voci. Privi di vera e personaggio a questo ο quel tipo teatrale non va intesa in termini
propria dignità tematica, essi si differenziano da un comune basso rigidi e immutabili, ma va verificata in ogni singola situazione della
albertino per la presenza di rapide note di passaggio e per una più commedia: così la sospirosa Clarice degli Astrologi immaginari
pungente articolazione ritmica, mentre le voci si sovrappongono ad (1779), piange durante il primo finale la propria sorte di ragazza
essi limitandosi ad eseguire un semplice declamato. Tale procedi segregata in casa, cantando un languido « Larghetto » in 6/8 e
mento compositivo, che Giuseppe Carpani definisce « un bel ritro
vato del celebre Paisiello »,22 forma l'impalcatura musicale di quasi
23 Efficacia che viene meno, però, nel momento in cui gli ostinati sono protratti
tutte le scene contenenti un'azione ο un dialogo a lungo protratti troppo a lungo, generando monotonia e cali di tensione: difetti, questi, dai quali
Paisiello non è sempre indenne, anche se il più delle volte le ripetizioni sono
accortamente dosate.
21 Anche negli altri brani d'assieme e nelle arie. 24 L'autore stesso pare esser stato pienamente consapevole di questa sua voca
22 G. Carpani, Le Rossiniane, Padova, s.e. 1824, p. 19. Figurazioni simili sono zione teatrale, come dimostra la frase (riportata dal Ferrari, op. cit., p. 98), in cui
presenti in realtà già nelle partiture di Piccinni e si possono far risalire alla egli riassume con colorita espressione dialettale le proprie qualità di compositore
scrittura orchestrale degli operisti napoletani della prima metà del Settecento (cfr. operistico: « Se tu mi parli di esprimere la parola, di combinazioni armoniose, di
M. Robinson, op. cit., p. 235). Radici più remote possono forse essere individuate far cantare un pastore, un buffone, un guerriero, un'eroina nel loro proprio caratte
nell'antico procedimento della perfidia, definito dal Brossard (Dictionaire de musique, re, se mi parli di effetti teatrali, ti dirò ca io nun mme metto paura 'è nisciuno ».
Parigi, Ballard 1703) « [...] une affectation de faire toûjours la même chose, de Vedremo più avanti quale importanza sarà da attribuire al termine « effetti teatra
suivre toûjours le même dessein [...] ». li ».
246 FRANCESCO BLANCHETTI CONCERTATI NELL'OPERA BUFFA DI G. PAISIELLO 247
nella tonalità di Sol minore, ma, alcune paginesecondo); ildopo,
contratto è dipronta
matrimonio a tra Rosina e il Conte nel
litigare con la sorella Cassandra e a inveire contro di lei
biere di Siviglia conquarto);
(finale brevi il edialogo tra Gelinda e Bastian
pungenti incisi di crome, nello stile delle parti
coppia buffe.25 Un'analoga
di sposi perseguitata dai creditori, nel primo finale d
divaricazione stilistica tra serio e buffo caratterizza,
Gare generose nel finale
(1786), quandosecon
i due, rimasti per un attimo soli
do del Tamburo, la parte del Marchese, cavalier servente
scena, prendono della
la decisione ba
di fuggire; quindi, nel finale seco
ronessa Violante: all'inizio del concertato egli si rivolge
della stessa alla nobil
opera, il rinvenimento d'una cambiale che determin
donna intonando su una ridicola strofetta arcadica
scioglimento (« Vezzosa
dell'intrigo. Clori,
L'elenco potrebbe continuare a lungo
/ perché non senti / gli aspri lamenti /ognuno del tuo pastor
di questi ») una
casi la scansione ritmica regolare s'arresta e le
melodia galante («Andantino», 6/8), ma viene in aseguito
s'alternano interrot
semplici accordi orchestrali, prima d'essere nuovam
to dall'intervento di un fantasma, in realtà coinvolte
il rivale Riccardo
nel rapido, trave
incalzante svolgersi degli eventi scenici.
stito. Da buon « disprezzatore delle larve e degli Un contributo
spiriti fondamentale
» - così lo alla definizione di personaggi e
definisce il Lorenzi nell'elenco dei personaggi tuazioni
del è suo
dato dall'orchestra.
libretto -Notevole il importanza in questo se
Marchese ride del panico degli altri, ma quando si trova
assume l'elemento faccia
timbrico, pur entro a i limiti di un'orchestrazi
sostanzialmente
faccia con il finto spettro perde tutta la propria sicurezzapovera,e a trova
causa della scarsità d'organico dell
appena la forza di balbettare qualche parola chestre
di scusa;napoletane,
il suo almeno per quanto
canto si riguarda i teatri dell'op
trasforma allora in un comico sillabato, reso spigoloso
buffa.28 Subordinati aglidall'abbon
archi ed utilizzati prevalentemente per
danza si salti di settima, com'è tipico dei bassi
guirecomici
note lunghe paisielliani.
ο per rinforzare le cadenze, gli strumenti a f
Non sempre però la presentazione del materiale
escono talvoltamelodico
allo scoperto: ildà fatto acquista allora, proprio p
luogo a una distinta articolazione delle partisua vocali: altrettanto
relativa rarità, nu
particolare evidenza. L'impiego degli ottoni r
merosi, soprattutto nei momenti di maggiore re concentrazione
ogni volta che i personaggi narrati
fanno sfoggio di pomposa magnif
va, sono i casi in cui gli interventi delle za.
varie voci iseguono
Sono appunto un
corni ad accompagnare l'ingresso in scen
Tonina
unico modello ritmico, molto spesso dattilico, cone Don
minimeLuigino variazioni
travestiti da spagnoli, « serj e gravi »,
nel movimento intervallare.26 In casi come suono
questo il dialogo
di maestoso concertoscorre
», nel finale secondo delle Trame p
via senza grandi problemi di caratterizzazione, mentre
amore, l'uniformità
commedia basata come tante altre su finzioni e travestim
ritmica conferisce ad esso un aspetto meccanico che
La comicità ne accentua
diventa scoperta nellala
scena del litigio tra Don Ma
vis comic a Τ tonio e Don Ercolino, nel primo finale delle Astuzie amor
Piuttosto diffusa è l'inserzione di frammenti di recitativo accom (1775); la didascalia del libretto recita: « al suono di allegra ma
pagnato in corrispondenza di momenti di sospensione da cui dipende vengono di nuovo [...] tutti e due ridicolosamente vestiti con lan
l'esito della vicenda: la lettura d'un messaggio nella Dardanè (finale scudi, cimieri ed usberghi, e si pongono con tutta formalità in
di duellare ». Qui la boria dei personaggi è espressa, oltre che d
fanfare dei corni, anche dalle voci, tese in trionfalistici vocali
25 Gli astrologi immaginari, edizione per canto e pianoforte a cura di B. così come avviene in una scena analoga del Matrimonio inaspet
Rigacci, Siena, Accademia musicale chigiana 1966, pp. 107-110 e 123-124.
26 Meno comuni, ma non del tutto assenti, sono le pagine in cui circolano tra (1779), che vede l'impiego delle trombe. Altrove il timbro d
le voci frasi assolutamente identiche, sia sotto il profilo ritmico, sia sotto quello strumenti a fiato è associato all'idea di ambienti esotici: incisi r
melodico, tutt'al più trasportate alla dominante ο alla sottodominante.
27 Friedrich Lippmann fa notare come i compositori italiani (Piccinni, Paisiello e
Cimarosa) prediligano « la ripetizione ' meccanizzata ' di frasi, ritmi, motivi, soprat
tutto nei punti culminanti dei grandi concertati [...] » (Haydn e l'opera buffa: tre 28 Cfr. M. Robinson, op. cit., p. 161 e F. Degrada, L'opera napoletana, i
confronti con opere italiane coeve sullo stesso testo, « Nuova rivista musicale Storia dell'opera, a cura di G. Barblan e A. Basso, I, Torino, Utet 1977, pp. 2
OSA
italiana», XVII, 1983, p. 246).
248 FRANCESCO BLANCHETTI CONCERTATI NELL'OPERA BUFFA DI G. PAISIELLO 249
renti dei corni scandiscono, nell'Arabo cortese, la vicenda
libretti d'opera del primo
buffa, soprattutto in quelli a soggetto roman
finale; corni ed oboi salutano l'arrivo del mercante
Paisiello ricorreArmarmottin di
in questi casi a gesti orchestrali più decisi,
Aden e del suo seguito nella Dardanè (finale secondo).29
prestito dall'opera seria, come tremoli e rapide scale degli a
Morbide figurazioni dei legni fanno eco figurazioni alle effusioni sincopate; amorose ad essi s'aggiungono di altri elementi sti
alcuni personaggi (i clarinetti nel Re Teodoro natura vocale in Venezia,e strumentale: mentre il declamato delle voci, arrest
Sandrino s'aggira per l'atrio della locandalunghe in cerca quando della il testo prevede sua Lisetta; espressioni di stupore, mod
oboe e fagotto soli come accompagnamento
This content downloaded from 193.204.40.97 on Fri, 11 Jan 2019 07:22:20 UTC
improvvise,
al lamento il tutto dominato d'amore da una didinamica straordinar
This content downloaded from 193.204.40.97 on Fri, 11 Jan 2019 07:22:20 UTC
Gelinda,All use nelsubject tofinale ricca, che
primo delle Gare generose)
https://about.jstor.org/terms oppurefaAlllarghissimo
use subject sono uso della stretta alternanza di pia
presenti,
to https://about.jstor.org/terms
con funzione parodistica, nelle scene in cui forte, di crescendo, dipersonaggi
compaiono sforzando. Ne scaturisce un discorso
travestiti da ombre,30 ad esempio nel finale dotato secondo
di grande energia degli interna Scherzi e di un'eccezionale forza pr
d'amore, quando si vedono arrivare Don Placido nei confronti e Rosadell'azione. vestiti Si veda con ad esempio come la modul
« candidi veli », accompagnati da una frase relativo dei minore, mediante un brusco
clarinetti.31 Unaarresto sull'accordo di
profonda suggestione notturna s'irradia dall'alone di sensibile intimbrico sforzando, dia dei rilievo all'imprecazione del Co
fiati
in un passo del finale secondo della Trascatana·, preso dai propri unanemici zuffa nel fra finaleoppo primo dell Osteria di Ma
ste fazioni di uomini armati, nell'oscurità (es.della
2); nel notte, finale secondo si èdella appena stessa opera il salto modu
conclusa con la fuga dei contendenti attraverso il bosco e i due inna
Es. 1
morati, Violante e Nardone, che in precedenza si erano nascosti per
evitare il pericolo, possono ora uscire allo scoperto; la loro compar
, 'nihihih
sa è annunciata da una frase che, esposta da violini, flauti e corni, e
poi ripresa dalle voci, dà inizio alla terza sezione del finale (es. I).32
Diverso è il trattamento dell'orchestra in presenza di eventi e
situazioni di particolare tensione drammatica, quali abbondano nei
29 Le orchestre ridotte dei teatri napoletani non consentivano
Or che in pla- ci-do si-evidentemente
I en- - zio quel ru~ mor S'e gia can-gia - to [ecc.J
maggiore ricchezza timbrica. Nella « marcia cinese » del secondo atto della Locanda,
[Gli strumenti raddoppiano il canto ripetendo 2 volte |e prima tre baJtLde]
opera scritta per il teatro londinese del Pantheon nel 1791, Paisiello potrà impiegare
un organico ben più numeroso, comprendente oboi, clarinetti, fagotti, corni, piattini
e tamburi. Es. 2
30 È evidente l'allusione alle ' arie d'ombra ' dell'opera seria. Cfr. H. Abert,
W. A. Mozart, I, Lipsia, Breitkopf & Hartel 19789, p. 187, nota, e M. Robinson,
Conte
op. cit., ρ. 82.
31 Tra gli operisti del Settecento Paisiello fu uno di quelli che manifestò
maggiore interesse per il clarinetto. Nelle opere buffe composte per i teatri napole
tani l'inserzione di tale strumento rimase sempre un fatto saltuario (Gli scherzi
d'amore, Il duello)·, scrivendo invece per le corti di Pietroburgo e di Vienna Archi <
Paisiello ebbe spesso occasione di impiegare il nuovo strumento in passi concertanti
di notevole interesse, nei brani d'assieme come nelle arie. Se ne hanno esempi, oltre
che nel Re Teodoro (Vienna, 1784), anche in alcuni lavori composti in Russia: La
serva padrona (1781), Il barbiere di Siviglia (1782), Il mondo della luna (1782) e
l'oratorio La passione di Gesù Cristo (1783).
33 I libretti di questo tipo sono spesso caratterizzati da una tendenza all'iperbo
32 Come non pensare alla sortita di Figaro (« Tutto è tranquillo e placido ») le, dietro alla quale sembra talvolta nascondersi un atteggiamento ironico, anche se
nel finale quarto delle Nozze di Figaro? Mozart potrebbe aver conosciuto la non è sempre facile stabilire quando le situazioni sono volutamente caricate e
Frascatana in occasione della rappresentazione viennese del 1783 (cfr. A. Loewen quando, invece, sono prese sul serio.
berg, Annals of opera, I, 2" ed., Ginevra, Societas Bibliographica 1955, p. 339).
250 FRANCESCO BLANCHETTI CONCERTATI NELL'OPERA BUFFA DI G. PAISIELLO 251
terza (da Re maggiore a Si bemolle maggiore)già dà
interna all'invenzione paisielliana,
l'impressione del che negli episodi precede
costituiva le nervature
passaggio ad una nuova sezione, anche senza mutamento della narrazione,
agogico, nel nei concertati statici co
sivi uno
momento in cui il genio della bottiglia compie si libera in un
dei gratuito,
suoi sfrenato vitalismo, in seno a cui tr
prodigi,
facendo saltare in aria e sparire il personaggio no risoluzione tutte le tensioni
dell'Abate. accumulate nel corso del finale. Diff
Simili
scatti in avanti del discorso musicale sono assai numerosi. Ecco rente è il rapporto tra musica e testo introdotto negli episodi
ancora un paio d'esempi: nel finale primo del Marchese di Tulipano zione e in quelli statici: nei primi, le battute dei personaggi ve
un repentino scoppio di rabbia del Marchese determina il passaggio no musicate quasi sempre una volta sola36 e il dialogo procede
da un « Andante » in 3/4 ad un tempo di 3/8, mentre la voce di la massima scioltezza; la polifonia ne è pressoché bandita, s
basso esegue un energico sillabato; nella Zelmira (finale secondo) brevi interventi omoritmici che sono parte integrante del fluss
l'accendersi d'una zuffa fra napoletani ed olandesi viene sottolineato logico. Nelle ' strette ', invece, le parole vengono più volte ripet
mediante una brusca modulazione a Do minore, su un tremolo degli sia che rientrino in un discorso diretto, sia che abbiano caratter
archi in forte-piano. Interrompendo il fluire indistinto degli accom commento « a parte »; accade persino che siano ripresi non
pagnamenti orchestrali ο le simmetrie delle frasi vocali, gli stilemi singoli versi, ma interi gruppi di versi, in modo che le stesse st
considerati fanno risaltare in modo nettissimo gli accadimenti crucia servano da testo a più d'una sezione musicale, come nel caso
li della commedia e danno la misura dell'immediatezza espressiva del due primi finali della Zelmira.
teatro paisielliano, così sovente proiettato alla ricerca di quegli « ef All'interno degli episodi di ' ripieno ' le voci vengono dispost
fetti teatrali » nei quali, come s'è visto,34 il musicista si sentiva seconda dei casi, in omoritmia, oppure con sfasature ritmiche. Paisi
particolarmente versato. lo tende ad adottare la seconda soluzione quando nel testo pr
gono generiche battute di commento e a preferire la prima in
Nella già citata prefazione alle commedie per musica di Giam senza del discorso diretto, quando cioè i personaggi, riuniti in g
battista Lorenzi, l'anonimo editore passa in rassegna le convenzioni pi contrapposti, si fronteggiano apertamente, pur in situazioni
dell'opera comica napoletana. Così a proposito dei finali d'atto: damentalmente statiche (in quanto non soggette ad ulteriori svi
pi). Nel finale primo dell Osteria di Marechiaro, ad esempio
[...] si conchiude finalmente l'Atto primo con un finale di sette, ο otto
assiste al contrasto fra due opposti schieramenti: da una parte
scene, quale poi deve terminarsi, con un ripieno, in cui tutti gli Attori
diranno le stesse parole, siano ο no confacenti al loro carattere, facendo coppia formata dal Conte e dalla popolana Chiarella, spallegg
colle voci, e strumenti una rumorosa sinfonia con imitazioni, canoni, dall'oste Carl'Andrea; dall'altra Lesbina e Dorina, che hanno ric
fughe, e strette, onde con grandi rumori, e grida termini l'Atto [...].35 to dal Conte formale promessa di matrimonio e pretendono so
sfazione, sostenute rispettivamente dall'Abate e dal Marchese (
Com'è noto, la scrittura polifonica coincideva con scene teatralmente 3). In altri casi la contrapposizione è tra un solo personaggio (L
statiche, durante le quali lo sviluppo dell'azione, raggiunto il punto dro nelle Due contesse, Bastiano nelle Gare generose) e il gru
culminante, s'arrestava, lasciando spazio ai commenti dei personaggi. degli altri.
Non necessariamente le parole erano le stesse per tutti; quello che è Quanto è stato notato a proposito del trattamento omoritm
certo, comunque, è che i singoli caratteri annegavano nel vortice non costituisce però regola fissa, dal momento che è possibile
della « rumorosa sinfonia ». Tale atteggiamento di disimpegno dram viduare casi in cui la sovrapposizione accordale corrisponde a v
matico si manifesta pienamente anche nei finali di Paisiello. L'ener di commento o, più raramente, casi di incastri tra le voci anche
testi di tipo dialogico. In linea di massima, comunque, l'alterna
34 Cfr. la nota 24.
35 G. B. Lorenzi, op. cit., ρ. ν. 36 Salvo certe ripetizioni delle parti serie, di tono parodistico.
252 FRANCESCO BLANCHETTI CONCERTATI NELL'OPERA BUFFA DI G. PAISIELLO 253
Es. 3 naggi seri inveiscono l'uno contro l'altro, le parti buffe par
Allegro le grida dei due al verso d'una gallina, eseguendo un cano
Chianzlla
„ .
fL » 9 —— mentale costituito da un moto martellante di crome. L'usanza di
contutti trenta contut-ti tren-ta. contutti mettere in musica una serie di richiami onomatopeici, antica eredità
Lesbina
Dorina
del madrigale dialogico tardo-cinquecentesco, era piuttosto diffusa
nell'opera buffa napoletana, già nella prima metà del Settecento.37
Abate
This content downloaded from 193.204.40.97
Paisiello s'inserisce dunque in una tradizione preesistente, rinnovan
Marchese [1_ . on Fri, 11 Jan 2019 07:22:20 UTC This content downloaded from 193.204.40.97 on Fri, 11 Jan 2019 07:22:20 UTC
contutti no subject
All use - i . . .todcvrai combat - te-r* k k k contutti no - i ...
https://about.jstor.org/terms dola in più di un'occasione. Nell'episodio « a nove » con cui termi
All use subject to https://about.jstor.org/terms
J K , K
na il primo finale della Zelmira, ad esempio, il testo delle due parti
dialettali non è altro che un rumoroso susseguirsi di esclamazioni
(« turre, turre »; « zirre, zirre ») ad imitare il rumore della ruota
che strazia il cervello dei personaggi disorientati (es. 4). Coinvolti
nella confusione generale essi perdono la loro individualità, mentre
cade ogni legame con l'azione precedente: se ne ha la prova osser
vando come la cellula ritmica comune a sette delle nove voci so
vrapposte compaia già alcune pagine prima, in una frase della sola
Zelmira che, grazie alla tonalità minore e all'abbondanza di pause,
risulta pienamente rispondente al carattere della protagonista, erede
diretta della Cecchina picciniana38 (es. 5). Trasportata alla tonalità
di Sol maggiore ed inserita nella grande macchina del concertato, la
frase di Zelmira viene sottoposta ad un processo di meccanizzazione,
fino a perdere ogni precedente connotato espressivo.
I due episodi trascritti rivelano chiaramente la natura elementare
del contrappunto paisielliano, costituito da cellule ritmico-melodiche
- ma spesso il secondo termine è escluso - continuamente ripetu
te, in modo da determinare la successione regolare di accordi di
tonica e di dominante.39 Il discorso musicale procede così in senso
tra omoritmia e intrecci polifonici riman
mento dell'autore nei confronti delle si
37 Ne parla il Robinson, op. cit., p. 208, recando come esempio il primo finale
soluzione è ancora in certo
dell'opera di Leonardo Leo, Amor vuol qual
sofferenza modo
(Napoli, 1739), in cui tre
drammatiche (anche se alla
personaggi dialettali si rispondonolunga tale
imitando versi animaleschi (della rana, della sub
pecora e della mosca). L'opera di Leo è pubblicata in edizione moderna a cura di
contraddetta dalle ripetizioni
Giuseppe Pastore (Bari, Società di storia testuali
patria per la Puglia 1962). di i
la seconda, invece, il 38discorso
Zelmira è una nobile turca fuggita da Istanbul musicale
in seguito a incredibili
autonoma e a slittaredisavventure
verso e rifugiatasi sotto falso
la nome alla
sfera« marina del Granatiello del
» (così g
suona il sottotitolo dell'opera). Il libretto di Francesco Cerlone è ispirato al
natura burlesca dei versi,
romanzo di Pietro Chiari, spesso consiste
La turca in cimento ο sia l'avventure di Zelmira,
come l'onomatopea e Napoli, Flauto
il 1768-69.
non-sense. Un esem
39 Anche nelle pagine contrappuntistiche è dunque possibile rilevare quel carat
si trova nel finale secondo
tere meccanico di cui parla il Lippmann del Furbo
(cfr. la precedente nota 27). m
CONCERTATI NELL'OPERA BUFFA DI G. PAISIELLO 255
254 FRANCESCO BLANCHETTI
Es. 5
Es. 4
Allegro presto
Allegro presto Zelmina
Giuliella
cab ca- fc
ah calo vota vo-ta,
pc me vota, vo - ta,arrusso
arrossosisi--a,comm'a
a,comm'a na
nu ro-'tache
ro-ta che turrz
tUrm tur-re
tur-re da
de. prexo
presso
Norella
Morella
Rina
Zelmira
Don Ricct
circolare e l'impressione che ne deriva è quella di un moto che
potrebbe protrarsi all'infinito. Gli episodi polifonici vengono talvolta
ripresi con l'aggiunta di nuove voci, fino all'impiego dell'organico
completo: nel finale della Zelmira appena considerato sono le due
DonMartino
Don Martino
parti dialettali a proporre per prime la loro frase, quella con i salti
ah lo car-vieL- lo me gimattUor- no comm'a na pul- la che.malo tuornochezir-re
d'ottava, quindi s'aggiungono le altre parti, cosicché il numero delle
d ^ J *· \ Aj. a.
voci passa da due a sei e, in ultimo, a nove; qualcosa d'analogo si
oboi
comi
r t S-' r ^ i —z—
r ^ riscontra nelle Trame per amore (finale primo) e nella Dardane
(finale secondo): non si tratta, in realtà, d'uno sviluppo organico,
bassi
2 J * ma di una giustapposizione di momenti diversi, tanto più che, una
volta raggiunta la massima sonorità, si ricomincia da capo, con due
ο tre voci soltanto, in un gioco di pieni e vuoti che esclude il
fa
fa iurre
torretur-m tur-ra
tur-re tur-retur-re
tur-re tor. re tur-m [eccJ
tur- re tur-m [eccJ
principio del divenire.
[contenuta]
[contcnutbj
Le caratteristiche fondamentali dei finali e dei concertati di Pai
siello, fin qui descritte, si ripetono puntualmente in quasi tutti i
Z.
DR.
gom
gam - braa.se-
hraase- gno brani, per più di trent'anni. Con l'andar del tempo, però, agli ele
,J ï.i—L
■J
O.
D.Rx menti costanti se ne aggiungono altri nuovi, anche se ciò avviene in
modo graduale, tanto che risulta difficile isolare singoli momenti
nell'ambito della produzione paisielliana senza creare cesure arbitra
[contenutoj
[contenutoj rie. Si può comunque affermare che le innovazioni riguardino so
prattutto le opere composte negli anni Ottanta e Novanta del Sette
gir- re defitta fu Zir-re Zir-re eir-re Blr-re. cento, vale a dire durante quella che l'autore stesso definì la « terza
, L* ' Ìllf I ì epoca » della propria vicenda artistica.40 Inoltre, sarà bene chiarire
subito che la presenza di innovazioni non determina necessariamente
40 Si veda la lettera scritta nel 1811 all'amico Gioacchino Avellino e pubblicata
da N. Cortese, Un'autobiografia inedita di Giovanni Paisiello, « La rassegna musi
cale », III, 1930, p. 129.
256 FRANCESCO BLANCHETTI CONCERTATI NELL'OPERA BUFFA DI G. PAISIELLO 257
un aumento di qualità, ma soltanto un arricchimento del
appariscente della vocabolario
scrittura paisielliana degli anni Ottanta e Nova
musicale a disposizione del musicista. inseriti nel cuore dei finali a coronamento di scene cruciali,
Un primo fattore di novità consiste nella maggiore diffusione
creano uno sfogo di carattere dei
lirico prima di ulteriori sviluppi
brani d'assieme all'interno d'ogni lavoro, fino a costituire,
vicenda. Anche qui, come talvolta,
nelle ' strette l'invenzione paisiell
la metà dell'intera partitura. L'aumento delletende
dimensioni riguarda
ad evadere verso l'universoindella musica pura; ciò non av
ne però
modo particolare i finali d'atto che raggiungono sotto il segno
ormai, dell'eccitazione ritmica {si riveda l'es
mediamente,
le This
ottocento battute. Essi non sono solo molto
content downloaded from 193.204.40.97 on Fri, 11 Jan 2019 07:22:20 UTC pio This mapiù
4),content grazieampi
downloaded all'immissione
from
che in
193.204.40.97 on Fri, 11 Jand'una ricca
2019 07:22:20 UTC vena melodica ch
passato, All ma tendono
use subject a diventare organismi più
to https://about.jstor.org/terms luogo complessi
a morbidi subject to e
All use intrecci articola
tra le parti. Prendiamo come esempio
https://about.jstor.org/terms
ti, secondo un processo di rinnovamento attuato primo finalegià del alla base, in
Re Teodoro nei Venezia·. Teodoro, re di Corsica
libretti. All'interno delle opere del primo periodo napoletano,41
esilio a Venezia,44 alloggia nella locanda l'a di Taddeo, insieme al p
zione seguiva un percorso, per così dire, rettilineo, prio ministrodurante Gafforio; nelle il prime
quale pagine del finale il re spodes
gli avvenimenti si susseguivano nel modo chiede più semplice
al ricco locandiere possibile, la mano della figlia Lisetta, di cu
senza sovrapposizioni di vicende e di eventi innamorato, scenici secondari.non senza il secondo Valga fine di mettere le mani sui s
per tutti l'esempio del finale primo dell'Osteria
del padre. Ladi Marechiaro
prima sezione («Andante», 4/4) termina con
(1768), il cui contenuto consisteva unicamente brevenelle
spunto diverse fasi del
imitativo a quattro voci, sul testo « merta ben p
contrasto, via via sempre più acceso, fra il Conte
no e scusa e /i quel
suoi avversari.
silenzio e quel timor » (il silenzio di Lisetta, c
Nei finali della « terza epoca » il progredire non
della vicenda
sa come rispondere è alle
invece
offerte di Teodoro). Più avanti, do
sovente tortuoso, articolato in episodi diversi, con gli
alterne vicende attori
che vedono che
la momentanea presenza in scena di
vanno e vengono per la scena, determinando assembramenti
personaggi, Lisetta, ripudiato e svuo
il fidanzato Sandrino, dichiara d'a
tamenti repentini.42 La continuità dell'azione è spesso
sentire alle nozzeinterrotta
con l'ex sovrano, da di cui ignora la sorte. I per
cesure, in corrispondenza delle quali gli autorinaggidei libretti
commentano ' a mettono
parte ' il suo cambiamento in un seco
in bocca ai loro personaggi espressioni comuni di acommento.
episodio canone, ora a sei voci,In tali
che chiude la terza sezione («
punti Paisiello è solito raccogliere le voci in dante
brevi passi
», 2/4). polifonici,
In entrambi gli episodi le frasi comuni alle varie
per altro assai meno sviluppati degli episodidescrivono
conclusivi. un arco Nonmelodico che nei rispetto ai rudimentali s
più ampio
finali dei primi anni mancassero espressioni ti di commento
canonici pronuncia
delle ' strette ', costituiti da un meccanico moto per
te da più personaggi contemporaneamente, ma si brevi.45
vo di note trattava per lo più
di rapide esclamazioni musicate in omoritmia, Trache non
le parentesi originavano
polifoniche spicca, per risonanza sentimentale,
pause vistose nel procedere dell'azione, mentre solo in rarissime
occasioni le voci erano combinate contrappuntisticamente già nel
44 Per quanto riguarda la figura storica di Teodoro di Neuhoff, cui s'ispira il
corso dei finali.43 Nelle opere più tarde gli episodi polifonici
libretto di Casti, sono,
si veda l'articolo di E. al
Bonora, Il «Teodoro in Corsica» e i
melodrammi giocosi di Giambattista Casti, «Giornale storico della letteratura italia
contrario, piuttosto numerosi e costituiscono forse la novità più
na », CXXXIV, 1957, pp. 169-248.
45 Spunti imitativi non molto diversi dal secondo canone del Re Teodoro si
trovano nell'ensemble con coro dell'opera di Grétry, Richard Coeur-de-Lion (atto
41 Cfr. la nota 13. terzo), composta anch'essa nel 1784 (si veda lo spartito per canto e pianoforte, a
cura di L. Narici, Parigi, Choudens s.d., p. 69 e sgg.). È estremamente difficile, allo
42 Già alcuni finali degli anni Settanta si avvicinavano a tale complessità stato attuale delle ricerche, rendere conto dei rapporti, sicuramente esistenti, tra
scenico-narrativa: il finale primo degli Scherzi d'amore (1771), il secondo delle opera buffa e opéra-comique. I cosiddetti ensembles de perplexité dell'opera francese
Astuzie amorose (1775) e, più degli altri, il finale notturno del secondo atto della non dovevano comunque essere sconosciuti a Paisiello, dal momento che in Russia,
Frascatana (1774). Si tratta ancora, a quell'epoca, di eccezioni. dove il musicista soggiornò dal 1776 al 1784, le opere di Grétry e Monsigny
43 Ad esempio, nel primo finale della Zelmira (1770) ο nel secondo del Socrate venivano spesso rappresentate (cfr. A. Mooser, Annales de la musique et des
immaginario (1775). musiciens en Russie au XVIII siècle, Ginevra, Mont-Blanc 1948-51).
258 FRANCESCO BIANCHETTI CONCERTATI NELL'OPERA BUFFA DI G. PAISIELLO 259
l'episodio a tre voci del finale secondo delleprattutto
Gare pergenerose
quanto riguarda (1786). le voci acute (per esempio
La vicenda ha luogo in America, sullo sfondo sodio a d'unsei voci ambiente
che conclude gli merZingari in fiera, del 1789),
cantile dominato da cambiali e interessi di l'abitudine
prestito. di frantumare
Nel corso il testo
del poetico isolando negli intr
secondo atto Mister Dull ha scoperto che latrappuntistici
schiava Dianina, le singole parole,di cui separate dai versi di cui fann
è intensamente innamorato, serviva in casa sua sotto
Al termine delle Gare falso nome.
generose, ad esempio, la parola ' fest
Gelinda (così si chiama in realtà) è sposata passacon di vocel'altro
in voce in schiavo di
un fitto incrociarsi di richiami.47 Al
casa, Bastiano: i due hanno mutato nome e modo,tenuto nel grande
nascosto sestetto il con
lega cui termina il Re Teodoro («
me che li unisce per far perdere le loro una tracce ruota ai è il creditori,
mondo », il cuima testo fa riferimento alle
vicende
questi sono riusciti ugualmente a trovarli. Nel corsodella del
sorte)finale
sono ormai s'odesemplici frammenti di vers
appunto la fanfara dei fiati che annuncia in disu, lontano
chi in giù ») l'arrivo
a dare luogodel a comici ' madrigalismi
delirante alternanza
« Baglivo » con le guardie, venute ad arrestarli come di salti ascendenti e discendenti
debitori insol fra le voci.
venti. Mister Dull compie allora uno dei gesti di generosità ai quali
allude il titolo dell'opera, facendo fuggire Ila brani d'assieme rappresentano
coppia da una dunque
porta nell'opera buffa di Pai
secondaria: prima di separarsi i personaggi siello una forma in continua
invocano un aiuto espansione:supe
i finali d'atto diventano nel
riore (« ombre amiche un denso velo / or si corso degli anni sempre
spanda perpiù ilampi ed articolati;
cielo / eparallelamente ad
essi,cantato
ci salvi per pietà ») in un episodio a tre voci come di riflesso, anche gli altri concertati
sottovoce, consi moltiplicano e
i due sposi (soprano e basso) che si effondonoaumentano di proporzioni.
in ampie Ciò nonmelo
frasi implica, tuttavia, una vera e
diche a distanza di decima, sostenute dalla seconda
propria voce
evoluzione stilistica, di basso
dal momento che, come s'è visto, alcu
(Mister Dull).46 ne componenti basilari della scrittura paisielliana ricorrono costan
Se, dunque, l'impiego della polifonia già temente,
neldaicorsoprimi agli ultimi
dei lavori,
finalipur raggiungendo di volta in
rappresenta un arricchimento del linguaggio volta paisielliano,
una diversa qualità inventiva. Le poche an
è vero innovazioni introdotte
nel periodo della maturità,
che che le parentesi polifoniche risultano incorporate innestandosi
negli su un terreno già assestato,
episodi
10 arricchiscono senza mutarne sostanzialmente
d'azione senza che venga meno la consueta contrapposizione fra la la conformazione.
L'atteggiamento
parte iniziale e centrale dei brani e gli episodi dell'autore è tipico
di ' ripieno di un'epoca in cui comporre per
' concen
11 teatro significava
trati nella parte conclusiva. Quest'ultimi aumentano di fornire al pubblico un prodotto che desse ogni
proporzioni
per fare da contrappeso a finali più ampi volta(il settimino
vita nuova con cui
ad un modello collaudato, lasciando inalterati alcu
termina il primo finale del Re Teodoro, conta ni elementi da di fondo.48
solo La fedeltà
più alle diconvenzioni
due non esclude però
cento battute) e sono sovente suddivisi al loro interno
la precisa consapevolezza in sezionirivestita dai brani d'assie
dell'importanza
me nell'economia
distinte. La scrittura contrappuntistica di Paisiello dell'opera buffa,
continua insulmolti
duplice versante della funzio
casi ad essere estremamente semplice, consistente nella sovrapposi
zione di incisi comuni alle varie voci, ripetuti 47 L'episodioall'infinito,
costituisce il motto conclusivosudell'opera
un (« Ed andiam de' genero
si / questealcune
telaio armonico elementare. Si notano tuttavia gare a festeggiar »). Come s'è detto
novità, qualiin precedenza, nelle opere in due
atti è l'ultima sezione del finale secondo a celebrare il lieto fine.
l'immissione in taluni brani di una più spiccata venaa questo
48 Emblematica, melodica, so dei rimaneggiamenti del Bar
proposito, è la vicenda
biere di Siviglia: nella prima versione, in quattro atti (Pietroburgo, 1782) la
fedeltà quasi assoluta al testo di Beaumarchais comportava l'assenza di finali per i
primi due atti. Riproponendo l'opera al teatro dei Fiorentini, in Napoli, nel 1787,
Paisiello,
46 La somiglianza delle situazioni sceniche fa pensare allain collaborazione
preghiera con Lorenzi,
dellela ridusse
tre in tre atti, componendo al
termine del primo
maschere nel primo finale del Don Giovanni (b. 251-272): atto un finale tradizionale.
in entrambi i casi Per un'analisi
si più approfondita della
questione, si nell'imminenza
vedono tre personaggi nell'atto di stringersi l'uno all'altro veda l'articolo di V. Scherliess, d'un
Il Barbiere di Siviglia: Paisiello und
grande pericolo. Rossini, « Analecta musicologica », XXI, 1982, pp. 100-127.
260 FRANCESCO BIANCHETTI
nalità drammaturgica e della musica pura.49 Questo secondo aspetto
dell'invenzione di Paisiello sembra aver colpito i contemporanei non
meno del suo spiccato temperamento teatrale. Ferdinando Galiani,
ad esempio, in una lettera da Napoli alla viscontessa di Belzunce,
del 7 novembre 1778, scrive:
Or, sachez que, dans le même temps qu'on donnait la Frascatana à
votre
This contentopéra, on l'a
downloaded from 193.204.40.97 on Fri,donnée ici; et moi qui ne savais
11 Jan 2019 07:22:20 UTC rien
This content downloaded de ce
from 193.204.40.97 qui
on Fri, se
11 Jan 2019 07:22:20 UTC
passait àAll Paris, use subject to https://about.jstor.org/terms
je brûlais du désir qu'on y jouât le premier All use subject to https://about.jstor.org/terms
final et
surtout le morceau momento più funesto-, et je disais en moi-même: Si
les Parisiens entendent ce prodige des effets de la musique, ils en de
viendront fous; je disais vrai, Paësiello est infiniment plus fort que
Piccinni dans le contrapunto·, ainsi il est plus sûr de réussir, aidant sa
nature avec l'art.50
Ponendo così l'accento su uno dei grandi episodi polifonici paisiel
liani, l'abate napoletano riconosce nello sviluppo dei concertati stati
ci uno dei tratti distintivi dello stile del musicista. Se, infatti, la
sovrapposizione delle voci in episodi autonomi, al termine dei brani,
è consuetudine comune a pressoché tutti i concertati dell'opera buf
fa, la carica di gioioso vitalismo che Paisiello è solito innestare nelle
proprie pagine contrappuntistiche s'impone con un'evidenza assolu
tamente originale.
Francesco Blanchetti
49 Fra l'altro, a partire dal 1787, con il Pirro, Paisiello introdusse i finali d'atto
anche nell'opera seria.
50 F. Galiani, Correspondance inédite, II, Parigi, Dentu 1818, p. 288.
Potrebbero piacerti anche
- Roma Nu Fa La StupidaDocumento1 paginaRoma Nu Fa La StupidaLuigi PalumboNessuna valutazione finora
- Esplorazione Del Blanco II - Salvatore SciarrinoDocumento6 pagineEsplorazione Del Blanco II - Salvatore SciarrinoVanessaNessuna valutazione finora
- Casella AlfredoDocumento66 pagineCasella AlfredoClaudia Manusardi100% (1)
- Mauro Giuliani - Sei ArietteDocumento58 pagineMauro Giuliani - Sei ArietteGio Arguello92% (12)
- Cimarosa-Sonata in Re Minore No.17Documento12 pagineCimarosa-Sonata in Re Minore No.17Anastasia Razvalyaeva100% (1)
- Mauro Giuliani Sei ArietteDocumento58 pagineMauro Giuliani Sei Ariettefabyguitar6660Nessuna valutazione finora
- Musica - Metodo - Manuale Di Improvvisazione JazzDocumento18 pagineMusica - Metodo - Manuale Di Improvvisazione JazzTommaso Saviano100% (1)
- Barzellette MusicistiDocumento36 pagineBarzellette MusicistiCarlotta Paolacci100% (1)
- Storia Della MusicaDocumento83 pagineStoria Della MusicaAnonymous SAuK4CNessuna valutazione finora
- Astor Piazzola e I Suoi Cinco Piezas - Tesi Di Francesco D'AngeloDocumento75 pagineAstor Piazzola e I Suoi Cinco Piezas - Tesi Di Francesco D'AngeloFrancesco D'AngeloNessuna valutazione finora
- RespighiDocumento52 pagineRespighidianadrog100% (4)
- Cronologia E Storia Della Musica RockDocumento25 pagineCronologia E Storia Della Musica RockGioele Alchimista FragaleNessuna valutazione finora
- Dal Glicibarifono Al Clarinet To BassoDocumento24 pagineDal Glicibarifono Al Clarinet To BassoNadia Lanzafame Russo100% (1)
- Lorena Fontana, CantoDocumento10 pagineLorena Fontana, CantoFrancesco Turco50% (2)
- Baldassarre Galuppi Dixit Dominus in SolDocumento9 pagineBaldassarre Galuppi Dixit Dominus in SolcarcomalNessuna valutazione finora
- Letteratura FlautisticaDocumento29 pagineLetteratura Flautisticailenia100% (1)
- La Musica Sacra Nel 700 A Napoli PDFDocumento100 pagineLa Musica Sacra Nel 700 A Napoli PDFFrancescoPellegrinoNessuna valutazione finora
- Hit The Road Jack - Ray Charles - PianoDocumento5 pagineHit The Road Jack - Ray Charles - PianoPianist AbdullahNessuna valutazione finora
- Tesi LegnaniDocumento25 pagineTesi Legnanisilvia100% (1)
- Musica in Arte - Il ConcertoDocumento35 pagineMusica in Arte - Il ConcertoMarco SuraceNessuna valutazione finora
- Relazioni Musicali Tra Italia e Spagna PDFDocumento20 pagineRelazioni Musicali Tra Italia e Spagna PDFGaetano PreviteraNessuna valutazione finora
- Mauro - Gioielli, Quattro - Colascionate, Utriculus, X, n.39,2006, Pp.18 39Documento22 pagineMauro - Gioielli, Quattro - Colascionate, Utriculus, X, n.39,2006, Pp.18 39Virtù ManuelNessuna valutazione finora
- Musica Coral RomanticismoDocumento29 pagineMusica Coral RomanticismoSiegnagel Ninguno100% (2)
- Vortragbologna 2013Documento23 pagineVortragbologna 2013Riccardo Srèè CasaNessuna valutazione finora
- Lezione Storia Della MusicaDocumento2 pagineLezione Storia Della MusicaLara VarinNessuna valutazione finora
- Respighi PDFDocumento52 pagineRespighi PDFGiovanni Luigi100% (1)
- Bortoletti - ORLANDO FURIOSO (3) - RemovedDocumento11 pagineBortoletti - ORLANDO FURIOSO (3) - RemovedFrancesco TincaniNessuna valutazione finora
- Lococo, Giusepina - I Testi Del Petrarca Nel Repertorio Musicale Del QuattrocentoDocumento14 pagineLococo, Giusepina - I Testi Del Petrarca Nel Repertorio Musicale Del QuattrocentoMau AlvaradoNessuna valutazione finora
- Articolo Teuzzone CagliariDocumento4 pagineArticolo Teuzzone CagliariAlessandro BorinNessuna valutazione finora
- Sui Drammi Per Musica Di Alessandro ScarDocumento25 pagineSui Drammi Per Musica Di Alessandro ScarRiccardo Gambino RupilNessuna valutazione finora
- The Metaphor of The Building As A Body in The: Hypnerotomachia PoliphiliDocumento1 paginaThe Metaphor of The Building As A Body in The: Hypnerotomachia Poliphilitatsuya kikuchiNessuna valutazione finora
- Confronto Tra Tre Intavolature Italiane Del Xvii SecoloDocumento7 pagineConfronto Tra Tre Intavolature Italiane Del Xvii SecoloAlbertaNessuna valutazione finora
- Esotismo e Realismo Nell'opera LiricaDocumento22 pagineEsotismo e Realismo Nell'opera LiricaChiara Corinne AmicoNessuna valutazione finora
- Byrd, William (Deumm B II 30-37)Documento8 pagineByrd, William (Deumm B II 30-37)Frida CuccurulloNessuna valutazione finora
- Rapporto Testo Musica PDFDocumento4 pagineRapporto Testo Musica PDFRiccardo BarabinoNessuna valutazione finora
- Lezione 3Documento4 pagineLezione 3Francesca BassaniNessuna valutazione finora
- AlbenizDocumento5 pagineAlbenizvickyNessuna valutazione finora
- Respighi 1Documento4 pagineRespighi 1dianadrogNessuna valutazione finora
- La ZarzuelaDocumento6 pagineLa ZarzuelaMartina ScutoNessuna valutazione finora
- Tesi 28Documento4 pagineTesi 28Giulia Sardi100% (1)
- Il Ballo Primo Di Europa Riconosciuta DiDocumento34 pagineIl Ballo Primo Di Europa Riconosciuta DiDardo CocettaNessuna valutazione finora
- ID98 Pensieri Amorosi Giulio Sanpiero Di Negro p1Documento8 pagineID98 Pensieri Amorosi Giulio Sanpiero Di Negro p1tiorbaNessuna valutazione finora
- Lopera Dei Pupi e Il Maggio EpicoDocumento14 pagineLopera Dei Pupi e Il Maggio EpicoAnnalisa CostantiniNessuna valutazione finora
- Cipollone, Barbara - La Tradizione Musicale Del Sonetto or Che'l Ciel Et La Terra. Arcadelt, Rore, MonteDocumento15 pagineCipollone, Barbara - La Tradizione Musicale Del Sonetto or Che'l Ciel Et La Terra. Arcadelt, Rore, MonteMau AlvaradoNessuna valutazione finora
- S Mercadante Francesca Da Rimini Ed CritDocumento9 pagineS Mercadante Francesca Da Rimini Ed Critmarinka123234Nessuna valutazione finora
- RICERCA Sulla Forma RicercareDocumento10 pagineRICERCA Sulla Forma RicercareAlessandro MauroNessuna valutazione finora
- Le Opere Di Clarinetto Di Luigi Bassi1Documento2 pagineLe Opere Di Clarinetto Di Luigi Bassi1Angelo Gioacchino licalsiNessuna valutazione finora
- PurcellDocumento5 paginePurcellErnesto TortorellaNessuna valutazione finora
- Mozart 2Documento5 pagineMozart 2Silvia AntoniNessuna valutazione finora
- 03 Musica Strumentale BaroccaDocumento89 pagine03 Musica Strumentale BaroccaJIACKNessuna valutazione finora
- BookletnlsDocumento15 pagineBookletnlsHåkon HallenbergNessuna valutazione finora
- Luigi CherubiniDocumento9 pagineLuigi CherubiniConan EdogawaNessuna valutazione finora
- 2003 La Fenice Nel Mondo Repertorio AvanDocumento90 pagine2003 La Fenice Nel Mondo Repertorio AvanSimone EgidiNessuna valutazione finora
- Articolo 32045 3 10 20181207Documento22 pagineArticolo 32045 3 10 20181207wellsiteNessuna valutazione finora
- Booklet - CleopatraDocumento16 pagineBooklet - CleopatraFelipeNessuna valutazione finora
- Biografia Di Girolamo Crescentini (Maria Borgato)Documento4 pagineBiografia Di Girolamo Crescentini (Maria Borgato)Rosario Caponnetto100% (1)
- Commedie in Musica e Febi Armonici - Drammi ItaloDocumento8 pagineCommedie in Musica e Febi Armonici - Drammi ItaloMarcia KaiserNessuna valutazione finora
- Ensemble Frescobaldi Musiche Per OttoniDocumento12 pagineEnsemble Frescobaldi Musiche Per OttoniAngelo MagarelliNessuna valutazione finora
- Antolini Edizioni PianisticheDocumento32 pagineAntolini Edizioni PianisticheElenaNessuna valutazione finora
- Storia Della Musica II - Manuale Di Sopravvivenza Dello StudenteDocumento89 pagineStoria Della Musica II - Manuale Di Sopravvivenza Dello StudenteGabriela VelitchkovaNessuna valutazione finora
- Il ClassicismoDocumento3 pagineIl ClassicismoOblivionNessuna valutazione finora
- Scorpione DomenicoDocumento2 pagineScorpione DomenicotittiNessuna valutazione finora
- Conservatorio Di Musica "Stanislao Giacomantonio" Di Cosenza Triennio Di PianoforteDocumento31 pagineConservatorio Di Musica "Stanislao Giacomantonio" Di Cosenza Triennio Di PianoforteMonicaNessuna valutazione finora
- Introduzione Fu Il Lauro Sempre VerdeDocumento4 pagineIntroduzione Fu Il Lauro Sempre VerdeEmanuele Salvatore Paolo DuchettaNessuna valutazione finora
- Carlo Lombardo e Il paese dei campanelli Breve storia di un'operettaDa EverandCarlo Lombardo e Il paese dei campanelli Breve storia di un'operettaNessuna valutazione finora
- Latanza Player Piano DupliceDocumento49 pagineLatanza Player Piano DupliceAlexandre PiretNessuna valutazione finora
- Gallotta SelezioneDocumento46 pagineGallotta SelezioneAlexandre PiretNessuna valutazione finora
- BARBIERE-DI-SIVIGLIA Fenice PDFDocumento173 pagineBARBIERE-DI-SIVIGLIA Fenice PDFMa RiNessuna valutazione finora
- TangoDocumento1 paginaTangoAlexandre PiretNessuna valutazione finora
- 3iggc1447689751 PDFDocumento176 pagine3iggc1447689751 PDFAlexandre PiretNessuna valutazione finora
- 24Documento17 pagine24Alexandre PiretNessuna valutazione finora
- Le Figure Musicali e Le PauseDocumento4 pagineLe Figure Musicali e Le PauseAlexandre PiretNessuna valutazione finora
- Contenuto Del TestDocumento1 paginaContenuto Del TestgiovanniNessuna valutazione finora
- 24875brochure Alloggi PDFDocumento2 pagine24875brochure Alloggi PDFAlexandre PiretNessuna valutazione finora
- Avvi So Contrib UziDocumento18 pagineAvvi So Contrib UziAlexandre PiretNessuna valutazione finora
- 94 1097 1 SP PDFDocumento1 pagina94 1097 1 SP PDFAlexandre PiretNessuna valutazione finora
- Chitarra Classica - Vecchio ProgrammaDocumento17 pagineChitarra Classica - Vecchio ProgrammaDaniele LigiosNessuna valutazione finora
- Ver SuriDocumento16 pagineVer Surigabiy24Nessuna valutazione finora
- All That Jazz Clarinet PartDocumento9 pagineAll That Jazz Clarinet PartMaria CarnariusNessuna valutazione finora
- 02 - Autumn Leaves (Analisis)Documento4 pagine02 - Autumn Leaves (Analisis)Nicolau Cauaneque100% (1)
- 00 - Marcia Brillante - WALTERIANA - Partitura MaestroDocumento8 pagine00 - Marcia Brillante - WALTERIANA - Partitura MaestroLINO73Nessuna valutazione finora
- Mozart - Mitridate Tenor AriasDocumento43 pagineMozart - Mitridate Tenor Ariasjackgardner100% (2)
- Frammenti Di Trascrizioni Per Arr Pop - G. de BiagiDocumento6 pagineFrammenti Di Trascrizioni Per Arr Pop - G. de BiagiNicola NataleNessuna valutazione finora
- Musica - Diaspora Afroamericana V Parte - Il Blues - Origini e SviluppoDocumento11 pagineMusica - Diaspora Afroamericana V Parte - Il Blues - Origini e SviluppoDaniele MutinoNessuna valutazione finora
- Il Pianoforte Sett 2011Documento24 pagineIl Pianoforte Sett 2011Ana María Pérez TI100% (1)
- Cesar - Catalogo FridaDocumento44 pagineCesar - Catalogo FridaCesarcucineNessuna valutazione finora
- Dispense-Appunti Corso Di Chitarra Di Vincenzo GriecoDocumento8 pagineDispense-Appunti Corso Di Chitarra Di Vincenzo Griecoros56Nessuna valutazione finora
- Björk: Neo Sciamana IperpopDocumento100 pagineBjörk: Neo Sciamana IperpopgorditoNessuna valutazione finora
- Manuale Garage BandDocumento20 pagineManuale Garage BandCecilia004Nessuna valutazione finora
- Krusty Krab Spongebob Theme For Marching BandDocumento2 pagineKrusty Krab Spongebob Theme For Marching BandSaulQuispeValdezNessuna valutazione finora
- 1 TROMBA SIB Ricordo InfaustoDocumento1 pagina1 TROMBA SIB Ricordo Infaustoroberto erranteNessuna valutazione finora
- Le Scale Pentatoniche Sono Scale Composte Da Cinque NoteDocumento3 pagineLe Scale Pentatoniche Sono Scale Composte Da Cinque NoteLeandroCarnevaleNessuna valutazione finora
- RV 522 Cello To ViolinDocumento2 pagineRV 522 Cello To ViolinBlanca Solis ChNessuna valutazione finora
- It - Wikipedia.org Wiki Enrico Caruso PDFDocumento11 pagineIt - Wikipedia.org Wiki Enrico Caruso PDFGianluca GregantiNessuna valutazione finora
- Docenti Unina Alvino Trombetti RicchionDocumento4 pagineDocenti Unina Alvino Trombetti Ricchionrocoloco95Nessuna valutazione finora
- GraduatorieDocumento4 pagineGraduatorieGian Paolo LuppiNessuna valutazione finora
- Strutturaperiodo Musxviii RatnerDocumento12 pagineStrutturaperiodo Musxviii RatnerElena CavaniNessuna valutazione finora