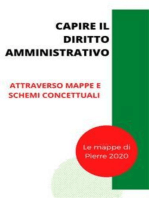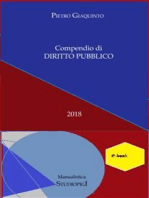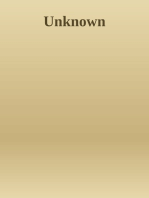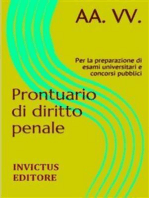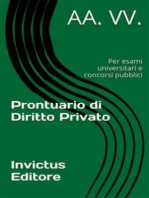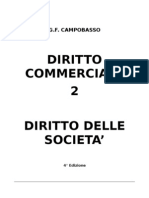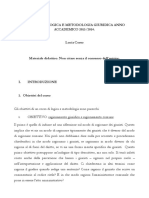Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
Schemi Schede Di Istituzioni Di Diritto Privato Parte1
Caricato da
Weiwei ChenCopyright
Formati disponibili
Condividi questo documento
Condividi o incorpora il documento
Hai trovato utile questo documento?
Questo contenuto è inappropriato?
Segnala questo documentoCopyright:
Formati disponibili
Schemi Schede Di Istituzioni Di Diritto Privato Parte1
Caricato da
Weiwei ChenCopyright:
Formati disponibili
TUTTI I DIRITTI RISERVATI
Vietata la riproduzione anche parziale
Tutti i diritti di sfruttamento economico dell’opera appartengono alla Esselibri S.p.A.
(art. 64, D.Lgs. 10-2-2005, n. 30)
Di particolare interesse per i lettori di questo volume segnaliamo:
5 • Istituzioni di diritto privato (Diritto civile)
5/1 • Prepararsi per l’esame di diritto civile
5/3 • Compendio di istituzioni di diritto Privato
5/4 • Compendio di diritto di famiglia
5/5 • Successioni e donazioni
5C • Count-down - Le domande di Istituzioni di Diritto Privato (Diritto civile)
221 • Elementi di diritto civile
221/3 • Istituzioni di Diritto Privato (Nozioni essenziali)
504 • Codice civile
504/1 • Codice civile (minor)
E1 • Codice civile esplicato
E1/A • Codice civile esplicato (minor)
LX5 • Le parole del diritto privato (Diritto civile)
Il catalogo aggiornato è consultabile sul sito internet: www.simone.it
Finito di stampare nel mese di marzo 2011
dalla «Grafica Sud s.r.l.» - Via Nazionale delle Puglie Km 35.935 - Casalnuovo (NA)
per conto della ESSELIBRI S.p.A. - Via F. Russo, 33/D - 80133 - Napoli
Grafica di copertina a cura di Giuseppe Ragno
PREMESSA
Schemi e Schede intende fornire un moderno supporto didattico ai tra-
dizionali manuali di diritto civile, per coloro che, nella preparazione di esa-
mi universitari o pubblici concorsi, necessitano di un quadro sistematico e
riepilogativo della materia.
Il volume, infatti, fa il punto sugli elementi portanti della materia, fornen-
do una definizione di base dell’argomento oggetto di studio, che viene poi
schematizzato e analizzato nei suoi aspetti principali.
Il lavoro, dunque, attraverso comode slide , consente di mettere ordine
nelle idee e concetti, classificare istituti e argomenti per agevolare anche
la memoria visiva nella fase del ripasso, la sistematizzazione e memoriz-
zazione finale.
Questa edizione, come la precedente, si caratterizza per tre innovative
rubriche, che completano la lettura degli schemi:
— la rubrica Osservazioni, nella quale vengono puntualizzati concetti,
nuovi o problematici, spesso oggetto di dibattito in dottrina e in giuri-
sprudenza, di approfondimento della materia;
— la rubrica Differenze, che analizza aspetti particolari degli argomenti,
stimolando al confronto fra i diversi istituti;
— la rubrica In sintesi, che offre un quadro riepilogativo, in chiave critica,
degli argomenti affrontati nei precedenti paragrafi o capitoli.
PARTE PRIMA
TEORIA GENERALE DEL DIRITTO
Capitolo Primo: Lo Stato, il diritto, l’ordinamento giuridico ............. Pag. 7
1 Nozioni generali • 2 Lo Stato • 3 Il diritto • 4 Ordinamento giuridico
Capitolo Secondo: La norma giuridica ................................................ » 9
1 La norma giuridica: Struttura, Caratteri, Sanzioni • 2 Classificazione
delle norme giuridiche • 3 Efficacia delle norme nel tempo e nello spa-
zio • 4 Applicazione • 5 Interpretazione della norma giuridica • 6 Analo-
gia
Capitolo Terzo: Il rapporto giuridico .................................................... » 13
1 Rapporto giuridico: Struttura e vicende • 2 Situazioni soggettive atti-
ve • 3 Situazioni soggettive passive • 4 Corrispondenza tra situazioni
soggettive attive e situazioni soggettive passive • 5 Classificazione dei
diritti
Capitolo Quarto: Partizioni e fonti del diritto ...................................... » 17
1 Diritto pubblico - diritto privato • 2 Fonti del diritto
Capitolo 1 LO STATO, IL DIRITTO
L’ORDINAMENTO GIURIDICO
1 Nozioni generali
Gli uomini tendono naturalmente ad associarsi e a collaborare tra loro per realizzare i propri inte-
ressi. Le associazioni più semplici (famiglia, gens) sono funzionali ad interessi minimi: difesa della
proprietà, conservazione del patrimonio familiare.
Lo Stato è l’associazione umana più complessa in quanto è funzionale a molteplici interessi.
Tutte le associazioni umane sono caratterizzate essenzialmente dalla presenza di una organizza-
zione capace di creare e imporre delle regole che disciplinano i rapporti tra gli associati.
2 Lo Stato
Nozione: lo Stato è un’associazione di individui che, spontaneamente o per determinazione di altri Stati,
si costituisce su un territorio, ed è dotata di regole comuni (diritto ) che disciplinano la intera vita della colletti-
vità che ad essa fa capo e da esso dipende.
䉴 Il popolo: elemento essenziale, da esso lo Stato dipende e ad esso fa
capo (1 Cost.)
䉴 Il territorio: l’ambito, la sede stabile ove lo Stato svolge le sue funzioni
Elementi
䉴 Sovranità: lo Stato, per realizzare i suoi compiti e per garantire la sicu-
rezza della collettività, deve potersi imporre, anche con la forza, sulla
collettività nei cui confronti vanta, quindi, una posizione di supremazia
䉴 Soggezione: dei componenti della collettività nei confronti dello Stato
䉴 Lo Stato non si fonda su investiture di altri ordinamenti ma è autonomo
nei confronti di ogni altra organizzazione della vita sociale, sia essa nazio-
Originarietà nale che internazionale; si precisa, tuttavia, che con l’ingresso nella Co-
ed autonomia munità europea e successivamente nell’Unione Europea, si è verificata
una progressiva riduzione della sfera di autonomia dello Stato soprattutto
in materia economica, in quanto alcuni atti delle Comunità europee sono
immediatamente efficaci nel nostro ordinamento (atti self-executing)
3 Il diritto
Nozione: il diritto costituisce l’insieme delle regole di comportamento che lo Stato impone ai con-
sociati e di cui garantisce, anche attraverso l’uso della forza, l’osservanza.
䉴 Alterità o intersubiettività o bilateralità: in quanto regola azioni umane
rilevanti nei rapporti sociali, stabilendo così, tra i componenti delle so-
cietà, delle relazioni giuridiche aventi per contenuto una serie di obbli-
Caratteri (Trabucchi) ghi e di correlativi diritti
䉴 Statualità: in quanto, in primo luogo, esso deriva esclusivamente dallo
Stato e, in secondo luogo, è lo Stato che garantisce l’osservanza del-
l’ordinamento giuridico
Capitolo 1 • Lo Stato, il diritto, l’ordinamento giuridico 7
䉴 Obbligatorietà: in quanto si impone con una serie di norme obbligato-
Caratteri (Trabucchi)
rie il cui rispetto è garantito dallo Stato anche con la forza
䉴 Diritto oggettivo: l’insieme delle norme (normae agendi ) che discipli-
nano in astratto la condotta degli individui
Manifestazioni
䉴 Diritto soggettivo: come potere di agire (facultas agendi) riconosciuto
ad un soggetto per la realizzazione in concreto di un suo diritto
4 Ordinamento giuridico
Nozione: inteso in senso elementare, l’ordinamento giuridico è il complesso di norme mediante le
quali viene garantito l’ordinato vivere sociale e vengono regolati i rapporti interindividuali.
• nozione: si deve analizzare la struttu-
ra dell’ordinamento giuridico, che va
considerato un insieme di norme di-
sposte in un rigido ordine gerarchico
facente capo ad un’unica norma base,
fondamentale ed astratta (c.d. Grun-
䉴 Teoria normativista dnorm).
(Kelsen-Bobbio) La norma base è l’ elemento di coe-
sione del sistema
• conseguenze: concezione monista,
cioè l’ordinamento è uno solo; si fra-
ziona in tanti ordinamenti particolari,
facenti tutti capo alla norma base
Concezioni dottrinarie
(divergenti) • nozione: si deve analizzare la funzio-
ne dell’ordinamento giuridico, che va
considerato come una istituzione
• composizione : 1) un corpo sociale
(più persone che si associano); 2) una
organizzazione gerarchica di esso; 3)
䉴 Teoria istituzionalista un ordine normativo che disciplina il
(Hauriou e Santi Romano) funzionamento dell’istituzione
• conseguenze: concezione pluralista,
in quanto ritiene che ciascuna istitu-
zione (famiglia, società etc.) abbia un
ordinamento proprio che si pone in
posizione gerarchica rispetto agli al-
tri ordinamenti
In sintesi
In particolare, nell’associazione che prende il nome di Stato (e che si fonda sul «diritto») questi
elementi strutturali assumono una nomenclatura precisa e cioè:
— l’organizzazione è detta ordinamento giuridico;
— i comandi che da essa derivano sono le norme giuridiche;
— i rapporti che disciplina si definiscono rapporti giuridici;
— le posizioni di ciascuno nei confronti degli altri e dello stesso Stato sono dette situazioni giuri-
diche soggettive.
8 Parte Prima • Teoria generale del diritto
Capitolo 2 LA NORMA GIURIDICA
1 La norma giuridica: Struttura, Caratteri, Sanzioni
Nozione: la norma giuridica è un comando generale ed astratto rivolto a tutti i consociati, con il
quale si impone una particolare condotta, sotto la minaccia di una determinata reazione (sanzione).
䉴 Precetto: è il comando contenuto nella norma
Struttura 䉴 Sanzione: è la reazione che l’ordinamento minaccia in caso di inosser-
vanza del precetto (*)
䉴 Generalità: le norme si rivolgono alla generalità dei soggetti.
䉴 Astrattezza: la norma disciplina una situazione tipo (c.d. fattispecie
astratta) e non un caso particolare
Caratteristiche 䉴 Statualità: fonti di produzione della norma sono esclusivamente gli or-
gani dello Stato preposti alla sua creazione
䉴 Obbligatorietà: in quanto tutti i consociati sono tenuti all’osservanza
della norma e questa è garantita dalla sanzione
Sanzione: è il momento essenziale di tutte le norme giuridiche; è la reazione che l’ordinamento
minaccia in caso di violazione delle norme.
䉴 Diretta: realizza in modo diretto il risul- • esempio: esecuzione for-
tato che la norma violata prescrive zata, nullità del negozio
Tipi di sanzione
䉴 Indiretta: realizza in modo indiretto il ri- • esempio: risarcimento del
sultato prescritto dalla norma danno, riparazione
2 Classificazione delle norme giuridiche
䉴 Norme precettive: contengono un comando (es.: 433)
䉴 Norme proibitive: contengono un divieto (es.: 1471)
In base al contenuto
䉴 Norme permissive: concedono ai soggetti particolari facoltà, garanti-
te dall’ordinamento (es.: 832)
䉴 Norme cogenti o imperative o di ordine pubblico: l’applicazione è
imposta dall’ordinamento, prescindendo finanche dalla volontà dei sin-
goli (es.: norme penali).
In base al comando • norme dispositive: (1815 co. 1) rego-
䉴 Norme relative o dero- lano un rapporto lasciando le parti li-
gabili: l’applicazione può bere di disciplinarlo diversamente
essere evitata dagli inte-
ressati • norme suppletive: disciplinano un rappor-
to in mancanza di volontà delle parti
(*) La sanzione è elemento esclusivo della struttura della norma giuridica; vi sono infatti alcune norme che
prevedono, in conseguenza del precetto, un premio, come quelle che favoriscono, ad es., il finanziamento per parti-
colari categorie di soggetti (es. imprese femminili) o di territori (es. benefici fiscali nelle aree depresse).
Capitolo 2 • La norma giuridica 9
䉴 Norme perfette: munite di sanzione
䉴 Norme imperfette: prive di sanzione (315)
In base alla sanzione
䉴 Norme «minus quam perfectae»: la cui inosservanza viene punita
con sanzioni non adeguate (combinato disposto degli artt. 89 e 140)
䉴 Norme di diritto materiale: dirette al regolamento di rapporti (quasi
tutte le norme di diritto civile)
In base alla funzione
䉴 Norme di diritto strumentale: dettano regole per l’attuazione in con-
creto del comando giuridico (es.: norme di diritto processuale).
䉴 Norme generali: sono quelle che trovano uguale applicazione su tutto
il territorio
In base all’estenzione 䉴 Norme locali: vigono soltanto in alcune parti dello Stato (es. leggi re-
dell’efficacia gionali)
䉴 Norme comuni: sono quelle dettate per tutti i rapporti giuridici
䉴 Norme speciali: soddisfano particolari esigenze e si applicano solo in
alcune materie, luoghi, circostanze o per categorie di soggetti
3 Efficacia delle norme nel tempo e nello spazio
䉴 Entrata in vigore della
• pubblicazione nella G.U.
norma giuridica: affinché
Vigore • decorso di un lasso di tempo (vacatio
dispieghi l’efficacia erga
omnes è necessaria: legis) normalmente di 15 giorni
䉴 Dichiarazione espressa del legislatore
䉴 Dichiarazione tacita del legislatore: il legislatore emana una nuova
legge incompatibile o una nuova legge regola interamente la stessa
materia
䉴 Referendum popolare: (75 Cost.)
Abrogazione
䉴 Cause intrinseche: quando la legge è emanata solo per un certo las-
so di tempo o per disciplinare particolari circostanze (leggi eccezionali)
䉴 Dichiarazione di illegittimità: pronunciata dalla Corte Costituzionale.
La dichiarazione ha efficacia retroattiva, restano salvi solo i rapporti
definiti con sentenza passata in giudicato (così GALGANO)
䉴 Nozione: l’art. 11 delle disp. prel. al cod. civ. detta: «la legge non dispo-
ne che per l’avvenire: essa non ha effetto retroattivo»
䉴 Eccezioni: il principio su-
bisce delle deroghe in li- • leggi più favorevoli al reo (2 c.p.)
Irretroattività nea di massima quando il
legislatore ravvisa l’oppor-
• aumenti di stipendio con decorrenza
retrodatata
tunità di estendere l’effica-
cia della nuova legge al • norme di carattere interpretativo.
passato; esempi:
10 Parte Prima • Teoria generale del diritto
䉴 L’applicazione del principio di irretroattività delle norme giuridiche non
è sempre agevole, in quanto il sopravvenire di nuove norme determina
problemi riguardo a situazioni giuridiche che, non esaurendosi in un
Successione nel tempo dato momento, durano nel tempo; quindi in relazione ad una determi-
nata fattispecie può determinarsi un conflitto di norme.
Il conflitto può essere disciplinato e risolto dal legislatore con norme
speciali, dette transitorie, appositamente emanate.
• la nuova norma non modifica i diritti
䉴 Qualora il legislatore non quesiti, cioè diritti che sono già entrati
provveda in questo senso, nel patrimonio di un soggetto (teoria
Successione nel tempo il conflitto di norme va ri- dei diritti quesiti)
solto utilizzando due cri-
teri: • la legge nuova non estende i suoi effetti
ai fatti compiuti sotto il vigore della legge
precedente (teoria del fatto compiuto)
䉴 Il principio generale è quello della territorialità della legge, essa cioè ha effi-
cacia solo nel territorio dello Stato in cui è emanata (leges feruntur territorio).
La disciplina di rapporti che non si svolgono in un unico Stato è regola-
Efficacia nello spazio
ta dalle norme di diritto privato internazionale, che disciplinano i conflit-
ti tra diverse legislazioni (fondamentale in materia è la legge 218/1995)
4 Applicazione
Nozione: l’applicazione della norma è la realizzazione concreta di quanto ordinato dalle regole
dell’ordinamento giuridico.
䉴 Applicazione necessa-
• conoscere la norma da applicare (iura
ria del diritto: operata dal novit curia)
giudice per dirimere con-
Caratteri troversie; il giudice deve: • conoscere il fatto da regolare
䉴 Applicazione volontaria: quella operata da un privato (es. pagamen-
to del debito)
5 Interpretazione della norma giuridica
Nozione: l’interpretazione della norma è la ricerca del significato della medesima e della volontà
del legislatore.
䉴 Interpretazione storica: ricerca del significato della norma conside-
rando il momento storico e le ragioni politiche per cui è stata emanata
䉴 Interpretazione sociologica:ricerca del significato della norma consideran-
do gli aspetti economico sociali dei rapporti regolati dalla norma interpretata
䉴 Interpretazione sistematica: ricerca dell’esatto siginificato della nor-
ma osservando la sua collocazione nell’intero sistema normativo del-
l’ordinamento giuridico
Tipi 䉴 Interpretazionelogica:ricercadell’esattosignificatodellanormaconsiderando
gli scopi che il legislatore si è prefisso al momento della sua emanazione
䉴 Interpretazione equitativa: ricerca dell’esatto significato della norma
cercando di evitare ciò che contrasta con il senso di giustizia e che
offre una soluzione del conflitto non equilibrata
䉴 Interpretazione letterale: ricerca dell’esatto significato della norma
considerando il «significato proprio delle parole secondo la connessio-
ne di esse» (12 disp. prel.)
Capitolo 2 • La norma giuridica 11
• interpretazione giudiziale: compiuta
dal giudice nell’esercizio del potere
giurisdizionale; è vincolante nei con-
fronti delle parti in giudizio
• interpretazione dottrinale: compiuta
da studiosi delle discipline giuridiche;
䉴 In relazione ai soggetti non è vincolante
• interpretazione autentica: compiuta
dallo stesso legislatore che emana
appositamente delle norme (norme
interpretative) per chiarire il significa-
to di norme preesistenti; questa inter-
pretazione è vincolante
Specie • interpretazione dichiarativa: se il risul-
tato dell’interpretazione letterale coin-
cide con quello della interpretazione
logica (lex tam dixit, quam voluit)
• interpretazione estensiva: se l’ambito di
applicazione della norma è più esteso
di quanto si ricava dalla sola formulazio-
䉴 In relazione ai risultati
ne letterale (lex minus dixit, quam voluit)
• interpretazione restrittiva: se l’ambito di
applicazione della norma è meno esteso
di quanto si ricava dalla sola formulazio-
ne letterale (lex plus dixit, quam voluit)
6 Analogia
Nozione: l’analogia (o interpretazione analogica) è un procedimento logico attraverso il quale un
fatto non previsto o non regolato dal diritto viene disciplinato ricorrendo o alla disciplina prevista per un
caso simile (analogia legis), o ai principi generali dell’ordinamento giuridico (analogia iuris).
䉴 Il caso in questione non è previsto da alcuna norma
䉴 Vi sono somiglianze tra la fattispecie prevista dalla legge e quella non
Presupposti prevista
䉴 La somiglianza riguarda gli elementi della fattispecie prevista che giu-
stificano la disciplina dettata dal legislatore (eadem ratio)
Limiti: l’analogia non è ammessa rispetto alle norme penali cd. in malam partem, ossia sfavorevoli al
reo, e alle norme eccezionali (14 disp. prel.).
Differenze
L’analogia non va confusa con l’interpretazione estensiva: si ricorre alla analogia quando manca
una norma che regoli una materia, l’interpretazione estensiva invece amplia la portata letterale di
una norma esistente; in definitiva, tramite l’analogia si scoprono nuove norme, con l’interpretazione
estensiva si attribuisce alla norma esistente un significato tale da comprendere più casi.
L’interpretazione serve a conoscere ciò che il legislatore ha pensato, l’analogia ciò che il legislatore
avrebbe pensato se avesse previsto il caso.
12 Parte Prima • Teoria generale del diritto
Capitolo 3 IL RAPPORTO GIURIDICO
1 Rapporto giuridico: Struttura e vicende
Nozione: il rapporto giuridico è la relazione tra due o più soggetti, disciplinata dal diritto.
䉴 Attivo: colui al quale l’ordinamento giuridico attribuisce un potere; ad
esempio, il potere di pretendere il pagamento di un debito
䉴 Passivo: colui al quale fanno capo doveri; ad esempio, l'obbligo di pa-
Soggetti
gare un debito
䉴 Terzo: è terzo chi è estraneo al rapporto; nei suoi confronti il rappor-
to, normalmente, non produce effetti né favorevoli né sfavorevoli
䉴 Il rapporto si costituisce quando il soggetto acquista un diritto
• titolo originario: il diritto sorge a favo-
Costituzione re di una persona senza che sia sta-
䉴 L’acquisto può essere a: to trasmesso da nessuno
• titolo derivativo: il diritto si trasferisce
da una persona all’altra
Modificazione: quando un rapporto subisce un mutamento che consiste nella limitazione del suo
contenuto o in una variazione dell’oggetto o di un soggetto.
Estinzione: quando il soggetto attivo perde il diritto senza che questo sia trasmesso ad altri.
Differenze
L’acquisto a titolo derivativo può essere di due tipi: traslativo o costitutivo.
Nel primo caso si trasmette lo stesso diritto che aveva il soggetto che ha posto in essere il trasferi-
mento. In quest’ipotesi si parla di successione a titolo universale quando una persona subentra
nella generalità dei rapporti di un’altra; si parla, invece, di successione a titolo particolare quando il
trasferimento ha per oggetto un singolo rapporto determinato.
L’acquisto a titolo costitutivo-derivativo si verifica quando il diritto acquistato è differente da quello della
persona che l’ha trasferito, ma da questo scaturisce in quanto lo suppone o ne assorbe il contenuto.
2 Situazioni soggettive attive
䉴 È il potere di agire ( ius est facultas agendi) per il soddisfacimento del
proprio interesse, protetto dall’ordinamento giuridico in maniera piena
e diretta
Diritto soggettivo • volontà: il diritto soggettivo rappresen-
ta un potere della volontà.
䉴 Caratteri fondamentali • potere : attribuito ad un soggetto per il
soddisfacimento di un interesse giu-
ridicamente protetto.
Capitolo 3 • Il rapporto giuridico 13
䉴 Il contenuto è rappresentato da facoltà, pretese e poteri di varia natu-
Diritto soggettivo ra, che costituiscono manifestazioni del diritto stesso. Ad esempio go-
dere e disporre della cosa sono facoltà che costituiscono il contenuto
del diritto di proprietà
䉴 Le potestà sono poteri attribuiti ad un soggetto per la realizzazione di
interessi che non fanno capo a lui direttamente
Potestà 䉴 Il titolare non è libero, come il titolare del diritto soggettivo, ma resta
vincolato dagli interessi per cui la potestà è stata attribuita (c.d. potere
- dovere) (es. potestà dei genitori)
䉴 I diritti potestativi consistono nel potere di determinare mutamenti nella
situazione giuridica di un altro soggetto mediante un atto unilaterale (1373)
Diritti potestativi 䉴 Il soggetto passivo non ha particolari obblighi in corrispondenza del
diritto potestativo altrui, ma è in uno stato di soggezione (pati)
䉴 Lo status è la posizione di un soggetto rispetto all’appartenenza a de-
Status terminati gruppi sociali (status di figlio legittimo, coniuge, madre); dallo
status derivano diritti e poteri
䉴 È la posizione di attesa in cui si trova il soggetto a favore del quale
viene maturando un diritto soggettivo. Tale posizione è tutelata dal dirit-
to in via provvisoria e strumentale per favorirne la conservazione e
l’attitudine a trasformarsi in diritto soggettivo (es. 1356-1358)
Aspettative 䉴 L’aspettativa di diritto (c.d. diritto al diritto o diritto informazione) non va
confusa con la mera speranza di un futuro diritto soggettivo ( aspettati-
va di fatto), che è del tutto irrilevante per il diritto. Un esempio di aspet-
tativa di fatto giuridicamente irrilevante è la speranza dei figli di una
persona di succedergli alla sua morte, la quale assume rilevanza giuri-
dica solo al momento della apertura della successione
䉴 È una situazione soggettiva di vantaggio qualificata dall’ordinamento e
volta al conseguimento di un risultato favorevole consistente nella con-
servazione o nella modificazione di una certa realtà in occasione del-
l’esercizio della potestà pubblica o anche pretese alla legittimità del-
Interesse legittimo l’azione amministrativa
䉴 Pur essendo nato nell’ambito del diritto amministrativo, attualmente
viene riconosciuto anche nel campo del diritto privato, in quanto fatti-
specie appartenente alla teoria generale del diritto (es.: interesse del
debitore a liberarsi tempestivamente attraverso l’adempimento; inte-
resse del lavoratore alla conservazione del posto di lavoro)
Osservazioni
Occorre rilevare, come a seguito di un mutato quadro normativo e giurisprudenziale (cfr. D.Lgs. n.
80/1998, L. n. 205/2000 nonché, da ultimo D.Lgs. n. 104/2010 e Cass. S.U. n. 500/1999), sia stata
riconosciuta una tutela in sede civile degli interessi legittimi, essendo stata ammessa la risarcibi-
lità ex art. 2043, anche ad opera del Giudice Amministrativo (e non solo nelle materie rientranti
nella sua giurisdizione esclusiva), del danno derivante dalla lesione degli interessi legittimi, ciò in
quanto l’art. 2043 non sarebbe una norma secondaria che sanziona la violazione di altre norme
primarie, ma sarebbe una norma primaria essa stessa che dispone il risarcimento del danno ingiu-
sto causato da attività di altri soggetti.
14 Parte Prima • Teoria generale del diritto
3 Situazioni soggettive passive
Dovere generico 䉴 Incombe su tutti come corrispondente della figura attiva del diritto as-
di astensione soluto (es.: la situazione di chi deve rispettare l’altrui diritto di proprietà)
䉴 È correlato ad una situazione attiva di diritto relativo.
Obbligo giuridico Consiste nell’obbligo di tenere un determinato comportamento (es.: al
diritto del creditore corrisponde l’obbligo del debitore al pagamento)
䉴 È la situazione soggettiva passiva correlata ad un altrui diritto potesta-
tivo.
Consiste in un semplice dover sopportare (pati) l’esercizio dell’altrui
Soggezione diritto potestativo, senza potersi sottrarre. Ad esempio in caso di comu-
nione, uno qualsiasi dei comunisti è titolare del diritto potestativo di
chiederne lo scioglimento; qualora ciò accada gli altri non possono
opporsi ma devono solo sopportare l’esercizio del diritto altrui (1111)
䉴 Consiste nel sacrificio, imposto ad un soggetto, di un interesse proprio
come condizione per ottenere o conservare un vantaggio giuridico. Ad
Onere esempio il compratore che vuole avvalersi della garanzia per vizi della
cosa vendutagli ha l’onere di denunciare i vizi entro otto giorni dal mo-
mento in cui li ha scoperti
4 Corrispondenza tra situazioni soggettive attive e situazioni sog-
gettive passive
Diritto assoluto → Dovere generico di astensione
Diritto relativo → Obbligo giuridico
Diritto potestativo → Soggezione
5 Classificazione dei diritti
5.1. • Diritti assoluti e relativi
䉴 Nozione: sono i diritti che conferiscono al titolare un potere che egli può
far valere verso tutti gli altri soggetti indistintamente, cioè «erga omnes».
Su costoro grava l’obbligo di non turbare il godimento del diritto stesso
Diritti assoluti
«erga omnes» • Diritti reali ( iura in re )
䉴 Categorie • Diritti della personalità
• Diritti su beni immateriali
䉴 Nozione: il potere concesso al titolare può essere fatto valere solo ver-
so determinati soggetti, sui quali grava l’obbligo di tenere un determi-
Diritti relativi
«in personam» nato comportamento (dare, fare, non fare)
䉴 Categorie: diritti di credito che si fanno valere prevalentemente nei
confronti dei debitori
Capitolo 3 • Il rapporto giuridico 15
5.2. • Diritti patrimoniali e non patrimoniali
Diritti patrimoniali: hanno per oggetto interessi economici, cioè valutabili in danaro.
Diritti non patrimoniali: hanno per oggetto interessi di natura prevalentemente morale, non su-
scettibili, quindi, di valutazione economica (es. diritti attinenti ai rapporti familiari).
5.3. • Diritti trasmissibili ed intrasmissibili
Diritti trasmissibili: sono quelli che possono essere trasferiti a persone diverse dai titolari.
䉴 Nozione: sono quelli che non possono essere trasferiti a persone di-
verse dai titolari
• Diritti personalissimi (es.: diritto al nome)
Diritti intrasmissibili • Diritti che soddisfano interessi superiori
(es.: diritti familiari)
䉴 Specie
• Alcuni diritti patrimoniali (es.: uso e abita-
zione, 1024, che fanno esclusivamente
capo alla persona del beneficiario)
5.4. • Diritti reali e diritti di obbligazione
Diritti reali: facoltà di agire di un soggetto sopra un bene per la soddisfazione di un proprio inte-
resse (Barbero).
䉴 Immediatezza: assicurano un potere immediato sulla cosa da parte
del titolare
Caratteri 䉴 Assolutezza: si fanno valere nei confronti di tutti i terzi (erga omnes)
䉴 Tipicità: costituiscono un numerus clausus , cioè le parti non possono
crearne di nuovi
Diritti di obbligazione: sono caratterizzati dal fatto che alla pretesa di un soggetto corrisponde un obbli-
go facente capo ad un altro soggetto (o altri soggetti determinati) rapporto di debito. Tale debito se non viene
adempiuto, trasforma il rapporto sottostante da rapporto di debito in rapporto di responsabilità (2740).
In sintesi
Il rapporto giuridico è, dunque, ogni relazione tra due o più soggetti prevista e regolata dal diritto:
il soggetto attivo, titolare di una posizione di vantaggio (diritto soggettivo, diritto potestativo ecc.)
e il soggetto passivo, titolare di una situazione soggettiva passiva (dovere, obbligo ecc.).
L’esercizio del diritto soggettivo consiste «nell’esplicazione dei poteri di cui il diritto consta» (così
Torrente) e, quindi, esso può definirsi anche come un’espressione di libertà, per cui, secondo la
dottrina tradizionale, deve essere garantito al titolare qualunque sia lo scopo che questi persegue.
Tuttavia, lo spirito della nostra carta costituzionale impone un richiamo al preminente valore della solidarie-
tà, rimarcando che vi sono dei limiti che il singolo è tenuto ad osservare nell’esercizio del diritto medesimo.
In quest’ottica la dottrina dominante parla di abuso del diritto per indicare un uso, per così dire, anormale
del diritto stesso che travalica i confini del diritto soggettivo e finisce per qualificarsi come illecito.
Sarebbero ipotesi di abuso di diritto:
— quando con la propria condotta si viola il principio di buona fede (es.: artt. 833, 938, 1150,
1358, 1359 ecc.);
— quando si altera il fattore causale di un atto (es.: artt. 1414, 1438, 1447, 1448 ecc.);
— le ipotesi di concorrenza sleale (es.: art. 2958).
Questo orientamento ha trovato seguito nella giurisprudenza che ne ha fatto applicazione in singoli
casi (es., recesso ad nutum dal contratto) alla luce dei precetti di buona fede e correttezza.
16 Parte Prima • Teoria generale del diritto
Capitolo 4 PARTIZIONI E FONTI DEL DIRITTO
1 Diritto pubblico - diritto privato
Il diritto, in quanto tendente ad assicurare gli interessi dell’intera collettività, è un fenomeno unita-
rio. Nell’evoluzione storica, esso è, però, stato tradizionalmente distinto in due grandi sfere, da sem-
pre, comunque, oggetto di numerose dispute dottrinali:
䉴 Il diritto pubblico disciplina l’ organizzazione dello Stato e degli altri Enti
Pubblici, regolando la loro azione e i rapporti tra Stato e privati e tra
Diritto pubblico Stato ed Enti pubblici, nonché le libertà fondamentali
䉴 Si articola in varie branche: diritto costituzionale, tributario, amministrati-
vo, penale, processuale (civile e penale), ecclesiastico, navigazione ecc.
䉴 Il diritto privato disciplina i rapporti intersoggettivi lasciando alla inizia-
Diritto privato tiva personale l’attuazione delle singole norme anche se nel rispetto
delle norme costituzionali, dell’ordine pubblico e buon costume
2 Fonti del diritto
2.1. • Generalità
Nozione: sono fonti gli atti o i fatti da cui traggono esistenza le norme giuridiche, lo studio delle
fonti è oggetto del diritto costituzionale.
Con l’affermarsi del pluralismo istituzionale (Regioni, Province, Comuni, Università, Camere di
Commercio etc.) e delle comunità sovranazionali il numero e il tipo di fonti si è notevolmente accre-
sciuto creando complessi problemi di gerarchia e coordinamento.
䉴 Fonti di produzione: organi che concorrono alla formazione delle nor-
me (es.: Parlamento, Governo ecc.)
Specie
䉴 Fonti di cognizione: atti attraverso i quali le pubbliche autorità porta-
no a conoscenza della collettività il diritto vigente
2.2. • Fonti dirette (art. 1 Disp. sulla legge in generale)
• costituzione e leggi costituzionali
䉴 Atti normativi emanati nei • leggi ordinarie
Leggi modi e nelle forme previ-
ste dalla Costituzione • leggi delegate
• decreti legge
Regolamenti: sono fonti di secondo grado, emanate dal potere esecutivo nell’esercizio di un’auto-
noma potestà normativa (87 Cost.); data la loro natura di fonte di secondo grado, i regolamenti sono
subordinati alla legge e non possono modificarla.
Usi: regole di comportamento, osservate dai consociati, per un congruo periodo di tempo in modo
costante ed uniforme, con la convinzione che si tratti di comportamento giuridico doveroso.
Capitolo 4 • Partizioni e fonti del diritto 17
䉴 Usi contrattuali: quelli creati nel commercio contemplati in «clausole d’uso»
o in «pratiche generali dei mercati» (1340)
䉴 Usi interpretativi: valgono per l’utilizzazione e l’interpretazione dei contratti
(1368)
— oggettivi: generalità d’uso, costan-
za d’uso, durata nel tempo
• Elementi
— soggettivi: convincimento di adem-
piere ad un dovere giuridico
Specie — usi « praeter legem»: riguardano
materie non disciplinate da leggi;
䉴 Usi normativi o sono efficaci anche se non richia-
consuetudini mati da legge
— usi «secundum legem»: riguarda-
• Efficacia no materie disciplinate dalla leg-
ge; sono efficaci solo se espres-
samente richiamati
— usi «contra legem»: non hanno ef-
ficacia (15 disp. prel.)
Osservazioni
Le fonti comunitarie
Con il Trattato di Maastricht del 17-2-1992 è stata istituita l’Unione Europea (U.E.) che raggruppa le
tre comunità Europee già esistenti (CE; CECA; EURATOM) e che si propone un’unione progressiva
e globale tra i popoli d’Europa.
Per poter realizzare tali scopi l’U.E., sulla scia della Comunità Europea, si avvale di apposite istitu-
zioni (Parlamento europeo, Commissione, Consiglio) comunitarie.
Il diritto comunitario è costituito, oltre che dalle norme del trattato, dall’insieme delle norme giuridi-
che emanate da tali istituzioni.
In particolare tra le fonti normative comunitarie vincolanti è possibile individuare:
a) i regolamenti, che hanno portata generale, sono obbligatori in tutti i loro elementi e sono
direttamente applicabili ( self-executing) in ciascuno degli Stati membri;
b) le direttive, che vincolano, invece, ciascuno Stato membro cui sono rivolte per quanto riguarda
il risultato da raggiungere, lasciando liberi gli organi nazionali di scegliere la forma e i mezzi
con cui raggiungere il risultato;
c) le decisioni, atti a portata individuale immediatamente applicabili e obbligatorie in tutti i loro elementi.
2.3. • Fonti indirette
La giurisprudenza: insieme delle decisioni giudiziarie, le quali non hanno valore vincolante nel
nostro ordinamento, mentre negli ordinamenti di derivazione britannica (common law) hanno valore
vincolante per il principio dello «stare decisis».
Dottrina: risultati degli studi universitari e di cultori del diritto. Non hanno valore vincolante.
䉴 Come fonte in senso stretto: ha valore quando la legge espressa-
mente vi fa richiamo (es.: 1374)
Equità (giustizia
䉴 Come fonte indiretta: indica una tendenza come criterio di applica-
del caso singolo)
zione delle norme.
È ammessa solo in casi eccezionali
18 Parte Prima • Teoria generale del diritto
PARTE SECONDA
SOGGETTI, ATTI E FATTI GIURIDICI
Capitolo Quinto: Soggetti del diritto .................................................... Pag. 21
Sezione Prima: Persone fisiche - 1 Capacità giuridica • 2 Capacità di
agire • 3 Istituti a protezione degli incapaci • 4 Sede giuridica della
persona • 5 I diritti della personalità • Sezione Seconda: Persone giu-
ridiche - 1 Persona giuridica • Sezione Terza: Enti di fatto - 1 Associa-
zioni non riconosciute • 2 Comitati • 3 Organizzazioni di volontariato •
4 L’impresa sociale
Capitolo Sesto: Spazio e tempo: incidenza su fatti giuridici ............ » 37
1 Generalità • 2 Prescrizione • 3 Decadenza
Capitolo Settimo: Fatti ed atti giuridici: negozio giuridico ................ » 40
1 Generalità • 2 Fatti e fattispecie • 3 Dal fatto al negozio giuridico • 4 Il
negozio giuridico • 5 Caratteri del negozio giuridico • 6 La volontà •
7 Manifestazione della volontà (forma) • 8 La causa • 9 Il soggetto del
diritto e la rappresentanza • 10 La procura • 11 Elementi accidentali del
negozio giuridico • 12 L’invalidità del negozio giuridico • 13 Inefficacia
Capitolo Ottavo: Prova e pubblicità dei fatti giuridici ........................ » 63
A) La prova - 1 Generalità - Il principio dispositivo • 2 Onere della prova
• 3 Mezzi di prova • B) Pubblicità dei fatti giuridici - 4 La pubblicità dei fatti
giuridici • C) La trascrizione • 5 Nozione - Funzione - Natura • 6 Ambito di
applicabilità della trascrizione e principi che la regolano • 7 Singoli atti
soggetti a trascrizione • 8 Altre funzioni della trascrizione • 9 Pubblicità
sanante • 10 Modalità di trascrizione
Capitolo 5 SOGGETTI DEL DIRITTO
Sezione Prima: Persone fisiche
1 Capacità giuridica
1.1 • Nozione - Acquisto - Limitazioni
Nozione: la capacità giuridica è l’attitudine del soggetto ad essere titolare di diritti e di doveri, cioè
di essere punto di riferimento di effetti giuridici. È attribuita indistintamente a tutti i soggetti senza
distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e
sociali (3 Cost.).
䉴 Nascita della persona • Separazione del feto dal corpo della madre (non è richie-
fisica (1 co. 1): sta la vitalità, cioè l’idoneità fisica alla sopravvivenza).
— capacità a succedere «mortis
• Nascituro causa» (462)
concepito — capacità a ricevere donazioni
䉴 Concepimento: in alcu- (784)
Acquisto ni casi è riconosciuta
una eccezionale capaci- — capacità a ricevere successioni
tà subordinata all’even- o donazioni, purché figlio di per-
to nascita: • Nascituro sona determinata, vivente al mo-
non concepito mento della morte del testatore
(462, co. 3) o al momento della
donazione (784, co. 1)
Differenze
Tra il nascituro concepito e il nascituro non concepito, sono state individuate le seguenti differenze
di disciplina giuridica (Bigliazzi-Geri ed altri):
— i concepiti rientrano nelle regole della successione legittima, mentre i non concepiti possono
ricevere solo per testamento;
— l’amministrazione dei beni ereditari è affidata per i concepiti ai genitori, per i non concepiti
all’amministratore dell’eredità (chiunque sia, artt. 641, 642, 643);
— solo per i concepiti la tutela si estende ai rapporti personali, in quanto solo il nascituro concepi-
to può essere riconosciuto come figlio naturale (art. 254).
1.2. • Perdita della capacità giuridica
• Estinzione dei diritti personalissimi
— usufrutto
• Estinzione dei diritti patrimoniali legati
Morte 䉴 Conseguenze
alla persona — alimenti
• Apertura della successione (456)
Capitolo 5 • Soggetti del diritto 21
• Nozione: più persone muoiono a causa dello stesso even-
to (es. naufragio) e non è possibile stabilire chi sia morto
prima
Morte 䉴 Commorienza — presunzione di morte nello stesso
istante
• Disciplina — onere di provare la sopravvivenza di
un commoriente rispetto ad un altro,
a carico di chi vi ha interesse (2697)
— allontanamento dall’ultimo domicilio o
• Presupposti dall’ultima residenza
— mancanza di notizie
— lo scomparso non può ricevere per
䉴 Scomparsa: eredità (70)
Situazione di — il Tribunale dell’ultimo domicilio o re-
fatto (48) sidenza nomina, su istanza di chiun-
• Disciplina que ne abbia interesse o del P.M., un
curatore che rappresenterà lo scom-
parso negli atti che siano necessari
per la conservazione del suo patrimo-
nio (48)
• Presupposti — scomparsa che si protragga da 2 anni
— l’assenza è dichiarata con sentenza
del Tribunale dell’ultimo domicilio, il Tri-
bunale ordina anche:
– l’apertura dei testamenti
– l’immissione temporanea degli ere-
di (legittimi o testamentari) nel pos-
Incertezza 䉴 Assenza:
sull’esistenza sesso dei beni
Situazione di
diritto (49-57) • Disciplina — l’immissione attribuisce:
– l’amministrazione dei beni dell’as-
sente
– la sua rappresentanza in giudizio
– il godimento di eventuali rendite
— la dichiarazione di assenza non è
equiparata alla morte, quindi non scio-
glie il matrimonio dell’assente
— scomparsa protrattasi per 10 anni o
scomparsa verificatasi in alcuni casi
che fanno ritenere probabile la morte
• Presupposti
(60)
— produce gli stessi effetti della morte
䉴 Morte presunta:
Situazione di — gli aventi diritto dispongono libera-
diritto (58-68) mente dei beni
— il coniuge può contrarre nuovo matri-
• Disciplina monio
— la dichiarazione di morte presunta scio-
glie il matrimonio dello scomparso
22 Parte Seconda • Soggetti, atti e fatti giuridici
— se la persona presunta morta ritorna
o viene provata la sua esistenza in
vita gli effetti della dichiarazione ces-
sano con efficacia ex nunc
— la persona ha diritto a recuperare i
䉴 Morte presunta:
Incertezza beni nello stato in cui si ritrovano ed
Situazione di • Disciplina
sull’esistenza ha diritto di conseguire il prezzo di
diritto (58-68)
quelli alienati (66)
— il nuovo matrimonio eventualmente
contratto dal coniuge è invalido (68),
ma l’annullamento non pregiudica i fi-
gli che rimangono legittimi
2 Capacità di agire
2.1. • Nozione, acquisto, perdita
Nozione: la capacità di agire è l’idoneità del soggetto a costituire, modificare o estinguere la propria
situazione giuridica; coincide con la piena acquisizione della capacità di intendere e di volere (2).
䉴 Maggiore età: la piena capacità di agire si acquista di norma al compimento
del 18° anno di età (2)
• matrimonio su dispensa: 16 anni (84)
• adozione: è necessaria una differen-
za di età tra adottante ed adottato di-
versa secondo i vari casi disciplinati
䉴 In alcune ipotesi è prevista dal legisla- dal legislatore
tore una età diversa, ad esempio: • lavoro: l’età minima per l’ammissione al
lavoro è quella posseduta dal minore nel
momento in cui conclude il periodo di
istruzione obbligatoria (che, da ultimo, è
fissato al compimento del 16° anno di
età, ex art. 1, co. 622, l. 296/2006)
Acquisto
• Con il matrimonio autorizzato dal Tribunale e contratto a
16 anni, si consegue, ipso iure, una limitata capacità di
agire (390)
— cessazione della potestà parentale
— acquisto della capacità di agire limi-
䉴 Emancipazione tata agli atti di amministrazione ordi-
per matrimonio naria (394, co. 1); non piena in quan-
to per alcuni atti è richiesto il consen-
• Effetti so del curatore e l’autorizzazione del-
l’A.G. Se l’emancipato è autorizzato
dal Tribunale all’esercizio di un’impre-
sa commerciale, acquista la piena
capacità di agire nell’ambito patrimo-
niale (esclusa la capacità a donare)
䉴 Morte
Perdita
䉴 Interdizione (giudiziale e legale)
Capitolo 5 • Soggetti del diritto 23
Osservazioni
La legge finanziaria 2011 (L. 220/2010) al fine di contrastare il fenomeno del gioco illegale, con
particolare riferimento ai minori, ha espressamente sancito il divieto di partecipazione ai giochi
pubblici con vincita in denaro per i minori di anni diciotto.
2.2. • Interdizione, inabilitazione e incapacità naturale
䉴 Il maggiore di età, che si trovi in abituale stato di infermità mentale, può
essere dichiarato con sentenza incapace a provvedere in modo totale
ai propri interessi. Rispetto alla precedente disciplina, la dichiarazione
di interdizione non consegue necessariamente alla situazione di abi-
tuale infermità mentale poiché, dopo l’introduzione dell’amministrazio-
ne di sostegno (v. par. 3.4), l’utilizzo della misura tradizionale dell’inter-
dizione dovrà essere limitato ai casi di maggiore gravità, quando, cioè,
sia necessario per la protezione della persona priva di autonomia
Interdizione giudiziale 䉴 La sentenza ha natura costitutiva
(414 e segg.)
• incapacità totale di agire. Tuttavia,
nella sentenza può stabilirsi che talu-
ni atti di ordinaria amministrazione
possano essere compiuti dall’interdet-
䉴 Conseguenze to senza l’intervento ovvero con l’as-
sistenza del tutore (427, co. 1)
• nomina di un tutore
• annullabilità degli atti eventualmente po-
sti in essere dall’interdetto (1441, co. 1)
䉴 Prevista dalla legge come pena accessoria di una condanna all’erga-
stolo o a più di 5 anni di reclusione
䉴 L’incapacità dell’interdetto è limitata agli atti di natura patrimoniale (l’in-
Interdizione legale terdetto legale può quindi contrarre matrimonio, riconoscere il figlio na-
turale, fare testamento)
䉴 Annullabilità assoluta degli atti eventualmente posti in essere dall’inter-
detto (1441, co. 2)
Si ha, invece, incapacità relativa in caso di:
䉴 L’inabilitazione comporta una limitazione della capacità del soggetto
• limitazione della capacità ai soli atti
di ordinaria amministrazione
• per gli atti eccedenti l’ordinaria am-
ministrazione è necessaria l’autoriz-
zazione del giudice tutelare ed il con-
senso del curatore. Tuttavia, nella sen-
Inabilitazione (415)
tenza che pronuncia l’inabilitazione
䉴 Effetti
può stabilirsi che taluni atti eccedenti
l’ordinaria amministrazione possano
essere compiuti dall’inabilitato senza
l’assistenza del curatore (427, co. 1)
• atti di cui all’art. 375: autorizzazione del
Tribunale ed assistenza del curatore
24 Parte Seconda • Soggetti, atti e fatti giuridici
• gli atti compiuti, senza le dovute for-
me, sono annullabili su istanza del-
䉴 Effetti
l’inabilitato o dei suoi eredi o aventi
causa
Inabilitazione (415) • infermità abituale non grave
• prodigalità
䉴 Cause • abuso di sostanze alcooliche o stu-
pefacenti, imperfezioni o menomazio-
ni fisiche (415)
䉴 L’incapacità naturale consiste nell’incapacità di intendere e di volere,
anche transitoria, dovuta ad una qualsiasi causa (ubriachezza, delirio
febbrile, infermità di mente, ipnosi)
• atti unilaterali: è necessario dimostra-
re l’incapacità ed un grave pregiudizio
per l’autore (428, co. 1)
Incapacità naturale • contratti: è da dimostrare la mala fede
(428) o di fatto dell’altro contraente (428, co. 2), che
䉴 Gli atti posti in essere in
tale stato sono annullabi- risulti dal pregiudizio subito dall’inca-
li, in particolare: pace, dalla qualità del contratto o altri-
menti
• per altri atti (matrimonio, testamento,
donazione) è sufficiente dimostrare la
sola incapacità naturale
Osservazioni
La dottrina (BIANCA), poi, ha elaborato il concetto di atti minuti di vita quotidiana, con riferimen-
to a quegli atti che, pur potendo essere considerati veri e propri negozi giuridici, non richiedono
tuttavia la generale capacità di agire del soggetto agente ma, in considerazione della loro quotidia-
nità, presuppongono semplicemente in chi li compie la capacità di comprenderne e valutarne il
significato.
3 Istituti a protezione degli incapaci
3.1. • Potestà dei genitori o potestà parentale
Nozione: potere spettante ai genitori di proteggere, educare, istruire i figli e di curarne gli interessi
patrimoniali.
• i genitori possono compiere disgiuntamente gli at-
ti di ordinaria amministrazione, agendo quali rap-
䉴 Cura dei beni presentanti
del minore • gli atti di straordinaria amministrazione devono es-
Potestà parentale sere compiuti congiuntamente e con l’autorizza-
zione del giudice tutelare
— la sicurezza
䉴 Cura della persona
del minore • I genitori devono proteggere: — la salute
— la moralità
Capitolo 5 • Soggetti del diritto 25
3.2. • Tutela
Nozione: la tutela è un ufficio di diritto privato, gratuito ed irrinunciabile, istituita allo scopo di
realizzare l’interesse pubblico della protezione degli interdetti e dei minori privi di genitori in condizione
di esercitare la potestà. Il tutore è nominato dal giudice tutelare.
䉴 Volontaria: il tutore è designato dal genitore
䉴 Legittima: quando è affidata a parenti prossimi o ad affini del minore
Tipi di tutela 䉴 Dativa: quando è affidata a persone che non sono parenti, scelte libe-
(Trabucchi) ramente dal giudice tutelare
䉴 Assistenziale: affidata ad un ente di assistenza nei casi previsti dal-
l’art. 345
• Nomina il tutore (346)
— rappresenta il mino-
re che abbia un in-
䉴 Alla funzione tutoria so- teresse in contrasto
vraintende un giudice tu- con quello del tuto-
Disciplina telare che dà le direttive re (360, co. 1).
circa l’amministrazione e
• Nomina un
l’educazione del minore;
protutore che — compie atti conser-
in particolare:
vativi e di urgente
amministrazione
quando manca il tu-
tore (360, co. 3)
䉴 Il tutore rappresenta l’incapace non solo nei rapporti patrimoniali ma
anche in quelli personali (tutor datur personae curator bonis)
䉴 Il tutore può compiere gli atti di ordinaria amministrazione e quelli ne-
Poteri del tutore
cessari al mantenimento dell’incapace. Alcuni atti possono essere po-
sti in essere dal tutore solo se autorizzati dal giudice tutelare (374). Gli
atti previsti dall’art. 375 possono essere posti in essere dal tutore solo
se autorizzati dal Tribunale su parere del giudice tutelare
3.3. • Curatela
Nozione: con la curatela viene integrata la volontà dell’inabilitato o minore emancipato. È un istitu-
to di protezione prevalentemente privatistico. Il curatore è nominato dal giudice tutelare.
䉴 Il curatore non rappresenta, ma assiste l’incapace, integrando la sua
volontà
Poteri 䉴 Il curatore interviene solo per alcuni atti; in particolare interviene solo
per rapporti patrimoniali e provvede solo alla cura dei beni ( tutor datur
personae curator bonis)
䉴 Svolge funzioni analoghe a quella della curatela, ma è limitata ad una
sfera particolare o alla gestione di un patrimonio separato o di determi-
Curatela speciale
nati beni.
La nomina compete ad autorità diverse dagli organi tutelari
26 Parte Seconda • Soggetti, atti e fatti giuridici
• Curatore assistente: nelle convenzioni
matrimoniali, viene nominato al mino-
re o agli inabilitati (90,165, 166).
• Curatore rappresentante: casi di con-
flitto di interessi tra figli soggetti alla
stessa potestà, o tra essi e i genitori,
o tra essi ed il genitore che in via
esclusiva esercita la potestà (320, co.
Curatela speciale 䉴 Casi 6).
• Curatore con funzioni di rappresen-
tanza in giudizio: a soggetti assenti o
privi di rappresentanza (78-80 c.p.c.;
486 c.c.; 780 c.p.c.; 2845 c.c.; 795
c.p.c.).
• Curatore rappresentante processua-
le (273-274, 264, co. 2, 247, 248).
3.4. • Amministrazione di sostegno
Nozione e fondamento: con l’amministrazione di sostegno l’ordinamento tutela coloro i quali, pur
non versando in condizioni di infermità tali da richiedere una pronuncia di interdizione o di inabilitazio-
ne, sono affetti da forme di disabilità fisica o di disagio psichico che ostacolano il pieno esercizio dei
propri diritti ed impediscono di attendere ai propri interessi.
䉴 Infermità di mente anche parziale o temporanea
Presupposti
䉴 Menomazione fisica o psichica (es. autismo, sindrome di Down etc.)
䉴 Da parte dell’interessato, anche in previsione della propria futura inca-
pacità (in tale ultimo caso è necessario l’atto pubblico o la scrittura
Scelta privata)
dell’amministrazione
䉴 Da parte del giudice, in mancanza di indicazione da parte dell’interes-
sato ovvero in presenza di gravi motivi
• interessato
䉴 Ricorso al giudice • soggetti indicati nell’art. 417
tutelare proposto da: • responsabili dei servizi sanitari e so-
ciali impegnati nella cura e assisten-
Procedimento za della persona (406)
䉴 Il giudice deve sentire personalmente l’interessato e tenere conto, com-
patibilmente con le esigenze di protezione della persona, dei bisogni e
delle richieste di questa (407)
䉴 Il giudice provvede alla nomina con decreto
䉴 Il beneficiario dell’amministrazione di sostegno conserva la capacità di
agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o
Effetti l’assistenza necessaria dell’amministratore
䉴 Gli atti compiuti dal beneficiario o dall’amministratore in violazione del-
la legge o delle prescrizioni del giudice sono annullabili
Capitolo 5 • Soggetti del diritto 27
Osservazioni
La Corte cost., con sent. 9-12-2005, n. 440, nel rigettare le questioni di legittimità costituzionale
relative all’istituto in esame, ne ha fornito un’autorevole lettura interpretativa.
Ha sostenuto la Corte che spetta al giudice l’individuazione dell’istituto che garantisce all’incapace
la tutela più adeguata alla sua situazione e, nel caso in cui si opti per l’amministrazione di sostegno,
i poteri dell’amministratore devono essere strettamente modulati sul caso concreto. «Solo se non
ravvisi interventi di sostegno idonei ad assicurare all’incapace siffatta protezione, il giudice può
ricorrere alle ben più invasive misure dell’inabilitazione o dell’interdizione, che attribuiscono uno
status di incapacità, estesa per l’inabilitato agli atti di straordinaria amministrazione e per l’interdet-
to anche a quelli di ordinaria amministrazione».
Finalità dell’istituto è, quindi, a detta della Corte, quella di tutelare, con la minore limitazione possi-
bile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle
funzioni della vita quotidiana.
L’istituto è stato, invece, aspramente criticato in dottrina (su tutti Gazzoni), che si è soffermata
sull’inutilità della nuova disciplina. Si è osservato che il fine legislativo era quello di fornire una
protezione non solo patrimoniale ma anche e soprattutto nel campo degli interessi personali alle
persone incapaci di badare ai propri interessi e, tuttavia, i riferimenti che la legge fa alla cura della
persona e agli interessi morali dell’assistito sono destinati a rimanere una formula vuota. Ciò in
quanto o il soggetto è capace di intendere e di volere e, dunque, può badare a se stesso sul piano
personale, oppure non lo è e quindi deve essere interdetto o inabilitato. Anche l’amministratore di
sostegno è, quindi, destinato a diventare un curatore di interessi patrimoniali.
4 Sede giuridica della persona
Il luogo in cui le persone vivono e svolgono la propria attività assume rilevanza nell’ordinamento
giuridico, in quanto è necessario che si conosca il luogo dove il soggetto opera e può essere reperito.
䉴 Dimora: luogo in cui una persona si trova occasionalmente.
• nozione: luogo in cui la persona ha la
sua abituale dimora (43, co. 2)
• caratteristiche: effettiva ed abituale pre-
senza del soggetto in un dato luogo
• Se la residenza coincide con il domi-
䉴 Residenza cilio il trasferimento della prima impli-
(res facti) ca, per i terzi in buona fede, il trasferi-
mento del secondo (44)
Tipi • Si può avere anche più di una resi-
denza se la dimora abituale è in più
luoghi (Trabucchi)
• Nozione: luogo dove il soggetto stabilisce la sede
principale dei propri affari ed interessi (43)
䉴 Domicilio — oggettivo: presenza in un luogo dei
(res juris) prevalenti interessi economici del-
la persona, e non necessariamen-
• Elementi te della persona stessa
— soggettivo: volontà di fissare in un
luogo la sede dei propri affari
28 Parte Seconda • Soggetti, atti e fatti giuridici
— domicilio volontario
— domicilio legale: stabilito dalla leg-
ge (art. 45: il minore ha il domicilio
nel luogo di residenza della fami-
Tipi 䉴 Domicilio • Tipi glia o quello del tutore)
(res jius) — domicilio generale: si riferisce a
tutti i diritti ed affari di un soggetto.
— domicilio speciale: per atti o affari
determinati (47)
Differenze
La residenza e il domicilio si differenziano, in sostanza, per il carattere statico della prima, quale
dimora abituale, e dinamico del secondo, centro degli affari e degli interessi personali e patrimo-
niali del soggetto. Un soggetto può essere privo del domicilio o della residenza qualora non abbia
costituito con una certa stabilità un centro dei propri affari e interessi o non abbia una dimora
abituale. Non si possono avere più domicili; analogamente, la definizione di residenza quale dimora
abituale sembra escludere che vi possano essere più residenze diverse (Di Pirro).
5 I diritti della personalità
Nozione: diritti soggettivi aventi ad oggetto taluni attributi essenziali della persona umana.
䉴 Essenziali: garantiscono le ragioni fondamentali della vita e dello svi-
luppo fisico e morale di una persona
䉴 Personalissimi: hanno ad oggetto un modo d’essere della persona
䉴 Originari, se sorgono con la nascita; sono detti anche innati in quanto
prescindono da un qualsiasi riconoscimento giuridico
䉴 Derivati, se si acquistano successivamente, durante la vita della per-
sona (es.: il diritto allo status di coniuge)
Caratteristiche
䉴 Non patrimoniali: perché non possono assumere un valore di scam-
bio
䉴 Assoluti: opponibili erga omnes
䉴 Inalienabili
䉴 Imprescrittibili
䉴 Irrinunziabili
䉴 Il diritto alla vita e alla integrità fisica: è tutelato sia dal codice pena-
le che dal codice civile (5) che vieta gli atti di disposizione del proprio
Tipi corpo
䉴 Il diritto all’onore: tutela il rispetto della propria dignità personale (ono-
re) e la considerazione sociale di cui una persona gode (reputazione);
è espressamente previsto e tutelato da norme penali
Capitolo 5 • Soggetti del diritto 29
䉴 Il diritto alla riservatezza: tutela l’esigenza di un uomo ad escludere
dall’altrui conoscenza quanto ha riferimento alla propria persona
È previsto e tutelato da norme del codice civile (10), dalla legge sul
diritto di autore, da norme del codice penale (615bis ) e dal d.lgs. 196/
2003 (Codice in materia di dati personali).
Le norme del Codice, in particolare, sono dettate a garanzia delle esi-
genze di riservatezza, identità personale e dignità dei soggetti i cui dati
personali vengono trattati, con previsione del diritto di ottenere l’ag-
giornamento, la rettifica, l’integrazione o la cancellazione dei dati me-
desimi, nonché del diritto di opporsi in tutto o in parte al trattamento. La
medesima ratio ha condotto all’istituzione di un’autorità amministrativa
con finalità di controllo: il Garante per la protezione dei dati personali.
In dottrina (GALGANO) si è prospettato un diritto all’oblio, che consi-
sterebbe nel diritto ad ottenere la cancellazione dei propri dati o di parti
di essi, contenuti in banche dati, nel momento in cui cessi l’utilità della
loro conservazione.
䉴 Il diritto alla immagine: tutela l’interesse di ciascun individuo a che il
proprio ritratto non sia diffuso o esposto pubblicamente
Tipi 䉴 Il diritto al nome: tutela l’interesse di un soggetto ad usare il proprio
nome inteso come segno distintivo della persona.
È espressamente tutelato dal codice civile con due azioni.
Azione di reclamo, con la quale si tutela il diritto di una persona ad
usare il proprio nome contro atti dei terzi che contrastino tale uso.
Azione di usurpazione: diretta contro l’uso illegittimo che altri facciano
del nome
䉴 Il diritto alla propria identità personale: diritto di conio prettamente
giurisprudenziale, è il diritto ad essere se stessi, cioè a non vedersi
attribuire comportamenti, idee o modi di essere diversi da quelli che si
sentono come propri
䉴 Il diritto alla identità sessuale: è il diritto al riconoscimento del pro-
prio sesso
䉴 Il diritto alla bigenitorialità: diritto del figlio minore, in caso di separa-
zione dei genitori, di mantenere un rapporto continuativo ed equilibrato
con entrambi i genitori e di conservare rapporti significativi con gli ascen-
denti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale
Osservazioni
L’esistenza di un diritto all’identità sessuale costituisce il fondamento della legittimità della L.
164/82 sulla rettificazione di sesso. La dottrina (Di Pirro) ha osservato che l’equilibrio psicofisico
della persona transessuale non implica necessariamente l’adeguamento chirurgico degli organi
sessuali, al quale spesso si ricorre per la necessità di regolarizzare una situazione nella quale si è
soggetti a discriminazione e privazione dei diritti fondamentali. Negli ultimi anni la giurisprudenza
della Corte europea dei diritti dell’uomo ha progressivamente riconosciuto l’esistenza di un diritto
all’identità di genere sulla base degli artt. 8 e 14 della Convenzione europea per la salvaguardia
dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Sarebbe opportuno, pertanto, secondo la dottrina
citata, che il legislatore italiano rendesse esplicito il principio del diritto all’identità di genere, secon-
do cui la rettificazione degli atti dello stato civile e il cambio di nome devono essere effettuati
indipendentemente dall’intervento chirurgico di adeguamento degli organi genitali.
30 Parte Seconda • Soggetti, atti e fatti giuridici
Sezione Seconda: Persone giuridiche
1 Persona giuridica
Nozione: la persona giuridica è un complesso organizzato di persone e di beni, rivolto ad uno
scopo, al quale la legge riconosce la qualifica di soggetto di diritto.
Fondamento: per motivi di opportunità si attribuisce la soggettività ad enti diversi dalla persona
fisica per assicurare il conseguimento di determinati obiettivi che non si prestano ad essere conseguiti
da individui singolarmente considerati.
Caratteristica: autonomia patrimoniale; il patrimonio delle persone giuridiche è nettamente distin-
to da quello dei singoli componenti.
1.1. • Tipi ed elementi costitutivi
Corporazioni: complesso organizzato di perso- 䉴 Associazioni: in esse lo scopo è di natura non pre-
ne fisiche riunite per il conseguimento di uno sco- valentemente economico (es. culturale, sportivo)
po e nelle quali predomina l’elemento personale 䉴 Società: hanno scopo di lucro (società di capitali)
(si parla, infatti, di Universitas personarum). o mutualistico (società mutualistiche) (2247)
Istituzioni: complesso organizzato di beni de- 䉴 Fondazioni: un fondatore o un comitato promoto-
stinati ad una determinata opera dalla volontà re conferiscono il patrimonio iniziale e fissano lo
di uno o più fondatori, nelle quali predomina scopo da perseguire
l’elemento patrimoniale (Universitas rerum).
䉴 Comitati: vedi infra.
䉴 Pluralità di persone: il patrimonio è solo un mezzo per raggiungere lo
Elementi delle scopo
corporazioni
䉴 Scopo comune: deve essere determinato e lecito
䉴 Patrimonio: i soggetti sono solo destinatari dell’attività delle fondazioni
Elementi delle istituzioni
䉴 Scopo: deve essere determinato e lecito
䉴 Riconoscimento (elemento formale): non è più concesso con decre-
to del Presidente della Repubblica. È attribuito dalla Regione per le
persone giuridiche private che operano nelle materie delegate ex d.P.R.
n. 616/1977 e le cui finalità si esauriscono nell’ambito di una sola Re-
gione; dal Prefetto in tutti gli altri casi (d.P.R. 361/2000 che ha abrogato
Elemento comune: l’art. 12 c.c.); si ottiene con l’iscrizione nel registro delle persone giuri-
riconoscimento diche appositamente istituito presso le Regioni e le Prefetture - Uffici
territoriali del Governo
䉴 Riconoscimento delle società commerciali: esse acquistano la per-
sonalità giuridica ope legis con l’iscrizione nel registro delle imprese (2331)
䉴 Riconoscimento per registrazione (39 Cost.): per i soli sindacati; è
inattuato
Il riconoscimento è un elemento necessario per l’acquisto della personalità giuridica.
Capitolo 5 • Soggetti del diritto 31
Differenze
Le maggiori differenze tra associazioni e fondazioni riguardano:
— il patrimonio, che per le fondazioni è elemento costitutivo essenziale e prevalente rispetto a
quello delle persone, mentre per le associazioni costituisce un elemento costitutivo di minore
importanza rispetto a quello delle persone, anche se costituisce, comunque, un mezzo (stru-
mento) per il raggiungimento dello scopo;
— lo scopo, che nelle fondazioni è esterno, in quanto consiste nella realizzazione di un vantaggio per
altri, mentre nelle associazioni è interno, in quanto consiste nell’arrecare un dato vantaggio ai soci;
— la volontà, che nelle fondazioni è esterna, in quanto proviene dal fondatore, mentre nelle asso-
ciazioni è interna, in quanto è manifestata dagli stessi soci attraverso gli organi competenti;
— gli organi direttivi, i quali nelle fondazioni sono sottoposti alla volontà del fondatore, mentre
nelle associazioni sono dominanti .
1.2. • Capacità e vicende
• atto costitutivo (14-16): è un atto pub-
blico, appartenente alla categoria dei
negozi bi o plurilaterali. Secondo la
maggior parte della dottrina ha natu-
ra di contratto di organizzazione,
con comunione di scopo.
È un contratto perché le parti si obbli-
gano, con esso, ad eseguire apporti
economicamente valutabili: la natura
non economica dell’interesse, che tali
䉴 Associazioni apporti tendono a soddisfare, non in-
fluisce sulla natura contrattuale del
vincolo (Galgano).
• statuto: atto pubblico che contiene le
norme che regoleranno la vita dell’ente.
È vincolante anche per i futuri compo-
Costituzione nenti (16). Le modificazioni dello statuto
e quelle dell’atto costitutivo devono es-
sere approvate con le modalità e i ter-
mini previsti per l’acquisto della perso-
nalità giuridica dall’art.1 d.P.R. 361/2000.
• negozio di fondazione: negozio uni-
laterale che esprime la volontà del
fondatore a che sorga la fondazione;
deve anche in tal caso rivestire la for-
ma dell’ atto pubblico. Le fondazioni
possono però essere disposte anche
䉴 Fondazioni per testamento (14, co. 2)
• atto di dotazione: negozio unilaterale
che opera l’attribuzione dei beni a ti-
tolo gratuito, avente, quindi, contenu-
to strettamente patrimoniale, al con-
trario del negozio di fondazione che
ha contenuto personale
• statuto: come per le associazioni
32 Parte Seconda • Soggetti, atti e fatti giuridici
Capacità giuridica: 䉴 Nel campo dei diritti personali: la persona giuridica è priva di tutti quei
capacità illimitata e diritti che presuppongono un organismo fisico. Gode eccezionalmente
generale, salvo le li- di alcuni diritti personalissimi (es. diritto al nome)
mitazioni dovute alla
䉴 Nel campo dei diritti patrimoniali: era necessaria l’autorizzazione go-
particolare natura
vernativa (17) per l’acquisto di immobili e per l’accettazione di eredità e
legati. La norma, dettata allo scopo di evitare la c.d. «manomorta», è
stata abrogata dall’art. 13 l. 127/97
䉴 Nozione: non fornita di entità fisica, la persona giuridica agisce attraverso
gli amministratori che non sono rappresentanti dell’ente, ma parte dello
stesso, legati ad esso da un rapporto di «immedesimazione organica»
Capacità di agire 䉴 Amministratori: organi comuni ad ogni persona giuridica
䉴 Assemblea sociale: organo deliberativo delle associazioni. Per le de-
liberazioni si applica il principio maggioritario, e l’atto posto così in es-
sere è atto collegiale (20-21)
Osservazioni
La tutela civilistica del nome e dell’immagine è invocabile anche dalle persone giuridiche, pub-
bliche o private, e dai soggetti diversi dalle persone fisiche, in relazione all’eguale interesse ad
evitare confusione con altri soggetti (cfr. Cass. 18218/2009).
Sede: luogo dove la persona giuridica svolge la propria attività.
䉴 Iscrizione nel registro delle persone giuridiche: le vicende delle per-
sone giuridiche vanno iscritte negli appositi registri regionali e prefettizi
istituiti dal d.P.R. 10-2-2000, n. 361, che ha soppresso il registro delle
persone giuridiche tenuto presso la Cancelleria del Tribunale in ogni
capoluogo di provincia
䉴 Carattere costitutivo: le associazioni, le fondazioni e le altre istituzio-
ni di carattere privato acquistano la personalità giuridica «mediante il
riconoscimento determinato dall’iscrizione nel registro delle persone
Pubblicità giuridiche» (art. 1 d.P.R. 361/2000)
• sanzioni amministrative a carico degli
amministratori (35). Responsabilità
personale e solidale degli amministra-
tori per le obbligazioni assunte in nome
䉴 Omissione e per conto della persona giuridica
• inopponibilità ai terzi dell’atto, se non
si prova che questi ne erano a cono-
scenza
• cause previste dalla volontà degli associati o
dal fondatore
Estinzione 䉴 Cause comuni
• conseguimento dello scopo o impossibilità di
raggiungerlo
Capitolo 5 • Soggetti del diritto 33
— mancanza di tutti gli as-
sociati
• Associazioni
Estinzione — scioglimento disposto dal-
䉴 Cause specifiche
l’assemblea
• Fondazioni: trasformazione dello scopo dispo-
sta dall’autorità governativa (28)
Con l’entrata in vigore del d.P.R. 361/2000 l’estinzione non deve essere più dichiarata dall’au-
torità governativa; la Prefettura, la Regione o la Provincia autonoma competente accerta, su istanza
dell’interessato o anche d’ufficio, l’esistenza di una delle cause di estinzione e dà comunicazione
della dichiarazione di estinzione agli amministratori e al Presidente del Tribunale competente. Si
apre così la fase della liquidazione, in cui si definiscono i rapporti giuridici pendenti e si provvede
sui beni, al termine della quale si provvede alla cancellazione dell’ente dal registro delle persone
giuridiche.
Sezione Terza: Enti di fatto
1 Associazioni non riconosciute
Nozione: complessi organizzati di persone e di beni, diretti alla realizzazione di uno scopo, econo-
mico o meno, che non hanno richiesto o ottenuto il formale riconoscimento . L’ordinamento giuridico
riconosce rilevanza al loro modo di essere e di operare.
䉴 Teoria negatrice della personalità: afferma che le associazioni non
riconosciute sono dotate di una semplice autonomia patrimoniale, ma
non si tratta di soggetti di diritto distinti dai propri membri. Titolari dei
rapporti giuridici inerenti alle associazioni sarebbero i singoli asso-
ciati
Natura giuridica
䉴 Teoria della personalità attenuata (o della soggettività senza persona-
lità): le associazioni non riconosciute sono soggetti collettivi, dotati di
capacità giuridica limitata e di autonomia patrimoniale imperfetta. Si
afferma, in particolare, che le associazioni non riconosciute non hanno
personalità, ma solo soggettività giuridica, che implica il formarsi di un
autonomo centro di interessi cui fanno capo obbligazioni e diritti distinti
da quelli dei componenti
Disciplina 䉴 L’ordinamento interno e l’amministrazione sono regolati dagli accordi
degli associati (36)
䉴 I contributi degli associati e i beni acquistati dall’ente costituiscono il
c.d. fondo comune e su di esso si possono eventualmente soddisfare i
terzi creditori
䉴 Delle obbligazioni rispondono anche, personalmente e solidalmente,
le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione
䉴 Sono dotate di capacità processuale
Secondo le disposizioni della L. 22-6-2000, n. 192 che ha abrogato gli artt. 600 e 786, le associazioni
non riconosciute possono accettare eredità, legati o donazioni senza necessità di chiedere il ricono-
scimento entro un anno, come precedentemente previsto.
34 Parte Seconda • Soggetti, atti e fatti giuridici
2 Comitati
Nozione: si designa con tale termine una organizzazione di persone che si propone il raggiungi-
mento di uno scopo, generalmente di interesse pubblico ed in ogni caso non egoistico, attraverso la
costituzione, per pubbliche sottoscrizioni, di un fondo.
䉴 Aspetto soggettivo: componenti del comitato (promotori)
䉴 Aspetto oggettivo (fondo): attività dei promotori per la raccolta a mez-
zo di pubbliche sottoscrizioni o inviti ad offrire, dei mezzi materiali per
Caratteri generali costituire il fondo. Aspetto prevalente rispetto a quello soggettivo
䉴 Scopo: beneficenza, opere pubbliche, soccorso (39)
䉴 Forma: anche verbale
䉴 Autonomia patrimoniale imperfetta: il fondo non appartiene né agli obla-
tori né ai membri del comitato, ma è irrevocabilmente destinato allo scopo
Disciplina
䉴 Regime di responsabilità: delle obbligazioni assunte rispondono tutti
i componenti del comitato, personalmente e solidalmente (40-41)
• Eventuali residui sono devoluti se-
condo le previsioni dell’atto di co-
䉴 Raggiungimento dello scopo
Estinzione stituzione; in mancanza provvede
l’autorità governativa (42)
䉴 Insufficienza dei fondi
Se i promotori chiedono il riconoscimento della personalità giuridica, il comitato diventa una vera e
propria fondazione; secondo Trabucchi, però, resta applicabile l’art. 40, di guisa che sussiste una
speciale responsabilità solidale degli organizzatori.
3 Organizzazioni di volontariato
Nozione: organismo liberamente costituito al fine di svolgere attività di volontariato che si avvalga
in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti
(l. 11-8-1991, n. 266).
䉴 Le organizzazioni possono assumere qualsiasi forma giuridica
䉴 L’attività è svolta in modo personale, spontaneo e gratuito
Caratteristiche
䉴 Assenza di scopo di lucro
䉴 Fini di solidarietà
䉴 Non possono perseguire fini di lucro
䉴 Devono avere una struttura democratica
Limiti 䉴 Le cariche associative devono essere elettive e gratuite
䉴 Hanno l’obbligo di iscriversi nel Registro delle organizzazioni di volon-
tariato, tenuto dalle Regioni e Province autonome, per accedere ai con-
tributi pubblici
Capitolo 5 • Soggetti del diritto 35
4 L’impresa sociale
Nozione: enti imprenditoriali privi del carattere lucrativo tipico dell’imprenditore commerciale, so-
stituito dalla finalità di utilità sociale e di interesse collettivo.
䉴 Organizzazioni private, comprese le società e gli enti di cui al libro V
del codice civile, che esercitano, in via stabile e principale, un’attività
economica organizzata per la produzione e lo scambio di beni e servizi
di utilità sociale con finalità di interesse generale, e che sono in pos-
Tipologie sesso dei requisiti richiesti dal D.Lgs. 155/2006
䉴 Imprese che esercitano attività al fine dell’inserimento lavorativo di sog-
getti che siano lavoratori svantaggiati o lavoratori disabili, indipenden-
temente dal settore di attività
䉴 Atto pubblico: deve espressamente indicare, oltre a quanto stabilito
per ciascun tipo di organizzazione, il carattere sociale dell’impresa, l’og-
Costituzione getto sociale e l’assenza dello scopo di lucro
e amministrazione
䉴 Si applicano le disposizioni previste dal codice civile in materia di direzione
e controllo del gruppo cooperativo paritetico (artt. 2497 ss., 2545septies)
In sintesi
Persona, nel linguaggio giuridico, sta a significare soggetto di diritto. L’ordinamento giuridico stabili-
sce che debba essere considerato soggetto di diritto, ossia persona: tale qualificazione deriva dal
riconoscimento di un soggetto come centro unitario di imputazione di situazioni giuridiche soggettive.
Nel nostro ordinamento, soggetti dell’attività giuridica sono: le persone fisiche; le persone giuri-
diche; gli enti di fatto.
Per quanto riguarda le persone fisiche, la nostra Costituzione sancisce due fondamentali principi :
ogni essere umano, solo perché è persona fisica, è considerato dall’ordinamento anche soggetto
di diritto; tali soggetti hanno tutti uguale grado di soggettività giuridica.
Relativamente, invece, alle persone giuridiche, la Costituzione prevede tra i diritti dei cittadini quel-
lo di associarsi liberamente per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. La libertà di
associazione, dunque, postula la creazione di formazioni sociali che coinvolgono una pluralità di
cittadini, la creazione, cioè, di enti soggetti ad una particolare disciplina a seconda della struttura o
dello scopo che sono loro imposti.
36 Parte Seconda • Soggetti, atti e fatti giuridici
Capitolo 6 SPAZIO E TEMPO: INCIDENZA SU FATTI GIURIDICI
1 Generalità
Per alcuni autori (SANTORO PASSARELLI, TORRENTE) spazio e tempo non vanno annoverati
tra i fatti giuridici, ma debbono essere intesi come «modi di essere» dei fatti giuridici. In particolare:
— lo spazio è la dimensione spaziale in cui si colloca il fatto;
— il tempo è la dimensione temporale in cui si realizza un determinato fatto giuridico.
Il computo del tempo avviene sulla base del calendario comune, secondo i criteri previsti dall’art.
2963.
Il tempo, insieme ad altri elementi, può dar luogo:
— all’acquisto di un diritto reale per usucapione (vedi cap. 17).
— alla prescrizione (vedi par. 2);
— alla decadenza (vedi par. 3).
2 Prescrizione
Nozione: la prescrizione è l’estinzione del diritto soggettivo conseguente al mancato esercizio
dello stesso da parte del titolare per un lasso di tempo determinato dalla legge (2934).
Fondamento: il mancato esercizio del diritto da parte del titolare genera un contrasto tra una
situazione di diritto e una situazione di fatto. Questa difformità contrasta con il principio della certez-
za del diritto, per cui la situazione di fatto viene privilegiata rispetto a quella di diritto; la prescrizione
può essere considerata come il prezzo, in termini di giustizia, dell’istanza di certezza del diritto.
䉴 Esistenza di un diritto soggettivo
Presupposti 䉴 Mancato esercizio del diritto
䉴 Decorso del tempo previsto dalla legge
Inderogabilità: la prescrizione, tutelando un interesse di carattere generale, non è derogabile
dalla volontà privata: per cui è nullo ogni patto di modifica o di rinuncia alla prescrizione (2936 - 2937).
Le parti non possono prevedere la prescrizione dei diritti ma solo limitarsi a prevedere decadenze.
La rinuncia è esercitabile solo dopo che la prescrizione è compiuta; essa può essere espressa o
tacita (fatti incompatibili in modo assoluto con la volontà di farla valere). Essendo interesse del sogget-
to farla valere o meno, non è rilevabile d’ufficio la prescrizione non opposta (2938).
䉴 Diritti indisponibili (es.: diritti della personalità)
Oggetto: di regola tutti
i diritti (2934). 䉴 Diritto di proprietà (può, però, essere usucapito da altri)
Sono però esclusi
䉴 Altri diritti indicati dalla legge
Inizio: la prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto avrebbe potuto essere legittimamente
esercitato (actiones nondum natae non praescribitur).
Capitolo 6 • Spazio e tempo: incidenza su fatti giuridici 37
䉴 Nozione: si verifica quando l’inerzia del titolare è giustificata espressa-
mente dalla legge (2941-2942) (es. determinati rapporti tra le parti,
particolare condizione del titolare)
Sospensione
䉴 Effetti: il periodo di sospensione non si calcola (si opera una parentesi
nel corso della sospensione). Cessata la causa, il termine riprende il
suo corso
• il titolare esercita il suo diritto (doman-
da giudiziale, messa in mora) (2943)
䉴 Nozione: si ha interruzione • il diritto viene riconosciuto da parte di
quando: colui contro il quale può essere fatto
Interruzione valere (2944) (es. ricognizione di de-
bito)
䉴 Effetto: il periodo già trascorso perde effetto; dalla cessazione della
causa ricomincia a decorrere, per intero, un nuovo periodo
䉴 Prescrizione ordinaria: 10 anni, in tutti i casi in cui la legge non dispo-
ne diversamente (2946)
Durata della prescrizione 䉴 Prescrizione dei diritti reali su cosa altrui: 20 anni
䉴 Prescrizione breve: meno di 10 anni (2947 - 2953). L’azione diretta
alla esecuzione del giudicato si prescrive, però, nel termine ordinario
䉴 Nozione: alcuni diritti, propri della vita quotidiana, si presumono pre-
scritti in tempi ridotti, in quanto è necessario che la certezza del diritto
prevalga.
Si estinguono pertanto senza particolari formalità; ad esempio, si pre-
scrive in un anno il diritto per il prezzo delle merci vendute a chi non ne
fa commercio (2955 n. 5), in sei mesi il diritto degli albergatori e degli
Prescrizioni presuntive osti (2954)
• inversione dell’onere della prova: il de-
bitore è esonerato dal fornire in giudi-
zio la prova della estinzione dei debiti
䉴 Effetto:
• limitazione dei mezzi di prova: è am-
messo il solo giuramento decisorio
(2960)
䉴 Estinzione del diritto: il riferimento del legislatore alla estinzione del
diritto viene contestato da chi sostiene che il diritto non si estingue ma
perde la propria forza, nel senso che chi è chiamato in giudizio può
bloccare l’iniziativa giurisdizionale eccependo l’intervenuta prescrizio-
Effetto della prescrizione
ne (estinzione dell’azione). Ciò anche in base a quanto disposto dal-
l’art. 2940 secondo cui non è ammessa la ripetizione di quanto sponta-
neamente pagato in adempimento di un’obbligo prescritto. Se il diritto
non esistesse più dovrebbe ammettersi la ripetizione (2033)
3 Decadenza
Nozione: la decadenza consiste nella perdita della possibilità di esercitare un diritto per il mancato eser-
cizio in un termine perentorio (2964). Secondo la migliore dottrina si riferisce per lo più a diritti potestativi.
38 Parte Seconda • Soggetti, atti e fatti giuridici
Presupposti: oggettiva mancanza di esercizio di un diritto nel tempo stabilito.
Fondamento: esigenza di certezza e tutela dell’affidamento nei rapporti giuridici, in relazione a
situazioni soggettive che non sono suscettibili di un esercizio ripetuto ma dipendono dal compimento
di un unico atto e per le quali è opportuno circoscrivere l’incertezza ad un tempo limitato.
Da tale fondamento derivano alcune differenze della decadenza rispetto alla prescrizione:
— non si applicano l’interruzione e la sospensione, salvo che non sia disposto altrimenti (es. art.
489);
— l’unico modo di evitare la decadenza è il compimento dell’atto previsto.
Effetto: il tempo determina la perdita della possibilità di esercitare un diritto.
• nell’interesse generale (è inderogabile, irrinunzia-
䉴 Legale (prevista dalla legge): bile, rilevabile di ufficio).
è un istituto eccezionale e
• nell’interesse individuale di una delle parti (è dero-
può essere stabilita :
Specie gabile, rinunziabile, va eccepita)
• può essere prevista — i diritti siano disponibili
䉴 Convenzionale: dalla volontà privata — i termini non siano ec-
purché: cessivamente gravosi
Differenze
Prescrizione e decadenza hanno un sostrato comune: in entrambe, l’azione del tempo determina
la perdita di un diritto. Essendo diversa la funzione e la disciplina, la dottrina ha identificato le
seguenti differenze:
a) nella prescrizione si ha riguardo alle condizioni soggettive del titolare del diritto mentre nella
decadenza si ha riguardo solo al fatto obiettivo del mancato esercizio del diritto (SANTORO-
PASSARELLI);
b) nella prescrizione il tempo è considerato come durata (si parla, cioè, di mancato esercizio del
diritto per un certo periodo), mentre nella decadenza il tempo è considerato come distanza
(mancato esercizio del diritto entro un certo periodo) (TRABUCCHI);
c) la prescrizione, data la sua funzione, ha sempre un fondamento di ordine pubblico, mentre la
decadenza può tutelare anche un interesse privato come la decadenza negoziale (TEDESCHI);
d) la prescrizione ha la sua unica fonte nella legge, le cui norme sono inderogabili, mentre la
decadenza può anche essere stabilita dalla volontà dei privati (FERRUCCI);
e) nella prescrizione vi è un’intenzione sanzionatoria da parte dell’ordinamento a carico dei negli-
genti, mentre nella decadenza l’effetto preclusivo è previsto anche se al soggetto non può
addebitarsi un contegno negligente (MAGAZZÙ);
f) la prescrizione è sempre correlata ad un diritto soggettivo, mentre la decadenza (secondo la
recente dottrina) può essere correlata anche a diritti potestativi (GENTILE-PUGLIESE);
g) altra differenza è quella (WINDSCHEID, CARIOTA-FERRARA) secondo cui mentre la prescri-
zione comporta la perdita di un diritto che era già nella sfera del soggetto, la decadenza impe-
disce , invece, l’acquisto di un nuovo diritto e cioè comporta la perdita della possibilità dell’ac-
quisto di un diritto.
Dalla diversità degli istituti deriva che uno stesso diritto che è esposto a decadenza, può essere, in
un secondo momento (quando è stata evitata la decadenza), soggetto a prescrizione: vedi, ad
esempio, l’art. 1495 co. 1° e 3°. Il 1° comma dell’art. stabilisce che se il compratore non denunzia al
venditore, entro 8 giorni dalla scoperta, i vizi occulti della cosa che gli è stata venduta, decade dal
potere di proporre azione di garanzia per i vizi stessi (termine di decadenza).
Secondo il 3° comma, invece, se l’azione di garanzia non è proposta entro un anno dalla consegna
della cosa, il relativo diritto si prescrive (termine di prescrizione).
Capitolo 6 • Spazio e tempo: incidenza su fatti giuridici 39
Capitolo 7 FATTI ED ATTI GIURIDICI: NEGOZIO GIURIDICO
1 Generalità
Tra i molteplici avvenimenti che si producono nella realtà alcuni rivestono una particolare impor-
tanza per l’ordinamento giuridico. In particolare si definiscono «fatti giuridici» i fatti che avvengono
nel mondo naturale o nella realtà sociale, quando producono conseguenze rilevanti per il diritto (RE-
SCIGNO).
Tali conseguenze si definiscono «effetti giuridici»; gli effetti giuridici possono essere:
— costitutivi, se sono diretti alla formazione di un rapporto giuridico;
— modificativi, se intervengono per modificare un rapporto giuridico;
— estintivi, se determinano la estinzione di un rapporto giuridico.
2 Fatti e fattispecie
Fatto giuridico: è un qualsiasi accadimento rilevante per il diritto.
Fattispecie: sono quei fatti o situazioni tipo al cui verificarsi si ricollegano gli effetti giuridici previsti
dalla norma.
䉴 Astratta: costituita dalla situazione tipica prevista in astratto dal legi-
slatore
Fattispecie 䉴 Concreta: costituita dal fatto concretamente verificatosi nella realtà.
䉴 Semplice: se consta di un solo fatto.
䉴 Complessa: se consta di molteplici fatti.
L’effetto (finale) regolato dalla norma si verifica solo quando si sono realizzati tutti i fatti giuridici di cui
è costituita la fattispecie. Si parla di fattispecie a formazione progressiva quando la pluralità di fatti si
succede nel tempo. In tali casi possono essere previsti dall’ordinamento effetti preliminari (tutela del-
l’aspettativa).
3 Dal fatto al negozio giuridico
La dottrina ha creato una classificazione che partendo dal fatto giuridico, arriva al negozio giu-
ridico. La sequenza si può rappresentare con lo schema della pagina seguente.
40 Parte Seconda • Soggetti, atti e fatti giuridici
䉴 Fatti naturali o fatti giuridici in senso stretto: fatti dovuti ad eventi naturali
senza l’intervento della volontà umana (es. terremoto, morte di un soggetto
per malattia)
• Atti illeciti: ogni atto giuridico che viola una norma giuri-
dica ed arreca danno ad un altro soggetto. Da esso deri-
va l’obbligo di risarcire il danno (2043)
– atti materiali:
che consistono
— Atti giuridici in in una diretta
senso stretto: modificazione
䉴 Atti umani o atti sono atti posti in mater iale del
Fatti giuridici: ac- giuridici: fatti ca- essere volonta- mondo esterno
cadimenti, umani o ratterizzati da riamente. La vo- (es.: specifica-
naturali, rilevanti una attività uma- lontà del sogget- zione, 940).
per il diritto; ai qua- na volontaria e to è diretta al solo – dichiarazioni di
li, cioè, l’ordina- consapevole, po- compimento del- scienza o di veri-
mento ricollega il sta in essere da l’atto e non ai suoi tà: atti con i quali
prodursi di effetti un soggetto ca- effetti che sono un soggetto volon-
giuridici pace di intende- • Atti leciti: atti disciplinati diret- tariamente dichia-
re e di volere, cui conformi al tamente dall’ordi- ra di avere cono-
l’ordinamento at- diritto namento (es.: oc- scenza di un fatto
tribuisce il potere cupazione) giuridico (es.: con-
di modificare la fessione, 2730)
realtà esterna
— Negozio giuridico: sono tutti gli atti
posti in essere volontariamente al fine
di manifestare la propria volontà. La
volontà è diretta sia al contenuto del-
l’atto che alla produzione degli effetti
che l’ordinamento riconosce e tutela
Differenze
La distinzione tra atti giuridici in senso stretto e atti negoziali non è puramente teorica, in
quanto è rilevante principalmente ai fini della disciplina giuridica applicabile. Infatti, la disciplina
degli atti giuridici in senso stretto è completamente tipizzata. Cioè è la legge stessa che ne indivi-
dua le tipologie e ne stabilisce le conseguenze giuridiche; al contrario, per gli atti negoziali è con-
sentito ai privati creare nuove figure non previste dalla legge e determinarne liberamente il conte-
nuto nella misura in cui gli interessi perseguiti dalle parti siano meritevoli di tutela secondo l’ordina-
mento giuridico (art. 1322).
Un’altra differenza è ravvisabile in materia di vizi della volontà (errore, violenza e dolo); essi, per
quanto riguarda gli atti giuridici in senso stretto non hanno rilevanza generalizzata (come avviene
per i negozi giuridici): è la legge stessa che predetermina specifiche regole, così ad es. il riconosci-
mento del figlio naturale può essere impugnato solo per violenza; la confessione può essere impu-
gnata per errore di fatto o violenza.
Capitolo 7 • Fatti ed atti giuridici: negozio giuridico 41
4 Il negozio giuridico
4.1. • Nozione e generalità
Nozione: il negozio giuridico è una dichiarazione di volontà con la quale vengono enunciati gli effetti
perseguiti e alla quale l’ordinamento giuridico ricollega effetti giuridici conformi al risultato voluto.
Generalità: la nascita e l’evoluzione della categoria dei negozi giuridici è connessa strettamente
al ruolo attribuito alla volontà del soggetto agente. È con la rivoluzione industriale e l’affermazione
della borghesia che si afferma il concetto di negozio giuridico come dichiarazione di volontà diretta ad
uno scopo garantito dalla legge; l’affermazione dei principi di libertà e di rispetto della persona si
risolvono nel mondo del diritto nel riconoscere alla volontà il potere di stabilire rapporti giuridici e di
autoregolamentarli.
La successiva evoluzione del concetto di negozio giuridico vede l’attenuarsi del ruolo dominante
della volontà e l’emergere di concezioni volte a valorizzare i principi dell’autoresponsabilità e dell’affida-
mento. Il legislatore del 1942, accogliendo tali concezioni, non si occupa del negozio giuridico; ciò non
esclude l’utilità di una elaborazione sul negozio giuridico poiché lo stesso codice civile la presuppone.
4.2. • L’autonomia negoziale
Ogni soggetto può curare i propri interessi attraverso atti e negozi giuridici. La possibilità di porre
in essere negozi è genericamente definita «autonomia negoziale». Il termine autonomia negoziale
assume due significati (RESCIGNO): autonomia come vincolo che sta a indicare l’irrevocabilità del-
l’impegno assunto (1372) e autonomia come libertà che consiste nella possibilità per i privati di deter-
minare gli effetti del negozio (1322).
L’autonomia negoziale concede una vasta gamma di libertà che, parallelamente al ridimensiona-
mento della volontà, possono subire limitazioni. Tali libertà possono essere così classificate: libertà di
compiere il negozio, libertà di determinare il contenuto dei negozi, libertà di concludere negozi non
appartenenti ai tipi previsti (c.d. negozi atipici), libertà delle forme dell’atto, libertà di inserire nel nego-
zio elementi accidentali, libertà di scelta dei contraenti.
Osservazioni
In dottrina, tuttavia, la categoria del negozio giuridico continua a costruire uno dei concetti più
diffusi e studiati; in particolare, un problema di particolare rilievo consiste nell’individuare l’esatta
natura del negozio giuridico: atto di volontà o dichiarazione?
Secondo una prima e più antica impostazione, strettamente connessa all’emergere del concetto di
negozio giuridico e di autonomia negoziale, ciò che ha rilievo non è tanto la volontà quale appare
dall’atto, ma l’intenzione dell’agente, la sua volontà effettiva e reale (teoria soggettiva della vo-
lontà); ne consegue che rilevano in modo decisivo, ai fini della validità dell’atto negoziale, tutte le
cause che hanno perturbato la volontà del disponente (errore, violenza, dolo, simulazione).
Nonostante in tempi recenti qualche autore si sia affannato nel vano tentativo di rilanciare e rendere
attuale la teoria soggettiva della volontà, è indubitabile, tuttavia, come una siffatta impostazione non
potesse seguire il passo degli sviluppi commerciali ed economici. Tali evoluzioni, infatti, hanno con-
dotto alla elaborazione della teoria della dichiarazione, per la quale ciò che conta non è quello che
il soggetto realmente ed effettivamente voleva, ma ciò che è apparso all’esterno, vale a dire la mani-
festazione di quella volontà, e quindi la dichiarazione secondo il suo oggettivo significato.
Nel tentativo di combattere il soggettivismo insito nell’indagine sul reale volere dell’autore dell’atto
(teoria della volontà) e nel tentativo di non cadere nell’eccessivo formalismo (teoria della dichiara-
zione), sta prevalendo tra i nostri studiosi del diritto, una nuova teoria, definita precettiva (BETTI,
SCOGNAMIGLIO). In base a questa tesi, ciò che rileva è il fatto sociale del negozio, la sua rilevan-
za oggettiva, il comportamento e l’imputabilità di esso agli autori del negozio stesso.
42 Parte Seconda • Soggetti, atti e fatti giuridici
4.3. • Classificazione dei negozi
• Unipersonali: in cui la manifestazione di volontà provie-
ne da una sola persona fisica
䉴 Negozi unilate- — Atto collettivo: dichiarazioni di volontà
rali: posti in es- provenienti da più persone tendenti ad
sere da una sola un fine comune per la cura di interessi
parte (cioè la vo- identici ma che restano distinti
lontà negoziale L’unione è esterna (es. delibera con-
proviene da una dominiale, 1136)
sola parte)
— Atto collegiale: le dichiarazioni di vo-
Rispetto al nume- • Pluripersonali:
lontà si fondono e formano la volon-
ro delle parti: per l’unica parte ne-
tà di un soggetto diverso. L’unione è
parte di un negozio goziale è compo-
interna (es. deliberazione dell’assem-
deve intendersi il sta da più perso-
blea di una società per azioni)
centro di imputa- ne fisiche.
zione degli interes- Nell’ambito di tale — Atto complesso: – a complessità
si. Una parte del categoria si di- più volontà aventi uguale: le vo-
stinguono le se- lo stesso contenu- lontà sono sul-
negozio può esse-
guenti figure: to si fondono in lo stesso piano
re composta da più
una sola volontà (2258);
persone (v. negozi
pluripersonali) interna per la cura – a complessità
di un unico inte- ineguale: una
resse. Si distin- volontà preva-
guono gli atti: le sull’altra. Es.
volontà del-
l’inabilitato ri-
spetto a quel-
la del curatore
䉴 Negozi bilaterali: negozi posti in essere da due parti, cioè la volontà negoziale
proviene da due parti diverse
䉴 Negozi plurilaterali: negozi posti in essere da più di due parti, cioè la volontà
negoziale proviene da più di due parti
䉴 Negozi non patrimoniali: riguardano i rapporti non patrimonialmente valuta-
bili.
Ad es. il matrimonio.
– negozi traslativi:
la diminuzione
— Negozi di dispo- del patrimonio
• Negozi di attri- sizione: negozi avviene median-
Rispetto alla natu- buzione patri- te alienazione
ra dei rapporti og- 䉴 Negozi patrimo- che comportano
niali: riguardano moniale: negozi una immediata – negozi abdicati-
getto dei negozi che attribuiscono
rapporti econo- diminuzione del vi: la diminuzione
micamente valu- ad un soggetto patrimonio del patrimonio
tabili un vantaggio o avviene median-
uno svantaggio te rinunzia
patrimoniale:
— Negozi di obbligazione: negozi che dan-
no luogo alla nascita di una obbligazio-
ne
Capitolo 7 • Fatti ed atti giuridici: negozio giuridico 43
Rispetto al corrispetti- 䉴 A titolo oneroso: all’attribuzione a favore di un soggetto fa riscontro
vo: questa distinzione ri- un corrispettivo a carico dello stesso
guarda solo i negozi pa-
trimoniali 䉴 A titolo gratuito: quando manca tale corrispettivo
䉴 Negozi mortis causa: quelli in cui la morte costituisce il presupposto
per la loro efficacia; unico esempio è rappresentato dal testamento
Rispetto all’evento morte
䉴 Negozi inter vivos: tutti gli altri negozi
䉴 Negozi di dichiarazione: sono quelli in cui il soggetto esprime (tacita-
mente o espressamente) la propria volontà dichiarandola
In relazione alla manife-
䉴 Negozi di attuazione: sono quelli in cui l’agente, senza porsi in rela-
stazione di volontà
zione con altri soggetti, attua la sua volontà immediatamente attraver-
so un comportamento concludente (es. distruzione del testamento olo-
grafo, 684)
䉴 Negozi dispositivi: sono quelli che modificano una situazione preesi-
stente
䉴 Negozi di accertamento: categoria molto discussa, sono i negozi tra-
mite i quali le parti lasciano inalterato un rapporto giuridico preesisten-
te limitandosi solo ad accertarlo
In relazione agli effetti
䉴 Recettizi: atti nei quali la produzione degli effetti si realizza quando
sono portati a conoscenza di una determinata persona alla quale deb-
bono essere comunicati o notificati (es. disdetta)
䉴 Non recettizi: atti che producono effetti in virtù della sola manifesta-
zione di volontà (es. rinuncia all’eredità)
In relazione alla causa v. schema par. 8.2.
5 Caratteri del negozio giuridico
䉴 Atto giuridico: atto umano, consapevole e volontario
䉴 Lecito: conforme alle prescrizioni dell’ordinamento
Caratteri 䉴 Consistente in una dichiarazione di volontà diretta verso determi-
nati effetti giuridici riconosciuti e garantiti dall’ordinamento. Tali effetti
possono consistere nella costituzione, modificazione o estinzione di
un rapporto giuridico (1321, in relazione ai contratti)
• uno o più soggetti
• volontà
䉴 Generali
Elementi essenziali (ove manchi un ele- • forma (manifestazione)
mento essenziale il negozio è nullo, 1418) • causa
䉴 Particolari: se previsti solo per alcuni negozi, ad es:
oggetto nei negozi patrimoniali.
Elementi accidentali: sono elementi che in ossequio al principio • condizione
dell’autonomia negoziale le parti possono liberamente apporre, ma • termine.
una volta apposti incidono sulla efficacia del negozio • modo
44 Parte Seconda • Soggetti, atti e fatti giuridici
Elementi (o effetti) naturali: più che elementi sono da considerarsi delle conseguenze che l’ordi-
namento riconnette al negozio anche se le parti ne omettono la previsione (es. garanzia per evizione
o per vizi occulti in caso di compravendita, 1476).
• capacità della persona
Presupposti: riconosciuti solo da parte della dottrina, sono circo-
• legittimazione al negozio
stanze estrinseche al negozio giuridico che ad esso preesistono e
ne determinano la validità • idoneità dell’oggetto.
6 La volontà
6.1. • Nozione e caratteri generali
La volontà negoziale per essere giuridicamente rilevante deve essere manifestata, cioè deve es-
sere esternata.
Normalmente la volontà interna e la sua manifestazione coincidono; talvolta, però, può determi-
narsi una divergenza dovuta o ad una errata manifestazione della volontà (penso 100, dico 10) o alla
interferenza di un elemento perturbatore che ne vizia la stessa formazione.
Nel disciplinare queste ipotesi di divergenza il legislatore accoglie il principio generale dell’affida-
mento, in base al quale il negozio è valido se il destinatario della dichiarazione era in buona fede e non
era in grado, usando la normale diligenza, di accorgersi della divergenza.
6.2. • Mancanza della volontà
Si ha mancanza di volontà quando la dichiarazione è emessa senza che vi sia una volontà effetti-
va del soggetto.
䉴 Dichiarazioni di apparente contenuto giuridico fatte durante una
rappresentazione teatrale o a scopo didattico
• dichiarazioni fatte nello scherzo, cioè
in condizioni tali che tutti intendano che
䉴 Dichiarazioni effettuate
non si agisce sul serio
per scherzo, in questo
caso si distinguono: • dichiarazioni fatte per scherzo, ossia
con intenzione non seria senza, che
Esempi
però ciò risulti all’altra parte
Nel secondo caso il negozio non è nullo se l’altra parte non era in
grado di avvedersi dello scherzo
䉴 Violenza fisica (vis absoluta ): ricorre quando un soggetto manifesta
una volontà negoziale perché costretto a viva forza da un altro sogget-
to; è il caso della firma di un atto perché altri ha guidato la mano. Il
negozio è nullo
6.3. • Divergenza tra volontà e dichiarazione
Si ha divergenza quando la volontà esiste ma la dichiarazione ne è difforme.
Riserva mentale: un soggetto manifesta intenzionalmente una volontà difforme da quella effetti-
va. Poiché la riserva è esclusivamente interna al dichiarante il destinatario non può avvedersene. Il
negozio è valido ed efficace.
Capitolo 7 • Fatti ed atti giuridici: negozio giuridico 45
Errore ostativo: comporta l’annullabilità. È l’er- 䉴 Sulla dichiarazione: dico 100 ma volevo dire 10
rore che cade:
䉴 Sulla trasmissione della dichiarazione: errore
dell’addetto al telegrafo o del nuncius che la tra-
smettono in modo inesatto
Dissenso: tipico nei negozi bilaterali o plurilate-
rali, si ha quando una dichiarazione di un sog- 䉴 Annullabilità del contratto se dipende da errore
getto viene fraintesa dall’altra, e il destinatario ostativo.
della dichiarazione ha dato il suo assenso frain-
tendendo il vero contenuto del discorso. Il dis- 䉴 Nullità in tutti gli altri casi.
senso può comportare:
Simulazione: Vedi par. 6.5.
6.4. • Vizi
Nozione: elementi perturbatori che si inseriscono nel processo formativo della volontà fuorvian-
dola e determinandone una formazione anormale.
In questo caso la volontà c’è ma è viziata, il negozio è annullabile.
Gli elementi perturbatori, o meglio i vizi della volontà, presi in considerazione dal nostro diritto
sono l’errore, la violenza morale, il dolo.
6.4.1. • Errore
Nozione: falsa rappresentazione della realtà che concorre a determinare la volontà del soggetto;
ad esso è equiparabile l’ignoranza, ossia la non conoscenza di qualsiasi nozione di un dato di fatto.
䉴 Errore ostativo: è l’errore che cade sulla manifestazione della volon-
tà, dando luogo ad una inconsapevole divergenza tra volontà e manife-
stazione (vedi par. 6.3.)
Tipi 䉴 Errore vizio o errore mo- • errore di fatto: quando ricade su una
tivo: è l’errore che incide circostanza di fatto.
sul processo formativo
della volontà. Esso può • errore di diritto: quando ricade su una
essere: norma giuridica.
䉴 Riconoscibile: l’errore è riconoscibile quando, in relazione al conte-
nuto del negozio, alle sue circostanze o alle qualità delle parti una per-
sona di normale diligenza avrebbe potuto rilevarlo (1431)
• errore di fatto: errore sulla natura od
oggetto del negozio;
䉴 Essenziale: l’errore è es- errore sulla identità dell’oggetto della
Effetti: determina l’annul- senziale se ha da solo de- prestazione ovvero su una qualità dello
labilità del negozio se è terminato la parte a con- stesso;
cludere il contratto, cioè errore sulla identità o qualità di una
senza l’errore la parte non persona (error personae).
avrebbe manifestato alcu- L’errore sulla quantità è rilevante solo se
na volontà negoziale non dipende da errore di calcolo (1430)
• errore di diritto : quando è stato la ra-
gione unica o principale del contratto
46 Parte Seconda • Soggetti, atti e fatti giuridici
L’errore sui motivi che inducono un soggetto a concludere un negozio non è essenziale né
riconoscibile, quindi non ha alcuna rilevanza.
Nella donazione e nel testamento , però, l’errore sul motivo assume una eccezionale rilevanza se
risulta dall’atto e sia stato determinante per il compimento del negozio.
In alcune ipotesi eccezionali l’errore non è rilevabile, in particolare:
— nella accettazione dell’eredità (483);
— nella transazione, dove non rileva l’errore di diritto (1969).
6.4.2. • Violenza morale
Nozione: la violenza morale (vis animo illata) consiste nella minaccia di un male ingiusto e notevo-
le posta in essere al fine di determinare un soggetto a compiere un negozio. Per sfuggire al male
minacciato il soggetto agisce nel modo voluto da chi lo ha minacciato (coactus tamen voluit).
䉴 Male ingiusto: il male che può essere inferto ponendosi contro la legge.
Non ricorre nel caso di minaccia di far valere un proprio diritto, a meno
che non sia diretta a conseguire vantaggi ingiusti (1438)
䉴 Male notevole: il male minacciato deve essere tale da impressionare
una persona sensata avendo riguardo alle circostanze del caso e in
Requisiti (1435) particolare «all’età, al sesso e alla condizione delle persone». È rile-
vante anche la minaccia proveniente da un terzo (1434), e deve essere
diretta contro la stessa persona o i suoi beni o contro il suo coniuge,
ascendenti o discendenti o i loro beni (1436). Anche la minaccia su
persone diverse dai prossimi congiunti può essere rilevante, ma in tal
caso il giudizio sulla rilevanza è rimesso all’apprezzamento del giudice
Effetti: determina l’annullabilità del negozio.
Differenze
La violenza si distingue dallo stato di pericolo (1447) che comporta la rescindibilità dal negozio con-
cluso a condizioni eccessivamente onerose per il contraente che si trovava in tale situazione. La
differenza è nel fatto che nella violenza il timore che determina il soggetto ad emettere la dichiarazio-
ne negoziale proviene da una altrui minaccia (metus ab extrinseco); nello stato di pericolo il timore è
invece determinato da uno stato di fatto oggettivo, spesso da forze naturali (metus ab intrinseco ).
La violenza morale va tenuta distinta anche dal c.d. timore reverenziale, cioè il timore che il sogget-
to nutre, a prescindere da specifiche minacce esterne, nei confronti di una persona che si presenta
ai suoi occhi, per le più svariate ragioni, gravemente severa ed autorevole. In tal caso il negozio non
è annullabile (art. 1437).
6.4.3. • Dolo
Nozione: il dolo consiste negli artifizi e raggiri posti in essere per ingannare un soggetto ed appro-
fittare di un suo errore allo scopo di determinarlo a compiere un negozio che non avrebbe compiuto o
avrebbe compiuto in modo diverso.
䉴 Dolus bonus: consiste nella normale esaltazione della merce o della
propria prestazione, tipiche del commercio. Non rileva sul negozio (tutti
Tipi possono opportunamente valutare questa forma di pubblicità)
䉴 Dolus malus: vizia il negozio
Capitolo 7 • Fatti ed atti giuridici: negozio giuridico 47
Il dolo deve:
— Provenire dalla controparte (cfr. con la disciplina di cui all’art. 1434, in relazione alla violenza).
— Se proviene da un terzo deve essere noto alla controparte che ne ha tratto vantaggio (1439, co. 2).
䉴 Dolo determinante (o causam dans ) è quello senza il quale il negozio
non si sarebbe concluso (negozio annullabile)
Incidenza 䉴 Dolo incidente (dolus incidens): il negozio si sarebbe egualmente con-
cluso, ma a condizioni meno gravose. Il negozio è valido, ma la vittima
ha diritto ad avere il risarcimento dei danni subiti
6.5. • La simulazione
Nozione: la simulazione sia ha quando le parti, d’accordo, pongono in essere deliberatamente
dichiarazioni difformi dall’interno volere; è la figura più importante di divergenza tra volontà e dichiara-
zione, la peculiarità è nel fatto che la divergenza è voluta e concordata dalle parti al fine di creare una
situazione apparente di fronte ai terzi.
6.5.1. • Elementi
Divergenza voluta: il contrasto tra volontà e dichiarazione è voluto e concordato dalle parti.
Accordo simulatorio: è l’accordo tra gli stipulanti diretto a stabilire che il contratto stipulato tra
loro è inidoneo a produrre gli effetti che apparentemente ne derivano; esso vale a distinguere la simu-
lazione dalla ricerca mentale, in cui manca l’intesa tra i soggetti.
L’accordo simulatorio è spesso documentato in una controdichiarazione scritta.
6.5.2. • Tipi
Simulazione assoluta: le parti simulano un negozio ma in realtà non ne vogliono nessuno (es.
vendita simulata per sottrarre i beni ad una esecuzione forzata).
䉴 Simulazione soggettiva (c.d. interposizione fittizia): si fa apparire come
parte un soggetto (prestanome) mentre parte è, in realtà, un altro sog-
Simulazione relativa: le
getto
parti pongono in essere
un negozio (simulato), • la natura del negozio: es. si si-
ma ne vogliono uno di- mula una vendita mentre in re-
verso (negozio dissimu- 䉴 Simulazione oggettiva riguarda: altà si vuole una donazione
lato). Può aversi:
• un elemento del negozio: es. il
prezzo
6.5.3. • Effetti
䉴 Simulazione assoluta: il negozio simulato non produce effetti.
Tra le parti (1414)
䉴 Simulazione relativa: il negozio dissimulato (occulto) produce i suoi
effetti purché ne sussistano i requisiti di sostanza e di forma
䉴 Terzi subacquirenti (co. 1): ai terzi in buona fede che acquistano dal
titolare apparente non può essere opposta la simulazione. Contro di
Nei confronti dei terzi essi non può essere fatta valere la simulazione né dai contraenti, né
(1415). Si applica il prin- dagli aventi causa, né dai creditori del simulato alienante, salvi gli effet-
cipio dell’affidamento ti della trascrizione della domanda giudiziale.
䉴 Terzi pregiudicati (co. 2): i terzi interessati a dedurre la simulazione
possono farla valere in confronto delle parti.
48 Parte Seconda • Soggetti, atti e fatti giuridici
䉴 Creditori del simulato alienante: possono far valere la simulazione che pre-
giudica i loro diritti (1416, co. 2)
• con garanzia reale sul bene che è oggetto del
negozio simulato: la simulazione è ad essi inop-
䉴 Creditori del simulato ponibile, se sono in buona fede
acquirente • creditori chirografari: è loro opponibile la simula-
zione, a meno che, in buona fede, non abbiano
già compiuto atti di esecuzione sui beni
Nei confronti dei
creditori (1416)
— i creditori del simulato
• ricorre se i creditori alienante: quando il
del simulato alienan- loro credito è anterio-
te e del simulato ac- re all’atto simulato
䉴 Conflitto di creditori quirente vogliono — i creditori chirografari
soddisfarsi sui beni del simulato acquiren-
oggetto del contrat- te: quando il credito dei
to simulato. La legge creditori del simulato
tutela: alienante è successivo
all’atto simulato
Per accertare la simulazione il soggetto interessato deve adire l’A.G. con l’azione di simulazione,
che è un’azione di mero accertamento e come tale è imprescrittibile. Viceversa è soggetta alle regole
generali in ordine alla prescrizione l’azione che venga eventualmente esperita per far valere il negozio
dissimulato.
Differenze
La simulazione deve essere distinta dal negozio indiretto e dal negozio fiduciario.
Negozio indiretto: le parti, per raggiungere un effetto perseguibile con un determinato negozio,
seguono una via indiretta e si servono di un negozio tipico che viene adattato ad uno scopo diverso
da quello che ne costituisce la causa (es. mandato irrevocabile ad amministrare ed alienare senza
obbligo di rendiconto anziché donazione). Il negozio indiretto si distingue da quello simulato in
quanto le parti vogliono realmente gli effetti giuridici del negozio, che sono strumentali rispetto al
fine ulteriore perseguito.
Negozio fiduciario: col negozio fiduciario si attua il trasferimento di un diritto da un soggetto (fidu-
ciante) ad un altro (fiduciario) senza che la titolarità del fiduciario sia in realtà effettivamente piena ,
in quanto quest’ultimo ha l’obbligo di usare il diritto trasmessogli secondo l’accordo stabilito. Va
distinto dal negozio simulato, in quanto questo trasferisce il diritto solo in apparenza, mentre il
negozio fiduciario trasferisce realmente il diritto al fiduciario, anche se solo temporaneamente.
Negozio in frode alla legge: la volontà negoziale è conforme solo apparentemente alle norme pre-
cettive, ma nella sostanza le viola; in tal caso però le parti vogliono che i vari elementi che compongo-
no il negozio producano i loro effetti perché è solo dalla loro combinazione che riusciranno ad ottene-
re il risultato vietato dalla legge; nel negozio simulato, invece, le parti non vogliono quanto appare.
7 Manifestazione della volontà (forma)
Nozione: è il mezzo con cui si manifesta la volontà negoziale.
Nel nostro ordinamento vige il principio di libertà delle forme, cioè i soggetti possono manifestare la
loro volontà negoziale usando qualsiasi mezzo. Solo in alcuni casi è richiesta una forma ad substan-
tiam, cioè una forma la cui mancanza incide sulla validità del negozio (forma scritta o atto pubblico).
Capitolo 7 • Fatti ed atti giuridici: negozio giuridico 49
In altri casi è richiesta una particolare forma non per la validità del negozio ma solo per la sua
prova (forma ad probationem).
Le parti possono, infine, convenzionalmente stabilire la forma di un futuro negozio: in questo caso
si presume che la forma sia voluta per la validità di esso.
La volontà negoziale, per produrre gli effetti cui è diretta, deve uscire dalla sfera interna del sog-
getto e manifestarsi nel mondo esterno.
La manifestazione può essere:
Espressa: se si attua con parole, scritti, cenni ecc., cioè con qualunque mezzo che la rende
palese veicolandola all’esterno.
Tacita (o per facta concludentia): se consiste in un comportamento che esclude, in modo univo-
co, una volontà contraria (es. 476).
Il silenzio non ha alcun valore in diritto privato. Assume valore negoziale solo in presenza di
alcune circostanze: ad esempio, se il soggetto aveva l’onere di emettere una dichiarazione.
Il principio si può riassumere nella massima: qui tacet consentire videtur si loqui debuisset ac
potuisset. In tali casi il silenzio vale come dichiarazione espressa di volontà.
7.1. • Il documento informatico
Nozione: il documento informatico è la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridica-
mente rilevanti. Le riproduzioni informatiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di
fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono
prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime (art. 2712). La disciplina del
codice va integrata con le disposizioni del d.lgs. 82/2005 (come modificato da ultimo dal d.lgs. 235/
2010) e, in particolare, con le nuove disposizioni sulla firma elettronica.
Firma elettronica: insie- 䉴 firma elettronica avanzata: insieme di dati in forma elettronica allega-
me dei dati in forma elet- ti oppure connessi a un documento informatico che consentono l’iden-
tronica, allegati oppure tificazione del firmatario del documento e garantiscono la connessione
connessi tramite asso- univoca al firmatario, creati con mezzi sui quali il firmatario può conser-
ciazione logica ad altri vare un controllo esclusivo, collegati ai dati ai quali detta firma si riferi-
dati elettronici, utilizzati sce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati succes-
come metodo di identifi- sivamente modificati
cazione informatica
䉴 firma elettronica qualificata: particolare tipo di firma elettronica avan-
zata basata su un certificato qualificato e realizzata mediante un dispo-
sitivo sicuro per la creazione della firma
䉴 firma digitale particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su
un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una
pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare trami-
te la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispetti-
vamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l’integrità
di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici
䉴 firma elettronica: il documento informatico è liberamente valutabile in
giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, si-
curezza, integrità e immodificabilità
Efficacia 䉴 firma elettronica avanzata, qualificata o digitale: il documento infor-
matico sottoscritto tali firme, e formato nel rispetto delle regole tecni-
che che garantiscano identificabilità dell’autore, integrità e immodifica-
bilità del documento, ha l’efficacia prevista dall’art. 2702 c.c.; l’utilizzo
del dispositivo di firma si presume riconducibile al titolare, salvo che
questi dia prova contraria
50 Parte Seconda • Soggetti, atti e fatti giuridici
In sintesi
Le modifiche al Codice dell’amministrazione digitale tendono alla progressiva digitalizzazione
della pubblica amministrazione e adeguano alle nuove tecnologie la disciplina del documento
informatico e delle copie informatiche, con sistemi che ne garantiscono sicurezza e validità. A tal
fine è dedicata particolare attenzione alla conservazione digitale dei documenti, con procedure di
certificazione e intervento di conservatori accreditati. Fra le novità è da segnalare il disposto del-
l’art. 20 del Codice per il quale sono liberamente valutabili in giudizio tanto l’idoneità del documento
informatico a soddisfare il requisito della forma scritta che il suo valore probatorio, tenuto conto
delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità e fermo restan-
do quanto prevede l’art. 21 a proposito del documento informatico sottoscritto con firma elettronica
(v. schema precedente). È stabilito altresì che gli atti di costituzione e trasferimento di diritti reali
immobiliari, se fatti con documento informatico, devono essere sottoscritti con firma elettronica
qualificata o con firma digitale, a pena di nullità.
8 La causa
Nozione: per la dottrina tradizionale (teoria oggettiva) la causa è la funzione economico-sociale
che il negozio tende obiettivamente a realizzare (es. nella compravendita lo scambio bene-prezzo).
Osservazioni
In tempi più recenti si è affermata l’idea che la causa debba essere intesa, più come funzione
economico-sociale del negozio, quale funzione economico-individuale, cioè la giustificazione
concreta dell’operazione economica posta in essere dai privati. Questa teoria della causa in con-
creto è stata accolta dalla Suprema Corte (Cass. 10490/2006), che ha affermato che: «[…] la
causa quale elemento essenziale del contratto non deve essere intesa come mera ed astratta
funzione economico-sociale del negozio, bensì come sintesi degli interessi reali che il contratto è
diretto a realizzare, e cioè come funzione individuale del singolo, specifico contratto […]».
䉴 La mancanza: ne determina • negozio illegale: se contrario a norme
Natura: la causa è un la nullità imperative o all’ordine pubblico
elemento essenziale
del negozio, per cui: 䉴 L’illiceità: determina del pari • negozio immorale: se la causa è con-
la nullità traria al buon costume
Negozio in frode alla legge (1344): le parti pongono in essere il negozio al fine di eludere norme
imperative (es. vendita con patto di riscatto per realizzare un prestito usurario). La frode alla legge è equipa-
rata all’illecità della causa, ma occorre in tal caso dimostrare l’intento fraudolento. Il negozio è nullo.
8.1. • Motivi
Nozione: mentre la causa è lo scopo obiettivo, i motivi sono i particolari interessi o bisogni che
rappresentano lo scopo ulteriore individuale e concreto che le parti intendono raggiungere con il nego-
zio.
I motivi, salvo casi particolari, sono irrilevanti; unica eccezione è la rilevanza del motivo illecito
comune ad entrambe le parti (1345), in questo caso il negozio è nullo.
Per la rilevanza dell’errore sui motivi vedi par. 6.4.1.
Capitolo 7 • Fatti ed atti giuridici: negozio giuridico 51
8.2. • Distinzione dei negozi rispetto alla causa
Negozi tipici (o nominati): sono i negozi corrispondenti a tipi fissati dalla legge, forniti di propria
denominazione e autonoma disciplina.
Negozi atipici (o innominati): 䉴 Sono soggetti alle norme ed ai principi generali dell’ordinamento
creati dai soggetti e quindi non (1323)
corrispondenti a categorie previ-
ste e disciplinate dalla legge 䉴 Debbono realizzare interessi meritevoli di tutela (1322, co. 2)
Negozi misti: sono negozi derivanti dalla fusione di due o più negozi tipici (es. il contratto di
posteggio in cui confluiscono le cause della locazione e del deposito). Ad essi si applicano, per la parte
relativa, le norme dei singoli contratti (c.d. teoria della combinazione). Secondo la teoria dell’assor-
bimento si applica invece la disciplina del negozio la cui causa è in concreto prevalente.
Negozi collegati: una determinata funzione sociale può essere realizzata solo attraverso il ricor-
so a più negozi tra loro interdipendenti. Ogni negozio produce gli effetti che gli sono propri, ma gli
effetti dei singoli negozi concorrono alla realizzazione di un unico risultato.
Il collegamento negoziale può essere:
— volontario quando l’interdipendenza è voluta dalle parti;
— necessario o funzionale quando l’interdipendenza è insita nella funzione perseguita.
Negozi astratti: negozi, formali e tipici, che producono provvisoriamente effetti prescindendosi
dalla loro causa (ad es. la cambiale).
Diversa dalla astrazione sostanziale è la astrazione processuale, che produce solo una inversione
dell’onere della prova; infatti chi agisce in giudizio per ottenere la prestazione dovuta in base ad un
negozio processualmente astratto non ha l’onere di provare l’esistenza e la liceità della causa del
negozio: quest’onere grava, invece, sulla parte che vuol sottrarsi all’adempimento.
Negozi causali: sono quelli in cui la causa è elemento essenziale e costitutivo; essi non produco-
no alcun effetto in caso di mancanza o illiceità della causa.
9 Il soggetto del diritto e la rappresentanza
9.1. • Concetto di parte
Il negozio giuridico è espressione della volontà di uno o più soggetti. Per parte, però, non è da
intendere il singolo, ma ciascun centro di interessi. Dall’identificazione della parte con il centro di
interessi di cui il negozio è espressione, deriva la distinzione tra:
— parte in senso formale, con la quale si indica l’autore del negozio;
— parte in senso sostanziale, che designa il destinatario degli effetti.
Normalmente il negozio giuridico è posto in essere e concluso dal soggetto nella cui sfera giuridi-
ca esso è destinato a produrre effetti giuridici e, pertanto, parte in senso formale e parte in senso
sostanziale coincidono. Vi sono però dei casi in cui al soggetto interessato si affianca o si sostituisce
un’altra persona che collabora con lui.
Cooperazione: il soggetto che si affianca resta estraneo al rapporto che si costituisce, non ne
diventa, quindi, parte.
Sostituzione: un soggetto ha il potere di sostituirsi ad un altro nel compimento di un negozio,
divenendo parte in senso formale ma rimanendo estraneo agli effetti che dal negozio scaturiscono.
52 Parte Seconda • Soggetti, atti e fatti giuridici
Osservazioni
Autorevole dottrina (Bianca) contesta la nozione di parte intesa come centro di interessi, in quanto
la disciplina del contratto fa riferimento ai soggetti del rapporto contrattuale e non ad un astratto
centro di interessi che non può essere, come tale, destinatario di imputazioni giuridiche (ad es.,
quando l’art. 1428 richiede che l’errore rilevante ai fini dell’annullamento deve essere riconoscibile
dall’altro contraente, l’indagine sulla riconoscibilità deve riguardare la persona della controparte e
non il centro d’interessi). Pertanto, secondo questa tesi, le parti del contratto sono le singole perso-
ne che assumono la titolarità del rapporto.
9.2. • La rappresentanza
Nozione: la rappresentanza è l’istituto mediante il quale un determinato soggetto (rappresen-
tante), in virtù di un potere attribuitogli dalla legge o dall’interessato, agisce in sostituzione di un
altro soggetto (rappresentato) nel compimento di un negozio giuridico.
La rappresentanza può essere:
䉴 Manca la spendita del nome altrui
䉴 Perché gli effetti del negozio si tra-
smettano nella sfera giuridica del rap-
Diretta: quando il rappresentante agisce in nome e per presentato occorre un ulteriore nego-
conto dell’interessato. Caratteristiche: zio. Il rappresentante è tenuto a que-
sta ulteriore attività in base al rappor-
to interno che lo lega al rappresentato
Indiretta o «interposizione reale di persona»: quando 䉴 Spendita del nome altrui: c.d. con-
il rappresentante agisce solo per conto, ma non in nome templatio domini
del rappresentato. Non è una vera e propria ipotesi di rap-
䉴 Gli effetti si realizzano direttamente
presentanza. Questa figura si differenzia dalla interposi-
nella sfera giuridica del rappresentato
zione fittizia di persona che si realizza nel caso di simula-
(1388)
zione soggettiva (su cui cfr. par. 6.5.2). Caratteristiche:
Il nuncius, a differenza del rappresentante, si limita a trasmettere la volontà del soggetto interes-
sato; pertanto non partecipa alla formazione della volontà poiché tutti gli elementi del negozio sono
predeterminati dall’interessato.
In base alla fonte del potere di rappresentanza essa si distingue in:
Legale: trova la sua fonte nella legge ; ricorre normalmente nelle ipotesi in cui ci sia un soggetto
incapace. Ad. es. il tutore, il curatore dello scomparso.
Volontaria: trova la sua fonte nella volontà dei soggetti.
Viene conferita mediante uno specifico negozio giuridico: la procura.
La rappresentanza volontaria non può aver luogo per tutti quegli atti per il cui compimento la
legge richiede l’attività esclusiva del titolare del diritto: è il caso dei negozi personalissimi.
䉴 Testamento (631)
䉴 Donazione (777 e 778)
Negozi personalissimi
䉴 Matrimonio: nel matrimonio per procura, il procuratore non è altri che
un nuncius che si limita a trasmettere il consenso
䉴 Negozi di diritto familiare
Capitolo 7 • Fatti ed atti giuridici: negozio giuridico 53
Si ha, invece, rappresentanza organica quando un soggetto, avente una funzione di organo
esterno di una persona giuridica, è investito del potere di dichiarare nei confronti di altri soggetti, una
volontà negoziale che vale come diretta volontà dell’ente stesso. Essa non può essere considerata
come una vera e propria forma di rappresentanza, in quanto tra la persona giuridica e il soggetto che
agisce esiste un rapporto di compenetrazione (cd. immedesimazione organica).
10 La procura
Nozione: la procura è il negozio giuridico con il quale un soggetto conferisce ad altri il potere di
rappresentarlo (TORRENTE).
La procura riguarda il lato esterno della rappresentanza, cioè il rapporto rappresentante-terzi, e
serve a rendere noto ai terzi che abbiano a contattare con il rappresentante che egli è fornito del
potere di agire in nome del rappresentato.
Il lato interno della rappresentanza, cioè il rapporto tra rappresentato e rappresentante (rapporto
di gestione) può sorgere ed essere disciplinato da un contratto di mandato con rappresentanza (1703,
1704), da un rapporto di lavoro, da un rapporto di società, da un rapporto di semplice amicizia.
Natura: la procura è un negozio unilaterale, per il quale non è richiesta alcuna forma ad substan-
tiam; fanno eccezione i casi in cui tale forma è richiesta per il negozio che il rappresentante deve
concludere (1392) (es. la procura a vendere immobili deve essere fatta per iscritto); recettizio, in quan-
to la sua efficacia è subordinata alla ricezione da parte del rappresentante; preparatorio, essa viene
conferita, infatti, per il compimento di uno o più negozi giuridici cui accede.
Capacità (1389): va valutata con riferimento al rappresentato. Se ad es. vi è un divieto di cessione
(1261), essa non può avvenire nemmeno a mezzo di rappresentanti. Il rappresentato deve essere
capace di agire; per il rappresentante è sufficiente la capacità di intendere e di volere.
Vizi della volontà e stati soggettivi rilevanti: (1390-1391) si ha riguardo alla persona del rappre-
sentante; pertanto il negozio sarà annullabile se la volontà del rappresentante si era formata in modo
viziato. Si fa eccezione se il vizio riguarda elementi predeterminati dal rappresentato: in questo caso il
negozio è annullabile se era viziata la volontà del rappresentato (1390).
10.1. • Tipi di procura
Espressa: se l’interessato esplicitamente conferisce ad un soggetto il potere di rappresentanza
(anche verbalmente).
Tacita: se risulta da fatti concludenti (es. il commesso di un negozio addetto alle vendite è autoriz-
zato a vendere).
Generale: se riguarda tutti gli affari del rappresentato.
Speciale: se riguarda solo uno o determinati affari.
Revocabile: lo è in linea generale in quanto è attribuita, di regola, nell’interesse esclusivo del
rappresentato. La revoca è un negozio unilaterale. Essa deve essere comunicata ai terzi con mezzi
idonei, poiché, in mancanza di pubblicità, il negozio concluso dal rappresentante privo di poteri è
valido ed efficace se non si prova che il terzo era comunque a conoscenza della revoca.
Irrevocabile (1723): è irrevocabile la procura in rem propriam, quando, cioè, è conferita anche
nell’interesse del rappresentante o di terzi.
54 Parte Seconda • Soggetti, atti e fatti giuridici
Differenze
Anche se spesso la procura è compresa in un mandato è necessario distinguerli:
— la procura è un negozio unilaterale, costitutivo di poteri per il rappresentante, mentre il man-
dato è un contratto (pertanto un negozio bilaterale), costitutivo di diritti e di obblighi per le parti
e destinato a regolare i rapporti interni tra rappresentante e rappresentato (rapporto gestorio);
— la procura può essere connessa ad un negozio diverso dal mandato (es.: rapporto institorio,
che è un rapporto di lavoro);
— il mandato può essere stipulato anche senza l’attribuzione del potere di rappresentanza: il
mandatario assume l’obbligo di compiere un’attività giuridica per conto del mandante senza
avere il potere di agire in nome di questi, il rapporto si riconduce nella figura della rappresen-
tanza indiretta.
• Contratto concluso dal rappresentan-
te in conflitto di interessi con il rap-
presentato (1394). Il contratto è annul-
Limiti: il contratto con- 䉴 Abuso di potere: quando labile su domanda del rappresentato
cluso dal rappresentan- il rappresentante pur forni- se il conflitto era conosciuto o ricono-
te in nome e per conto to del potere, ne fa un uso scibile dal terzo
del rappresentato vinco- distorto, e agisce per un • Contratto concluso dal rappresentan-
la costui soltanto nei li- fine diverso da quello per te con se stesso (1395) in qualità di
miti delle facoltà conces- cui il potere gli era stato contraente in proprio o di rappresen-
segli (1388) conferito tante di due distinti soggetti.
Il contratto è annullabile su domanda
del rappresentato, è invece valido nei
casi previsti dall’art. 1395
Limiti: il contratto con- 䉴 Eccesso di potere (1398): quando il rappresentante supera i limiti del-
cluso dal rappresentan- la procura. Il negozio è inefficace. È possibile la ratifica.
te in nome e per conto
del rappresentato vinco- 䉴 Difetto di potere (1398): è il caso di chi agisce in qualità di rappresen-
la costui soltanto nei li- tante non avendone i poteri. Il negozio è inefficace. È possibile la ratifica.
miti delle facoltà conces- In questo caso, così come nel precedente, il rappresentante è respon-
segli (1388) sabile del danno che il terzo contraente ha sofferto per aver confidato,
senza sua colpa, nella validità del contratto (1398).
Ratifica (1399): la ratifica è un negozio unilaterale recettizio con il quale il rappresentato conferisce
efficacia al negozio compiuto dal rappresentante senza potere o che ne abbia ecceduti i limiti, accettan-
done gli effetti nella propria sfera giuridica. La ratifica è, in pratica, una sorta di procura successiva.
La ratifica ha effetto retroattivo, però sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi. Può essere espressa o tacita.
Differenze
La ratifica va tenuta distinta dalla convalida: la ratifica sana «la mancanza di legittimazione come
vizio a monte dell’atto, mentre la convalida sana un vizio intrinseco dell’atto che ne comporta l’an-
nullabilità» (TRABUCCHI).
11 Elementi accidentali del negozio giuridico
Nozione: gli elementi accidentali del negozio sono quegli elementi che possono essere libera-
mente apposti in un negozio dalle parti, condizionandone l’efficacia, e servono per rendere giuridica-
mente rilevanti i motivi.
Essi sono: condizione, termine, modo.
Capitolo 7 • Fatti ed atti giuridici: negozio giuridico 55
Alcuni negozi non sopportano l’apposizione di tali elementi; essi sono:
䉴 Il matrimonio (108)
䉴 Negozi di diritto familiare in genere
Actus legitimi
䉴 Accettazione e rinuncia all’eredità (470, 520)
䉴 Accettazione e girata della cambiale
11.1. • La condizione
Nozione: la condizione è un avvenimento futuro ed incerto dal cui verificarsi le parti fanno dipen-
dere l’inizio (condizione sospensiva) o la cessazione ( condizione risolutiva) degli effetti del negozio.
䉴 Futuro: non ancora verificatosi. Se l’evento si è già verificato ma le par-
parti lo ignorano, si avrà una condizione impropria
Caratteri
dell’avvenimento 䉴 Incerto: occorre cioè che, al momento in cui la condizione è apposta, sia
obiettivamente impossibile prevedere con certezza il suo verificarsi o meno
11.1.1. • Tipi
䉴 Sospensiva: quella dalla quale dipende l’inizio dell’efficacia del nego-
zio (es.: ti darò 100 se la nave verrà dall’Asia)
䉴 Risolutiva: quella dalla quale dipende la cessazione degli effetti del
negozio
䉴 Affermativa: quando la situazione di fatto, esistente al momento della
conclusione del negozio, si modifica in seguito al verificarsi della con-
dizione (es.: ti darò 100 se la nave verrà dall’Asia)
䉴 Negativa: quando la situazione di fatto non viene modificata dalla verifica-
zione dell’evento, dedotto in condizione (es.: ti darò 100 se non pioverà)
䉴 Casuale: quella il cui verificarsi dipende dal caso o dalla volontà di terzi
䉴 Mista: se il caso e la volontà delle parti concorrono al verificarsi della
condizione (es.: ti darò 100 se supererai l’esame)
Condizione • vera e propria: consiste in un fatto che, pur
volontario, non è indifferente compiere per-
ché costa qualche sacrificio o perché la vo-
lontà dipende da una valutazione discre-
zionale di vari motivi ed interessi (es.: se
aprirò uno stabilimento ti assumerò)
䉴 Potestativa: è quella il cui • meramente potestativa o arbitraria: quan-
verificarsi dipende dalla do l’impegno che la parte si assume è ri-
volontà di una delle parti. messo al suo mero arbitrio (es. se vorrò).
Se sospensiva determina la nullità del ne-
gozio (1355). Se risolutiva, in mancanza di
disciplina normativa, parte della dottrina ri-
tiene tale clausola un potere di recesso.
È valido se dipende dalla volontà dell’acqui-
rente o del creditore (es.: patto di riscatto)
䉴 Legale (c.d. condicio iuris): trova la sua fonte nell’ordinamento e non
nella volontà delle parti
56 Parte Seconda • Soggetti, atti e fatti giuridici
11.1.2. • Vicende della condizione
䉴 Si ha finché la condizione non si è verificata, ma è ancora possibile che
si verifichi. Durante il periodo di pendenza possono compiersi atti con-
Pendenza servativi e atti di disposizione (gli effetti di questi ultimi sono però su-
bordinati alla stessa condizione) e vige l’obbligo di comportarsi secon-
do buona fede (1356 e ss.)
䉴 Si ha quando l’evento dedotto non si è verificato ed è ormai certo che
Mancanza non può verificarsi. Se la condizione è sospensiva il negozio resta de-
finitivamente inefficace, se è risolutiva gli effetti diventano definitivi
䉴 La situazione giuridica di-
venta definitiva con effetto
retroattivo, salvo che, per • condizione sospensiva: gli effetti del
volontà delle parti o per la negozio si considerano prodotti ex tunc
Effetti del verificarsi natura del rapporto, gli ef-
fetti del contratto o la loro • condizione risolutiva: gli effetti del ne-
risoluzione debbano esse- gozio si annullano ex tunc.
re riportati ad un momen-
to diverso (1360)
• atto tra vivi: negozio nullo
䉴 Se contraria a norme im- • atto mortis causa: si ha per non appo-
Illiceità (1354) perative, all’ordine pubbli- sta salvo che risulti essere motivo uni-
co, al buon costume co della disposizione, in questo caso
l’atto è nullo
• Fisica: se tocchi il cielo con un dito
䉴 Tipi
• Giuridica: se mi vendi un bene demaniale
Impossibilità (1354) — sospensiva: nullità del negozio
• Atto tra vivi
䉴 Effetti — risolutiva: si considera non apposta
• Atto mortis causa: si ha per non apposta (634)
Se la condizione illecita o impossibile è apposta ad un patto singolo del contratto si applicheranno
le disposizioni contenute in via generale nell’art. 1354, salvo quanto è disposto dall’art. 1419 (c.d.
nullità parziale).
11.1.3. • La presupposizione
È una condizione non apposta in maniera esplicita per cui resta a livello di motivo, tuttavia è cono-
sciuta ed è quindi comune alle parti (es. locazione di un balcone per assistere ad una cerimonia). Si
discute sulla sua rilevanza giuridica e sulle conseguenze derivanti dal non verificarsi dell’evento previsto.
䉴 È una condizione non sviluppata, pertanto è irrilevante (dottrina tra-
dizionale)
䉴 È un errore di previsione che se essenziale e riconoscibile deter-
Tesi mina l’annullabilità del contratto
䉴 Incide sulla causa del contratto determinando la invalidità del negozio
䉴 È causa di risoluzione del contratto per eccessiva onerosità (1467)
Capitolo 7 • Fatti ed atti giuridici: negozio giuridico 57
In sintesi
La giurisprudenza di legittimità ha considerato la presupposizione come una circostanza «esterna» al
contratto che non attiene all’oggetto, né alla causa, né ai motivi e che, pur se non specificamente dedotta
come condizione ne costituisce, specifico ed oggettivo presupposto di efficacia, assumendo per en-
trambe le parti o anche per una sola di esse - ma con riconoscimento da parte dell’altra - valore determi-
nante ai fini del mantenimento del vincolo contrattuale, il cui mancato verificarsi legittima l’esercizio del
recesso (Cass. 12235/2007). In altra pronuncia la presupposizione è stata definita come figura giuridica
che si avvicina, da un lato, ad una particolare forma di «condizione», da considerarsi implicita e, comun-
que, certamente non espressa nel contenuto del contratto e, dall’altro, alla stessa «causa» del contratto
(intendendosi per causa la funzione tipica e concreta che il contratto è destinato a realizzare) e il cui rilievo
resta affidato all’interpretazione della volontà contrattuale delle parti; la presupposizione deve, perciò,
ritenersi configurabile tutte le volte in cui, dal contenuto del contratto, si evinca che una situazione di fatto,
considerata, ma non espressamente enunciata dalle parti in sede di stipulazione del medesimo, quale
presupposto imprescindibile della volontà negoziale, venga successivamente mutata dal sopravvenire di
circostanze non imputabili alle parti stesse, in modo tale che l’assetto che costoro hanno dato ai loro
rispettivi interessi venga a poggiare su una base diversa da quella in forza della quale era stata convenuta
l’operazione negoziale, così da comportare la risoluzione del contratto stesso ai sensi dell’art. 1467 c.c.
(Cass. 6631/2006).
11.2. • Il termine
Nozione: il termine è un avvenimento futuro e certo dal quale le parti fanno dipendere l’inizio o la
cessazione dell’efficacia di un negozio giuridico.
Il termine si differenzia dalla condizione per il carattere di certezza dell’evento .
䉴 Futuro: non ancora verificatosi
䉴 Certo: l’evento deve senz’al- • dies certus an et certus quando (es. il
Caratteri tro verificarsi. Può essere, 10 marzo 2000).
però, incerto il momento • dies certus an et incertus quando (es.
della sua verificazione il giorno della morte di Caio)
䉴 Iniziale: consiste nell’evento dal quale debbono prodursi gli effetti
Tipi
䉴 Finale: consiste nell’evento fino al quale debbono prodursi gli effetti
Effetti: a differenza della condizione sospensiva il termine iniziale non pone in dubbio gli effetti del
negozio, ma li differisce ad un momento successivo.
Scadenza: è in quel momento che si verificano gli effetti negoziali. Efficacia ex nunc.
Il termine di efficacia non va confuso con il termine di adempimento che attiene alla esecuzione.
11.3. • Il modo
Nozione: il modo (o onere) è una clausola accessoria che si appone ai soli atti di liberalità (legato,
istituzione di erede, donazione) allo scopo di limitarla.
Il modo, pur se limita una liberalità, non ne costituisce il corrispettivo. Si diversifica dalla condizione
sospensiva in quanto non sospende l’efficacia del negozio ma produce un obbligo.
䉴 Di fare (es.: istituzione di erede con l’obbligo di erigere un monumento)
䉴 Di non fare (dono un immobile con l’obbligo di non modificarne la struttura)
Obbligo
䉴 Di dare (istituzione di erede con l’obbligo di compiere un atto di libera-
lità verso i poveri)
58 Parte Seconda • Soggetti, atti e fatti giuridici
• in caso di illiceità o impossibilità si ha
per non apposto, salvo che risulti es-
䉴 Possibile
sere il solo motivo determinante del-
Caratteri la liberalità (794)
• l’impossibilità sopravvenuta del modo
䉴 Lecito
libera l’obbligato (1256)
䉴 Adempimento: può essere richiesto da tutti gli interessati (648, co. 1).
È sufficiente un interesse anche solo morale
Effetti 䉴 Inadempimento: poiché il modo non è un corrispettivo di un negozio a
prestazioni corrispettive, in caso di inadempimento non potrà aversi la
risoluzione del negozio cui è apposto, a meno che questa sia stata
espressamente prevista come conseguenza dell’inadempimento (648)
Differenze
La condizione si differenzia dal termine, altro elemento accidentale del negozio, sotto il profilo
della certezza/incertezza del verificarsi dell’evento futuro. In particolare, mentre nel termine l’even-
to futuro, dal cui verificarsi dipende l’inizio (termine iniziale) o la fine (termine finale) dell’efficacia
del contratto, si verificherà certamente ma non si sa quando, nella condizione non si sa se l’evento
futuro, dal cui verificarsi dipende l’efficacia o la cessazione di efficacia del contratto, si verificherà
(ad es., il riferimento alla futura morte di una persona non costituisce condizione ma termine,
poiché l’evento è certo ma è incerto il momento in cui si verificherà). Invece, la condizione si distin-
gue dal modo poiché quest’ultimo vincola il destinatario senza sospendere l’efficacia del negozio,
mentre la condizione sospende l’efficacia ma non vincola i contraenti (Di Pirro).
12 L’invalidità del negozio giuridico
12.1. • Inesistenza (figura riconosciuta solo da parte della dottrina)
Nozione: si avrebbe inesistenza quando il negozio non è semplicemente viziato, ma manca quel mini-
mum di elementi necessari per poterlo qualificare o identificare come negozio giuridico. Non esiste nemmeno
l’apparenza: è un non negozio (es. matrimonio tra due persone dello stesso sesso; testamento orale).
䉴 Inconvalidabilità assoluta
Effetti: 䉴 Impossibilità di produrre alcun effetto, neanche indiretto
䉴 Inconvertibilità
12.2. • Nullità
Nozione: il negozio è nullo quando: manca di un elemento essenziale; è contrario a norme impe-
rative; risulta illecito per illiceità della causa o dei motivi; per mancanza dei requisiti dell’oggetto (1418)
o, comunque, in tutti gli altri casi stabiliti dalla legge.
䉴 Improduttività di effetti: il negozio non produce gli effetti della catego-
ria cui appartiene, tuttavia può produrre effetti indiretti
䉴 Rilevabilità di ufficio (1421)
Caratteri
䉴 Insanabilità: non può sanarsi né per convalida (1423) né per prescrizio-
ne dell’azione (1422). Eccezioni sono contenute negli artt. 590 e 799
Capitolo 7 • Fatti ed atti giuridici: negozio giuridico 59
䉴 Imprescrittibilità
䉴 Azione di mero accertamento, dichiarativa: non modifica la situazio-
Caratteri dell’azione ne preesistente ma si limita soltanto a farla accertare giudizialmente
di nullità 䉴 Assolutezza: esercitabile da chiunque abbia interesse
䉴 Efficacia retroattiva della dichiarazione di nullità
䉴 Nullità totale: riguarda l’intero negozio
• se la clausola ha valore preminente:
Tipi 䉴 Nullità parziale: si riferi- la nullità si estende all’intero negozio
sce ad una o più clausole • se la clausola ha carattere accesso-
del negozio (1419) rio : è invalida solo la clausola, l’altra
parte del negozio resta in vita
䉴 Se il negozio è stato eseguito: chi ha effettuato la prestazione ha diritto
alla sua ripetizione (2033)
䉴 Se un terzo ha acquistato un diritto da chi, a sua volta, ha acquistato in
Effetti virtù di un atto nullo, il suo diritto viene meno (resoluto iure dantis,
resolvitur et ius accipientis).
Questo principio può essere derogato per tutelare i terzi di buona fede
(2652 n. 6)
䉴 Nozione: un negozio nullo può produrre gli effetti di un negozio diverso
del quale contenga però tutti i requisiti di forma e sostanza. La conver-
sione è possibile solo se risulta che le parti, sapendo della nullità del
negozio, avrebbero voluto quello diverso (c.d. conversione sostan-
ziale). Diversa è la conversione formale, che non riguarda il contenu-
to ma opera quando un atto può rivestire una pluralità di forme (es.: un
testamento segreto nullo può valere come olografo)
Conversione del negozio
nullo (1424) • elemento soggettivo: la volontà dei
soggetti a concludere un negozio di-
verso se fosse stata nota la nullità del
䉴 Requisiti negozio concluso
• elemento oggettivo: requisiti di so-
stanza e di forma del negozio nel qua-
le deve essere convertito
Osservazioni
La nullità di protezione è una categoria di nullità molto diffusa soprattutto nella legislazione spe-
ciale, per cui un contratto viene definito nullo non per interesse generale o contrarietà all’ordine
pubblico economico, ma a tutela di una delle parti che è l’unica a potersi avvalere della nullità
stessa. È quanto accade, ad esempio, nei contratti del consumatore: l’art. 36 del codice del consu-
mo ha ad oggetto la nullità di protezione.
Altri esempi si rinvengono nei contratti bancari, in quelli relativi alla prestazione di servizi finanziari
nella subfornitura etc.
Caratteri delle nullità di protezione sono: operano solo a vantaggio del consumatore; sono rilevabili
d’ufficio solo se a vantaggio del consumatore, colpiscono solo le clausole vessatorie, mentre il
contratto rimane valido per il resto.
60 Parte Seconda • Soggetti, atti e fatti giuridici
12.3. • Annullabilità
Nozione: l’annullabilità è una forma di invalidità di minore gravità e deriva dall’inosservanza delle
regole previste dall’ordinamento che mirano a tutelare una delle parti.
䉴 Incapacità legale o naturale della parte (1425)
Il negozio è annullabile
䉴 Vizi del consenso (1427 e ss.)
in caso di
䉴 In tutti i casi previsti dalla legge
䉴 Annullabilità relativa: può essere fatta valere solo dalla parte nel cui
interesse è stabilita, dai suoi legali rappresentanti, eredi o aventi causa
• per gli atti posti in essere dall’interdet-
Tipi 䉴 Annullabilità assoluta: to legale
può essere fatta valere da
• per il testamento
chiunque vi abbia interes-
se. È prevista: • per alcuni casi di annullamento del ma-
trimonio
È un’eccezione alla legittimazione unilaterale all’annullamento
䉴 Testualità: l’annullabilità deve essere espressamente prevista dalla legge
䉴 Efficacia interinale del negozio annullabile: finché non viene annul-
Caratteri lato, il negozio produce i suoi effetti
dell’annullabilità
䉴 Non rilevabilità d’ufficio: è necessaria una domanda di parte affin-
ché il giudice possa rilevarla
䉴 Sanabilità • per effetto di convalida
• per effetto della prescrizione dell’azio-
ne di annullamento
䉴 Prescrittibilità: 5 anni dal giorno in cui è cessata la causa che ha dato
luogo al vizio del negozio.
In altri casi previsti dalla legge (es.: incapacità naturale) i 5 anni decor-
rono dal giorno in cui si è concluso il negozio (1442)
Caratteri
dell’annullamento 䉴 Natura costitutiva: in quanto mira a modificare la situazione giuridica
preesistente; la sentenza elimina gli effetti che il negozio aveva prodot-
to durante il periodo della sua efficacia
䉴 Relatività: l’azione può essere esperita solo da chi ne abbia interesse
(1441), salvi alcuni casi di annullabilità assoluta (es.: 1441, co. 2)
䉴 Retroattività tra le parti: • chi ha ricevuto la prestazione è tenuto
la sentenza di annullamen- a restituirla per intero
to elimina gli effetti con ef- • l’incapace deve restituire solo quanto
ficacia retroattiva (ex tunc) rivolto a proprio vantaggio (1443)
• se l’annullamento dipende da incapacità
Effetti dell’annullamento legale: gli effetti retroattivi dell’annullamen-
to si applicano anche nei confronti dei terzi
䉴 Retroattività nei confron-
• se l’annullamento deriva da altre cau-
ti dei terzi. Occorre distin-
se: la sentenza non pregiudica i diritti
guere:
acquistati a titolo oneroso dai terzi in
buona fede (1445)
Capitolo 7 • Fatti ed atti giuridici: negozio giuridico 61
䉴 Nozione: negozio giuridico unilaterale con il quale il soggetto legittima-
to a proporre azione di annullamento manifesta la propria volontà di
sanare il vizio del negozio (1444)
• espressa: quando contiene l’indicazione del ne-
gozio annullabile, del motivo di annullabilità, la di-
Convalida chiarazione che si intende sanare il negozio
䉴 Forma • tacita: consiste nella esecuzione volontaria del ne-
gozio annullabile con la consapevolezza della sua
annullabilità; parte della dottrina considera la con-
valida tacita un atto giuridico in senso stretto
13 Inefficacia
Nozione: inidoneità di un negozio giuridico valido a produrre i suoi effetti verso tutti o alcuni soggetti.
13.1. • Tipi
Inefficacia relativa (c.d. inopponibilità): quando il negozio è valido ma non produce effetti solo
verso alcuni soggetti (es.: alienazione di beni in frode ai creditori).
Inefficacia in conseguenza dell’apposizione di elementi accidentali (c.d. requisiti volontari di
efficacia): quando il negozio è, ad esempio, sottoposto a condizione sospensiva.
Inefficacia per mancanza di legittimazione: la mancanza del potere di disposizione del sogget-
to rispetto ad un bene o un diritto comporta inefficacia del negozio rispetto ad alcune delle conseguen-
ze dell’atto (es.: vendita di cose altrui: produce effetti obbligatori, quindi è efficace inter partes, ma è
inefficace rispetto allo scopo tipico di trasferire la proprietà, 1478).
Inefficacia per mancanza dei requisiti legali di efficacia cui è subordinata l’efficacia di alcuni
atti giuridici.
13.2. • Irregolarità
Nozione: il negozio si dice irregolare quando, pur valido ed efficace, viola norme che, come sanzione,
non comportano riflessi sull’atto, ma una pena contro chi lo ha posto in essere (es.: lutto vedovile, 140).
In sintesi
Per negozio giuridico deve intendersi quella particolare figura di atto giuridico lecito i cui effetti
non sono prestabiliti dalla legge, ma sono liberamente determinabili dalle parti, in conformità alla
volontà manifestamente espressa ed alla causa (cioè alla funzione economico-sociale) che l’atto
stesso è obiettivamente capace di raggiungere.
Dunque, il negozio giuridico costituisce la manifestazione più importante dell’autonomia privata e
cioè del potere riconosciuto ai soggetti privati di regolare da sé i propri interessi; esso è però una
categoria di creazione dottrinale non recepita espressamente dal codice civile del 1942 che disci-
plina il contratto e non il negozio giuridico. Ciò nonostante tale categoria continua ad essere uno
dei più diffusi e studiati concetti da parte della dottrina, con l’alternanza nel tempo di numerose
teorie volte ad illustrarne il fondamento e la natura.
Tra queste merita una menzione la teoria della dichiarazione, volta a dar rilevanza all’ oggettivo
significato o valore della dichiarazione per richiamare l’autore del negozio alla responsabilità per le
dichiarazioni rese e far così risaltare la tutela dell’affidamento che il destinatario dell’atto poneva
nella dichiarazione.
62 Parte Seconda • Soggetti, atti e fatti giuridici
Capitolo 8 PROVA E PUBBLICITÀ DEI FATTI GIURIDICI
A) La prova
1 Generalità - Il principio dispositivo
La materia delle prove forma oggetto del diritto processuale, cui si rinvia per un esame più approfondito.
Principio dispositivo: nel processo civile non è il giudice che deve ricercare le prove relative ai
fatti dedotti in giudizio, ma sono le parti che devono indicare i mezzi di prova con cui comprovare le loro
affermazioni, il giudice deve valutarne la ammissibilità, la rilevanza e la concludenza.
2 Onere della prova
Nozione: «Onus probandi incumbit ei qui dicit non ei qui negat » (2697).
䉴 Chi vuole far valere un suo diritto deve provarne i fatti costitutivi
Soggetto 䉴 Chi nega la rilevanza di tali fatti giuridici deve provarne l’inefficacia, o
deve provare che altri fatti abbiano modificato o estinto il diritto in que-
stione
In taluni casi, però, è possibile una inversione dell’onere della prova. Essa può essere:
Legale: quando è la stessa legge a prevederla (es. la promessa di pagamento o il riconoscimento
del debito esime il creditore dal provare l’esistenza del rapporto fondamentale che ha dato origine alla
promessa o al riconoscimento del debito; spetterà al debitore dare la prova dell’assenza del rapporto
fondamentale, 1988).
Convenzionale: fissata dalle parti; può aversi solo se si tratta di diritti disponibili e se non rende
eccessivamente difficile l’esercizio del diritto per una delle parti (2698).
3 Mezzi di prova
Nozione: mezzi di prova sono gli strumenti (cose o fatti) idonei a provare i fatti.
䉴 Prove precostituite o docu- • atto pubblico
mentali: esistono prima del giu-
dizio in cui sono addotte • scrittura privata
Tipi • testimonianza
䉴 Prove semplici o costituende: • presunzioni
si formano in giudizio • confessione
• giuramento
Capitolo 8 • Prova e pubblicità dei fatti giuridici 63
䉴 Prove libere: sono prove liberamente apprezzabili dal giudice in base
al suo libero convincimento (116 c.p.c.)
䉴 Prove legali: sono le pro-
ve che il giudice non può • atto pubblico
Valutazione valutare liberamente, in • scrittura privata riconosciuta
quanto è la legge che le
ritiene idonee in modo
• confessione
preciso a dimostrare un • giuramento
fatto
䉴 Prove storiche che consistono nella rappresentazione o nella esposi-
zione del fatto (es.: prova per testi)
Altre distinzioni
䉴 Prove logiche che consistono in argomentazioni o congetture da cui
si desume un fatto (es.: presunzioni)
3.1. • Le presunzioni
Nozione: la presunzione è un’argomentazione o costruzione logica, mediante la quale, provato un
fatto, se ne considera provato un altro sfornito di autonoma prova.
䉴 Presunzioni semplici: se è il giudice a dedurre il fatto da provare dal
fatto conosciuto (2729)
䉴 Presunzioni legali: quando è la legge ad attribuire ad un fatto valore
probatorio rispetto ad un fatto diverso (es.: 1147)
Specie • relative (iuris tantum): è ammessa la
prova contraria (es.: presunzione di
paternità, 231)
䉴 Possono essere: • assolute (iuris et de iure): non è am-
messa la prova contraria (es.: presun-
zione di concepimento durante il ma-
trimonio, 232)
3.2. • Prove documentali
Nozione: prove raggiunte tramite documenti. Per documento si intende un atto scritto rappresen-
tativo di un fatto.
䉴 Atto pubblico: documento redatto da un notaio o da un altro pubblico
ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni (2699).
Fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza e del conte-
nuto, ma non della verità delle affermazioni in esso contenute
Specie 䉴 Scrittura privata: qualsiasi documento sottoscritto da un privato fa prova
solo contro chi ha sottoscritto il documento e solo se questi riconosca
come vera la sottoscrizione. La sottoscrizione si considera legalmente
riconosciuta se è autenticata da un notaio o da un pubblico ufficiale o
se è accertata giudizialmente attraverso un procedimento di verifica-
zione (216 e ss. c.p.c.)
64 Parte Seconda • Soggetti, atti e fatti giuridici
Osservazioni
Il documento informatico da chiunque formato, la memorizzazione su supporto informatico e la
trasmissione con strumenti telematici conformi alle regole dettate in materia dalla normativa nazio-
nale e internazionale sono validi e rilevanti agli effetti di legge, secondo le disposizioni del Codice
dell’amministrazione digitale (v. Cap. VII, §7.1). In materia di atto pubblico informatico redatto dal
notaio sono dettate norme specifiche, anche ai fini dell’autenticazione delle sottoscrizioni con l’uti-
lizzo di modalità informatiche (D.Lgs. 110/2010).
3.3. • Testimonianza
Nozione: la testimonianza è la narrazione fatta al giudice da una persona estranea ai fatti oggetto
della causa di fatti controversi di cui è a conoscenza.
䉴 Per provare contratti il cui valore sia superiore a due euro e cinquantot-
to centesimi, salvo che il giudice ritenga opportuno disporla ugualmen-
te
䉴 Per provare patti anteriori, contemporanei o successivi ad un accordo
scritto
䉴 Per provare un contratto per il quale è richiesta la forma scritta ad sub-
Limiti: non è ammessa stantiam. In questo caso è ammessa la prova per testimoni solo se la
parte ha perduto, senza sua colpa, il documento che forniva la prova
• vi è un principio di prova scritta
䉴 È ammessa peraltro in • la parte si è trovata nell’impossibilità
ogni caso quando (2724, di procurarsi prova scritta
2725): • la parte ha perduto, senza colpa, il
documento
Osservazioni
La legge di riforma del processo civile (L. 69/2009) ha disciplinato l’ipotesi della testimonianza
scritta: il giudice, su accordo delle parti, tenuto conto della natura della causa può disporre di
assumere la deposizione chiedendo al testimone di fornire, per iscritto e nel termine fissato, le
risposte ai quesiti sui quali deve essere interrogato; a tal fine la parte che ha richiesto l’assunzione
predispone il modello di testimonianza in conformità agli articoli ammessi e lo notifica al testimone
il quale rende la deposizione compilando il modello, con risposta a ciascuno dei quesiti, e precisa
quali sono quelli cui non è in grado di rispondere, indicandone la ragione. La deposizione è sotto-
scritta e poi spedita o consegnata alla cancelleria del giudice a cura del testimone.
3.4. • Confessione
Nozione: confessione è la dichiarazione che una parte fa della verità di fatti ad essa sfavorevoli e
favorevoli all’altra parte (2730).
Natura: dichiarazione di scienza, revocabile solo per errore di fatto o violenza. È un atto giuridico
in senso stretto.
Efficacia: prova legale. La confessione ha efficacia solo se proviene da persona capace di dispor-
re del diritto al quale si riferiscono i fatti confessati.
Capitolo 8 • Prova e pubblicità dei fatti giuridici 65
䉴 In relazione al momento • Stragiudiziale: resa fuori del giudizio
in cui interviene
— spontanea
• Giudiziale: resa nel giudizio — provocata mediante
interrogatorio formale
Specie • Qualificata: si riconosce la verità dei fatti sfavorevoli e si
aggiungono altri fatti che tendono alla modifica dell’effi-
cacia del fatto contestato
䉴 In relazione al contenuto
• Complessa: si riconosce il fatto sfavorevole e si aggiun-
gono altri fatti che tendono alla estinzione degli effetti
del fatto ammesso
In questi casi particolari, se l’altra parte non contesta la verità dei fatti aggiunti, la dichiarazione fa
piena prova nella sua integrità; in caso di contestazione, invece, il giudice ne apprezza liberamente
l’efficacia probatoria (2734).
3.5. • Giuramento
Nozione: il giuramento è la dichiarazione solenne resa in giudizio con cui si attestano fatti rilevanti
per la decisione. È la prova estrema cui si ricorre in mancanza di ogni altra.
Il giuramento è prestato personalmente dalla parte dinanzi al giudice istruttore, il quale ammoni-
sce sull’importanza dell’atto e sulle conseguenze penali di dichiarazioni false (238 c.p.c.).
䉴 Prova legale: una volta prestato il giuramento, il giudice deve necessa-
riamente decidere sulla base di esso; se ci si sottrae, dunque, si soc-
combe, mentre se il giuramento è prestato, è l’altra parte a soccombere
Natura ed effetti (2738) 䉴 Non ammette prova contraria; la sua falsità può essere accertata solo in sede
penale, se la falsità è accertata lo spergiuro è tenuto al risarcimento dei danni,
ma la sentenza basata sul giuramento non è soggetta a revocazione
䉴 Decisorio: è deferito da una parte che sfida l’altra a confermare sotto il giura-
mento la verità di una sua affermazione. La parte cui il giuramento è stato
deferito può a sua volta riferirlo alla prima che non può rifiutarsi di giurare
䉴 Suppletorio: è deferito dal giudice qualora si trovi di fronte ad un fatto
rimasto incerto, per il quale la parte che aveva l’onere di provarlo abbia
fornito prove rilevanti ma non persuasive (prova semipiena). Una for-
ma ne è il c.d. giuramento estimatorio tendente a stabilire in maniera
Specie (2736)
definitiva il valore di un oggetto di controversia.
• de scientia: se ha ad oggetto un fatto
di cui la parte è a conoscenza, ma
䉴 In ordine al contenuto che non la riguarda
• de veritate: se ha ad oggetto un fatto
proprio della parte
䉴 Su diritti indisponibili
䉴 Per provare un fatto illecito del giurante
䉴 Per provare un atto per cui è richiesta la forma scritta ad substantiam
Inammissibilità (2739) 䉴 Per contraddire l’attestazione contenuta in un atto pubblico che il fatto
è avvenuto alla presenza del pubblico ufficiale
䉴 Per fatti che, anche se non illeciti, siano turpi ed esporrebbero il giuran-
te alla riprovazione sociale
66 Parte Seconda • Soggetti, atti e fatti giuridici
B) Pubblicità dei fatti giuridici
4 La pubblicità dei fatti giuridici
Nozione: la pubblicità è uno strumento previsto dal diritto affinché i terzi possano venire a cono-
scenza di fatti giuridici, del contenuto di negozi, dello stato delle persone fisiche nonché di varie vicen-
de delle persone giuridiche.
Natura: la pubblicità non va confusa con la dichiarazione di volontà negoziale e quindi è cosa
diversa dalla forma.
La pubblicità presuppone la dichiarazione negoziale, costituendo solo un mezzo tramite il quale
questa viene resa conoscibile per i terzi.
䉴 Pubblicità notizia: costituisce un onere per i soggetti; la sua inosser-
vanza dà luogo a sanzioni pecuniarie o penali. Il rapporto giuridico
resta però valido ed opponibile ai terzi (es. pubblicazioni matrimoniali)
䉴 Pubblicità dichiarativa: costituisce un onere per i soggetti, in quanto
serve a rendere l’atto opponibile ai terzi.
Tra le parti esso resta valido anche in mancanza di pubblicità (es. tra-
scrizione immobiliare)
Specie 䉴 Pubblicità costitutiva: in tal caso la pubblicità è un elemento costitu-
tivo della fattispecie negoziale.
Il negozio, inopponibile ai terzi, è inefficace anche tra le parti. Ne sono
esempi l’iscrizione nei registri immobiliari dell’ipoteca (2808), l’iscrizio-
ne delle s.p.a. nel registro delle imprese (2331)
䉴 Pubblicità di fatto: è una forma di pubblicità che si aggiunge a quelle
previste ed organizzate dalla legge.
È costituita dai «mezzi idonei» cui la legge fa riferimento, a volte, per
portare un fatto a conoscenza dei terzi (es. 1396)
䉴 Pubblicità sanante: oltre ad avere funzioni informative e dichiarative,
ha anche quella di eliminare, dopo un certo periodo di tempo dalla
trascrizione, alcuni vizi dell’atto.
4.1. • La pubblicità in relazione alle varie categorie di beni
I modi di rendere pubbliche le situazioni giuridiche mutano a seconda della natura del bene:
— per i beni mobili vige la regola «il possesso vale titolo»;
— per i beni mobili registrati è necessaria l’iscrizione negli appositi registri (es. nella vendita di
automobili la registrazione al P.R.A.);
— per i beni immobili è necessaria la trascrizione nei registri immobiliari.
C) La trascrizione
5 Nozione - Funzione - Natura
Nozione: la trascrizione è un mezzo di pubblicità delle vicende dei beni immobili e mobili registrati.
Funzione: assicurare la conoscibilità delle vicende relative ai beni immobili e mobili registrati e
dirimere controversie tra più acquirenti dallo stesso dante-causa .
Capitolo 8 • Prova e pubblicità dei fatti giuridici 67
Natura: pubblicità dichiarativa, non è un obbligo per le parti ma semplicemente un onere (in
caso di omissione l’atto resta valido tra le parti ma inopponibile ad alcuni terzi), quindi:
— non è soggetta a prescrizione o decadenza;
— è effettuabile in ogni momento;
— ha efficacia ex nunc.
La trascrizione è invece un obbligo per il pubblico ufficiale rogante l’atto.
5.1. • Caratteri ed effetti
Le norme che disciplinano la trascrizione mirano a tutelare non solo un interesse individuale, ma
anche quello sociale alla sicurezza degli acquisti; sono quindi norme di ordine pubblico inderogabili .
Le norme hanno, inoltre, natura strumentale, rispetto al diritto la cui certezza tendono ad attuare.
La trascrizione è un regime di pubblicità a carattere personale, cioè il bene è considerato in rela-
zione al proprietario; la trascrizione segnala i mutamenti della legittimazione del soggetto in relazione
ad un dato bene.
Si attua all’Ufficio dei Registri immobiliari della località dove è ubicato il bene. Le registrazioni
catastali, invece, seguono un criterio reale: è il bene che è messo in evidenza, non il suo titolare.
䉴 Efficacia negativa: gli atti soggetti a trascrizione e non trascritti tem-
pestivamente non possono essere opposti a chi ha acquistato e tra-
scritto tempestivamente il suo titolo
䉴 Efficacia positiva: non possono avere effetto, nei confronti di chi ha
trascritto, le successive iscrizioni o trascrizioni di diritti acquistati dallo
stesso autore, quantunque l’acquisto risalga a data anteriore.
Efficacia Quindi, se un soggetto, mediante successivi atti di disposizione, trasfe-
risce ad altri soggetti lo stesso diritto immobiliare (o, comunque, diritti
immobiliari tra loro incompatibili), il criterio in base al quale si risolve il
conflitto è quello della priorità della trascrizione
䉴 Eccezionale efficacia costitutiva: la trascrizione è un elemento della
fattispecie di diritto sostanziale (es. usucapione abbreviata)
䉴 Efficacia sanante: vedi par. 9.
6 Ambito di applicabilità della trascrizione e principi che la regolano
6.1. • Ambito di applicabilità
Quanto all’ambito di applicabilità della trascrizione, si ricordi:
— la trascrizione opera solo per gli acquisti a titolo derivativo e non per quelli a titolo originario. In
particolare, nel conflitto fra acquisto a titolo derivativo ed acquisto a titolo originario, si applicano le
regole dell’usucapione;
— le norme sulla trascrizione non valgono nel caso in cui il conflitto da dirimere sia fra soggetti
acquirenti da diversi danti causa: bisogna risalire al comune autore, rispetto al quale vale il princi-
pio della priorità dell’acquisto;
— essa non vale per gli acquisti «a non domino»: non ha infatti efficacia sanante, salvo quanto detto
per l’usucapione abbreviata;
— nel caso che nessuno dei due o più soggetti abbia effettuato la trascrizione, si applica il criterio
della priorità dell’acquisto;
— fra due soggetti che abbiano acquistato dallo stesso autore l’uno un diritto reale e l’altro un diritto
di credito, prevale il diritto reale anche se non trascritto.
68 Parte Seconda • Soggetti, atti e fatti giuridici
6.2. • Principi in materia di trascrizione
Non vale la pubblicità di fatto, in quanto la legge non ammette equipollenti.
Priorità della trascrizione come titolo prevalente per l’acquisto del bene (2644). Chi ha trascritto
per primo ha la preferenza assoluta rispetto a pretese o diritti di altri aventi causa dallo stesso autore.
Nei rapporti tra primo avente causa, secondo avente causa che ha trascritto per primo e alienante, il
primo avente causa trova la sua tutela fuori dell’ambito della trascrizione; cioè ha diritto alla garanzia per
evizione, risarcimento dei danni, revocatoria se ne sussistono i presupposti (la fraudolenta preordinazione).
Si discute se l’acquisto del secondo avente causa è acquisto «a domino ».
Produce i suoi effetti in perpetuo, salvo cancellazioni o inefficacia.
La trascrizione del contratto preliminare perde efficacia se entro un anno dalla data convenuta tra
le parti per la conclusione del definitivo e in ogni caso entro tre anni dalla trascrizione non è eseguita
la trascrizione del definitivo.
䉴 Non è efficace la trascrizione operata contro un determinato soggetto,
se il diritto di quest’ultimo non risulta da una precedente trascrizione
䉴 Mira a costituire il «c.d. stato civile degli immobili» e a generare la cer-
tezza sulla consistenza giuridica e spettanza della proprietà medesima
Principio della continuità 䉴 La trascrizione operata da un soggetto senza che sia trascritto l’acquisto
del suo dante causa vale come prenotazione e opera come un atto di
pubblicità ad efficacia sospesa, subordinata al compimento di successivi
atti di pubblicità. Se gli atti successivi facciano seguito, l’efficacia retroagirà
7 Singoli atti soggetti a trascrizione
7.1. • Singoli atti
䉴 Titoli o modi d’acquisto non consistenti in atti o negozi (es. usuca-
Non vanno trascritti pione)
䉴 Pactum de non alienando.
䉴 Contratti (anche preliminari) che trasferiscono la proprietà di beni
immobili o che costituiscono o modificano diritti reali di godimento su
beni immobili; inoltre gli atti di rinuncia ai diritti su menzionati.
䉴 Contratti che conferiscono diritti personali di godimento su beni
Vanno trascritti (2643) immobili se superano una certa durata.
䉴 Le sentenze costitutive, i provvedimenti giudiziari con i quali nella ese-
cuzione forzata si trasferiscono la proprietà o altri diritti reali su beni
immobili, gli atti e le sentenze di affrancazione del fondo enfiteutico
È opinione diffusa che l’elencazione di cui all’art. 2643 abbia carattere tassativo esclusivamente
per ciò che riguarda il tipo di effetto prodotto, qualunque sia l’atto giuridico che vi ha dato origine,
come si desume dall’art. 2645 (che prescrive di sottoporre a trascrizione ogni altro atto o provvedimen-
to che produce, in relazione a beni immobili o a diritti immobiliari, taluno degli effetti dei contratti
menzionati nell’articolo 2643, salvo che dalla legge risulti che la trascrizione non è richiesta o è richie-
sta a effetti diversi). Conferma la non tassatività dell’elencazione degli atti soggetti a trascrizione an-
che la norma — art. 2645ter, introdotto dal d.l. 273/2005 conv. in l. 51/2006 — relativa alla trascrizione
dei negozi atipici (1322) che dispongano di beni immobili o di mobili iscritti in pubblici registri destinati
alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferiti a disabili, pubbliche amministrazioni o altre
Capitolo 8 • Prova e pubblicità dei fatti giuridici 69
persone fisiche o enti, al fine di rendere opponibile ai terzi il vincolo di destinazione. Il riferimento
riguarda prevalentemente i trusts ossia i rapporti giuridici istituiti da una persona (con atto tra vivi o
mortis causa) qualora dei beni siano posti sotto il controllo di un trustee nell’interesse di un beneficia-
rio o per un fine specifico (Convenzione dell’Aja, 1-7-1985, ratificata con l. 364/1989).
La trascrizione del preliminare è prevista dall’art. 2645bis introdotto dall’art. 3 d.l. 669/96, conv. in
l. 30/1997. Sono trascrivibili i preliminari stipulati per atto pubblico o per scrittura privata con sotto-
scrizione autenticata o accertata giudizialmente.
8 Altre funzioni della trascrizione
Alla funzione tipica della trascrizione si aggiungono funzioni peculiari alla differente natura degli
atti trascritti.
Trascrizione delle divisioni: poiché la divisione ha natura dicharativa mira a tutelare unicamente
i terzi che abbiano acquistato e legalmente conservato diritti sull’immobile comune (2646). Soddisfa
inoltre l’esigenza di continuità delle trascrizioni.
Trascrizione degli atti con i quali si costituisce il fondo patrimoniale fra i coniugi: rende
opponibile ai terzi la situazione in cui i beni vengono a trovarsi (2647). Parte della dottrina, però, ritiene
si tratti di semplice pubblicità notizia.
Trascrizione dell’accettazione di eredità e dell’acquisto del legato (2648): la sua funzione è
quella di salvaguardare il principio di continuità delle trascrizioni.
Trascrizione di sentenze da cui risulta la prescrizione o l’usucapione (2651): è operata solo
a fini fiscali, per cui la mancanza della trascrizione porterà semplicemente a una multa. Si ricordi,
infine, la trascrizione degli atti di interruzione dell’usucapione (2653 n. 5), che permette di portare a
conoscenza dei terzi se si sia verificata o meno l’usucapione, e cioè se essa sia stata interrotta: si noti,
altresì, che l’efficacia di tali atti interruttivi decorre dalla data della loro trascrizione.
Trascrizione delle domande giudiziali: permette ai terzi di conoscere della proposizione di una
domanda giudiziale con la quale viene contestata la titolarità di un diritto relativo a beni immobili o mobili
registrati, in ossequio al principio di diritto processuale secondo cui la sentenza che accoglie la domanda
retroagisce al momento della domanda stessa (principio dell’efficacia anticipata del giudicato).
9 Pubblicità sanante
Nozione: è una figura introdotta dalla dottrina (FERRI) per indicare una ulteriore funzione che la
trascrizione assolve quando determina un particolare affidamento sulla legittimità dell’atto trascritto:
occorre, affinché ricorra la figura in esame, il concorso di vari elementi, per cui si può asserire che la
pubblicità sanante scaturisce da una fattispecie complessa.
9.1. • Esempi
• trascrizione dell’atto da parte del ter-
zo subacquirente
䉴 Requisiti • buona fede
• scadenza del termine di decadenza
Nullità o annullamento (5 anni) per l’azione
per incapacità legale • l’azione non produce effetto nei con-
fronti del terzo subacquirente (a titolo
䉴 Effetto oneroso o gratuito) che ha trascritto
prima della domanda giudiziale
• l’atto resta nullo o annullato tra le parti
70 Parte Seconda • Soggetti, atti e fatti giuridici
Acquisti dall’erede o legatario apparente: 534, 2652, n. 7.
Acquisti dal donatario o dal beneficiario di una disposizione testamentaria in caso di ridu-
zione: 2652, n. 8.
10 Modalità di trascrizione
La trascrizione deve essere eseguita presso l’ufficio dei Registri Immobiliari nella cui circoscrizio-
ne sono ubicati i beni oggetto della stessa.
Nel caso in cui un bene sia riportato in più Registri Immobiliari (ipotesi di immobili siti ai confini di
diverse circoscrizioni) la trascrizione sarà effettuata presso tutti gli uffici per la parte di loro competenza.
Per ottenere la trascrizione di un atto inter vivos è necessario che l’interessato sia munito di:
— copia del titolo in forza del quale si chiede la trascrizione (sentenza, atto pubblico o scrittura
privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente);
— duplice copia della nota di trascrizione (che è una sintesi, in bollo, dell’atto da trascriversi, in cui si
indicano i nominativi degli alienanti e degli acquirenti).
Per ciò che riguarda la trascrizione di un atto mortis causa occorre:
— l’atto di accettazione dell’eredità;
— il certificato di morte del de cuius;
— la copia del testamento, se l’acquisto segue in base ad esso;
— duplice nota con gli estremi previsti all’art. 2660.
Per la trascrizione della domanda giudiziale sono richieste:
— copia autentica del documento che la contiene;
— relata di notifica alla controparte.
Le spese per la trascrizione gravano su colui a cui favore la trascrizione opera.
Capitolo 8 • Prova e pubblicità dei fatti giuridici 71
Potrebbero piacerti anche
- Riassunto DIRITTO PRIVATODocumento103 pagineRiassunto DIRITTO PRIVATOlcattaneo_2100% (3)
- Istituzioni Di Diritto Privato PDFDocumento288 pagineIstituzioni Di Diritto Privato PDFSonia Rossi100% (4)
- Capire il diritto amministrativo: attraverso schemi, mappe concettuali e schedeDa EverandCapire il diritto amministrativo: attraverso schemi, mappe concettuali e schedeNessuna valutazione finora
- Riassunto Manuale Di Diritto Civile Di Pietro Perlingieri PDFDocumento210 pagineRiassunto Manuale Di Diritto Civile Di Pietro Perlingieri PDFRaffaellaBaccariNessuna valutazione finora
- Istituzioni Di Diritto PrivatoDocumento151 pagineIstituzioni Di Diritto PrivatoFra MontaNessuna valutazione finora
- Diritto del lavoro: Sintesi ragionata di Diritto del lavoro per concorsi pubblici e esami universitariDa EverandDiritto del lavoro: Sintesi ragionata di Diritto del lavoro per concorsi pubblici e esami universitariNessuna valutazione finora
- Economia aziendale e Ragioneria per concorsi pubblici e esami universitari: L'azienda, la contabilità, l'organizzazione e la gestione aziendaleDa EverandEconomia aziendale e Ragioneria per concorsi pubblici e esami universitari: L'azienda, la contabilità, l'organizzazione e la gestione aziendaleNessuna valutazione finora
- Il diritto amministrativo in tasca: 25 schede sintetiche per concorsi ed esamiDa EverandIl diritto amministrativo in tasca: 25 schede sintetiche per concorsi ed esamiValutazione: 5 su 5 stelle5/5 (1)
- Tutor Magistralis. Compendio di diritto pubblico per concorsi pubblici: Per concorsi pubblici nel settore GiustiziaDa EverandTutor Magistralis. Compendio di diritto pubblico per concorsi pubblici: Per concorsi pubblici nel settore GiustiziaNessuna valutazione finora
- Concorso Istruttore Enti Locali - Servizi pubblici locali: Sintesi ragionata per concorsi pubbliciDa EverandConcorso Istruttore Enti Locali - Servizi pubblici locali: Sintesi ragionata per concorsi pubbliciNessuna valutazione finora
- Riassunti PerlingieriDocumento70 pagineRiassunti PerlingieriOttavio CiconteNessuna valutazione finora
- Riassunto Schematizzato Del MANUALE DI DIRITTO PRIVATO TorrenteDocumento48 pagineRiassunto Schematizzato Del MANUALE DI DIRITTO PRIVATO TorrenteDe-erMene Cen'è-unosolo85% (46)
- Percorso Visuale Di Diritto PrivatoDocumento103 paginePercorso Visuale Di Diritto PrivatoAlessandro Cascone100% (4)
- Istituzioni Di Diritto Privato - TorrenteDocumento81 pagineIstituzioni Di Diritto Privato - TorrenteDamiano Koepke100% (4)
- Compendio Diritto Commerciale - Simone - VIII Edizione - UnlockedDocumento320 pagineCompendio Diritto Commerciale - Simone - VIII Edizione - UnlockedElisa Martina Pannone0% (1)
- Simone - Schemi & Schede Di Diritto Commerciale Ed XDocumento354 pagineSimone - Schemi & Schede Di Diritto Commerciale Ed XAngioletto92100% (3)
- Schemi Di Diritto Privato Pietro PerlingieriDocumento154 pagineSchemi Di Diritto Privato Pietro PerlingieriHel Admn100% (1)
- Diritto AmministrativoDocumento159 pagineDiritto Amministrativo19avantasia87100% (1)
- Riassunto - Manuale Diritto PrivatoDocumento366 pagineRiassunto - Manuale Diritto Privatotwixt100% (2)
- Compendio Di Diritto PenaleDocumento164 pagineCompendio Di Diritto PenaleMarco Perasole100% (1)
- Cerulli Irelli Diritto AmministrativoDocumento92 pagineCerulli Irelli Diritto Amministrativotangled91100% (1)
- (Ebook - Var - Ita) Compendio Di Diritto PenaleDocumento23 pagine(Ebook - Var - Ita) Compendio Di Diritto PenaleMarco PerasoleNessuna valutazione finora
- Diritto CivileDocumento17 pagineDiritto Civileappuntigratis_unicamNessuna valutazione finora
- Istituzioni Di Diritto PrivatoDocumento62 pagineIstituzioni Di Diritto PrivatomemanuelemNessuna valutazione finora
- Fondamenti Di Diritto PrivatoDocumento25 pagineFondamenti Di Diritto PrivatoGianmarco AltieriNessuna valutazione finora
- Riassunto Diritto Commerciale 1 - CAMPOBASSO - Vol 2 - 2018 - 2019 JDocumento135 pagineRiassunto Diritto Commerciale 1 - CAMPOBASSO - Vol 2 - 2018 - 2019 JSalvatore Pecoraro100% (1)
- Diritto Dell' Unione EuropeaDocumento34 pagineDiritto Dell' Unione EuropeaWafaaDounaim100% (1)
- La tutela della Privacy - Sintesi aggiornata per concorsi pubblici: Il Codice di protezione dei dati personali, il diritto di accesso e la trasparenzaDa EverandLa tutela della Privacy - Sintesi aggiornata per concorsi pubblici: Il Codice di protezione dei dati personali, il diritto di accesso e la trasparenzaValutazione: 4 su 5 stelle4/5 (1)
- Diritto Amministrativo CasettaDocumento236 pagineDiritto Amministrativo CasettaFedericaGennaro60% (5)
- Diritto AmministrativoDocumento89 pagineDiritto AmministrativoRaffaele MeloNessuna valutazione finora
- Diritto Del Lavoro GheraDocumento58 pagineDiritto Del Lavoro GheraLayla_cre100% (3)
- Diritto Dell'Unione DanieleDocumento64 pagineDiritto Dell'Unione DanieleWalter Romano100% (2)
- Diritto Privato Galgano Riassunto CompletoDocumento137 pagineDiritto Privato Galgano Riassunto Completofrenky780% (5)
- Tonini PDFDocumento74 pagineTonini PDFMichele Pozzo100% (2)
- Mandrioli RiassuntoDocumento73 pagineMandrioli Riassuntoalteriuris100% (10)
- Domande Esame Diritto Del Lavoro 1 - 001 352 PDFDocumento115 pagineDomande Esame Diritto Del Lavoro 1 - 001 352 PDFIrene MargiottaNessuna valutazione finora
- Riassunto Di Istituzioni Di Diritto Dell'Unione Europea VillaniDocumento29 pagineRiassunto Di Istituzioni Di Diritto Dell'Unione Europea VillaniEdy RoxanaNessuna valutazione finora
- DIRITTO TRIBUTARIO AppuntiDocumento106 pagineDIRITTO TRIBUTARIO AppuntiMatteo CeredaNessuna valutazione finora
- Riassunto Diritto Amministrativo Scoca 23Documento335 pagineRiassunto Diritto Amministrativo Scoca 23Simone Demurtas100% (1)
- Diritto EcclesiasticoDocumento27 pagineDiritto Ecclesiasticoappuntigratis_unicamNessuna valutazione finora
- Manuale Diritto PenaleDocumento81 pagineManuale Diritto PenaleGiulia Casati BuscaNessuna valutazione finora
- Diritto Privato SchemiDocumento61 pagineDiritto Privato SchemiMagdalena GrudzińskaNessuna valutazione finora
- Procedura Civile - Luiso Libro 1Documento48 pagineProcedura Civile - Luiso Libro 1ebrtzNessuna valutazione finora
- Morbidelli Diritto Comparato Completo ConvertitoDocumento144 pagineMorbidelli Diritto Comparato Completo ConvertitoGiada ValdambriniNessuna valutazione finora
- Riassunto Diritto Penale Fiandaca MuscoDocumento183 pagineRiassunto Diritto Penale Fiandaca MuscoFederìca VìtoloNessuna valutazione finora
- Riassunto Diritto Penale Generale FioreDocumento164 pagineRiassunto Diritto Penale Generale FioreFrank Pellegrino100% (1)
- Le Obbligazioni BiancaDocumento110 pagineLe Obbligazioni BiancaCarrie1989bq50% (2)
- Diritto Commerciale Le SocietàDocumento94 pagineDiritto Commerciale Le Societàalteriuris100% (3)
- Compendio di DIRITTO REGIONALE e degli ENTI LOCALIDa EverandCompendio di DIRITTO REGIONALE e degli ENTI LOCALINessuna valutazione finora
- Esame avvocato 2020-21. CASI DI DIRITTO CIVILE: con soluzioni schematiche dimostrateDa EverandEsame avvocato 2020-21. CASI DI DIRITTO CIVILE: con soluzioni schematiche dimostrateNessuna valutazione finora
- Compendio di DIRITTO COMMERCIALE: Quarta edizioneDa EverandCompendio di DIRITTO COMMERCIALE: Quarta edizioneValutazione: 1 su 5 stelle1/5 (1)
- Faralli Le Grandi Correnti Della Filosofia Del DirittoDocumento12 pagineFaralli Le Grandi Correnti Della Filosofia Del DirittobennygattiNessuna valutazione finora
- Il Diritto Come LinguaggioDocumento24 pagineIl Diritto Come LinguaggioFederica Di ChioNessuna valutazione finora
- Alf Ross (1982) - Critica Del Diritto e Analisi Del LinguaggioDocumento128 pagineAlf Ross (1982) - Critica Del Diritto e Analisi Del LinguaggioEduardo GandulfoNessuna valutazione finora
- Agostino Il Diritto Naturale e La Fallacia NaturalisticaDocumento14 pagineAgostino Il Diritto Naturale e La Fallacia NaturalisticaOscar BeltránNessuna valutazione finora
- I Diritti Della PersonalitàDocumento16 pagineI Diritti Della PersonalitàclaudiaNessuna valutazione finora
- La Nuova Attività Della P.A. Tra Autorità e Consenso PDFDocumento22 pagineLa Nuova Attività Della P.A. Tra Autorità e Consenso PDFSebastiano ChighiniNessuna valutazione finora
- Luigi Ferrajoli Contro La Giurisprudenza CreativaDocumento20 pagineLuigi Ferrajoli Contro La Giurisprudenza CreativaHenry TuttleNessuna valutazione finora
- Analisi Del Sistema Canonico Di Giustizia AmministrativaDocumento41 pagineAnalisi Del Sistema Canonico Di Giustizia AmministrativaDudao da SilvaNessuna valutazione finora
- Diritto Penale Parte SpecialeDocumento237 pagineDiritto Penale Parte SpecialeTondozNessuna valutazione finora
- Riassunto Libro Lezioni Di Diritto AmministrativoDocumento58 pagineRiassunto Libro Lezioni Di Diritto AmministrativoViorel.sNessuna valutazione finora
- Manuale Teoria Generale Del Diritto (Completo)Documento33 pagineManuale Teoria Generale Del Diritto (Completo)Aurelia BadeaNessuna valutazione finora
- Dispense Di Istituzioni Di Diritto PubblicoDocumento72 pagineDispense Di Istituzioni Di Diritto Pubblicorafgraz90Nessuna valutazione finora
- Diritto Costituzionale, MartinesDocumento28 pagineDiritto Costituzionale, MartinesPiersilvio VisioliNessuna valutazione finora
- Manuale Di Diritto AgrarioDocumento66 pagineManuale Di Diritto AgrarioGuido Brandas100% (2)
- Appunti Diritto Privato 1Documento8 pagineAppunti Diritto Privato 1Laura Ramacciotti PicchiNessuna valutazione finora
- Checklist of ISO 9001 2015 Mandatory Documentation ITDocumento13 pagineChecklist of ISO 9001 2015 Mandatory Documentation ITgiorgioviNessuna valutazione finora
- DIRITTO INTERNAZIONALE RiassuntiDocumento5 pagineDIRITTO INTERNAZIONALE Riassuntialteriuris100% (4)
- GAZZONIDocumento145 pagineGAZZONIDavide GagliottiNessuna valutazione finora
- Riassunto Diritto Internazionale PrivatoDocumento30 pagineRiassunto Diritto Internazionale PrivatoLilith993100% (1)
- Dispensa Omaggio - Teorie Dell'Interpretazione Giuspositivismo, Ermeneutica Giuridica, NeocostituzionalismoDocumento30 pagineDispensa Omaggio - Teorie Dell'Interpretazione Giuspositivismo, Ermeneutica Giuridica, NeocostituzionalismoFrancesca IervolinoNessuna valutazione finora
- Diritto Tributario PollariDocumento94 pagineDiritto Tributario PollariLorenzo Castaldi100% (1)
- RAHNER KARL Pericoli Nel Cattolicesimo Di Oggi Alba 19511Documento54 pagineRAHNER KARL Pericoli Nel Cattolicesimo Di Oggi Alba 19511Urbán JózsefNessuna valutazione finora
- Lettera Al Dirigente Scolastico Di Non Adesione Al Cosiddetto "Patto Di Corresponsabilità"Documento2 pagineLettera Al Dirigente Scolastico Di Non Adesione Al Cosiddetto "Patto Di Corresponsabilità"Stefano Carmine ChiarellaNessuna valutazione finora
- Dispense Diritto Amministrativo PDFDocumento70 pagineDispense Diritto Amministrativo PDFAnnarita ParenteNessuna valutazione finora
- 1) La Norma GiuridicaDocumento2 pagine1) La Norma GiuridicaStefania Cardea ✩Nessuna valutazione finora
- Logica e Metodologia GiuridicaDocumento313 pagineLogica e Metodologia GiuridicaEmanuele MediatoreNessuna valutazione finora
- Schemi Schede Di Istituzioni Di Diritto Privato Parte1Documento72 pagineSchemi Schede Di Istituzioni Di Diritto Privato Parte1Weiwei ChenNessuna valutazione finora
- Berti - Il Metodo Della Filosofia Pratica Secondo AristoteleDocumento13 pagineBerti - Il Metodo Della Filosofia Pratica Secondo AristoteleCletto ArrighiNessuna valutazione finora
- Paolo Virno - Upotreba ŽivotaDocumento18 paginePaolo Virno - Upotreba ŽivotaPetar MilatNessuna valutazione finora
- Cei 20-34-1-1Documento24 pagineCei 20-34-1-1Franco FranchiNessuna valutazione finora