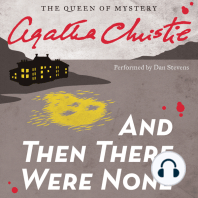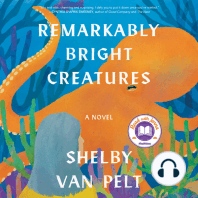Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
Aaa PDF
Caricato da
Antonio Joestar Brando PellegrinoTitolo originale
Copyright
Formati disponibili
Condividi questo documento
Condividi o incorpora il documento
Hai trovato utile questo documento?
Questo contenuto è inappropriato?
Segnala questo documentoCopyright:
Formati disponibili
Aaa PDF
Caricato da
Antonio Joestar Brando PellegrinoCopyright:
Formati disponibili
CAPITOLO 3 IL MERCATO DEI BENI IN ECONOMIA CHIUSA
mercoled 14 settembre 2016 20:33
Per capire cosa determina la domanda di beni occorre scomporre la produzione aggregata dal
punto di vista dei beni prodotti e dal punto di vista del tipo di consumatori.
La composizione della produzione aggregata in genere e
Consumo ( C ): Beni e servizi acquistati dai consumatori. Pane, biglietti aerei etc..
Investimento (I): chiamato anche investimento FISSO, Esso e la somma dell'investimento
non residenziale - impianti, computer, macchinari, etc- da parte delle imprese, e
dall'investimento residenziale -case, appartamenti, etc..- da parte degli individui. In
entrambi i casi la decisione di acquistare dipende dai servizi che questi beni renderanno in
futuro.
Spesa Pubblica in beni e servizi (G): Beni acquistati dallo stato o da enti pubblici -aeroplani,
cancelleria, stipendi, etc- G non include i trasferimenti come l'assistenza sanitaria,
pensioni, interessi sul debito pubblico, anche se esse sono spese statali.
LA SOMMA DELLE PRIME TRE VOCI RAPPRESENTA LA SPESA IN BENI E SERVIZI DA PARTE
DEI RESIDENTI. LA SPESA TOTALE IN BENI E SERVIZI NECESSITA DI ALTRE VOCI
Esportazioni nette (NX): Detto anche saldo commerciale. Esso si calcola come differenza
tra
Esportazioni (X): Beni Nazionali acquistati all'estero
Importazioni (IM): Beni esteri acquistati in nazione.
Investimento In scorte: Esso e la differenza tra la produzione e la vendita di beni e servizi.
Ci che non viene venduto rimane in magazzino per essere venduto in futuro. Ovviamente
se la produzione eccede le vendite le scorte aumentano viceversa diminuiscono.
La domanda di beni
Indichiamo con Z la domanda di beni rappresentata dall'equazione Z= C+I+G+X-IM poie
consideriamo l'investimento in scorte nullo(ossia uguale a zero). Dobbiamo ora introdurre delle
semplificazioni fondamentali
Tutte le imprese producono in solo bene usato indifferentemente da consumatori imprese
ed enti pubblici . In questo modo si studia un solo mercato.
Assumiamo che le imprese siano disposte a fornire qualsiasi quantit del bene ad un dato
prezzo. Questa ipotesi ci permette di focalizzarci sul ruolo della domanda.
Assumiamo che l'economia sia chiusa e quindi che X=IM=0 d quindi l'equazione della
domanda aggregata diventa
Z= C+I+G
IL CONSUMO (C )
Dipende dal reddito disponibile Yd che il reddito Y al netto delle imposte T, T indica le imposte
al netto dei trasferimenti ricevi dal governo; quindi
YD= Y-T
Con il consumo trascrivibile come funzione del reddito disponibile
C=C(YD)
+
Tale equazione viene chiamata funzione del consumo il segno + sotto ad Yd indica che
all'aumentare del reddito disponibile Yd anche i consumi aumentano. Tuttavia necessario
utilizzare la formula funzionale del consumo
C=C0 +C1YD
Stiamo assumendo che la funzione sia lineare.
C1 chiamato propensione al consumo ed esprime l'effetto, sul consumo, di un euro di
reddito in pi disponibile Se c1 =0,6 allora un euro in pi di reddito disponibile aumenta il
consumo di 60 centesimi. 0<C1 <1 Il significato di tale valore che i consumatori vogliono
risparmiare, pro futuro, una quota di reddito.
C0 Rappresenta il consumo desiderato quando il reddito disponibile Nullo. La gente
dovr pur mangiare! Se Yd=0 allora C=C0. Il consumo quindi anche in questa situazione
positivo, questo perch si ipotizza che per sopravvivere i consumatori attingano al prestito
o ai risparmi.
L'equazione del consumo, tenendo conto di tutto ci che abbiamo detto sar
C= C0 + C1 (Y-T)
Il consumo una funzione del reddito disponibile che dipende dal reddito e dalle imposte. Un
reddito pi elevato aumenta il consumo ma meno che proporzionalmente. Imposte pi elevate
diminuiscono il consumo ma meno che proporzionalmente.
BREVE PERIODO Pagina 1
INVESTIMENTO (I)
L'investimento una variabile esogena cio che non viene quindi spiegata all'interno del
modello. Questa variabile data. E quindi
I=
In questo capitolo l'investimento considerato esogeno per semplicit ma pi avanti
elimineremo questa semplificazione.
SPESA PUBBLICA (G)
G e T descrivono la politica FISCALE del governo e quindi le scelte relative alle entrate ed alle
uscite dello stato. Insieme alle imposte (T) anche la spesa pubblica esogena. Questo perch
Il governo non ha comportamenti regolari come i consumatori anche se molte delle sue
scelte sono prevedibili e pi avanti lo vedremo.
Il compito dei macroeconomisti consigliare il governo nelle sue scelte. Quindi noi
dovremo sapere le conseguenze di vari livelli di G e T. In virt di questo non spiegheremo
l'andamento di queste due variabili ed assumeremo che siano variabili di scelta del
governo.
LA PRODUZIONE DI EQUILIBRIO SUL MERCATO DEI
BENI IN ECONOMIA CHIUSA
Mettendo insieme tutte le relazioni fin qui studiate e sostituendole nell'equazione della
domanda di beni otteniamo
Z=C0 + C1 (Y-T) + I + G
La domanda di beni dipende positivamente dal reddito e negativamente dal livello delle
imposte. Le imposte inoltre dipendono positivamente dalla spesa pubblica e dall'investimento.
Detto cio, dai nostri studi di microeconomia sappiamo che la condizione di equilibrio dei mercati
e che la domanda deve essere uguale all'offerta(produzione), se indichiamo con Y la produzione,
avremo che in equilibrio i mercati avranno
Y=Z
Se ci fosse investimento in scorte, e quindi le scorte fossero positive, avremo che la produzione
potrebbe non essere, necessariamente, uguale alla domanda. Le aziende potrebbero attingere
alle scorte effettuando cosi degli investimenti negativi in scorte. Possono anche rispondere a cali
della domanda aumentando le scorte. Noi ora ipotizzeremo che l'investimento in scorte sia nullo
e quindi vale la relazione appena presentata. In equilibrio, considerando quanto detto sopra
otteniamo
Y=C0 + C1 (Y-T) + I + G
In equilibrio la produzione e uguale alla domanda che a sua volta dipende dal reddito Y che e
uguale alla produzione. Il motivo per cui Y indica sia la produzione che il reddito e che essi sono
due modi equivalenti di guardare al PIL e quindi sono identici. Vediamo ora che cosa succede se
varia una delle componenti del modello
Il termine (C0 + I + G - C1T ) rappresenta la spesa autonoma ossia quella parte della domanda che
non dipende dal livello della produzione. E molto probabile che la spesa autonoma sia positiva
poiche solo le imposte T sono negative. L'unico modo che la spesa autonoma avrebbe per essere
negativo e che le imposte sono insolitamente negative tanto da compensare gli effetti delle altre
variabili. Un altro caso e quello in cui T=G se C1 < 1 allora G-C1T e positivo e quindi anche la
domanda autonoma.
Il Termine 1/(1-C1) viene detto moltiplicatore della spesa autonoma, ricordando che 0<C1<1,
allora il moltiplicatore e un numero maggiore di 1. Il moltiplicatore moltiplica l'effetto delle
variazioni della spesa autonoma. Se esso e pari a 2,5 e c' stato un aumento della spesa
autonoma di un MLD, l'effetto complessivo sul mercato sara di 2,5 MLD, a prescindere di quale
componente della spesa autonoma vari. Per stabilire quale sia la variazione, se ipotizziamo che a
mutare sia la spesa pubblica, allora tale variazione sara
^Y=(1/(1-C1) )^G con ^= Delta
Equivalentemente questo escamotage puo essere utilizzato per studiare le variazioni delle altre
componenti. Da cosa deriva l'effetto del moltiplicatore? Un aumento di C0 fa aumentare Z e
quindi Z genera aumenti di Y. Tali aumenti portano ad aumenti del reddito di pari misura che a
sua volta aumenta C che aumenta Z e cosi via fino a quando non si stabilizza.
BREVE PERIODO Pagina 2
La domanda dipende dalla SA e dal Reddito attraverso il suo effetto sul consumo. La relazione
tra Z e Y e rappresentata dalla ZZ. L'intercetta sull'asse verticale e esattamente pari alla SA ed e il
valore della domanda quando il reddito e pari a zero. L'inclinazione invece e pari alla
propensione al consumo C1. Quando il reddito aumenta di 1 la domanda aumenta di C1. La retta
e inclinata positivamente in virtu delle caratteristiche di C1 che e minore di 1 ma positivo. Anche
la retta ZZ avra pendenza inferiore ad 1.
L'equilibrio si trova all'intersezione della ZZ con la retta a 45 gradi cioe nel punto A. Alla sinistra
di A, Z>Y. Variazioni della spesa autonoma generano traslazioni della ZZ
Che spostano l'equilibrio dal Punto A al punto A'. Studiamo il meccanismo di un aumento di C0
A seguito di questo aumento i consumatori aumentano la spesa C di un ammontare pari alla
variazione di C0. A questo punto, per ogni valore del reddito Z e piu alto di un ammontare pari
alla variazione. La domanda e ora rappresentata dalla ZZ', curva parallela alla ZZ ma piu alto di
^C0. La Produzione di equilibrio aumenta da Y ad Y' e possiamo notare che questo incremento
Si ricordi che ^ = DELTA
^Y>^C0 proprio per l'effetto del moltiplicatore. Sul grafico si hanno questi passaggi
1. Si passa da A a B dove B rappresenta livelli maggiori di Y e Z a parita del reddito
2. Le imprese dato che Z>Y aumentano la produzione per soddisfare la domanda, a sua volta
aumenta il reddito e ci spostiamo nel punto C
3. A sua volta un aumento del reddito genera aumenti di Z e ci spostiamo nel punto D
4. In D la produzione aumenta come sopra ed il tutto finisce finche arriviamo in A'
Y dipende da Z che a sua volta dipende dal reddito che e uguale ad Y. Incrementi di Z (per
esempio per G) fa aumentare produzione e reddito. L'aumento del reddito a sua volta fa
aumentare Z e quindi la produzione e cosi via. Alla fine il risultato e un aumento della
produzione superiore all'aumento della variabile che e mutata (abbiamo ipotizzato fosse G). Tale
BREVE PERIODO Pagina 3
produzione superiore all'aumento della variabile che e mutata (abbiamo ipotizzato fosse G). Tale
valore extra dipende dal moltiplicatore a sua volta influenzato dalla propensione al consumo.
Tanto maggiore e la propensione, tanto maggiore e il moltiplicatore.
L'aggiustamento viene analizzato in fasi per semplificare la comprensione, questo meccanismo
''accademicamente'' avviene immediatamente tuttavia ci non rispecchia la realt poich le
aziende potrebbero ad esempio non aggiustare la produzione in risposta ad aumenti della
domanda perche questi possono essere momentanei, allo stesso modo un lavoratore che vede
aumentare il proprio salario, potrebbe decidere di risparmiare il denaro oppure di investire in
titoli. La durata dell'aggiustamento dipende da molti fattori ma in modo importante, da quanto
in fretta le aziende rivedono i loro piani di produzione. Maggiore frequenza implica maggiore
velocita di aggiustamento.
UN MODO ALTERNTIVO DI VEDERE L'EQUILIBRIO
Possiamo vedere l'equilibrio anche dal punto di vista del risparmio e dell'investimento
Per definizione il risparmio privato e
S=Yd-C ossia S= Y-T-C
Cioe esattamente quanto rimane del reddito al netto di consumi ed imposte. Il risparmio privato
riguarda i consumatori, per intenderci si riferisce appunto ai privati, famiglie, persone etc
Il risparmio pubblico invece e dato da T-G poiche lo stato guadagna tramite le imposte e spende
tramite la spesa pubblica. Il risparmio e quindi tale differenza. Se le imposte eccedono la spesa si
parla di avanzo di bilancio, viceversa di disavanzo di bilancio. L'equazione nel mercato dei beni
Y=C+I+G
puo essere riscritta come
Y-T-C=I+G-T
Abbiamo quindi che in equilibrio
S=I+(G-T)
O equivalentemente
I=S+(T-G)
Il lato sinistro e l'investimento mentre il destro e il risparmio nazionale. Affinch il mercato sia in
equilibrio l'investimento deve essere uguale al risparmio nazionale. In equilibrio tutte le
decisioni di risparmio devono essere compatibili.
Tuttavia questo modo di vedere il mercato e equivalente a quello precedente, una volta deciso
quanto consumare il risparmio viene determinato per differenza e viceversa.
Ricordiamo
S=Y-T-C
Ma C puo essere riscritto
S= Y-T-C0 - C1(Y-T)
E quindi riordinando i termini
S= -C0+(1-C1)(Y-T)
Qui(1- C1) e la propensione marginale al risparmio e ci dice quanta parte di un incremento
unitario di reddito viene risparmiata. La propensione al risparmio e anch'essa compresa tra 0 ed
1 in virt di quanto detto e quindi C1 e compreso tra zero ed uno quindi il risparmio privato
aumenta all'aumentare del reddito disponibile ma meno che proporzionalmente.
OFF TOPIC
Risolvendo per la produzione otteniamo
In virtu di quanto detto tale relazione viene detta curva IS
BREVE PERIODO Pagina 4
Potrebbero piacerti anche
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeDa EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeValutazione: 4.5 su 5 stelle4.5/5 (20015)
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeDa EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeValutazione: 4 su 5 stelle4/5 (5794)
- The 7 Habits of Highly Effective People: The Infographics EditionDa EverandThe 7 Habits of Highly Effective People: The Infographics EditionValutazione: 4 su 5 stelle4/5 (2475)
- Art of War: The Definitive Interpretation of Sun Tzu's Classic Book of StrategyDa EverandArt of War: The Definitive Interpretation of Sun Tzu's Classic Book of StrategyValutazione: 4 su 5 stelle4/5 (3321)
- Habit 1 Be Proactive: The Habit of ChoiceDa EverandHabit 1 Be Proactive: The Habit of ChoiceValutazione: 4 su 5 stelle4/5 (2556)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItDa EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItValutazione: 4.5 su 5 stelle4.5/5 (3275)
- American Gods: The Tenth Anniversary EditionDa EverandAmerican Gods: The Tenth Anniversary EditionValutazione: 4 su 5 stelle4/5 (12945)
- Habit 3 Put First Things First: The Habit of Integrity and ExecutionDa EverandHabit 3 Put First Things First: The Habit of Integrity and ExecutionValutazione: 4 su 5 stelle4/5 (2507)
- The 7 Habits of Highly Effective PeopleDa EverandThe 7 Habits of Highly Effective PeopleValutazione: 4 su 5 stelle4/5 (2566)
- Pride and Prejudice: Bestsellers and famous BooksDa EverandPride and Prejudice: Bestsellers and famous BooksValutazione: 4.5 su 5 stelle4.5/5 (19653)
- Habit 6 Synergize: The Habit of Creative CooperationDa EverandHabit 6 Synergize: The Habit of Creative CooperationValutazione: 4 su 5 stelle4/5 (2499)
- How To Win Friends And Influence PeopleDa EverandHow To Win Friends And Influence PeopleValutazione: 4.5 su 5 stelle4.5/5 (6520)
- The 7 Habits of Highly Effective PeopleDa EverandThe 7 Habits of Highly Effective PeopleValutazione: 4 su 5 stelle4/5 (353)
- The Iliad: A New Translation by Caroline AlexanderDa EverandThe Iliad: A New Translation by Caroline AlexanderValutazione: 4 su 5 stelle4/5 (5718)
- Remarkably Bright Creatures: A NovelDa EverandRemarkably Bright Creatures: A NovelValutazione: 4.5 su 5 stelle4.5/5 (5484)
- The Perfect Marriage: A Completely Gripping Psychological SuspenseDa EverandThe Perfect Marriage: A Completely Gripping Psychological SuspenseValutazione: 4 su 5 stelle4/5 (1107)
- Wuthering Heights (Seasons Edition -- Winter)Da EverandWuthering Heights (Seasons Edition -- Winter)Valutazione: 4 su 5 stelle4/5 (9486)
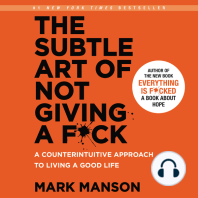
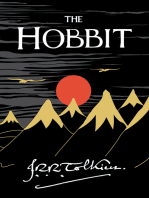
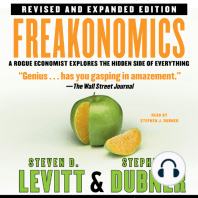
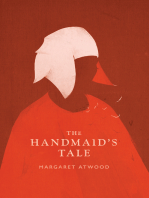
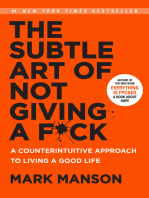



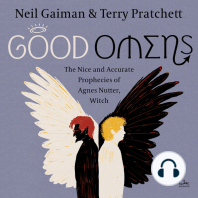





![American Gods [TV Tie-In]: A Novel](https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/audiobook_square_badge/626321117/198x198/22ab6b48b6/1712683119?v=1)