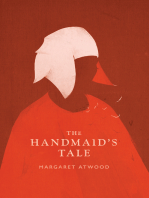Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
Le Funzioni Della Provincia Di Torino Nella Transizione Verso La Città Metropolitana
Caricato da
Marco Orlando0 valutazioniIl 0% ha trovato utile questo documento (0 voti)
155 visualizzazioni65 pagineRicognizione analitica delle funzioni amministrative della Provincia di Torino, in funzione della transizione alla Città Metropolitana.
Documento approvato dal Consiglio Provinciale di Torino nell'adunanza del 25/6/2014.
Titolo originale
Le Funzioni della Provincia di Torino nella Transizione verso la Città Metropolitana
Copyright
© © All Rights Reserved
Formati disponibili
PDF, TXT o leggi online da Scribd
Condividi questo documento
Condividi o incorpora il documento
Hai trovato utile questo documento?
Questo contenuto è inappropriato?
Segnala questo documentoRicognizione analitica delle funzioni amministrative della Provincia di Torino, in funzione della transizione alla Città Metropolitana.
Documento approvato dal Consiglio Provinciale di Torino nell'adunanza del 25/6/2014.
Copyright:
© All Rights Reserved
Formati disponibili
Scarica in formato PDF, TXT o leggi online su Scribd
0 valutazioniIl 0% ha trovato utile questo documento (0 voti)
155 visualizzazioni65 pagineLe Funzioni Della Provincia Di Torino Nella Transizione Verso La Città Metropolitana
Caricato da
Marco OrlandoRicognizione analitica delle funzioni amministrative della Provincia di Torino, in funzione della transizione alla Città Metropolitana.
Documento approvato dal Consiglio Provinciale di Torino nell'adunanza del 25/6/2014.
Copyright:
© All Rights Reserved
Formati disponibili
Scarica in formato PDF, TXT o leggi online su Scribd
Sei sulla pagina 1di 65
1
CONSIGLIO PROVINCIALE DI TORINO
Le funzioni della Provincia di Torino
nella transizione verso la Citt Metropolitana
Torino, 25 giugno 2014
2
Il documento raccoglie le risultanze delle audizioni
realizzate nel 2014 dalle Commissioni Permanenti del Consiglio Provinciale,
con il supporto della Direzione Area Relazioni e Comunicazione,
Ufficio Studi e Ricerche sul Federalismo e le Riforme Amministrative
3
1. Il nuovo rapporto tra il governo di prossimit e il governo di area vasta, nella
transizione dalla Provincia di Torino alla Citt Metropolitana
La legge 7 aprile 2014, n. 56, Disposizioni sulle citt metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di
comuni ha riordinato in modo formale e sostanziale la disciplina statale sulle Province in concomitanza con
listituzione delle Citt metropolitane come nuovi enti di governo delle grandi aree urbane.
Per gli aspetti relativi alla forma di governo e allassetto funzionale, gli enti di area vasta sono stati trasformati
da enti eletti direttamente dai cittadini con distinte funzioni amministrative ad enti di secondo livello che
saranno legati da un rapporto di stretta interdipendenza con i Comuni delle loro circoscrizioni territoriali.
I primi segnali concreti del nuovo rapporto fra i due livelli di governo saranno visibili in occasione del rinnovo
dei consigli provinciali e dellistituzione del consiglio metropolitano, quali nuovi organi di indirizzo politico e di
controllo. In tale occasione, la particolare composizione del corpo elettorale attivo e passivo (sindaci e
consiglieri comunali) e, nondimeno, lattribuzione ai titolari del diritto di elettorato attivo di un voto diseguale e
ponderato in funzione della popolazione rappresentata, provocheranno la ricostituzione dellindirizzo
politico a partire dalle esigenze dei territori e, solo in via mediata, delle rispettive popolazioni
rappresentate. Il nuovo indirizzo politico degli enti di area vasta sar quindi direttamente correlato e
dipendente dai processi di mediazione e composizione dei diversi interessi dai Comuni, che come noto sono
deputati al governo delle cd. politiche di prossimit.
Questo fenomeno sar visibile in modo particolare in un territorio come quello della Provincia di Torino, che
avviata a seguito della legge alla transizione verso la Citt Metropolitana. Come ben noto, infatti, la nostra
Provincia ha caratteristiche uniche in Italia. Essa si estende su una superficie di 6.830,25 kmq, cio pi di un
quarto dellintero Piemonte. E collocata allestremo ovest nella parte alta della Pianura Padana e contiene in
s il lembo pi occidentale dellItalia peninsulare. Lestremo orientale della Provincia sul Po, al confine con le
province di Vercelli e Alessandria. Lestremo settentrionale al confine con la Valle dAosta, per una
estensione tra i meridiani estremi (ovest-est) di circa 116 Km, e tra i paralleli (sud nord), di circa 98 km.
Sia dal punto di vista morfologico che da quello socio-economico, il territorio provinciale fortemente
diversificato, con corrispondenti differenti livelli di antropizzazione, che sono rilevabili anche dalla distribuzione
della densit demografica. C una forte concentrazione delle attivit della pianura e nei fondovalle e con radi
insediamenti alpini, sempre meno abitati.
In un territorio disomogeneo, lintervento dellente di governo dellarea vasta strategico e non
sostituibile. Basti pensare agli interventi realizzati dalla Provincia a favore del contenimento in termini
occupazionali degli effetti della crisi economica, oppure al coinvolgimento dellente su tematiche in materia di
sicurezza sociale, delle infrastrutture viarie, scolastiche e patrimoniali, pur in un equilibrio reso alquanto
difficile dai noti vincoli finanziari imposti al governo locale nellultimo quinquennio.
Basti pensare, altrettanto, al ruolo svolto nei servizi pubblici locali di tipo ambientale, ad esempio nella
programmazione e gestione del ciclo idrico integrato e del ciclo dei rifiuti, dalla promozione della raccolta
differenziata alla realizzazione degli impianti, o al ruolo di riequilibrio tra capoluogo e territori periferici nella
gestione del trasporto pubblico locale.
Lente di area vasta concorre quindi a salvaguardare e sostenere il riferimento locale ai problemi del territorio
e della comunit, in un orizzonte economico nazionale che si aggravato: la possibilit delle imprese nazionali
e locali di operare sui mercati internazionali diminuita; serpeggia una costante crisi di fiducia tra le famiglie e
le imprese con conseguenti ripercussioni negative sugli investimenti e sui consumi.
E inevitabile che tali temi abbiano profonde ripercussioni sul nostro territorio: il processo di ammodernamento
e di evoluzione degli enti locali nei rapporti con i cittadini e le imprese, che hanno impegnato con ottimi risultati
la Provincia, la Citt di Torino e tutti gli enti locali, soprattutto durante il periodo olimpico, risulta attenuato dalla
4
incertezza generale. I vincoli - seppur sotto taluni aspetti positivi derivanti dalla partecipazione dellItalia
allUnione Europea - determinano difficolt di gestione; lindustria, che anche dai dati piemontesi appare
essersi fortemente indebolita negli ultimi anni, ha trovato anche nelle iniziative regionali e del governo il
sostegno necessario a garantirne una continuit.
E la tendenza dei prossimi anni non sar certamente orientata alla crescita delle risorse a disposizione di
Comuni e Province, a causa del Patto di Stabilit interno e della difficolt crescente ad operare con la
tassazione locale, che impatta direttamente sulla domanda interna.
In questa logica, accanto alla pressione per interventi di riequilibrio, di coesione territoriale e per la ripresa
seria di una concertazione istituzionale che non riguardi solo il rapporto fra lo Stato e le Regioni, occorre
introdurre approcci finora implementati solo in piccola parte: ragionare seriamente a proposito di un rapido
recupero di produttivit dei servizi pubblici, di unorganizzazione del territorio strutturalmente orientata a
mantenere sotto controllo i costi di questi servizi, di un apporto maggiore dei privati alla costruzione e gestione
di opere di interesse collettivo, nellambito di nuove forme di copertura finanziaria.
Su tutti questi fronti, difficile sostenere che non vi siano margini anche cospicui di recupero di efficienza dei
sistemi locali, che potrebbero essere resi pi consistenti se perseguiti come effetto di una strategia
complessiva che si incardina su uno snodo politico: la piena valorizzazione del ruolo dei servizi pubblici
nel determinare la qualit della vita e, allo stesso tempo, la convinzione che ad essi opportuno tornare a
guardare in unottica industriale.
Di qui la centralit delle competenze specifiche della Citt Metropolitana nella gestione coordinata dei servizi
pubblici, tra cui i servizi ambientali, nei quali il fondamentale ruolo di regolazione a fronte della gestione da
parte delle societ pubbliche o private pu essere svolto dallente pubblico di area vasta. Se con la Provincia il
ruolo di regolazione poteva essere maggiormente rivendicato dai comuni, la stretta derivazione della Citt
metropolitana dai governi comunali potrebbe accentuare il citato ruolo di regolazione.
Un ente di area vasta che sia consapevole della complessit e variet del suo territorio deve continuare, come
ha fatto la Provincia, a favorire la maturazione di identit locali dotate di un proprio convincente indirizzo di
sviluppo economico e sociale. Per questo aspetto, la trasformazione istituzionale in Citt Metropolitana e la
sua particolare forma di governo a rappresentativit indiretta potranno agevolare ulteriormente la definizione di
un rapporto paritario tra la conurbazione e le valli, capace di evitare atteggiamenti passivi e orientati
sostanzialmente a gestire uneconomia locale assistita e dipendente dai contributi degli enti maggiori, o dai
territori economicamente pi competitivi.
Sotto questo profilo, la soddisfacente attivit volta alla perequazione territoriale che la Provincia di Torino ha
garantito negli anni deve per fronteggiare alcune difficolt di ridefinizione alla luce della prolungata
stagnazione economica. In particolare nelle aree pi prossime a Torino, dove cio lattivit di concertazione
territoriale ed economica stata particolarmente intensa e si sviluppata in sintonia con il recupero di
identit culturali e storiche precise, il problema urgente acquisire i cambiamenti intervenuti nel contesto
economico competitivo mondiale e darvi risposta. Occorre quindi ridiscutere la scala territoriale pi idonea
per costruire iniziative capaci di fronteggiare in modo intelligente questi fenomeni, dal punto di vista
dellintegrazione tra imprese, dellaccesso al credito, delle strutture in grado di permettere lingresso in nuovi
mercati. Occorre, altrettanto, superare la logica della competizione sulle risorse derivate, per individuare
nuove forme di cooperazione.
Da questo punto di vista, la Citt Metropolitana dovr risolvere una volta per tutte il rapporto fra le aree pi
marginali e quelle pi dinamiche e reattive, poich comporter un processo di istituzionalizzazione delle
esternalit che permetter di far agire la composizione degli interessi in un consesso il Consiglio
metropolitano che fin dalla sua genesi elettorale rappresenter adeguatamente il differente peso di tali
interessi sul complesso dellarea vasta.
Gli strumenti e i tavoli di concertazione e programmazione che fin qui sono stati inseriti dentro il processo
democratico, ma in modo collaterale e complementare ad esso, saranno quindi pienamente istituzionalizzati
nel Consiglio metropolitano, pur con tutti i limiti che rappresenta. E anche il rapporto con la Regione
5
Piemonte dovr essere rinnovato, guardando allinvestimento di lungo termine che il legislatore della riforma
ha compiuto nei confronti delle conurbazioni metropolitane come motori della crescita del Paese.
Il tema non certamente nuovo, poich sul piano dellorganizzazione istituzionale, le correzioni introdotte dalla
seconda met degli anni novanta, dapprima attraverso la legislazione di primo grado, e poi tramite le revisioni
costituzionali, hanno modificato il tradizionale equilibrio dei rapporti tra la Regione, la Provincia, la Citt di
Torino, gli altri capoluoghi e linsieme delle amministrazioni locali.
Le Regioni non sono quindi pi paragonabili, come poteva avvenire negli anni ottanta, alle grandi citt
capoluogo che un tempo potevano in qualche modo condizionarle e bilanciarle. Esse dispongono oggi di
poteri e competenze ampie, su tematiche che investono direttamente lorganizzazione del territorio della citt e
delle zone limitrofe.
Daltra parte, il rafforzamento dei poteri delle Regioni apre a sua volta il capitolo dei rapporti tra esse e i
governi locali, con pi forza che in passato.
La dimensione metropolitana di Torino va collocata in questo contesto. La Provincia, per le sue competenze e
per la sua autorevolezza, ha potuto svolgere un ruolo diretto di primo piano, e contemporaneamente ha
saputo difendere le autonomie comunali quali espressioni democratiche pi direttamente soggette alla
verifica dei cittadini, definendo sedi per consentire la reale partecipazione delle amministrazioni comunali alla
costruzione dello sviluppo economico e sociale della comunit provinciale e alla soluzione dei problemi sovra-
comunali.
Un simile ruolo potr essere proseguito e valorizzato dalla Citt Metropolitana, che fortunatamente (dopo il
quarantennale dibattito sulla sua estensione ideale) nasce con gli identici confini dellattuale Provincia, ma con
una forma di governo e un assetto funzionale differenti.
Ci nonostante, si manifesta lesigenza che la Citt Metropolitana compia una scelta di fondo, riportando
allinterno di zone omogenee unitarie il florilegio di strumenti di concertazione territoriale attivati dalla
Provincia nel corso dei decenni e, allo stesso tempo, riorganizzando le proprie articolazioni di decentramento
dei servizi, in sintonia operativa con la nuova cartina della rappresentanza e della concertazione.
6
Per questo motivo, fin dalla definizione statutaria, si render necessario un approccio graduale alla
zonizzazione interna della Citt Metropolitana, che prima elabori un livello minimo di rappresentativit del
territorio capace di portare a sintesi le precedenti stagioni di concertazione, e poi trovi il giusto elemento di
innesco per avviare anche il decentramento delle proprie funzioni, utilizzando i nuovi strumenti di
cooperazione che la legge Delrio mette a disposizione, come le convenzioni di avvalimento/delega tra lente, i
comuni e le loro unioni.
Risulta gi evidente che una Citt Metropolitana di tali dimensioni e complessit richieder quindi due diverse
linee di azione strategica: da un lato, lintegrazione dei servizi nella conurbazione; dallaltro, il
decentramento dei servizi nelle zone esterne. Queste due linee interpretano esigenze territoriali
apparentemente antitetiche, ma la loro equilibrata combinazione permetter di mantenere alto il livello di
perequazione delle politiche e delle risorse, attribuendo al contempo alle esigenze di competitivit della
conurbazione il giusto e indispensabile peso allinterno delle decisioni concertate.
2. Le nuove funzioni fondamentali, caratterizzanti il governo di area vasta.
Linterdipendenza e la compenetrazione tra governo di prossimit e di area vasta rileveranno in modo
particolare per tutte quelle funzioni che oggi la Provincia esercita in modo sovrapponibile o complementare a
quelle esercitate dai comuni.
Dunque, uno dei primi temi che saranno allattenzione del governo della Citt Metropolitana la
ricomposizione delle competenze amministrative gestite dalla Provincia, in funzione degli elenchi delle funzioni
qualificate come fondamentali ai sensi dellart. 117, secondo comma, lett. p) della Costituzione per le
province e le citt metropolitane (dalla legge 56/2014) e per i comuni (dalla legge 135/2012, di
conversione del D.L. 95/2012, cd. spending review).
I due elenchi risiedono in due atti normativi differenti e temporalmente non allineati, che tuttavia appartengono
alla medesima stagione di adeguamento della legislazione ordinaria alla revisione del Titolo V del 2003.
Peraltro, la ragione del disallineamento temporale dei due cataloghi risiede, come ben noto, nella
dichiarazione di incostituzionalit operata dalla sentenza n. 220/2013 della Corte Costituzionale del catalogo di
funzioni fondamentali gi stabilito per le province e le citt metropolitane dal medesimo D.L. spending
review. Una sentenza che, bene ricordarlo, stata anche per questo aspetto la principale causa di avvio del
processo di riforma che si concluso con lapprovazione della legge 56/2014.
Quale che sia stato il percorso, oggi ciascuno dei due livelli di governo ha attribuite dallo Stato un nucleo di
funzioni fondamentali che ne caratterizzano la specificit. Esse sono, rispettivamente:
Organizzazione dei servizi pubblici
Pianificazione urbanistica ed edilizia
Protezione Civile
Rifiuti
Servizi Sociali
Edilizia Scolastica (1 grado)
Polizia locale
Stato civile, anagrafe, elettorale e statistica
C CO OM MU UN NI I P PR RO OV VI IN NC CE E
Pianificazione territoriale
Ambiente
Trasporti
Viabilit
Programmazione della rete scolastica ed edilizia
(2 grado)
Raccolta ed elaborazione di dati
Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali
Controllo dei fenomeni discriminatori in ambito
occupazionale
Pari opportunit
7
Per completezza bene citare che, d'intesa con i comuni interessati, la Citt Metropolitana o la Provincia potr
esercitare anche le funzioni di: predisposizione dei documenti di gara, stazione appaltante, monitoraggio dei
contratti di servizio, organizzazione di concorsi e procedure selettive.
Fin qui il catalogo delle nuove funzioni fondamentali. E a tutti noto, per, che nellattuale competenza della
Provincia esiste un insieme di funzioni ulteriori e proprie fissato dal Testo Unico Enti Locali, nonch un
terzo insieme di funzioni amministrative che la legislazione statale e regionale di decentramento
amministrativo della fine degli anni 90 hanno conferito ai comuni e alle province secondo i principi e i criteri
interpretativi del principio di sussidiariet stabiliti dagli artt. 3 e 4 della legge 59/1997.
Su questo triplice insieme di funzioni (fondamentali, proprie, conferite) si deve misurare limpatto della riforma
Delrio per le province e, in particolare, per la Citt metropolitana di Torino.
La prima considerazione che opportuno fare a riguardo che le novit introdotte dalla legge 56/14, in
particolare per le Citt Metropolitane, disegnano uno scenario che ben lontano dallidea di un possibile
svuotamento delle funzioni amministrative che oggi sono gestite dalla Provincia di Torino.
La legge Delrio, infatti, non solo rinnova il catalogo di funzioni fondamentali (sia nel numero che nel significato)
ma affida allo Stato e alle Regioni il compito di legiferare per superare i fenomeni di neocentralismo regionale
che, in alcune parti del Paese, si sono determinati con la riforma di fine anni 90, e quindi riordinare tutta la
pubblica amministrazione valorizzando il ruolo delle autonomie locali.
A diretta testimonianza di questa intenzione del legislatore, valga citare le norme della legge 56 che premiano
le Regioni che provvederanno al riordino e alla soppressione di tutte le agenzie ed organismi infra-
regionali che oggi esercitano le nuove funzioni fondamentali assegnate alle Citt Metropolitane e alle nuove
Province, secondo i criteri che dovranno essere sanciti allinterno del previsto Accordo da raggiungere in
Conferenza Unificata il prossimo 8 luglio.
Si richiamano, per questo aspetto, le possibili ed auspicabili evoluzioni degli ambiti territoriali ottimali (Ato) a
fronte della nascita della Citt Metropolitana, di concerto con le modifiche legislative che la Regione ha
apportato in alcuni di questi settori e potr apportare in altri.
E va altrettanto ricordato che questa disposizione corrisponde in realt a una delle finalit principali
dellintervento riformatore: restituire centralit di ruolo agli enti locali, e in particolare ai comuni,
permettendo alla classe politica degli amministratori comunali di organizzare le funzioni di area vasta in modo
elastico, differenziato e rispondente alle specifiche esigenze di mediazione e composizione degli interessi
territoriali.
C CI IT TT TA A M ME ET TR RO OP PO OL LI IT TA AN NE E
Tutte le funzioni delle Province
Pianificazione strategica e generale (reti,
infrastrutture)
Gestione coordinata dei servizi pubblici
Mobilit, viabilit e coordinamento della
pianificazione urbanistica
Sviluppo economico e sociale
Informatizzazione e digitalizzazione
8
Alla luce di un simile scenario di ricostruzione della funzionalit del governo di area vasta, il Consiglio
provinciale di Torino ha ritenuto necessario disporre un completo monitoraggio delle attuali funzioni svolte
dalla Provincia, sia su titolo di attribuzione statale che su conferimento regionale. Il censimento delle funzioni
ha avuto il precipuo scopo di individuare gli ambiti funzionali che possono rientrare nel novero delle nuove
funzioni fondamentali e quelli che, invece, potranno essere oggetto di riordino.
Sebbene la legge 56/2014 non offra un criterio ermeneutico di riconduzione delle attuali competenze alle
nuove funzioni fondamentali, del tutto evidente che nel nuovo catalogo si ritrovano molte delle funzioni o
delle attivit amministrative gi svolte oggi dalla Provincia. E, per altro verso, lelenco delle funzioni
fondamentali previsto nel comma 85 della stessa legge piuttosto eterogeneo: vi rientrano sia competenze
puntuali come, ad esempio, la pianificazione territoriale provinciale di coordinamento , sia funzioni
amministrative generali come ad esempio la tutela e valorizzazione dell'ambiente, nella quale rientrano
sicuramente diverse competenze oggi esercitate dalle Province definite come funzioni proprie.
Per questi aspetti, il censimento operato dalle Commissioni del Consiglio provinciale ha reso immediatamente
chiaro che la rinnovazione dellelenco delle funzioni fondamentali delle Province implica qualche
conseguenza di tipo interpretativo. Avviando il processo di riordino ai sensi dei commi da 89 a 92 della
legge 56, lo Stato e le Regioni dovranno infatti considerare che il ruolo delle Province stato riconfigurato in
modo da superare la classificazione per materie, funzioni e servizi che propria dellordinamento fin dalla
sistematica contenuta nel d.P.R: 616/77, e che stata puntualmente ribadita da tutta la legislazione statale e
regionale conseguente alla stagione di decentramento avviata dalla legge 59/1997.
Per evitare di compiere un improduttivo salto allindietro concettuale prima che giuridico, sar pertanto
necessario adeguare linterpretazione delle funzioni alla volont espressa dal legislatore della riforma. Lo
sforzo ermeneutico dovr seguire alcuni precisi assi concettuali, utili ad adeguare il significato delle nuove
funzioni alla finalit del legislatore.
Ad esempio, dovr essere rispettata - sia da parte dello Stato che della Regione - lattribuzione alle Province
delle diverse attivit amministrative riconducibili alle nuove funzioni fondamentali. In secondo luogo, come gi
accennato, sar necessario ricomporre in modo organico in capo alle Province tutte le competenze che
impropriamente sono esercitate da altri soggetti amministrativi e che invece rientrano nelle funzioni
fondamentali.
In terzo luogo, bisogner considerare leventuale trasferimento ad altri livelli di governo delle competenze
amministrative oggi svolte dalle Province e che non rientrino nelle loro funzioni fondamentali.
3. Le nuove funzioni fondamentali specifiche della Citt Metropolitana
Su un simile impianto, si innesta poi il tema delle nuove funzioni fondamentali specifiche della Citt
Metropolitana. Il tema presenta elementi di affinit rispetto alle nuove Province, pur considerando la diversa
intenzione di affermazione e di sviluppo che il legislatore ha espresso per gli enti di governo delle grandi aree
urbane del Paese.
Le affinit sono evidentemente contenute nel primo periodo del comma 44 della legge 56/2014, che qualifica
come fondamentali anche per le Citt Metropolitane tutte le funzioni fondamentali delle nuove Province. Le
ulteriori funzioni fondamentali descritte nelle lettere da a) ad f) del comma 44 rafforzano poi la visione di un
ruolo delle Citt Metropolitane come enti per il governo integrato delle grandi conurbazioni, sia dal punto di
vista della pianificazione strategica, sia dal punto di vista della regolazione dei servizi pubblici, delle reti e delle
infrastrutture strategiche locali
9
E pertanto evidente come uninterpretazione espansiva delle nuove funzioni fondamentali delle Province
possa giovare anche e soprattutto allo sviluppo delle Citt metropolitane. Ma lelemento realmente
differenziale della disciplina che la legge offre per le Citt Metropolitane rispetto alle Province, risiede
nellampiezza degli ambiti funzionali per esse individuati come funzioni fondamentali. Va infatti detto con forza
che le nuove funzioni fondamentali delle Citt Metropolitane non sono per nulla comparabili con le
corrispondenti funzioni oggi svolte dalle rispettive Province.
Per almeno quattro funzioni su sei (strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici;
pianificazione strategica triennale, pianificazione territoriale generale, promozione e coordinamento dello
sviluppo economico) non si tratta infatti di mere funzioni amministrative, ma di veri e propri ambiti di materia,
quindi di insiemi funzionali pi grandi nei quali devono confluire le funzioni come classificate dalle previgenti
leggi di decentramento statale e regionale, oltrech dal TUEL.
Non vi alternativa a una simile deduzione, poich accedendo a uninterpretazione riduttiva delle funzioni
fondamentali rispetto a quelle attualmente esercitate, leffetto paradossale sarebbe quello di far nascere
Citt Metropolitane pi deboli e meno dotate delle attuali Province. Alla luce di quanto esposto, si pu quindi
riclassificare in prima battuta il catalogo delle funzioni fondamentali delle Citt Metropolitane in quattro diverse
tipologie:
1. le funzioni fondamentali elencate nel comma 44, secondo periodo, lett. a) b) c) d) e) f);
2. le funzioni fondamentali che le Citt Metropolitane eserciteranno in qualit di enti che succedono alle
corrispondenti Province;
3. le funzioni attribuibili alle Citt Metropolitane nellambito del processo di riordino delle province, ai
sensi del comma 44, primo periodo;
4. le ulteriori funzioni attribuibili in qualsiasi momento alle Citt Metropolitane ai sensi dellart. 118 Cost,
come richiamato dal comma 46 della legge.
Lo sforzo ermeneutico gi proposto con riguardo alle nuove funzioni delle Province (comma 85) dovr essere
ancora pi intenso per la Citt Metropolitana, al fine di giungere a considerare lelenco di cui al comma 44
integralmente omnicomprensivo delle attuali funzioni svolte dalla Provincia di Torino.
Un esempio tra i pi significativi di tale reinterpretazione dovr riguardare il tema delle infrastrutture
strategiche della Citt Metropolitana. Come si vedr nel paragrafo dedicato allanalisi svolta dalle
Commissioni IV e V, sar necessario che il nuovo ente ribadisca la valenza strategica dei grandi progetti
infrastrutturali che la Provincia di Torino ha avviato negli scorsi mandati. Il Consiglio Metropolitano sar quindi
chiamato a compiere una valutazione di priorit sulla realizzazione di tali opere nellambito delle funzioni di
pianificazione strategica e generale del territorio, anche al fine di reperire le necessarie e ingenti risorse
finanziarie.
4. Il processo di riordino delle funzioni non fondamentali
Le considerazioni svolte sulle funzioni fondamentali della Citt metropolitana chiariscono il ruolo che lo Stato e
le Regioni dovranno avere nel processo di eventuale riattribuzione delle funzioni amministrative diverse dai
due cataloghi dei commi 44 e 85 della riforma
Come noto, dette funzioni dovranno essere individuate attraverso uno specifico accordo in Conferenza
unificata da concludersi entro l8 luglio 2014, secondo quanto stabilito dallart. 1, comma 91 della legge, sentite
le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
Il comma 89, infatti, prevede che lo Stato e le Regioni, secondo le rispettive competenze, attribuiscano le
funzioni provinciali diverse da quelle di cui al comma 85, fermo restando quanto disposto dal comma 88, in
10
attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, nonch al fine di conseguire lindividuazione dell'ambito
territoriale ottimale di esercizio per ciascuna funzione e lefficacia nello svolgimento delle funzioni fondamentali
da parte dei comuni e delle unioni di comuni, nonch la possibilit di favorire lesercizio associato delle
funzioni e la collaborazione tra pi enti in convenzione o attraverso intese.
Le funzioni che saranno trasferite continuano ad essere esercitate dalle Province fino alla data dell'effettivo
avvio di esercizio da parte dell'ente subentrante: tale data sar determinata dal decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui al comma 92 per le funzioni di competenza statale, ovvero sar stabilita dalle
Regioni ai sensi del comma 95 per le funzioni di competenza regionale.
Nel caso in cui disposizioni normative statali o regionali di settore riguardanti servizi di rilevanza economica
prevedano l'attribuzione di funzioni di organizzazione dei predetti servizi, di competenza comunale o
provinciale, ad enti o agenzie in ambito provinciale o sub-provinciale, il decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri di cui al comma 92 ovvero le leggi statali o regionali, secondo le rispettive competenze, dovranno
prevedere la soppressione di tali enti o agenzie e l'attribuzione delle funzioni alle province nel nuovo assetto
istituzionale.
Laccordo in Conferenza unificata previsto dal comma 91 assume quindi il valore giuridico di un accordo-
quadro, utile a individuare anzitutto il concreto perimetro delle funzioni fondamentali (comma 85) e, di
conseguenza, individuare le altre funzioni oggetto di possibile trasferimento. Sulla base di tale accordo-
quadro, lo Stato e le Regioni dovranno emanare gli atti di propria competenza, nel rispetto del riparto delle
competenze legislative previsto dalla Costituzione, in modo che le funzioni amministrative siano ricomposte in
modo organico sul livello di governo ritenuto adeguato.
Per questi aspetti, il monitoraggio delle funzioni esercitate dalla Provincia di Torino ha reso evidente che
lassetto delle attuali funzioni deriva da una concatenazione di esercizio della potest legislativa dello Stato e
della Regione, che si stratificata nei decenni passati.
Il fenomeno non da considerarsi patologico, poich era in realt previsto come normale meccanismo di
distribuzione delle competenze ai sensi degli artt. 3 e 4 della legge delega n. 59/1997, che aveva inaugurato
lultima stagione di decentramento amministrativo.
Tuttavia, lesercizio concatenato delle rispettive potest legislative dello Stato e delle Regioni ha determinato
anche delle sovrapposizioni di compiti, in virt delle quali le province hanno ricevuto in via diretta alcune
funzioni (o parti di esse) dallo Stato (secondo quanto era previsto dal vecchio art. 128 Cost.) e altre dalle
Regioni, in modo peraltro non omogeneo sul territorio nazionale. Inoltre, lesercizio della potest legislativa
avvenuto in gran parte antecedentemente alla riforma del Titolo V, cio negli anni dal 1997 al 2001, quindi in
modo non sempre coerente con le regole di distribuzione che poi sarebbero state previste nel nuovo art. 118
Cost.
Da ci deriva lattuale commistione di titoli di legittimazione e di fonti attributive delle competenze
provinciali, un nodo che oggi va sciolto e razionalizzato attraverso laccordo sul riordino previsto dal comma 91
della legge 56/2014.
Come ha chiarito la Corte costituzionale in pi occasioni, un accordo o unintesa in Conferenza unificata pu
precisare il perimetro delle funzioni fondamentali di cui allart. 117, secondo comma, lett. p) della Costituzione,
anche oltre lo stretto riparto di potest legislativa tra Stato e Regioni sulle singole materie. Da un lato,
pertanto innegabile che le Regioni abbiano potest legislativa (quantomeno concorrente) in alcune delle nuove
funzioni che la legge 56/2014 ha attribuito alle province e alle citt metropolitane, nonch in quelle che le
province esercitano attualmente ai sensi dellart. 118 Cost.
Lesercizio della potest legislativa regionale in tali materie potr essere utile a semplificarne la disciplina, e in
molti casi a razionalizzarne i relativi procedimenti amministrativi. Dallaltro lato, tuttavia, necessario affermare
nellAccordo che lesercizio della potest legislativa regionale non potr estendersi al punto di togliere o ridurre
alle province e alle citt metropolitane la titolarit o lesercizio delle funzioni, negli ambiti di materia che la
11
legge Delrio ha qualificato come fondamentali e che, anche per via interpretativa nellAccordo medesimo,
saranno riconosciute come funzioni caratterizzanti del governo di area vasta.
Come gi detto, la legge 56/14 introduce infine un rapporto di stretta interdipendenza politica e funzionale tra
le nuove Province e i Comuni, sulla gestione di attivit amministrative gi fortemente legate sul piano
gestionale. Per questo aspetto, la Conferenza unificata potrebbe individuare dei criteri e definire degli indirizzi
precisi che rafforzino le capacit di collaborazione di Comuni, Province e Citt metropolitane nello svolgimento
delle funzioni locali attraverso le convenzioni di delega/avvalimento, ovvero le diverse forme di intesa
richiamate dalla legge.
Ci senza dubbio auspicabile rispetto alle nuove funzioni fondamentali che la legge attribuisce alle Province,
come ad esempio quella di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei
contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive.
Ma linstaurazione di nuove forme di cooperazione tra Comuni e Province/Citt Metropolitane anche
auspicabile per le funzioni amministrative che oggi sono attribuite in modo frammentato e disperso in diverse
strutture amministrative afferenti ai vari livelli del governo locale (per esempio in materia di difesa del suolo e
prevenzione delle calamit) che potrebbero essere oggetto di appositi accordi nel territorio per individuare le
modalit di esercizio ottimale, ricomponendo in modo organico le relative funzioni ad un unico livello di
governo.
Per questo aspetto, andranno attentamente valorizzate le forme associate di esercizio, che al livello dei
Comuni sono gi ampiamente utilizzate in specie nella forma delle convenzioni plurifunzionali o delle Unioni
di Comuni ma che, invece, sono pressoch sconosciute alle Province ancorch gi previste fin dal Testo
Unico Enti Locali.
Il Consiglio Provinciale auspica infine che, nell'adottare i provvedimenti legislativi di riordino, lo Stato e la
Regione considerino l'esigenza di salvaguardare l'integrit dell'ente e la professionalit dei suoi
dipendenti.
Sulla base dellesame compiuto dalla VII Commissione Consiliare, risulta evidente che le funzioni
strumentali al funzionamento dellente (bilancio, personale, patrimonio, partecipazioni, sistema informativo)
sono state considerate dallintervento legislativo compiuto con la legge 56/2014, ancorch non siano
direttamente collegate allerogazione dei servizi rivolti allutenza esterna.
Il monitoraggio compiuto sulle funzioni finali stato finalizzato allaccordo sul riordino previsto dai commi da 89
a 92 della legge. Per le attivit strumentali, viceversa opportuno auspicare che le previsioni della legge
Delrio vengano opportunamente integrate in sede di accordo, con particolare riferimento alle previsioni del
comma 47 che integrano una fattispecie di successione universale dei beni mobili e immobili, cos come la
disposizione del comma 48 in materia di personale.
Le due disposizioni, infatti, integrano s una fattispecie di successione universale, che di per s il
meccanismo pi garantista tra quelli prevedibili, ma rimandano comunque alla disciplina prevista per le
Province non destinate a diventare Citt Metropolitane e che prevede lassoggettamento a riordino delle
funzioni non fondamentali, ognuna delle quali porta comunque con s una quota del personale e delle risorse
finanziarie e patrimoniali addette ai servizi strumentali.
Le disposizioni, pertanto, non appaiono offrire una piena e intangibile garanzia dellintegrit dellente e della
sua organizzazione allesito della transizione istituzionale. Allo stesso modo, le disposizioni di cui al comma 96
della legge prevedono il mantenimento dei trattamenti giuridici ed economici sino al prossimo rinnovo
contrattuale.
Posto che non definibile a priori lesito del processo di riordino rispetto alla tipologia di ente subentrante alla
attuale Provincia (Stato, Regione, Citt Metropolitane, Comuni e unioni di Comuni) le disposizioni citate non
integrano una fattispecie di successione universale, bens una successione a titolo particolare che riguarda
singole funzioni e che punta a una garanzia di continuit solo nel medio termine, rinviando a una futura
stagione di contrattazione collettiva.
12
E quindi opportuno che in sede di accordo si affermino alcuni criteri ulteriori di salvaguardia delle
professionalit, come potrebbe essere ad esempio limitare larea territoriale di ricollocazione dei dipendenti a
un raggio di 100 km (come peraltro prevede lattuale disegno di riforma della P.A. approvato dal Governo) o a
una circoscrizione territoriale non superiore a quella dellattuale Provincia. Leccessiva indeterminatezza della
norma di rinvio alla futura contrattazione collettiva pone inoltre lesigenza di stabilire un limite temporale
massimo entro il quale giungere al nuovo contratto, per evitare che i limiti posti dalla legge alla possibilit di
rivalutare i trattamenti giuridici ed economici restino indefiniti nel tempo.
Come gi detto nella parte iniziale del documento, la legge dedica soltanto il comma 47 al sistema delle
partecipazioni nella transizione istituzionale verso la Citt Metropolitana.
E chiaro ed evidente che ai fini prospettici del lavoro immediato che spetter ai nuovi amministratori, la Citt
Metropolitana potr beneficiare di un sistema collaudato di monitoraggio e di aderenza alle leggi degli enti
partecipati dalla Provincia di Torino. La dotazione di partecipazioni dellEnte strategica anche rispetto alle
future funzioni della Citt Metropolitana, tra le quali saranno centrali i temi della mobilit e dei trasporti, la
gestione coordinata dei servizi pubblici locali come ad esempio i rifiuti, lo sviluppo economico e
linformatizzazione del territorio.
Per questo aspetto la Citt Metropolitana potr supplire alle carenze di investimenti nelle nuove tecnologie
della rete, che spesso sono state registrate nei comuni soprattutto di minori dimensioni e risorse. In questo
settore, il nuovo ente potr vantare anche alcune partecipazioni strategiche e specialistiche, non possedute
peraltro nemmeno dalla Citt di Torino.
Per altro aspetto, invece, occorrer dare ad alcuni enti e organismi partecipati delle missioni nuove, per
renderli coerenti con le nuove finalit istituzionali dellente di governo dellarea vasta.
5. Conclusioni
Lassetto istituzionale della Citt Metropolitana non stato affrontato nel presente documento, sebbene come
noto il merito e il metodo delle scelte adottate dal legislatore della legge 56/14 siano state fortemente
criticate dallUnione delle Province dItalia, alla quale questo Consiglio Provinciale ha pi volte espresso
condivisione delle posizioni adottate nel confronto con il governo.
In particolare, le maggiori contrariet alle scelte operate dal Parlamento hanno riguardato e tuttora permangno
con riferimento al sostanziale deficit di democrazia che alcune parti della legge fanno registrare. Tale deficit
ad esempio rappresentato dallassenza di una previsione univocamente rivolta allelezione diretta del sindaco
e del consiglio metropolitano, nonch dallassenza di una specifica garanzia della rappresentanza dei piccoli
comuni, che sarebbe stata necessaria in un territorio cos ampio e disomogeneo come quello della Provincia
di Torino.
Allo stesso modo, si sono rivolte critiche purtroppo non ascoltate nei confronti di un approccio legislativo
debole e non concludente nei confronti della parit di genere nelle nuove cariche elettive di secondo grado
previste dalla legge. Infine, non si pu trascurare lirragionevole disparit di trattamento tra Province e Citt
Metropolitane che la legge prevede per la prima elezione dei consiglieri, escludendo dallelettorato passivo i
consiglieri della Provincia di Torino uscenti.
Pur nella consapevolezza che il legislatore ha compiuto quindi scelte differenti rispetto a quelle auspicabili e
pi volte sollecitate nelle occasioni di confronto istituzionale, il Consiglio provinciale ha tuttavia ritenuto
necessario elaborare il presente documento, che nellanalisi delle funzioni rivolte ai cittadini, alle famiglie e alle
imprese trova la propria ragion dessere.
In conclusione dellesperienza amministrativa dellultimo quinquennio, questo Consiglio ritiene ed auspica
pertanto che la salvaguardia e la corretta interpretazione delle competenze della Provincia di Torino a seguito
della transizione diventi un elemento centrale del dibattito politico e fra i nuovi futuri amministratori dellarea
13
vasta. E a tale riguardo segnala che lesperienza degli attuali amministratori provinciali a disposizione per
tutti coloro che avranno il compito di guidare la futura Citt metropolitana.
14
La ricognizione delle funzioni amministrative
della Provincia di Torino
SOMMARIO
PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE.............................................................................................................................................15
CULTURA, TURISMO E SPORT...............................................................................................................................................................15
SECONDA COMMISSIONE CONSILIARE ......................................................................................................................................19
SVILUPPO SOSTENIBILE; PIANIFICAZIONE AMBIENTALE; RISORSE IDRICHE; QUALIT DELLARIA E INQUINAMENTO ATMOSFERICO, ACUSTICO
ED ELETTROMAGNETICO; PARCHI E AREE PROTETTE; TUTELA FLORA E FAUNA ........................................................................................19
TERZA COMMISSIONE CONSILIARE ............................................................................................................................................27
EDILIZIA SCOLASTICA ..........................................................................................................................................................................27
ISTRUZIONE E ORIENTAMENTO.............................................................................................................................................................28
FORMAZIONE PROFESSIONALE.............................................................................................................................................................31
POLITICHE PER IL LAVORO...................................................................................................................................................................33
QUARTA COMMISSIONE CONSILIARE.........................................................................................................................................37
VIABILIT, TRASPORTI, GRANDI INFRASTRUTTURE, ESPROPRIAZIONI .....................................................................................................37
QUINTA COMMISSIONE CONSILIARE ..........................................................................................................................................50
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, URBANISTICA, PROTEZIONE CIVILE E ASSISTENZA TECNICA AI COMUNI ......................................................50
SESTA COMMISSIONE CONSILIARE ............................................................................................................................................53
POLITICHE DI SVILUPPO PER LE ATTIVIT ECONOMICHE E PRODUTTIVE LAVORO COORDINAMENTO PROGRAMMI EUROPEI
CONCERTAZIONE TERRITORIALE AGRICOLTURA.................................................................................................................................53
NONA COMMISSIONE CONSILIARE..............................................................................................................................................60
POLITICHE ATTIVE DI CITTADINANZA, DIRITTI SOCIALI E PARIT, RELAZIONI INTERNAZIONALI, PROGETTI EUROPEI....................................60
15
PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE
Cultura, turismo e sport
Le funzioni in materia di cultura vanno dalla programmazione delle attivit culturali locali, al coordinamento
delle reti di servizi, musei, ecomusei, biblioteche, archivi, aree archeologiche e patrimoni di beni culturali, al
loro censimento, inventariazione e riordino.
Si articolano inoltre nelle attivit di gestione di due sezioni provinciali del registro regionale delle
organizzazioni di volontariato, nella promozione delle attivit espositive e delle arti visive, nel sostegno alla
conservazione e valorizzazione, nella tutela delle minoranze linguistiche storiche e delloriginale patrimonio
linguistico, nellorganizzazione e sostegno delle attivit musicali, teatrali, di danza, cinematografiche, di
rassegne e festival.
Attengono, infine, anche alla specifica attuazione di piani di intervento a sostegno della musica corale e
bandistica.
Sono, come si vede, in gran parte funzioni proprie dellEnte, attribuite da alcune significative leggi statali (ad
es. la legge 482/99 in materia di tutela delle minoranze linguistiche) e in altra parte da leggi regionali. Sono
funzioni nelle quali la complementarit con le competenze regionali e comunali molto significativa, e
potrebbe trovare forme di razionalizzazione fra i tre livelli di governo.
Nessuna delle attuali funzioni compresa nel nuovo catalogo di competenze fondamentali della Citt
Metropolitana e delle nuove province. Si deve pertanto osservare che le funzioni in materia culturale non sono
di per s qualificate come caratterizzanti del governo di area vasta. Sar quindi determinante conoscere quale
sar latteggiamento della Conferenza delle Regioni nellambito dellaccordo nazionale, e se le regioni
riterranno di rivendicare una competenza nel riattribuire al governo di area vasta le funzioni in materia
culturale.
Nello specifico, tuttavia, le funzioni in parola sono tradizionalmente esercitate dallEnte mediante la propria
autonoma iniziativa, e hanno permesso di accumulare degli esempi di eccellenza.
In particolare, deve essere sicuramente citata la Biblioteca di Storia e Cultura del Piemonte della Provincia
di Torino, che stata istituita nel 1956 su impulso dei professori Luigi Firpo e Giuseppe Grosso, allora
Presidente dellAmministrazione Provinciale e poi Sindaco del Comune di Torino, ed stata ufficialmente
aperta al pubblico nel maggio 1964.
La biblioteca fu costruita per dotare il capoluogo e la sua Regione di un organismo specializzato nella raccolta
di opere di argomento piemontese, e attualmente ispone di un patrimonio di 120.000 volumi ed opuscoli, 11
incunaboli, 350 edizioni del Cinquecento, 150 manoscritti, 254 spartiti musicali, 1200 tesi di laurea, 2273
periodici, 347 carte geografiche, 428 stampe, 375 unit di grafica dautore, 1000 fotografie di cui una parte
incunaboli fotografici di rilievo internazionale, 42 fondi archivistici. Essa rappresenta oggi, per studiosi e
ricercatori non solo italiani, un punto di riferimento basilare in particolare per la storia del Piemonte e degli
antichi Stati Sardi in tutti gli aspetti, dalla letteratura allarte, dalla politica alla socio-economia, dalle discipline
scientifiche, alle tradizioni del folclore.
La Biblioteca uno di quegli esempi di eccellenza che deve essere salvaguardato nella transizione
istituzionale, cos come il Forte di Fenestrelle, simbolo della Provincia, e lAbbazia della Novalesa. Per questa
ragione il Consiglio Provinciale di Torino ha gi approvato una mozione (n. 15148/14) che qui si richiama
integralmente
Anche le altre funzioni in materia culturale, oggi svolte dalla Provincia, dovranno essere ugualmente
salvaguardate e razionalizzate nellambito del riordino previsto dalla legge, utilizzando le potenzialit
espansive del nuovo catalogo di competenze di cui al comma 44 e, in particolare, considerandole come parte
essenziale del concetto di sviluppo economico e sociale, salvaguardando in particolare le iniziative peculiari
della Provincia di Torino che in materia culturale, turistica e di promozione dei prodotti tipici hanno privilegiato
una visione di sistema e di connessione, dando cos rilievo a tutto il territorio di area vasta.
Nel dettaglio, le funzioni oggetto di conferimento regionale sono le seguenti:
16
CULTURA
- partecipazione di concerto con la Regione e gli enti locali alla definizione
delle modalit e degli standard di funzionamento di musei, biblioteche, archivi
e complessi monumentali, favorendo la creazione di sistemi integrati;
- coordinamento e promozione delle reti provinciali di servizi culturali in materia
di musei, biblioteche, archivi, aree archeologiche e complessi monumentali e
degli altri beni culturali del proprio territorio, a carattere provinciale o uto
impiego in accordo con i Comuni e gli enti interessati;
- coordinamento e promozione delle iniziative di formazione ed aggiornamento
del personale del settore;
- coordinamento dellattivit di censimento, inventariazione, riordino e
catalogazione dei beni culturali del proprio territorio, collaborando alla
formazione del sistema informativo regionale;
- sostegno, anche in concorso con Stato e Regione, alla conservazione,
manutenzione, sicurezza, restauro, gestione, valorizzazione e promozione dei
beni culturali;
- incremento del patrimonio pubblico di beni culturali sia mediante acquisto
diretto, sia mediante lesercizio del diritto di prelazione o di esproprio ();
- programmazione degli interventi di interesse locale, in materia di attivit
culturali e spettacolo, secondo gli indirizzi generali definiti;
- promozione delle attivit espositive e delle arti visive;
- tutela, valorizzazione e promozione delloriginale patrimonio linguistico;
- promozione delle attivit musicali, teatrali, di danza, cinematografiche, di
rassegne e festival.
L.r.
44/00,artt.124
e 126
Anche in materia turistica, la Provincia esercita funzioni di attribuzione regionale, che sono elencate nella
tabella seguente.
TURISMO
- gestione dellAlbo delle associazioni turistiche pro loco. L.r. 36/00,
art. 4
- elaborazione del programma turistico provinciale, in coerenza con gli indirizzi
dei programmi regionali;
- monitoraggio dello sviluppo del sistema di informazione e di accoglienza
locale e della promozione turistica locale, in coerenza con gli indirizzi dei
programmi regionali;
- sviluppo e gestione del sistema informativo turistico provinciale, con la
collaborazione dei Comuni, nellambito dellosservatorio turistico regionale ed
acquisizione, elaborazione e diffusione dei dati statistici e amministrativi sul
movimento turistico, sulle strutture, le attivit e i servizi turistici, compresa la
tenuta di albi ed elenchi;
- nulla-osta allistituzione di uffici di informazione ed accoglienza turistica (IAT) e
alluso della relativa denominazione;
- riconoscimento dei corsi di formazione per le professioni turistiche e
accertamento dellidoneit professionale allesercizio di attivit turistiche, da
individuare con specifica disciplina regionale;
- concorso allelaborazione e allattuazione delle politiche comunitarie, nazionali
e regionali riguardanti il turismo;
- individuazione dei Comuni rurali non montani ai fini delle deroghe alle attivit
agro-turistiche.
L.r. 44/00,
art. 83
17
- nomina delle commissioni desame (professioni turistiche)
- tenuta ed aggiornamento degli elenchi di coloro che sono abilitati allesercizio
delle professioni turistiche.
L.r. 33/01,
art. 5 e 7
-individuazione e gestione della rete locale del patrimonio escursionistico ed
istituzione delle relative Consulte provinciali per lo svolgimento di funzioni di
concertazione e consultive;
-approvazione del piano degli interventi sulla rete escursionistica provinciale;
- vigilanza, controllo e irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
L.r. 12/10,
art.
5,9,10,12,17
- rilascio delle concessioni minerarie e dei permessi di ricerca relative alle
acque termali ,di cui alla legge regionale 12 luglio 1994, n. 25;
- vigilanza mineraria,polizia mineraria e sanzioni sui lavori di ricerca di cui alla
citata l.r..
L.r. 44/00,
art. 86,
L.r. 25/94
- riconoscimento dei corsi di qualificazione organizzati dai soggetti formativi
previsti dalla l.r.63/95;
L.r.
33/01,art. 3
L.r.63/95
- accertamento del possesso delle caratteristiche professionali delle agenzie di
viaggio e turismo attraverso apposita commissione;
L.r. 38/09,
artt. 8, 9
L.r.
15/88,art. 8
- accertamento, irrogazione e riscossione delle sanzioni amministrative
pecuniarie in merito alle Irregolarit nella rilevazione dei dati sul movimento
turistico;
L.r. 8/10,
artt.13, 16
- vigilanza sulloperato delle ATL e sulla permanenza delle caratteristiche che
hanno dato luogo al riconoscimento da parte della Giunta regionale.
L.r. 10/11,
art. 14
Fonte: Regione Piemonte, 2014
Si tratta, come si vede, di funzioni amministrative di programmazione, gestione e vigilanza alle quali si
aggiungono importanti compiti di tipo autorizzatorio inerenti le professioni individuali e i soggetti commerciali
attivi nel settore.
Nessuna di queste funzioni espressamente citata negli elenchi di funzioni fondamentali di cui ai commi 44 e
85 della legge; pertanto, esse saranno oggetto di riordino. Come gi indicato nelle altre materie, si auspica
che il riordino a opera della legislazione regionale consideri lopportunit di confermare tali attivit alla
competenza della Citt Metropolitana, considerandole come strumentali alla funzione fondamentale di
promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale.
In materia sportiva, la Provincia di Torino esercita le funzioni di:
- pianificazione dello sviluppo sportivo (funzione di tipo programmatorio)
- assistenza tecnica e amministrativa in materia di sport ad enti pubblici, associazioni ed operatori
- gestione delluso extrascolastico e sociale degli impianti scolastici e sportivi
Dette funzioni sono da considerarsi proprie dellente, e tradizionalmente esercitate in forza di una indiretta
attribuzione operata dagli artt. 19 e 20 TUEL (funzioni programmatorie) e sia per diretta attribuzione del Testo
Unico della Scuola, D.lgs. 297/94 (funzioni gestorie nelluso extrascolastico). Lattivit legislativa regionale in
materia risalente nel tempo (legge regionale 93/1995), e non ha comportato ulteriori attribuzioni di funzioni
alle Province. Inoltre, la Regione Piemonte non ha dato attuazione a quanto previsto dalla legge 289/2002 (art.
90), che richiedeva alle regioni di legiferare in materia di regolazione della concessione dellimpiantistica
sportiva.
18
Sul piano del riparto di potest legislativa tra Stato e Regione, la materia qualificata come ordinamento
sportivo nellart. 117, comma terzo della Costituzione, ed iscritta nella competenza concorrente.
Sul piano, infine degli aspetti patrimoniali, va ricordato che la gran parte del patrimonio sportivo nella
disponibilit dei comuni, mentre la Provincia dispone del patrimonio strutturalmente connesso al proprio
patrimonio scolastico.
A seguito della riclassificazione delle funzioni operata dalla legge 56/2014, la materia politiche sportive
non indicata esplicitamente n nellelenco delle funzioni fondamentali delle province (comma 85), n
tantomeno in quello delle Citt Metropolitane (comma 44). Parimenti, la materia non prevista come
funzione fondamentale dei Comuni, ai sensi dellart. 19 del D.L. 95/2012.
Se ne dovrebbe dedurre che, a seguito della riforma, le funzioni relative allo sport siano state tolte alla
competenza degli enti locali.
Tale deduzione, basata sullinterpretazione letterale dei cataloghi di funzioni amministrative, sarebbe tuttavia
incoerente con gli aspetti patrimoniali, che vedono i comuni e (pi marginalmente le province) titolari della
quasi totalit del patrimonio di impiantistica sportiva.
E quindi pi ragionevole concludere che posta la competenza legislativa concorrente in materia la
Regione possa riattribuire con propria legge alla Citt Metropolitana e ai Comuni le diverse funzioni di
programmazione dellattivit sportiva, coordinamento delle associazioni del settore e gestione dellingente
patrimonio di beni destinati allo sport.
Viceversa, i limiti alla riattribuzione di funzioni non fondamentali alle Province che sono posti dal comma 89,
impediscono di prefigurare per le province diverse da Torino la possibilit di continuare a gestire le attuali
funzioni, a meno di non considerarle in via interpretativa come una sottospecie delle funzioni di assistenza
tecnico-amministrativa di cui al comma 85, lett. d), secondo periodo.
Tale conclusione in linea con la possibilit che, anche dopo la riforma Delrio, almeno la Citt Metropolitana
possa svolgere attivit di programmazione e gestione in materia sportiva. Una simile conclusione, peraltro,
sarebbe resa pi agevole qualora nellaccordo da sancire in Conferenza Unificata si convenisse sulla
natura di servizio pubblico di tutte le attivit amministrative collegate allo sport.
In questo modo, i comuni potrebbero riprendere la piena titolarit della gestione dei loro impianti comunali, e la
Citt Metropolitana potrebbe riconoscere, per via statutaria, che le proprie competenze rientrano nella
funzione fondamentale di strutturazione e gestione coordinata di servizi pubblici di interesse metropolitano.
Dato che la materia a tutti gli effetti una di quelle su cui la complementarit tra prossimit e area vasta pi
spiccata, lutilizzo delle potenzialit statutarie previste dal comma 11, lett. b) della legge potrebbe supplire
allattuale carenza di una disciplina regionale aggiornata, in particolar modo nelle funzioni di classificazione del
patrimonio, nella regolazione tariffaria dellutilizzo, nelle procedure di individuazione dei concessionari e nelle
funzioni di stazione appaltante per conto dei Comuni.
19
SECONDA COMMISSIONE CONSILIARE
Sviluppo sostenibile; Pianificazione Ambientale; Risorse Idriche; Qualit dellaria e inquinamento
atmosferico, acustico ed elettromagnetico; Parchi e aree protette; Tutela flora e fauna
Fin dalla seconda met degli anni Novanta, le funzioni in materia ambientale hanno rivestito un ruolo
decisamente centrale e strategico fra le attivit della Provincia di Torino. Le principali competenze sono state
attribuite, da ultimo, con fonte legislativa statale (in particolare il D.lgs. 152/96, 22/97, 112/98, 96/99), alle quali
hanno fatto seguito alcune leggi regionali di particolare importanza, come la L.R. 24/2002, la L.R. 19/04, la
L.R. 13/07 e naturalmente le L.R. 43/00 e 44/00 di attuazione del cd.decentramento Bassanini. Dette funzioni
si sono innestate su quelle tradizionalmente esercitate ai sensi del TUEL, e per le quali valgono le medesime
considerazioni gi espresse nei paragrafi iniziali del presente documento.
Le funzioni sono coerentemente distribuite fra attivit di programmazione e pianificazione, di coordinamento
degli enti locali e di gestione dei servizi pubblici, nei settori del ciclo integrato dei rifiuti, dellutilizzo delle risorse
idriche, del controllo e della vigilanza nelle emissioni in atmosfera, dellutilizzo delle risorse del suolo e di tutte
le attivit autorizzative che implicano valutazioni di compatibilit ambientale.
Alla materia afferiscono altres le competenze autorizzative e di vigilanza che la Provincia esercita in materia
di aree protette, nonch le attivit dirette alla protezione del patrimonio faunistico e della flora,
prevalentemente disciplinate con fonte legislativa regionale (L.R. 32/82, 45/89, 36/92, 47/95, 19/09, 32/04).
Nel dettaglio, le funzioni di derivazione regionale sono indicate nella tabella seguente:
AMBIENTE
(Tutela delle
acque)
- organizzazione e gestione della rete provinciale di controllo ambientale delle
risorse idriche superficiali e sotterranee;
- formazione e aggiornamento del catasto di tutti gli scarichi non recapitanti in
reti fognarie e del catasto delle utilizzazioni agronomiche;
- formazione e aggiornamento del catasto delle utenze idriche;
- funzione consultiva nei confronti della Regione nellambito dei procedimenti
relativi a grandi derivazioni di cui allarticolo 29, comma 3, e allarticolo 89,
commi 2 e 3, del d. lgs. 112/1998 sino al verificarsi delle condizioni in essi
previste;
- rilevamento, disciplina e controllo, ivi compreso il rilascio delle relative
autorizzazioni, degli scarichi di interesse provinciale;
- rilevamento, disciplina e controllo delle operazioni di utilizzazione agronomica
degli effluenti di allevamento o di acque reflue idonee al suddetto utilizzo, ivi
comprese quelle provenienti da allevamenti ittici ed aziende agricole ed
agroalimentari.
L.r.
44/00,artt. 55
e 56
AMBIENTE
(Via, Vas)
- valutazione ambientale strategica dei piani e programmi;
- partecipazione al procedimento di verifica di assoggettabilit alla valutazione
ambientale strategica e al procedimento di valutazione delle varianti strutturali e
parziali al p.r.g.c. e dei piani particolareggiati con contestuale varianti;
- valutazione dimpatto ambientale delle categorie progettuali di cui allAllegato
A2 della l.r. 40/1998;
- verifica di assoggettabilit alla valutazione dimpatto ambientale dei progetti di
cui allAllegato B2 della l.r. 40/1998;
- partecipazione ai procedimenti regionali o di altre autorit competenti, in
qualit di soggetti interessati di cui allarticolo 9 della l.r. 40/1998;
L.r. 56/77,
art. 3 bis
L.r. 56/77,
artt. 3 bis e
40
20
- attivit di controllo e sanzionatoria relativa ai progetti sottoposti alle procedure
di valutazione dimpatto ambientale;
- rilascio e rinnovo dellautorizzazione ambientale integrata per i progetti di cui
allAllegato VIII del d.lgs. 152/2006;
- valutazione dincidenza di piani e programmi di competenza provinciale;
- valutazione dincidenza di interventi e progetti nel caso in cui la Provincia si
configuri come soggetto gestore delle aree della rete Natura 2000 oppure nel
caso in cui la Provincia si configuri come autorit competente alla valutazione
dimpatto ambientale;
- rilascio dellautorizzazione unica ambientale a seguito dellentrata in vigore del
d.p.r. 59/2013.
L.r. 40/98,
artt. 4 e 6
L.r. 40/98,
art. 21
L.r. 40/98,
art. 36
L.r. 19/09,
artt. 43 e 44
L.r. 44/00,
art. 36
AMBIENTE
(Aree
protette e
protezione
della natura)
- gestione delle aree protette;
- partecipazione, mediante lo strumento del concerto, al procedimento
regionale di adozione della carta della natura e successivo recepimento;
- partecipazione, mediante lo strumento dellintesa, al procedimento regionale
di delimitazione delle aree contigue;
- partecipazione alla comunit delle aree protette ai fini dellelaborazione del
piano pluriennale economico-sociale. Adozione del piano pluriennale
economico e sociale per le aree protette;
- adozione, in qualit di soggetto gestore, del piano darea per le aree protette;
- adozione dei piani naturalistici per le aree protette;
- intesa nellambito del procedimento regionale diretto alla parziale
modificazione dei confini delle aree protette;
- vigilanza nelle aree protette istituite con legge ad opera degli agenti di
vigilanza provinciale;
- adozione del regolamento delle aree protette per le aree protette a gestione
provinciale;
- risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle coltivazioni agricole,
agli impianti di arboricoltura da legno, agli allevamenti e ai pascoli presenti
allinterno delle aree protette;
- irrogazione sanzioni per le violazioni di cui allarticolo 55, comma 2, l.r.
19/2009, accertate in aree a gestione provinciale;
- approvazione dei progetti di tutela, conservazione, valorizzazione e
risanamento dellambiente naturale;
- funzione consultiva e di proposta nel procedimento regionale diretto
allindividuazione di siti di importanza comunitaria e zone di protezione
speciale;
- funzione consultiva nella predisposizione dei piani dazione di competenza
regionale;
- vigilanza nelle aree della rete natura 2000;
- funzione consultiva nellambito delladozione regionale delle misure atte a
disciplinare i prelievi, le deroghe e le reintroduzioni e delle procedure idonee a
garantire il monitoraggio dello stato di conservazione degli habitat e delle
specie di interesse comunitario con particolare riferimento a quelli prioritari;
- emanazione dei provvedimenti di ripristino in caso di interventi e opere
realizzati in difformit da quanto disposto dai piani di gestione e dai piani di
azione, oppure gli interventi e le opere eseguiti in assenza della procedura di
L.r. 19/09,
artt. 3, 5, 10
bis, 11, 21,
24, 25, 26,
27, 36, 39,
47, 48, 49,
55, 74,
21
valutazione di incidenza, in difformit dal giudizio di valutazione di incidenza o
in contrasto con gli obiettivi specifici di tutela e di conservazione contenuti nelle
schede descrittive delle aree della rete Natura 2000 e dei siti di importanza
comunitaria proposti di cui allarticolo 50 della l.r. 19/2009;
- autorizzazione alla raccolta di specie vegetali protette;
- funzioni amministrative attinenti il controllo in ordine alla commercializzazione
e detenzione degli animali selvatici, il ricevimento di denunce, i visti su certificati
di importazione, il ritiro dei permessi errati o falsificati, lautorizzazione alla
detenzione temporanea, ad eccezione della normativa di cui alla convenzione
sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche
minacciate di estinzione (CITES);
- interdizione del transito ai mezzi motorizzati, su strade di competenza
provinciale, qualora sia ritenuto opportuno ai fini di tutela ambientale e
sicurezza stradale;
- autorizzazione al taglio e allo sfoltimento della vegetazione spontanea
prodottasi nei laghi, nelle paludi e nei terreni di ripa soggetti a periodiche
sommersioni;
- irrogazione di sanzioni attinenti alle violazioni di norme di cui alla l.r. 32/1982;
- interventi tecnico operativi finalizzati allasportazione ed al trasporto, presso
discariche pubbliche o centri di smaltimento, dei rifiuti e dei detriti accumulati
sulle superfici lacustri, fluviali e lungo le rive a seguito di eventi naturali
(funzione su delega regionale);
L.r. 44/00,
art. 74
L.r. 32/82,
artt. 8, 11,
14,
22
AMBIENTE
(Inquinamen
to
atmosferico)
- intesa nellambito del procedimento regionale diretto allapprovazione dello
stralcio del piano regionale di risanamento e tutela della qualit dellaria;
- adozione del piano provinciale di intervento per la gestione operativa di
episodi acuti di inquinamento atmosferico;
- tenuta e aggiornamento dellinventario delle fonti di emissione in atmosfera;
- attuazione della programmazione e degli interventi necessari alla riduzione
degli inquinanti secondo gli obiettivi generali fissati dal piano ed elaborazione
con i comuni interessati dei piani dintervento operativo che devono essere
adottati in caso di episodi acuti dinquinamento;
- autorizzazione allinstallazione di stabilimenti nuovi che producono emissioni
in atmosfera e relativo rinnovo, modifica e aggiornamento;
- irrogazione delle sanzioni per la violazione delle prescrizioni di cui allarticolo
277 del d.lgs. 152/2006, relative al controllo delle emissioni di composti organici
volatili;
- funzione consultiva nellambito della predisposizione regionale della proposta
di Piano triennale di intervento per la bonifica dallinquinamento acustico;
- esercizio del potere sostitutivo in caso di inerzia dei comuni nellattuazione
degli interventi per la gestione operativa di episodi acuti di inquinamento
atmosferico;
- rilevamento della qualit dellaria e controllo delle emissioni atmosferiche, ivi
compresi i provvedimenti di autorizzazione, di diffida, di sospensione, di
revisione e di revoca delle autorizzazioni agli stabilimenti che producono
emissioni;
- rilascio dellabilitazione alla conduzione degli impianti termici, compresa
listituzione dei relativi corsi di formazione;
- funzione consultiva nellambito della predisposizione regionale del sistema
regionale di rilevamento della qualit dellaria e dellindividuazione delle zone in
cui possono verificarsi episodi acuti di inquinamento atmosferico;
- autorizzazione alle officine per il rilascio del bollino blu;
L.r. 43/00,
art. 6
L.r. 44/00,
art. 44
L.r. 43/00,
art. 3
L.r. 44/00,
art. 44
LL.rr. 43 e 44
del 2000
L.r. 52/00,
art. 15
L.r. 44/00,
art. 44
L.r. 43/00,
art. 2
L.r. 43/00,
art. 3
AMBIENTE
(Inquinamen
to acustico
ed
elettromagn
etico)
- monitoraggio dellinquinamento acustico, promozione dellesecuzione di
campagne di misura, attuazione della programmazione e degli interventi
necessari alla riduzione dellinquinamento acustico;
- potere sostitutivo in caso di inerzia da parte delle amministrazioni comunali
riguardo allobbligo di zonizzazione acustica o di predisposizione dei piani di
risanamento acustico;
- vigilanza e controllo delle sorgenti sonore fisse ricadenti nel territorio di pi
comuni, oppure i cui effetti sonori si propagano nei territori di pi comuni
L.r. 52/00,
art. 4
L.r. 44/00,
art. 47 e L.r.
52/00, art. 4
23
ricompresi nella circoscrizione provinciale, nonch di quelle delle imprese sia di
beni sia di servizi soggette ad autorizzazione ambientale di competenza della
provincia;
- composizione di conflitti fra comuni limitrofi in relazione alla classificazione
acustica del territorio;
- monitoraggio dellinquinamento acustico ed esecuzione di campagne di
misura;
- approvazione dei piani pluriennali di risanamento acustico predisposti dagli
enti gestori delle infrastrutture di trasporto uto impiego e dei piani di
risanamento acustico predisposti dai titolari di imprese produttive sia di beni sia
di servizi soggette ad autorizzazioni ambientali di competenza della provincia;
- approvazione dei piani di risanamento acustico predisposti dai titolari di
imprese produttive sia di beni sia di servizi soggette ad autorizzazioni
ambientali di competenza della provincia;
- attuazione della programmazione e degli interventi necessari alla riduzione
dellinquinamento acustico secondo gli obiettivi fissati dal piano regionale di
bonifica acustica;
- funzione consultiva nellambito delle seguenti competenze regionali afferenti:
- fissazione dei criteri generali per la localizzazione degli impianti fissi
per telecomunicazioni e radiodiffusione e degli elettrodotti;
- fissazione dei criteri per la definizione dei tracciati degli elettrodotti ad
alta tensione fino a centocinquanta chilovolt;
- parere sul piano nazionale di assegnazione delle frequenze;
- funzione consultiva nellambito della predisposizione regionale della proposta
di Piano triennale di intervento per la bonifica dallinquinamento acustico;
- funzione consultiva nellambito dellapprovazione regionale dei piani
pluriennali di risanamento acustico predisposti dagli enti gestori delle
infrastrutture di trasporto;
- adozione dei piani di risanamento al fine di adeguare, in modo graduale, gli
impianti radioelettrici gi esistenti ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione
ed agli obiettivi di qualit;
- verifiche generali in ordine alla coerenza tra gli atti di programmazione e
sviluppo delle reti degli impianti e gli obiettivi di qualit conseguiti nonch
allattuazione dei piani di risanamento degli impianti radioelettrici;
- controllo e verifica sulla corretta applicazione delle linee guida regionali
contenenti i criteri generali per la localizzazione degli impianti e gli standard
urbanistici nonch per lindividuazione di aree sensibili e le misure di cautela da
adottarsi in esse;
- potere sostitutivo nei confronti dei comuni in caso di inerzia nel rilascio delle
autorizzazioni per linstallazione e la modifica degli impianti per
telecomunicazioni e radiodiffusione, nonch nellemanazione dei provvedimenti
di riduzione a conformit, di diffida, di disattivazione degli impianti per
telecomunicazioni e radiodiffusione o di revoca dellautorizzazione.
L.r. 52/00,
art. 4
l.r. 52/00, art.
15
L.r. 52/00,
art. 3
L.r. 19/04,
art. 6
24
AMBIENTE
(Gestione
dei rifiuti)
- individuazione allinterno del programma provinciale delle zone idonee alla
localizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani nonch
delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero
dei rifiuti;
- esercizio in forma associata delle funzioni di organizzazione e controllo
diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;
- adozione del programma provinciale per lo smaltimento dei rifiuti;
- controllo e verifica degli interventi di bonifica e monitoraggio ad essi
conseguenti;
- rilascio autorizzazioni e provvedimenti di diffida, sospensione, revoca, rinnovo
relativi allutilizzazione in agricoltura dei fanghi derivanti dalla depurazione delle
acque di cui agli articoli 8 e 9 d. lgs. 99/1992;
- iscrizione delle imprese e degli enti sottoposti alle procedure semplificate di
cui agli articoli 214, 215 e 216 del d.lgs 152/06 ed ai relativi controlli;
- approvazione dei progetti e rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione di
impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti, nonch rilascio delle
autorizzazioni allesercizio di impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti
previsti dagli articoli 208, 209 e 210 del d.lgs. 152/2006;
- rilascio dei provvedimenti per il trasporto transfrontaliero dei rifiuti;
- irrogazione delle sanzioni di cui alla l.r. 24/2002;
- promozione a livello provinciale di attivit educative, interventi di formazione,
attivit di divulgazione e sensibilizzazione in materia di rifiuti;
- assicurazione della gestione unitaria dei rifiuti urbani prodotti nel territorio
provinciale e della gestione delle situazioni di emergenza;
- attuazione e gestione dellanagrafe provinciale dei siti contaminati.
L.r. 4/02, art.
3
L.r. 7/12, art.
4
L.r. 44/00,
art. 50, L.r.
24/02, artt. 3,
6, 17
CACCIA E
PESCA
- autorizzazioni concernenti il controllo e limmissione di fauna selvatica;
- istituzione di zone di protezione lungo le rotte di migrazione dellavifauna;
- autorizzazioni per lo svolgimento di corsi in materia di caccia e pesca previsti
da norme statali e regionali, compreso il rilascio di attestati;
- autorizzazioni per listituzione di centri di riproduzione e di recupero per la
fauna selvatica:
- autorizzazioni per la cattura, linanellamento e lutilizzo della fauna selvatica a
scopo scientifico,
- attivit ispettiva in materia di caccia e pesca,
- attivit di promozione faunistica;
L.r. 17/99,
art. 2, comma
2
- approvazione piani di contenimento del numero dei cinghiali e risarcimento in
favore dei conduttori dei fondi rustici per danni arrecati;
L.r. 9/00, art.
2
- vigilanza sugli allevamenti di cinghiali e controlli sullapplicazione del
tatuaggio;
L.r. 47/89,
artt. 3 e 4
- promozione della costituzione del comitato di bacino;
- costituzione del comitato consultivo provinciale con funzioni consultive,
tecniche e propositive in materia di ambienti acquatici e di pesca;
- svolgimento delle attivit di ripopolamento, immissione e prelievo a fini
gestionali della fauna ittica;
- promozione delle azioni di prevenzione e riparazione in materia di danno
ambientale alla fauna acquatica e agli ambienti acquatici;
L.r. 37/06,
artt. 5, 7, 17
e 25
- attuazione della pianificazione definita a livello regionale;
- classificazione delle acque in zone ittiche, individuazione delle zone ittiche,
L.r. 37/06,
artt. 25
25
redazione ed aggiornamento della carta ittica provinciale;
- individuazione delle zone di pesca e i corpi idrici ove possibile praticare la
pesca professionale;
- definizione dei programmi di incremento e ripopolamento della fauna ittica;
- definizione dei programmi e interventi di tutela degli ecosistemi acquatici e
della fauna acquatica;
- promozione forme di collaborazione con le organizzazione piscatorie
riconosciute e con i comitati di bacino;
- censimento dei diritti esclusivi di pesca;
- valutazioni circa la qualit delle acque e degli ecosistemi acquatici sulla base
di parametri fisici, chimici e biologici significativi, a integrazione dei monitoraggi
effettuati ai sensi della normativa in materia di tutela delle acque;
- raccolta, elaborazione e diffusione dei dati relativi alla consistenza delle
popolazioni delle specie ittiche presenti nelle acque provinciali;
- individuazione delle popolazioni acquatiche appartenenti alle specie
autoctone in funzione della tutela e della fruizione del bene;
- valutazioni quantitative e qualitative utili per la razionalizzazione dei
ripopolamenti;
- predisposizione dei dati sulla capacit biogenica dei corsi dacqua, al fine di
individuare anche le misure minime di cattura;
- indicazioni per lindividuazione e la gestione dei Siti di importanza comunitaria
e delle zone speciali di conservazione;
- individuazione dei bacini di pesca;
- individuazione dei centri ittiogenici idonei per la produzione di materiale ittico
autoctono destinato ai ripopolamenti e alla tutela della biodiversit;
- definizione programmi di formazione e aggiornamento degli agenti di vigilanza
e degli altri soggetti coinvolti nella gestione dellattivit piscatoria;
- elaborazione progetti di interesse provinciale.
- individuazione dei corpi idrici ove consentito lesercizio della pesca
professionale.
L.r. 37/06,
art. 18
- adozione regolamenti finalizzati alla gestione di corpi idrici classificati ai fini
della pesca;
- riconoscimento delle organizzazioni piscatorie
- autorizzazione, ai fini della salvaguardia della fauna ittica,relativa alla messa
in secca di corsi dacqua, bacini e canali, compresi quelli privati in
comunicazione con acque pubbliche.
- disposizioni sulle modalit e criteri per gli adempimenti relativi agli impianti e
bacini privati per la pesca a pagamento e provvedono,
- adozione di misure idonee ad evitare diffusioni incontrollate di fauna ittica
alloctona;
- esercizio delle funzioni amministrative concernenti i diritti esclusivi di pesca;
- rilascio licenza per la pesca professionale e iscrizione dei titolari di licenza di
pesca professionale in un elenco aggiornato;
- autorizzazione alla pesca a scopo scientifico e agli interventi di protezione
ittica, attivit dirette a scopo di studio, ricerca, sperimentazione, protezione e
tutela della fauna e degli ambienti acquatici.
- vigilanza sullapplicazione delle leggi sulla pesca e laccertamento delle
infrazioni
relative;
- disciplina e coordinamento dellattivit di formazione, aggiornamento e
vigilanza
L.r. 37/06,
artt. 3, 4, 12,
13, 14, 18, 22
26
dei soggetti abilitati.
- organizzazione dei corsi di qualificazione e aggiornamento per il
riconoscimento della qualit di guardia ittica volontaria e rilascio attestato
didoneit.
L.r. 37/06,
art. 24
Fonte: Regione Piemonte, 2014
Alla luce dei nuovi cataloghi di funzioni fondamentali della Citt Metropolitana e delle nuove province, la
materia deve essere riletta considerando i contenuti di tipo pianificatorio e, parimenti, quelli di gestione dei
servizi pubblici connaturati alle attuali funzioni svolte dalla Provincia.
In questo senso, le funzioni presidiate dalla Provincia di Torino possono essere agevolmente considerate in
via interpretativa quali funzioni di pianificazione territoriale generale nonch volte alla strutturazione di
sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, pur con la probabile ridefinizione a opera della
legislazione regionale in ordine alla fondamentale attivit di governance e di regolazione dei servizi a rete:
competenze, queste, che comunque devono essere svolte da un ente di governo dellarea vasta.
Inoltre, le specifiche attivit di autorizzazione, vigilanza e controllo in campo ambientale sono perfettamente
coerenti con la nuova funzione delle Province classificata come tutela e valorizzazione dellambiente di cui al
comma 85 della legge 56/14.
27
TERZA COMMISSIONE CONSILIARE
Edilizia scolastica
Nello specifico delle materie di competenza della III Commissione, lesigenza di rinnovare i criteri ermeneutici
riguarda anzitutto le funzioni complementari al comparto relativo alledilizia scolastica di secondo grado.
Si tratta di funzioni come la programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della
programmazione regionale, che la legge 56 ha iscritto nel novero delle nuove funzioni fondamentali delle
Province e, quindi, anche della Citt Metropolitana, per effetto del combinato disposto dei commi 44 e 85 della
stessa legge.
Posto che il concetto di programmazione della rete scolastica ampio ed ampiamente interpretabile nei suoi
contenuti amministrativi, opportuno specificare in via interpretativa che tale concetto si estende ai compiti
attualmente esercitati dalla Provincia in materia di programmazione dellofferta di istruzione e formazione
professionale, orientamento scolastico e diritto allo studio. Lesempio dimostra quindi come si debba
adottare un approccio nuovo ed evolutivo nellinterpretazione delle nuove funzioni, rinnovando cio i
precedenti titoli di legittimazione delle diverse funzioni e considerandoli riassorbiti nella sanzione di funzione
fondamentale ai sensi della citata disposizione costituzionale.
E anche ledilizia scolastica in senso stretto rientra senzaltro nellelenco di funzioni che fino a oggi si sono
definite proprie e non fondamentali delle Province, e che quindi sono state rinnovate nel titolo di
legittimazione a opera della legge 56/2014.
Vale infatti la pena di ricordare che, sulla base della previsione generale dellart. 19, lett. i) del TUEL (il quale
individuava ledilizia scolastica come funzione delle Province rinviando a successive attribuzioni di legge
statale e regionale) detta funzione stata infatti attribuita alle Province dalla legge statale n. 23/1996, e quindi
appartiene alle funzioni storicamente esercitate, addirittura antecedentemente alla riforma costituzionale del
2001. Nello specifico dei compiti attribuiti dalla legge dello Stato alle province rilevano:
- la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici (messa in sicurezza degli edifici, messa a norma degli
impianti);
- la costruzione di nuove scuole;
- le spese per le utenze elettriche e telefoniche, per la provvista dellacqua e del gas, per il riscaldamento ed
per i relativi impianti;
- le spese varie di ufficio e per larredamento delle aule: banchi, sedie, aule multimediali, laboratori, etc..
A tali funzioni, il D.lgs. 112/1998 (attuazione della Bassanini I) ha poi aggiunto le funzioni e i compiti delegati
alle Regioni e descritti Nel Titolo IV (Servizi alla Persona e alla Comunit), Capo III (Istruzione scolastica),
artt. 135 e ss. Tra i vari compiti, quelli connessi alledilizia scolastica consistono in:
a) la programmazione dellofferta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale;
b) la programmazione, sul piano regionale, nei limiti delle disponibilit di risorse umane e finanziarie,
della rete scolastica, sulla base dei piani provinciali, assicurando il coordinamento con la programmazione
di cui alla lettera a);
Il medesimo Decreto Legislativo (art. 139) ha invece attribuito alle Province ai sensi dellart. 128 Cost. (testo
ante riforma del Titolo V del 2001) in relazione allistruzione secondaria superiore i seguenti compiti e
funzioni:
listituzione, laggregazione, la fusione e la soppressione di scuole in attuazione degli strumenti di
programmazione;
la redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche;
il piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature, dintesa con le istituzioni scolastiche;
28
In Piemonte, la legge regionale n. 5/2001, in sede di modifica della legge regionale n. 44/2000, aveva previsto
il trasferimento alle province di alcune ulteriori funzioni; tale trasferimento stato successivamente superato
con una nuova disposizione legislativa regionale di riordino di tutta la materia dellistruzione, la quale ha
stabilito la competenza delle province per tutte le seguenti funzioni in materia di edilizia scolastica:
- le funzioni e gli interventi riguardanti listruzione secondaria di secondo grado di cui all articolo 139 del d.lgs
112/1998;
- ladozione dei provvedimenti per lattuazione dei programmi di edilizia scolastica relativi a mirati e limitati
interventi di edilizia scolastica e per gli interventi su palestre ed impianti ginnico-sportivi, nonch per gli
interventi urgenti dovuti ad esigenze di sicurezza e di igiene.
Istruzione e orientamento
La combinazione di un impianto normativo articolato e differenziato, a livello nazionale e regionale, ha
attribuito in modo coerente alla Provincia di Torino funzioni di programmazione degli interventi e delle
risorse finanziarie, di erogazione dei servizi educativi e di orientamento rivolti ad adolescenti e
giovani. Lintegrazione tra gli interventi di istruzione, formazione professionale e orientamento, allinterno degli
indirizzi regionali, ha consentito di dare vita a un sistema di istruzione e formazione professionale con
proposte adeguate a soggetti con diverse attese e volte a conseguire, per ogni persona, il successo scolastico
e formativo.Listruzione articolata in tre macrofunzioni:
a) la programmazione della rete delle autonomie scolastiche e dellofferta dei percorsi della scuola
secondaria di secondo grado (art 139, comma, 1, lett a, b, del DLgs 112/1998). La Provincia
concorre, congiuntamente alla formazione professionale, alla programmazione regionale dellofferta
formativa integrata tra istruzione e formazione professionale (art. 138, comma 1, lett. a, del D Lgs
112/1998)
b) elaborazione e gestione del Piano provinciale per il diritto allo studio secondo quanto previsto
dallart. 30 della lr 28/2007, con particolare attenzione ai servizi di assistenza specialistica e al
trasporto disabili iscritti alle scuole secondarie di secondo grado, ma anche a supporto dei servizi
garantiti dai Comuni agli altri gradi di scuola. Lart. 139, comma 1, lett. c, del D Lgs 112/1998 assegna
alla Provincia la responsabilit dei servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli
alunni con handicap o in situazione di svantaggio. Lart. 123 della L.R. 44/2000 dispone inoltre che la
Provincia concorra con la Regione nellesercizio delle funzioni in materia di diritto allo studio
universitario
c) I compiti e le funzioni di coordinamento inerenti le attivit di orientamento allistruzione, lavoro e
formazione professionale, gi indicate allart 9 della lr 63/95, sono attribuite alla Provincia dallart. 77,
comma 3 della lr 44/2000. La Provincia assume le funzioni di vigilanza allassolvimento da parte degli
adolescenti del Diritto dovere di istruzione e formazione professionale secondo quanto indicato
dallart. 5, comma 2, lett. c del D Lgs 76/05.
Le funzioni sono attuate, in una prospettiva di uto impiego orizzontale e verticale, tramite accordi di
collaborazione tra gli enti territoriali, le istituzioni scolastiche autonome e le agenzie formative accreditate con
il coinvolgimento dei servizi sociali, sanitari, culturali e del lavoro presenti sul territorio nella progettazione,
realizzazione e monitoraggio degli interventi (art. 5 della lr 28/2007). I prodotti articolati per le diverse funzioni
sono principalmente:
) una pianificazione della rete scolastica dellofferta formativa a partire dalle analisi dei fabbisogni
professionali territoriali, dal confronto con gli attori istituzionali e sociali dei bacini territoriali. Azioni e
piani di supporto alle autonomie scolastiche e alle agenzie formative per la realizzazione e il
miglioramento dellofferta formativa.
) Piano provinciale ed erogazione diretta di servizi di orientamento individuali e di gruppo, in stretta
connessione con i Centri per lImpiego. Coordinamento delle reti territoriali.
29
) Programmazione e gestione del Piano provinciale del diritto allo studio con relativa attribuzione delle
risorse finanziarie.
La composizione di strumenti di programmazione delle attivit educative, a partire dalle esigenze delle
persone, del tessuto sociale e produttivo e dei territori, con lerogazione di idonei servizi alle persone e di
risorse finanziarie, garantisce il funzionamento di servizi educativi e di orientamento integrati con significativi
risultati nel conseguimento del successo formativo e nel contrasto alla dispersione formativa. Lunitaria
gestione provinciale consente di attivare analisi sulla popolazione e sugli interventi programmati quali ad
esempio lOsservatorio provinciale su orientamento, istruzione e formazione professionale e strumenti
di reportistica. Le informazioni prodotte hanno favorito la conoscenza di tutto quanto lesistente sui singoli
bacini territoriali e ambiti funzionali, evidenziato le carenze e supportato la programmazione integrata. In
particolare i Comuni richiedono e considerano molto importanti gli strumenti a supporto della programmazione.
Complessivamente, il quadro delle funzioni esercitate dalla Provincia su conferimento regionale
riassumibile nella tabella seguente:
30
EDILIZIA
SCOLASTICA
-funzioni relative alledilizia scolastica riguardanti le scuole secondarie di
secondo grado;
- funzioni amministrative relative allattuazione dei programmi, in favore dei
comuni, delle loro forme associative, delle comunit montane e collinari, per
mirati e limitati interventi di edilizia scolastica e per gli interventi su palestre ed
impianti ginnico-sportivi, nonch per gli interventi urgenti dovuti ad esigenze di
sicurezza e di igiene;
- titolarit dellanagrafe regionale delledilizia scolastica, per gli interventi a favore
del patrimonio di edilizia scolastica del sistema dellistruzione piemontese;
- realizzazione di interventi edilizi, con gli eventuali contributi concessi dalla
Regione e secondo le indicazioni contenute nel piano triennale (regionale) degli
interventi, finalizzati a:
a) adeguare il patrimonio edilizio scolastico esistente alle norme vigenti in
materia di agibilit, sicurezza, igiene ed alle normative regionali integrative
b) recuperare e riqualificare il patrimonio edilizio scolastico esistente, con
particolare riguardo agli edifici aventi valore storico monumentale ed
ambientale;
c) realizzare nuovi edifici scolastici e completare strutture scolastiche esistenti.
L.r.
28/2007,
artt. 22,
23 e 30
ISTRUZIONE
E
ORIENTAMEN
TO
- coordinamento delle attivit di orientamento allistruzione, lavoro e formazione
professionale
L.r.
44/2000,
art. 77,
co. 3
- concorso con la regione nellesercizio delle funzioni in materia di diritto allo
studio universitario (programmazione e finanziamento dello sviluppo
universitario);
L.r.
44/2000,
art. 123
- interventi per lintegrazione scolastica degli alunni disabili o con esigenze
educative speciali
nel quadro degli accordi di programma di cui all art. 17 della LR 1/2004 diretti ad
assicurare laccesso e la frequenza al sistema scolastico e formativo.
L.r.
28/2007,
art. 15
- concorso allelaborazione del piano triennale regionale in materia di diritto allo
studio;
- svolgimento di funzioni in materia di istruzione secondaria di secondo grado di
cui allarticolo 139 del d.lgs 112/1998;
- promozione della stipulazione degli accordi di collaborazione tra gli enti
territoriali, le istituzioni scolastiche autonome e le agenzie formative accreditate
con il coinvolgimento dei servizi sociali, sanitari, culturali e del lavoro di cui
allarticolo;
- predisposizione ed approvazione del piano annuale degli interventi in materia di
assistenza scolastica;
- predisposizione ed approvazione del piano annuale degli interventi in materia di
prevenzione e recupero dellabbandono scolastico;
- predisposizione ed approvazione del piano annuale degli interventi in materia di
dotazioni librarie.
L.r.
28/2007,
art. 30
Fonte: Regione Piemonte, 2014
Come si vede, le funzioni esercitate dalle province hanno avuto un diverso titolo di legittimazione: dalla
attribuzione, alla delega, al trasferimento, al riconoscimento di competenza dellultimo testo legislativo
regionale. Si quindi in presenza di una commistione tra funzioni proprie e funzioni conferite sia dallo Stato
che dalla Regione, e tutte incidenti sulla competenza legislativa concorrente di cui allart. 117, comma 3
della Costituzione.
31
Peraltro, dopo la sentenza Corte Costituzionale n. 238/2007, necessario riconoscere che la dicotomia tra
funzioni fondamentali e funzioni proprie da intendersi superata, poich la Corte ha affermato che le funzioni
proprie debbano essere ricondotte a quelle fondamentali. Tale assunto comporta per, nella materia
dellistruzione, una inevitabile conseguenza: se le funzioni proprie devono essere ricondotte a quelle
fondamentali, anche la relativa potest a legiferare deve essere riportata al livello di governo a cui spetta
individuare le funzioni fondamentali: cio, allo Stato.
Nel caso di specie, si determinerebbe quindi unattrazione alla sfera di potest legislativa statale anche delle
funzioni e dei compiti sui quali il legislatore piemontese si era espresso utilizzando la potest legislativa
concorrente, come abbiamo visto, con la L.R. 44/2000 e poi con la L.R. 28/2007. Nelle citate leggi regionali, la
Regione Piemonte in parte aveva trasferito proprie funzioni al livello provinciale e, in parte, aveva
ridefinito il titolo di conferimento (con la L.R. 28/2007) delle funzioni gi attribuite dalla legge dello Stato n.
23/1996.
In questa materia si dovrebbe pertanto registrare dopo la legge 56/2014 un affievolimento della potest
legislativa regionale, o comunque limpossibilit per la Regione di riallocare, con le proprie leggi di riordino,
le funzioni amministrative a un livello di governo diverso dalle Province e Citt Metropolitane.
Si ritiene opportuno sottolineare che a fronte di una programmazione regionale con un piano regionale di
orientamento, che garantisca un servizio omogeneo per gli utenti su tutto il territorio regionale, deve seguire
un piano di azione locale, a livello provinciale e di citt metropolitana, che valorizzi con efficacia la rete locale
dei servizi di orientamento.
Con la stessa modalit si dovrebbe procedere anche per il diritto allo studio del primo e del secondo ciclo.
Formazione professionale
Le funzioni in materia di formazione professionale sono esercitate a livello provinciale da molti anni, ancor
prima del decentramento amministrativo avviato alla fine degli anni 90 e della riforma del Titolo V della
Costituzione, che ha attratto la materia dellistruzione e della formazione professionale nella competenza
legislativa esclusiva regionale.
La ratio deriva dalla necessit di integrare a livello locale e in dimensione di area vasta le politiche
formative con le politiche del lavoro, dellistruzione e dellorientamento, per far s che i percorsi e i
processi di formazione e qualificazione delle persone dalla fase iniziale e lungo larco della vita rappresentino
una risposta efficace alle esigenze dei sistemi produttivi e del mercato del lavoro, contribuendo a valorizzare il
capitale umano quale fattore essenziale di sviluppo di un territorio.
Gi la Legge 845/78 (Legge quadro nazionale in materia di formazione professionale) individuava quale
modalit di esercizio normale la delega da parte delle Regioni alle Province delle funzioni amministrative.
Cos, lart. 143 del D.Lgs. 112/98 prevede che al fine di assicurare lintegrazione tra politiche formative e
politiche del lavoro la regione attribuisce [] di norma alle province le funzioni ad essa trasferite in materia di
formazione professionale
Secondo lart. 19 del TUEL, spettano alla Provincia, nel settore della formazione professionale, le funzioni
amministrative di interesse provinciale, che riguardino vaste zone intercomunali o lintero territorio
provinciale, attribuite dalla legislazione statale e regionale.
Il legislatore regionale ha fatto proprio lo spirito della normativa nazionale, dapprima delegando (LR 63/95) e
poi attribuendo (LR 44/2000, artt.75-77) alle Province le azioni di programmazione, attuazione,
amministrazione, valutazione delle attivit formative, conservando al livello regionale le funzioni
strategiche di indirizzo e controllo.
Ne deriva un quadro composito, che in linea generale prevede che spettino alla Regione i compiti di disciplina,
programmazione, indirizzo di rilievo regionale, da esercitarsi secondo un duplice sguardo:
- verso lUnione Europea e lo Stato, attraverso il concorso allelaborazione delle politiche comunitarie e
nazionali di settore e alla loro attuazione e la concertazione con lo Stato delle strategie, degli indirizzi
32
generali, degli obiettivi di qualit, sicurezza, previsione e prevenzione ai fini della loro attuazione a
livello regionale, la collaborazione e concertazioni con le autorit statali e sovraregionali
- verso gli Enti locali, attraverso lindirizzo, coordinamento, verifica e monitoraggio dei compiti e delle
funzioni conferite ivi compresa lemanazione di direttive, criteri, nonch modalit e procedure per
aspetti di carattere generale ai fini del loro esercizio omogeneo sul territorio, da attuarsi secondo
principi di leale collaborazione e concertazione istituzionale.
La Provincia esercita oggi la pienezza delle funzioni, declinando a livello territoriale, sulla base della lettura dei
fabbisogni dei diversi destinatari delle azioni, lutilizzo anche in forma integrata dei diversi strumenti di
programmazione, per rispondere nel modo pi soddisfacente alle esigenze delle persone e delle imprese sul
territorio.
I criteri di programmazione e gestione degli interventi e delle risorse finanziarie rispondono ai principi di:
flessibilit nei confronti delle persone e alle dinamiche del sistema economico
continuit per offrire opportunit di formazione lungo lintero arco della vita
concertazione con le parti sociali
pluralismo per valorizzare le diverse proposte formative presenti sul territorio
integrazione per favorire un rapporto costante tra formazione, scuola e lavoro.
Alla formazione professionale sono associati due obiettivi strategici parimenti importanti:
garantire a tutti lacquisizione delle competenze di base necessarie per un esercizio
consapevole dei diritti di cittadinanza attiva (politica educativa, rivolta essenzialmente ai giovani
studenti; diritto dovere allistruzione e alla formazione; assolvimento dellobbligo di istruzione nei
percorsi di formazione professionale);
favorire linserimento e la permanenza sul mercato del lavoro della popolazione attiva (politica
del lavoro, rivolta tendenzialmente ad adulti occupati e disoccupati, a sua volta da leggersi sia in
chiave di riqualificazione a valenza anticiclica, come rafforzamento delloccupabilit a medio termine,
sia in chiave di supporto ad una rapida ricollocazione in contesto di perdurante crisi economica).
Questa molteplice chiave di lettura delle funzioni e dei compiti in materia di formazione professionale pu
aiutare anche a collocarli nel nuovo contesto normativo conseguente alla Legge 56/2014, che riconosce tra
le funzioni fondamentali della Citt Metropolitana la programmazione provinciale della rete scolastica, la
promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale, la strutturazione di sistemi coordinati di
gestione dei servizi pubblici e lorganizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito
metropolitano.
Complessivamente, il quadro delle funzioni esercitate dalla Provincia su conferimento regionale
riassumibile nella tabella seguente:
FORMAZIONE
PROFESSIONALE
- concorso con la Regione alla programmazione, attuazione e valutazione
del sistema regionale di formazione ed orientamento professionale,
formulando proposte e pareri obbligatori sui Programmi triennali e sulle
direttive annuali
L.r. 44/00,
art. 76
L.r. 63/95,
artt. 8 e 9
- individuazione dei fabbisogni formativi;
-coordinamento delle azioni di orientamento professionale e scolastico;
- nomina delle Commissioni desame e rilascio dei relativi attestati, ad
eccezione dei corsi direttamente svolti dalle province, per i quali provvede
la Regione.
- attuazione di specifici progetti volti al potenziamento tecnico e della
dotazione di personale degli uffici provinciali competenti in materia di
L.r. 44/00,
art. 77
33
formazione ed orientamento professionale;
- aggiornamento anche da parte delle agenzie formative del sistema
informativo regionale sulla formazione e lorientamento professionale a
supporto dellattivit di valutazione;
- gestione delle attivit formative previste nelle direttive annuali di cui
allarticolo 18 della l.r. 63/1995, ad eccezione di quelle relative
alleffettuazione di azioni sperimentali o di rilevante interesse della
Regione che impongono la gestione unitaria a livello regionale, come
individuate nelle medesime direttive;
- funzioni e compiti relativi agli istituti professionali (ivi compresi quelli
concernenti listituzione, finanziamento e la vigilanza);
- riconoscimento dei corsi realizzati da soggetti diversi dalle agenzie
formative e esercizio della vigilanza sugli stessi;
- promozione della qualificazione dellofferta formativa dellapprendistato; L.r. 2/07,
art. 3
-definizione nellambito delle proprie competenze dei criteri e delle
modalit di finanziamento della formazione degli apprendisti e dei tutori
aziendali;
- promozione della qualit e diffusione di unadeguata offerta formativa per
gli apprendisti.
L.r. 2/07,
art. 8
Fonte: Regione Piemonte, 2014
Alla luce delle considerazioni fatte e del riordino delle deleghe a livello stato/regioni nelle attribuzioni delle
competenze, necessario che nellanalisi della ricaduta della gestione del servizio si tenga conto dellefficacia
ed efficienza dello stesso.
Si sottolinea limportanza che il decentramento delle funzioni sia omogeneo su tutto il territorio regionale,
prevedendo eventuali meccanismi di sostituzione. Inoltre, deciso il livello di gestione, si sottolinea che
limportanza della responsabilit del processo stesso ricada sul livello delegato.
Politiche per il lavoro
Le funzioni svolte dalla Provincia di Torino in materia di politiche per il lavoro e di servizi allimpiego sono
interessate da un processo di riforma legislativa in corso, rappresentato dal disegno di legge delega noto
come Jobs Act (A.S. 1428), e che deve essere confrontato con i nuovi cataloghi di funzioni fondamentali
previsti dalla legge 56/2014, nonch con la prospettiva di riforma costituzionale del Titolo V.
In questa materia quindi del tutto evidente la necessit di un coordinamento tra le diverse fonti, con
specifica attenzione alle politiche attive ed ai servizi per il lavoro.
A questo riguardo si ritiene strategico lavere stabilito che il tema della tutela sul lavoro rimanga nellambito
delle funzioni esclusive dello Stato in quanto attiene i diritti della persona. In questo senso appare evidente
come le tutele sul lavoro che interessano lavoratori e disoccupati debbano riguardare sia i rapporti di lavoro,
sia il mercato del lavoro. Le politiche attive e i servizi per limpiego vanno dunque intesi come temi la cui
definizione dei sistemi, dei principi e dei livelli dei servizi sia di competenza dello Stato .
E quindi prioritario che lo Stato recuperi la capacit di definire standard, riferimenti e funzioni di
coordinamento dei servizi per limpiego ed anche degli stessi centri provinciali per limpiego. Si rende
necessaria dunque lattribuzione allo Stato di una funzione di programmazione di azioni nazionali attraverso i
PON, come avviene in ogni Paese europeo, per assicurare le azioni di supporto al raggiungimento degli
standard e dei livelli essenziali delle prestazioni dei servizi per limpiego ed inoltre per poter garantire
34
programmi standard di riferimento sulle diverse condizioni della disoccupazione e dellinoccupazione, sul
modello della Garanzia Giovani.
Tale programmazione dovr essere integrata e specificata localmente con la definizione di programmi
operativi regionali sulle misure di politica attiva per il lavoro declinate sulle specifiche esigenze ed emergenze
territoriali, in stretta connessione con la programmazione territoriale degli interventi di istruzione, formazione
professionale e orientamento.
In questo senso la previsione contenuta nel ddl di una Agenzia nazionale di riferimento che promuova,
coordini, verifichi, valuti ed affianchi i territori utile e necessaria, anche se questa non pu eliminare del tutto
le responsabilit dirette dellente territoriale pi prossimo allerogazione del servizio, e cio della Citt
Metropolitana e della Provincia.
Ma prevedere come fa il ddl che allo Stato, per il tramite dellAgenzia nazionale, competa la gestione dei
centri per limpiego, non appare coerente con il principio costituzionale di prossimit dei servizi, n funzionale
ad un rinnovato assetto del mercato del lavoro in quanto, a differenza delle politiche passive erogate
dallINPS, le politiche attive richiedono servizi che conoscano e rispondano al territorio ed alle sue peculiarit
e potenzialit e che riconoscano le diversit e specificit delle persone e delle imprese sul territorio.
LAgenzia nazionale deve dunque: coordinare i servizi per limpiego, promuovere standard e livelli essenziali
delle prestazioni, garantire e promuovere i programmi nazionali e le azioni di sistema di politica attiva,
coordinare i diversi livelli nei progetti, svolgere azioni sussidiarie ed assistenza ai territori in difficolt mentre
non deve coordinare agenzie regionali, inutili rispetto al modello proposto, ma i territori, le istituzioni del
mercato del lavoro ed i servizi preposti .
Viceversa, soprattutto nella prospettiva di un rilancio delle politiche a favore delloccupazione giovanile, si
ritiene essenziale garantire il mantenimento dei centri per limpiego come presidio pubblico territoriale di area
vasta sul mercato del lavoro al nuovo livello provinciale e metropolitano, in quanto snodo di erogazione del
servizio amministrativo del collocamento e delle politiche attive del lavoro (nazionali e regionali).
Lesperienza pi che decennale delle Province nei sistemi territoriali ci porta ad affermare, come peraltro gi
evidenziato in documenti ed incontri ufficiali, come il modello di governance nazionale del mercato del lavoro
che appare pi efficace consista in un sistema in cui le Citt metropolitane e le nuove Province:
a) erogano gli interventi diretti alle persona ed alle imprese sul territorio attraverso la rete dei centri per
limpiego ed altri eventuali sportelli pubblici mirati;
b) partecipano ai programmi nazionali e regionali di politica attiva e determinano dal punto di vista
organizzativo la loro connessione con lattivit dei servizi per limpiego;
c) promuovono gli interventi informativi ed orientativi presso le scuole di loro competenza;
d) gestiscono gli adempimenti amministrativi ed alimentano attraverso i centri per limpiego la tenuta dello
status di disoccupazione e delle comunicazioni obbligatorie le banche dati delle regioni ed i relativi sistemi
informativi;
e) definiscono i percorsi integrati di inclusione sociale attraverso il lavoro per le categorie svantaggiate ed a
rischio di povert.
Quanto alle funzioni che la Provincia esercita su conferimento regionale, esse sono indicate nella tabella
seguente:
POLITICHE
PER IL
LAVORO
- concorso alla elaborazione del programma triennale delle politiche del lavoro
previsto allarticolo 15 (Programma triennale delle politiche del lavoro);
- predisposizione ed approvazione dei piani provinciali degli interventi di cui
allarticolo 17 (Piani provinciali degli interventi);
- organizzazione e gestione del collocamento e le attivit ad esso connesse, nonch
lavviamento a selezione presso le pubbliche amministrazioni;
- organizzazione e gestione delle attivit concernenti le politiche attive del lavoro di
cui al capo VI citata legge regionale, fatta eccezione per quelle che richiedono
lunitario esercizio a livello regionale,
L.r. 34/08,
art. 9
35
- istituzione, organizzazione e gestione dei centri per limpiego di cui allarticolo 20,
nellambito dei bacini individuati dalla Regione; - governo della rete locale dei servizi
per il lavoro, da svolgere attraverso il coordinamento degli operatori pubblici e privati
accreditati e laffidamento di servizi ai soggetti pubblici e privati, anche mediante il
conferimento di risorse pubbliche, nel rispetto delle disposizioni concernenti le
procedure ad evidenza pubblica;
- collaborazione con la Regione nellattivit di promozione e realizzazione di analisi
del mercato del lavoro;
L.r.
34/08,art.
14
- erogazione, tramite i Centri per limpiego, dei servizi individuali e collettivi connessi
al collocamento ordinario, agricolo, dello spettacolo, al collocamento dei lavoratori
non appartenenti allUnione Europea, dei lavoratori a domicilio, dei lavoratori
domestici e mirato, quali linformazione, i colloqui di orientamento, la preselezione e
lincontro tra domanda e offerta di lavoro;
- attivit di certificazione della conservazione, perdita e sospensione dello stato di
disoccupazione;
- servizi di orientamento finalizzati allinserimento o reinserimento dei soggetti nel
mercato del lavoro mediante misure di miglioramento delloccupabilit e di
accompagnamento alla ricerca di lavoro;
- formulazione di proposte di riqualificazione e formazione professionale e servizi di
prevenzione della disoccupazione di lunga durata, sostegno alla mobilit geografica
dei lavoratori e monitoraggio dei flussi del mercato del lavoro;
- gestione dellavviamento a selezione presso le pubbliche amministrazioni ai sensi
dellarticolo 16 della l. 56/1987;
- attivit di sostegno alla stabilizzazione dei contratti di lavoro ed ai processi di
regolarizzazione del lavoro;
- gestione delle attivit inerenti gli interventi di politica attiva del lavoro previsti al
capo VI, fatto salvo quanto previsto allarticolo 4, comma 2.
L.r.
34/08,art.
20
- collaborazione con la Regione nellambito delle procedure daccreditamento degli
operatori pubblici e privati.
L.r. 34/08,
art. 21
- realizzazione di cantieri di lavoro in base alle risorse finanziarie attribuite dalla
Regione;
L.r. 34/08,
art. 32
- individuazione dei criteri e delle priorit di utilizzo dei fondi trasferiti dalla Regione
per la concessione dei contributi per linserimento lavorativo di determinati soggetti.
L.r. 34/08,
art. 33
- concorso con la Regione allinserimento lavorativo delle persone disabili di cui
allart. 12 bis della l. 68/1999, previa individuazione delle stesse attraverso i centri
per limpiego e gestione del relativo fondo (Fondo regionale per loccupazione ei
disabili)
L.r. 34/08,
art. 34, 35
- attivazione di idonei servizi finalizzati al mantenimento del posto di lavoro delle
persone inserite;
- erogazione di risorse finanziarie per i progetti di inserimento lavorativo;
L.r. 34/08,
art. 36
- promozione e sostegno della qualificazione dei tirocini, nellambito delle previsioni
del programma triennale della Regione
L.r. 34/08,
art. 41
- concorso con la Regione e gli enti locali, alla concessione di contributi,
finanziamenti agevolati e garanzie di accesso al credito, servizi di
accompagnamento ed assistenza tecnica finalizzati anche al trasferimento di
impresa extra famiglia, nascita e sviluppo di iniziative di uto impiego
L.r. 34/08,
art. 42
- prevenzione, in concorso con la regione, enti locali e parti sociali di situazioni di
crisi territoriali, settoriali ed aziendali e salvaguarda dei livelli occupazionali;
- promozione di progetti di ricollocazione professionale nel mercato del lavoro a
L.r.
34/08,art.
43
36
favore di determinati soggetti.
- formazione e gestione degli elenchi del personale in disponibilit di cui allarticolo
34, comma 3, del d.lgs. 165/2001 ai fini della riqualificazione professionale e
ricollocamento presso altre amministrazioni .
L.r. 34/08,
art. 44
- concorso con la regione nellattuazione di interventi specifici di politica attiva del
lavoro a favore delle donne.
L.r. 34/08,
art. 51
- promozione e incentivazione, in concorso con la Regione e gli Enti Locali, di forme
di articolazione della prestazione lavorativa e dellorganizzazione del lavoro volte a
favorire la conciliazione tra tempi di vita e di lavoro ai sensi della legge 8 marzo
2000, n. 53;
- sostegno, anche finanziario, di progetti proposti da aziende e da enti.
L.r. 34/08,
art. 53
Fonte: Regione Piemonte, 2014
Allo stesso modo di quanto si detto in materia di istruzione, le funzioni sopra indicate potrebbero risultare
ridefinite allesito della riforma statale in corso, determinando una compressione (o viceversa unespansione)
della potest legislativa regionale.
In ogni caso, nellottica di un efficace coordinamento tra i livelli di governo, nellambito della potest legislativa
concorrente lo Stato e le Regioni dovrebbero:
d) definire la regolazione del sistema della condizionalit tra politica passiva e la partecipazione ai programmi
obbligatori di politica attiva;
e) definire laccreditamento dei soggetti privati sulla base di standard uniformi tra le regioni;
f) definire la remunerazione dei servizi avanzati per il lavoro, pagati a voucher resi disponibili per il disoccupato
e parte del diritto-dovere allinserimento lavorativo;
g) alimentare le banche dati sulle opportunit di impiego e le politiche attive;
h) verificare gli standard effettivi dei servizi accreditati;
i) verificare e garantire la corrispondenza tra i fabbisogni professionali delle imprese rilevati e leffettiva offerta
formativa disponibile ;
j) gestire i sistemi e le reti dellorientamento ed apprendimento permanente;
k) concorrere con premialit nella programmazione di una quota del 20 per cento del Fondo sociale europeo,
data a premialit tra Stato e regioni sulla base dei risultati dei programmi.
E infine, nellambito della potest legislativa esclusiva regionale, la Regione dovrebbe:
a) programmare una quota consistente dei fondi europei, definendo programmi di politica attiva avanzati,
legati in particolare alle condizioni del territorio ed alla prevenzione dal rischio delle crisi;
b) gestire le task force di intervento sulle crisi e programmano le relative azioni nel rapporto tra incentivi e
fondi;
c) rinforzare la capacit di analisi ed elaborazione dei dati dellOsservatorio sul mercato del lavoro, come
patrimonio specifico della programmazione delle politiche attive del lavoro, della formazione professionale,
dellistruzione e dellorientamento.
37
QUARTA COMMISSIONE CONSILIARE
Viabilit, Trasporti, Grandi Infrastrutture, Espropriazioni
In materia di viabilit, la Provincia esercita le seguenti funzioni di derivazione regionale:
VIABILITA
(Demanio
stradale e
programmazion
e degli
interventi)
- gestione delle strade di propria competenza;
- approvazione del Piano triennale di investimenti e di interventi
(Regione di concerto con le province).
L.r.
44/00,
art. 101
VIABILITA
(Progettazione,
manutenzione e
vigilanza sul
demanio
stradale)
- progettazione e costruzione degli interventi di attuazione della
programmazione sulla rete provinciale;
- manutenzione ordinaria, straordinaria, programmata delle strade
demaniali provinciali trasferite dallo Stato;
- poteri e compiti di cui allart. 14, DLgs 285/92 (controllo dellefficienza
delle strade e apposizione e manutenzione della segnaletica);
- classificazione e declassificazione amministrativa delle strade
provinciali;
- vigilanza sulla rete provinciale e sulle strade demaniali provinciali
trasferite dallo Stato.
L.r.
44/00,
art. 102
VIABILITA
(Usura stradale)
- rilascio dellautorizzazione alla circolazione ed introito del relativo
indennizzo per lusura;
- determinazione de criteri per la ripartizione ed il trasferimento delle
somme percepite a titolo di indennizzo a favore degli enti proprietari
delle strade.
L.r.
16/04,
art. 4
VIABILITA
(Autorizzazioni
per gare)
- rilascio delle autorizzazioni di competenza regionale per lespletamento
di gare con autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, nonch gare
atletiche, ciclistiche, con animali o con veicoli a trazione animale.
L.r.44/00,
art. 80
38
VIABILITA
(Concessioni per
pubblicit)
- determinazione dei criteri per la fissazione e la riscossione delle tariffe
relative alle licenze, alle concessioni ed allesposizione della
pubblicit lungo le strade trasferite al demanio provinciale.
L.r.
44/00,
art. 102
VIABILITA
(Autorizzazioni per
mezzi pesanti)
- rilascio delle autorizzazioni alla circolazione dei veicoli e dei trasporti
eccezionali per tutta lestensione della rete viaria regionale,
provinciale e comunale.
L.r.
16/04,
art. 2
VIABILITA
(Autorizzazioni in
regime di
concorrenza)
- autorizzazione del servizio di trasporto esercitato da terzi in regime di
concorrenza.
L.r. 1/00,
art. 3
VIABILITA
(Regolamentazione
sulla circolazione)
- regolamentazione della circolazione sulla rete stradale del demanio
regionale di cui al Codice della Strada.
L.r.
16/04,
art. 2
TRASPORTI
(Programmazione e
gestione dei servizi di
trasporto pubblico
locale su gomma)
- partecipazione alla programmazione regionale attraverso la
stipulazione di apposita intesa (con la Regione e gli altri enti locali)
- programmazione operativa ed amministrazione dei servizi TPL
attraverso l'elaborazione del piano provinciale dei trasporti e del
programma triennale dei servizi di trasporto pubblico locale;
- partecipazione alla definizione della politica tariffaria regionale e delle
strategia regionale di promozione del TPL
L.r. 1/00,
art. 4,5,
12
- rilascio delle concessioni di autostazioni per servizi di linea L.r. 1/00,
art. 5
- rilascio, sospensione revoca dell'autorizzazione all'uso in servizio di
linea degli autobus destinati al servizio di noleggio con conducente
L.r. 1/00,
art. 5
TRASPORTI (Servizi di
trasporto pubblico non
di linea su strada
taxi)
- funzioni amministrative inerenti al settore del trasporto di persone
mediante servizi pubblici non di linea su strada, compresi anche quelli
effettuati a mezzo veicoli a trazione animale.
- individuazione delle delimitazioni territoriali e misure di contenimento di
licenze e di autorizzazioni cui i comuni devono attenersi e vigilanza sui
servizi pubblici non di linea.
- costituzione di commissioni consultive per l'esercizio dei servizi e
sull'applicazione dei regolamenti.
L.R.
24/1995,
artt.2, 3,
4, 5 e 6
- istituzione presso ciascuna delle CCIAA del Piemonte del ruolo
provinciale dei conducenti di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea;
- Partecipazione alla commissione desame per valutazione dellidoneit
alliscrizione.
L.r.
21/1992,
art. 6
- individuazione di criteri e modalit per la presentazione delle domande
e per l'assegnazione dei contributi per il rinnovo del materiale rotabile a
favore dei servizi complementari al trasporto pubblico di linea.
L.r.
3/2000,
art. 5
TRASPORTI (Impianti
funiviari in servizio
pubblico per il
- concessione per la costruzione e l'esercizio di impianti funiviari in
servizio pubblico per il trasporto di persone nel caso in cui gli impianti
insistano sul territorio di pi comuni facenti parte della medesima
provincia.
L.r.
74/1989,
artt. 3,
10, 1,
39
trasporto di persone) - approvazione delle tariffe, orari e periodi di apertura al pubblico-
esercizio degli impianti funiviari
- vigilanza sulla costruzione e l'esercizio degli impianti funiviari in servizio
pubblico per il trasporto di persone, secondo le proprie attribuzioni.
13,14 e
16
TRASPORTI (Trasporto
di viaggiatori effettuato
mediante noleggio di
autobus con
conducente)
- definizione del numero massimo di autorizzazioni da prevedere nei
regolamenti comunali, in materia di servizi di noleggio con veicoli della
categoria m1 [veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo
otto posti a sedere oltre al sedile del conducente].
L.r.
1/2000,
art. 5
- rilascio dell'autorizzazione al servizio di noleggio degli autobus destinati
al servizio di linea relativamente alle linee di propria competenza;
- accertamento della permanenza dei requisiti prescritti;
- irrogazione e la riscossione delle sanzioni amministrative prescritte.
- gestione delle sezioni provinciali del registro regionale delle imprese
esercenti l'attivit di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus
con conducente.
L.r.
22/2006,
artt. 3 e
5
TRASPORTI
(Regolazione e
vigilanza in materia di
navigazione interna)
- rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di manifestazioni nautiche
o di altro tipo che interferiscono con la navigazione e interessano due o
pi comuni, una o pi province, regioni limitrofe o stati esteri,
limitatamente al demanio idrico regionale;
- tenuta dei registri delle navi minori e dei galleggianti, il rilascio delle
licenze di abilitazione, dei certificati di navigabilit e di ogni altro
adempimento connesso;
- tenuta dei registri di costruzione delle navi e dei galleggianti;
- rilascio di estratti cronologici, comprese le funzioni amministrative
collegate;
- rilascio di giornali di bordo, comprese le funzioni amministrative
collegate;
- rilascio del registro dei reclami, comprese le funzioni amministrative
collegate;
- rilascio dell'inventario di bordo, comprese le funzioni amministrative
collegate;
- tenuta dei registri ed il rilascio della licenza di abilitazione alla
navigazione delle imbarcazioni ad uso privato.
- partecipazione alla funzione regionale di regolamentazione delle vie
navigabili;
L.r.
2/2008,
artt.3 e 5
TRASPORTI
(Regolazione e
vigilanza in materia di
servizi di trasporto
pubblico di
navigazione non di
linea)
- predisposizione della metodologia di calcolo del fabbisogno teorico di
offerta del servizio di trasporto pubblico di navigazione non di linea;
- predisposizione di norme che consentano l'esercizio sovracomunale del
servizio di trasporto pubblico di navigazione non di linea per
raggruppamenti omogenei di comuni individuati dalle stesse norme, in
considerazione dei prescritti fattori.
- vigilanza sulla regolarit ed il buon andamento dei servizi di trasporto
pubblico di navigazione non di linea e sull'attivit delle scuole nautiche
tramite la redazione di appositi regolamenti sulla base della normativa di
riferimento.
- istituzione presso ciascuna delle CCIAA del ruolo provinciale dei
conducenti di veicoli adibiti a servizi pubblici di navigazione non di linea.
L.r.
2/2008,
artt. 3, 5
e 24
40
- partecipazione alla commissione di vigilanza sull'esercizio dei servizi
pubblici di navigazione non di linea.
TRASPORTI
(Programmazione degli
interventi di
infrastrutture
logistiche)
- partecipazione alla programmazione regionale degli interventi relativi
agli interporti ed alla logistica
L.r.
8/2008,
art. 2
Il deficit infrastrutturale della futura Citt Metropolitana contribuisce in modo significativo alla perdita di
competitivit economica del sistema produttivo piemontese colpito, in modo rilevante, dalla crisi e
caratterizzato da una ripresa rallentata di cui la provincia di Torino rappresenta lelemento di forza, sia dal
punto di vista quantitativo che qualitativo. Deficit infrastrutturale significa non solo marginalizzazione e costi
maggiori per il sistema produttivo, con conseguente perdita di competitivit nel contesto internazionale e
nazionale, ma costi ambientali e sociali sempre pi pesanti che gravano soprattutto sui residenti e sugli
utenti dellarea metropolitana torinese (congestione da traffico, inquinamento atmosferico ed acustico).
Il rilancio del sistema di investimenti nelle infrastrutture ed, in particolare, il trasferimento modale di una quota
rilevante del traffico pesante dalle strade alla ferrovia rappresenta una politica necessaria che produrr, nella
fase di realizzazione, ricchezza ed occupazione (breve termine) e costituir, a medio-lungo termine, una
grande opportunit di rilancio del sistema produttivo piemontese ed in particolare nellarea metropolitana
torinese (attraverso la riduzione del deficit logistico che comporta un rilevante incremento della
competitivit), di riduzione dei costi sociali (congestione da traffico) e degli impatti ambientali (inquinamento
atmosferico ed acustico).
E necessario pertanto rinnovare limpegno esplicito delle istituzioni, del mondo economico e del sociale, per la
realizzazione compiuta del sistema infrastrutturale della futura Citt Metropolitana quale volano per il rilancio
dellintero sistema piemontese, dando concreta attuazione agli interventi prioritari sulle grandi infrastrutture,
qui di seguito elencati:
- la realizzazione dei corridoi europei che collegano il Piemonte allEuropa (per il nostro territorio il
corridoio 5 Torino Lione e lHUB logistico di Orbassano);
- la realizzazione compiuta del Sistema Ferroviario Metropolitano e del Sistema Metropolitano Torinese
(come struttura di un rinnovato trasporto pubblico locale, in grado di migliorare lefficacia, lefficienza e
laccessibilit al principale attrattore della Regione e di ridurre la congestione ed il carico ambientale
nellarea metropolitana);
- il completamento ed il potenziamento del Sistema Tangenziale Torinese con la realizzazione degli
assi di Corso Marche e della Tangenziale Est
41
La Nuova Linea Ferroviaria Torino Lione rappresenta la scelta strategica di connessione internazionale del
nostro territorio con il corridoio 5 Lisbona-Kiev: una moderna infrastruttura ferroviaria europea che consentir,
attraverso adeguate politiche di sostegno, un effettivo trasferimento del traffico merci dalla strada alla ferrovia,
la disponibilit delle linee tradizionali per il trasporto pubblico locale, collegamenti europei passeggeri di livello
e qualit europea per la Francia e lInghilterra, la Spagna ed il Portogallo.
Gli effetti di tale investimento strategico, il pi rilevante realizzato con il contributo diretto dellU.E., sono
assolutamente importanti sia dal punto di vista economico - sociale che dal punto di vista ambientale. Infatti,
nellarco di 10 anni ed a fronte di un costo complessivo di 8,5 MLD, la realizzazione della tratta Torino-Lione
sul territorio torinese generer una produzione lorda di 18,2 MLD ed un valore aggiunto di 7,9 MLD. Secondo
queste stime la Torino-Lione potr generare una crescita del PIL torinese pari all'1% circa ed avr ricadute
occupazionali importanti, che si quantificano in almeno 7-8 mila occupati all'anno.
A medio-lungo termine poi, attraverso la compiuta realizzazione dellHUB di Orbassano, la nuova linea Torino
Lione costituir una grande opportunit di rilancio del sistema produttivo piemontese consentendo una
riduzione del deficit logistico. Di conseguenza si otterr un rilevante incremento della competitivit del
sistema manifatturiero torinese, sempre pi orientato allesportazione.
A regime la realizzazione della nuova linea dovr consentire il passaggio di una quota rilevante del traffico
pesante dalle strade alla ferrovia e rappresenta pertanto una scelta in grado di ridurre i costi sociali
(congestione da traffico) e gli impatti ambientali (inquinamento atmosferico ed acustico), nonch contribuire in
modo importante alla riduzione dei gas serra.
La Regione Piemonte e la Provincia di Torino hanno condotto un importante lavoro a sostegno della
realizzazione dellopera in collaborazione con il Commissario di Governo e attraverso lo strumento dell
Osservatorio Tecnico Torino Lione.
LOsservatorio Tecnico Torino-Lione la sede di confronto tecnico e di discussione collegiale tra i diversi
soggetti interessati dalla tratta (Stato, Regione, Provincia, Amministrazioni Locali, Enti Attuatori). Il suo
obiettivo quello di fornire alle istituzioni gli strumenti e le valutazioni necessarie a raggiungere una decisione
consapevole in merito all'opportunit ed ai modi di realizzazione dell'Alta Capacit ferroviaria Torino-Lione; in
altre parole di svolgere la funzione di governance unitaria del Progetto della Nuova Linea Torino Lione
(N.L.T.L.). Con la supervisione ed il coordinamento dellOsservatorio, stato concluso in data 25 giugno 2010
liter di predisposizione del Progetto Preliminare da parte di LTF e RFI-ITALFERR.
Il percorso condotto ha consentito di disporre di un Progetto Preliminare unitario per lintera linea Torino-Lione
da Settimo Torinese al Confine di Stato: un progetto preliminare sostanzialmente condiviso dalla maggioranza
degli Enti Locali interessati e che, proprio in quanto preliminare, serve a raccogliere critiche e proposte
migliorative.
Per la tratta comune Confine di Stato Chiusa San Michele, sottoposta a scadenze europee, la procedura
stata avviata il 10 agosto 2010. Il progetto stato approvato in linea tecnica dal Comitato Interministeriale per
la Programmazione Economica (CIPE) il 3 agosto 2011 (Delibera n. 57). A seguito di autorizzazione della
commissione intergovernativa, lordine di servizio per lavvio del progetto definitivo stato emesso il 6
dicembre 2011, con data di inizio 9 gennaio 2012.
Il 20 dicembre 2011 a Parigi, la Commissione Intergovernativa ha approvato il testo del nuovo Accordo bi-
nazionale, che stabilisce la realizzazione della Nuova Linea Torino Lione per fasi funzionali.
Ad Aprile 2013, conclusa la progettazione definitiva, stato ufficialmente avviato liter approvativo del Progetto
definitivo della Sezione Transfrontaliera, che porter alla dichiarazione di pubblica utilit.
Rispetto agli impegni presi con lU.E., sono state rispettate le scadenze di avvio dei lavori per la discenderia di
Chiomonte (maggio 2011) e di firma del nuovo accordo italo-francese (con nuova ripartizione dei costi
finanziari), avvenuta il 30 gennaio 2012. Il prossimo vincolo fondamentale da rispettare senzaltro lapertura
del cantiere per il tunnel di base.
42
Per la tratta nazionale SantAmbrogio di Torino Settimo Torinese, non sottoposta a scadenza europea, la
fase valutativa ed approvativa del Progetto Preliminare stata finalmente avviata con la pubblicazione il 27
marzo 2011 e con la trasmissione del progetto preliminare agli Enti interferiti ed al Ministero dellAmbiente (VIA
Nazionale). La Provincia di Torino ha messo in salvaguardia lintero tracciato, comprensivo della tratta
nazionale, con il PTCP approvato dal Consiglio Provinciale il 29 luglio 2010.
La Regione Piemonte e la Citt Metropolitana dovranno quindi confermare il pieno sostegno alla Nuova
Linea Torino Lione, che sar realizzata per fasi funzionali, dando priorit alla realizzazione del Tunnel di Base
e del Nodo ferroviario di Torino e richiedendo con forza al Governo di onorare gli impegni sottoscritti nell atto
integrativo Stato-Regione Piemonte del 03/02/20091. Dovranno impegnarsi a partecipare e sostenere
politicamente e tecnicamente lOsservatorio Torino Lione nelle fasi di approvazione del progetto della NLTL e
proseguire nellimpegno di miglioramento del progetto, con particolare attenzione agli impatti nella fase di
cantierizzazione, attraverso linterlocuzione continua con i proponenti LTF e RFI e con le Amministrazioni
locali interessate allopera.
1 LAtto Integrativo dellintesa quadro Regione-Governo per il riequilibrio modale ed il potenziamento del trasporto pubblico locale sul sistema di
rete riconducibile allasse Torino-Lione rappresenta una prima risposta agli impegni assunti dal Governo con il documento di Palazzo Chigi del 29
luglio 2008. Latto prevede opere per 300 milioni di euro (200 richiesti al Governo e 100 finanziati dalla Regione con fondi FAS) per avviare
immediatamente una prima serie di interventi concreti per il trasferimento modale e per potenziare il trasporto locale (il sistema ferroviario
metropolitano torinese). Vengono definiti 7 interventi :
Interconnessione ferrovia Torino-Ceres con passante ferroviario a Rebaudengo (C.so Grosseto) 162,00 Mln
Attivazione della fermata Zappata sul passante 15,75 Mln
Attivazione fermata Dora sul passante 23,00 Mln
Collegamento Dora-GTT e Dora-FS 1,00 Mln
Nuova fermata Orbassano e rifunzionalizzazione scalo 10,00 Mln
Attrezzaggio terminali del centro intermodale di Orbassano 10,00 Mln
Acquisto materiale rotabile (prima tranche di 10 treni) 80,00 Mln
43
Il Trasporto Ferroviario rappresenta la soluzione socialmente, ambientalmente ed economicamente pi
sostenibile per il trasporto delle persone e delle merci.
Per questo la Provincia di Torino e la Regione Piemonte sostengono da sempre la realizzazione compiuta del
progetto di Sistema Ferroviario Metropolitano (SFM) che costituisce il modello a cui tendere per
raggiungere una mobilit effettivamente sostenibile.
Il progetto volto a potenziare il trasporto su ferro, sfruttando al meglio gli interventi in corso di realizzazione
sul nodo ferroviario di Torino. Il SFM costituisce il primo livello dellarchitettura del sistema di trasporto
pubblico dellarea metropolitana: concepito come sistema a s, come i servizi RER di Parigi, VOR di Vienna
e S-Bahn di Zurigo.
Grazie al quadruplicamento del nodo ferroviario di Torino (Passante Ferroviario), le Linee di Ferrovia
Metropolitana percorrono da un capo allaltro larea torinese e attraversano tutte il nodo di Torino. Il baricentro
del sistema la stazione di Porta Susa dove possibile interscambiare con tutte gli altri servizi del SFM, con i
servizi ferroviari regionali, con i servizi ferroviari a lunga percorrenza ed internazionali, con la rete
Metropolitana Torinese, e con la rete dei servizi di mobilit urbana.
Il servizio Ferroviario Metropolitano entrato in esercizio con 5 linee, per una lunghezza complessiva di 210
chilometri su unarea compresa in un raggio di circa 50 km da Torino.
Attraverso implementazioni successive, il servizio arriver ad 8 linee, con 93 stazioni collegate. Il Progetto di
SFM trova anticipazione finanziaria nellatto integrativo Stato-Regione Piemonte del 03/02/2009 che prevede,
tra laltro, il finanziamento di alcuni interventi strategici. Inoltre risulta necessario:
- Estendere il sistema della Metropolitana Torinese completando la linea 1 in direzione Rivoli e avviare
la realizzazione delle linea 2 (prima tratta Porta Nuova Rebaudengo);
- programmare lattestamento del TPL sul nuovo sistema ferroviario con lobiettivo di fare
progressivamente convergere sui nodi del SFM e regionali, il trasporto pubblico su gomma gestito
oggi direttamente dalla Provincia per i trasporti extraurbani.
E particolarmente sentita la necessit di accelerare le fasi di realizzazione della linea ferroviaria e della
stazione FM5 del San Luigi di Orbassano; occorre pertanto anticipare la sua messa in funzione rispetto alla
entrata in esercizio della NLTL al fine di ridurre in modo significativo il traffico veicolare da e per lOspedale
San Luigi, dotando i comuni di Beinasco Orbassano - Rivalta Torinese e, a regime, Grugliasco (area le Gru)
di fermate ferroviarie. Allo stesso modo si intende promuovere la realizzazione della fermata
Buttigliera/Ferriera sulla linea 3 e del relativo centro di interscambio modale.
La Regione Piemonte e la Citt Metropolitana dovranno pertanto confermare il pieno sostegno al progetto di
SFM, che trova anticipazione nellAtto integrativo Stato-Regione Piemonte del 03/02/2009 e richiedere con
forza al governo il suo finanziamento. Dovranno convenire sulla necessit di accelerare le fasi di realizzazione
della linea ferroviaria e della stazione FM5 del San Luigi di Orbassano e della fermata Buttigliera/Ferriera sulla
linea 3, anticipando la loro messa in funzione rispetto a quella dellopera complessiva, impegnandosi a
sostenere riguardo alla Metropolitana Torinese:
- la piena realizzazione della linea 1 della Metropolitana (Rivoli);
- la programmazione per lotti funzionali della linea 2;
e a programmare, a partire dal completamento del Passante Ferroviario, lattestamento del TPL sul nuovo
sistema ferroviario con lobiettivo di fare progressivamente convergere sui nodi del SFM e regionali, il
trasporto pubblico su gomma gestito direttamente dalla Provincia per i trasporti extraurbani.
44
Il S.A.T.T. (Sistema Autostradale Tangenziale Torinese) un semicerchio autostradale che si sviluppa ai
margini dellarea metropolitana torinese e raccorda tra di loro le diverse autostrade che convergono su Torino:
a nord la A5 Torino - Ivrea e la A4 Torino - Milano; ad ovest la A32 Torino - Bardonecchia; a sud la A6 Torino -
Savona ed a est la A21 Torino - Piacenza. Il S.A.T.T. costituisce:
- un nodo essenziale nellambito del sistema autostradale che, attraverso il Traforo del Frjus, unisce
lest (la pianura padana) e lovest europeo (la Francia);
- svolge un importante ruolo di collegamento tra i Comuni limitrofi e lagglomerato urbano torinese,
grazie alla presenza di numerosi svincoli di raccordo con la viabilit ordinaria;
- linfrastruttura essenziale per dare attuazione alle politiche di linterscambio modale del sistema
piemontese (HUB SITO S.M. ORBASSANO) connettendo il sistema economico-produttivo della
Regione con il corridoio europeo 5.
Il Sistema Autostradale Tangenziale Torinese (S.A.T.T.) ormai saturo, con livelli di servizio del tutto
insoddisfacenti in ora di punta. Nel 2009 il traffico annuo stato di 88.882.000 veicoli (240.000 veicoli al
giorno), di cui 13.080.000 pesanti (36.000 veicoli al giorno). Nel 2005-2006 ATIVA, con i finanziamenti
dellIntesa Generale Quadro Stato-Regione 11/04/03 - Opere Olimpiche(L.285/2000), ha realizzato primi lavori
di adeguamento dell'interscambio autostradale di Bruere ed i lavori di adeguamento della Tangenziale Sud di
Torino per la costruzione della corsia di emergenza per circa 4 km.
E indispensabile realizzare gli interventi strutturali di adeguamento e potenziamento del Sistema Autostradale
Tangenziale Torinese, in parte gi progettati ed in parte in corso di definizione da parte della Provincia di
Torino e della Regione, attraverso la sua partecipata C.A.P. SpA2, dando piena attuazione, se necessario,
estendendo gli accordi di programma gi sottoscritti e ad oggi operativi.
ATIVA ha presentato ad ANAS il progetto preliminare (3) per la realizzazione del Sistema Autostradale
Tangenziale di Torino - Adeguamento Tangenziale Nord per la costruzione della quarta corsia
dall'Interscambio di Bruere allo svincolo di Falchera tratta Bruere-Borgaro, per una lunghezza complessiva
di circa 11 km.
Il progetto preliminare con il relativo Studio di Impatto Ambientale, al fine dell'inserimento in Legge Obiettivo,
stato presentato dalla societ concessionaria all'ANAS il 30 agosto 2006 per la validazione tecnica ed inserito
nel nuovo piano finanziario presentato dalla societ Ativa S.p.A..
ANAS ha inserito nel piano finanziario 2005/2009 della societ unicamente il tratto Bruere-Borgaro.
Il costo stimato dellintervento (somma non attualizzata) era pari a 57,31 M. Tale intervento non ha mai avuto
corso, a causa della presuntainterferenza esistente con le proposte di realizzazione della Nuova Linea
Torino Lione Gronda Merci allora in discussione. Con la presentazione formale del progetto preliminare della
tratta nazionale della nuova linea Torino Lione che prevede un tracciato interamente sotterraneo in Galleria
Naturale profonda il problema dellinterferenza risulta completamente risolto.
La tangenziale Est, in discussione da pi di 30 anni, completa il sistema tangenziale della conurbazione
torinese, chiudendo lanello del S.A.T.T., con la funzione prioritaria di razionalizzare e potenziare l'armatura
infrastrutturale del sistema metropolitano torinese (Figura n.1).
2
Concessioni Autostradali Piemontesi S.p.A. nasce per dare attuazione alla legge finanziaria per il 2008 che prevede, per la
realizzazione e la gestione di nuove infrastrutture autostradali ritenute strategiche sia a livello nazionale che regionale, che sia
costituita una societ mista ANAS Regione Piemonte. Per poter realizzare la propria mission CAP assume quindi le funzioni ed i
poteri di soggetto concedente ed aggiudicatore, normalmente attribuiti ad ANAS, prevedendo anche il parziale finanziamento
mediante contratti di concessione per la progettazione, costruzione e gestione delle opere.
Il Protocollo d'Intesa fra Ministero delle Infrastrutture, ANAS S.p.A e Regione Piemonte stato sottoscritto in data 8 aprile 2008
3
Il riferimento di programmazione lIntesa Generale Quadro Stato-Regione sottoscritta nel 2003.
45
Lazione della Provincia ha contribuito a sbloccare la definizione del tracciato nel dicembre del 2008, arrivando
a definire il corridoio di minore impatto per la tangenziale Est di Torino in accordo con le Amministrazioni
Locali ed a proporre una soluzione condivisa su cui avviare le fasi di progettazione dellinfrastruttura.
La soluzione progettuale, in corso di approfondimento da parte di C.A.P. S.p.A., prevede due corsie pi
l'emergenza per ogni senso di marcia. Nella tratta collinare il tracciato quasi completamente in galleria e si
collega da un lato al nuovo ponte sul Po, tra l'ex S.S. 11 e l'ex S.S. 590, dall'altro all'autostrada Torino-
Piacenza nei pressi di Pessione (frazione del comune di Chieri). La lunghezza complessiva del percorso di
circa 22 km di cui circa 9,1 km in galleria.
Come gi anticipato ANAS ha dato mandato alla societ di diritto pubblico "Concessioni Autostradali
Piemontesi S.p.A." (C.A.P. S.p.A.) di avviare la fase realizzativa, coerentemente con il corridoio concordato
tra la Provincia e le Amministrazioni locali. Attualmente in corso di conclusione lo studio di fattibilit
(comprensivo oltre che degli elementi tecnico progettuali della analisi dei flussi, del modello, del sistema di
pedaggiamento e del Piano Economico Finanziario quota di cofinanziamento pubblico) finalizzato a
procedere alla gara per lindividuazione del Promotore; i partecipanti dovranno predisporre il Progetto
preliminare e proporre le migliori condizioni economiche finanziarie per la gestione (durata concessione e
quota di cofinanziamento pubblico).
La Provincia, nellambito dellAccordo di Programma sottoscritto con la Regione il 03/06/2009 ha predisposto,
avvalendosi di C.A.P. Spa:
1. il completamento dello studio di fattibilit della Tangenziale Est di Torino, costituito da:
studi di traffico relativi al SATT esistente, al sistema Tangenziale Est, e a Corso Marche;
indagini geognostiche;
2. gli atti necessari allespletamento delle gare per lindividuazione del soggetto proponente lopera.
Le funzioni di coordinamento delle attivit, compresa la concertazione e la condivisione delle proposte
elaborate da C.A.P. S.p.A. con le Amministrazioni Coinvolte (comitato di Pilotaggio), sono state svolte dalla
Provincia di Torino.
ANAS, in attesa della predisposizione della documentazione relativa alla gara comprensiva del Piano
Economico Finanziario (P.E.F.), per procedere alla gara ritiene che possa rendersi necessario abbinare la
gara della Tangenziale Est al rinnovo della concessione del Sistema Autostradale Tangenziale Torinese
(affidato ad ATIVA in scadenza nel 2016). Una tale situazione sposterebbe i termini della gara di ulteriori 5
anni ed escluderebbe il Piemonte (C.A.P. S.p.A.) dalla gestione della Gara di Concessione, che resterebbe in
capo ad ANAS.
46
Figura 1: INTERVENTI SULLA VIABILITA PRINCIPALE: Sistema Autostradale Tangenziale Torinese
La Regione Piemonte e la Citt Metropolitana dovranno:
Rilanciare il decentramento regionale delle funzioni di ANAS (avviato con CAP esclusivamente per
Tangenziale Est e Corso Marche) richiedendo lestensione di tale delega anche al Sistema Autostradale
Tangenziale Torinese la cui concessione in scadenza al 2016.
Nellattesa del trasferimento avviare le procedure di gara per lindividuazione del promotore, attribuendo il
finanziamento della parte non coperta dal concessionario (determinato in sede di gara) al rinnovo della
concessione SATT.
La Regione Piemonte e la Citt Metropolitana dovranno concludere la predisposizione della
documentazione necessaria alle procedure di gara e ad avviare le procedure per la gara di project financing
per individuare il concessionario.
E insita tuttavia la consapevolezza che lo studio di CAP evidenzia come, in mancanza di un contributo
pubblico, che non sembra essere disponibile, praticamente impossibile realizzare lopera neppure nellipotesi
pi ottimistica sui rientri finanziari derivanti dal flusso dei ricavi della sua gestione. Per cui, per ovviare a tale
situazione, stato ipotizzato di poter impegnare per la sua costruzione e gestione da parte degli introiti del
pedaggio di unaltra societ concessionaria (lATIVA spa, di cui la Provincia azionista), senza per alcun
risultato finora utile allo scopo. Sulla base di dette considerazioni, sarebbe auspicabile che la Citt
Metropolitana, e con essa il Comune di Torino e la Regione Piemonte, assumessero quelle iniziative affinch
si possa procedee a eseguire progetti realizzabili per tale improcrastinabile infrastruttura, anche perch con
lattuazione della razionalizzazione del sistema autostradale (in corso di elaborazione al Ministero delle
Infrastrutture, con laccorpamento delle societ concessionarie per tratte continue e comunicanti), si
potrebbero ricercare quei finanziamenti utili per realizzare opere autostradali non inserite nei piani finanziari
delle attuali concessionarie, come la Tangenziale EST.
Di certo, il tracciato di tale opera andrebbe comunque ragionevolemente riproposto per contenere i costi con
un percorso, non pi come ipotesi di studio difficilmente realizzabile, ma con un progetto economicamente
fattibile.
47
Da pi di 50 anni Corso Marche rappresenta il principale nodo strategico per l'intera area metropolitana
torinese, individuato e trattato a pi riprese nel dibattito tecnico/politico. Infatti l'asse di corso Marche
costituisce oggi l'opportunit per realizzare un'opera unica nel territorio italiano: un corridoio infrastrutturale
che integri, su pi livelli, la nuova linea ferroviaria Torino-Lione; un nuovo tratto di autostrada tangenziale
sotterranea ed un nuovo viale urbano di superficie. Allo stesso tempo lopera in grado di promuovere un
intervento strutturale per il riequilibrio socio economico dell'area metropolitana, grazie alla "nuova centralit ed
accessibilit" delle aree limitrofe che risultano idonee ad essere utilizzate per funzioni terziarie e produttive di
livello superiore.
La Regione Piemonte, la Provincia di Torino ed i Comuni di Torino, Collegno, Grugliasco e Venaria
Reale, con la partecipazione della Camera di Commercio di Torino, hanno sottoscritto in data 18 luglio 2005
un Protocollo di Intesa per la realizzazione dellasse integrato del corso Marche e del connesso studio di
riassetto territoriale, aggiornato l8 luglio 2008.
Le motivazioni alla base del citato Protocollo nascono dallesigenza di realizzare un nuovo raccordo
infrastrutturale lungo il corridoio del corso Marche, circostanza che favorisce inoltre il ridisegno urbanistico di
unampia porzione del territorio metropolitano limitrofo. Tale Corridoio interessa pi comuni ed baricentrico
rispetto al settore ovest dellArea Metropolitana Torinese (A.M.T.) (Figure n.2a e 2b).
Figura 2a: Corso marche - autostrada in g.a. Figura 2b: Corso marche Viale di superficie
Gli Enti sottoscrittori del protocollo hanno realizzato una serie di studi preliminari finalizzati alla conoscenza dei
diversi elementi di criticit connessi alla realizzazione del progetto del corridoio plurimodale di corso Marche e
delle aree connesse: (Studio sullevoluzione futura del distretto logistico Torino Sud, Studio di ridisegno
territoriale del corridoio, Studio sui flussi e sui caratteri progettuali del raccordo ferroviario, Studio sui flussi e
sui caratteri progettuali del raccordo autostradale e del viale urbano, Meta-progetto ingegneristico dellasse
integrato del corso Marche)
La Provincia, nellambito dellAccordo di Programma sottoscritto con la Regione il 03/06/2009, impegnata a:
1) predisporre la redazione degli studi necessari per il riassetto e linquadramento territoriale e
predisposizione del progetto di ridisegno territoriale del corridoio plurimodale di corso Marche
(comprensivo di viale urbano);
48
2) concorrere alla progettazione infrastrutturale del viale urbano di superficie fino alla concorrenza di
100.000,00 Euro avvalendosi di C.A.P. S.p.A.;
3) redigere gli studi sui flussi di traffico indispensabili alla valutazione della sostenibilit (funzionale,
ambientale ed economica) dellinfrastruttura;
4) redigere ed approvare ladeguamento del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e promuovere,
in accordo con i comuni di Torino, Venaria, Collegno e Grugliasco, le varianti dei Piani Regolatori
Generali, allo scopo di attuare un regime di salvaguardia sulle porzioni di territorio interessate dal disegno
territoriale condiviso;
5) definire in condivisione con la Regione, sulla base di adeguate valutazioni economiche e finanziarie, la
forma, le caratteristiche, i contenuti, la missione e le funzioni del Soggetto per il governo dei processi di
trasformazione urbana indispensabile allattuazione coordinata degli interventi previsti dallassetto
territoriale di Corso Marche;
Le funzioni di coordinamento delle attivit, compresa la concertazione e la condivisione delle proposte
elaborate da C.A.P. S.p.A. con le Amministrazioni Coinvolte sono in capo alla Provincia di Torino. Una parte
considerevole delle attivit previste stata realizzata dalla Provincia di Torino:
1. redazione degli studi necessari per il riassetto e linquadramento territoriale, e predisposizione del progetto
di ridisegno territoriale del corridoio plurimodale di Corso Marche (Master Plan);
2. affidamento degli incarichi di progettazione infrastrutturale del viale urbano di superficie e redazione degli
studi sui flussi di traffico indispensabili alla valutazione della sostenibilit (funzionale, ambientale ed
economica) dellinfrastruttura;
3. redazione della variante di Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale al fine di definire un primo
livello di tutela dei corridoi infrastrutturali, delle aree di interesse pubblico e di valorizzazione urbanistica
individuate nel Master Plan (che richiedono una progettazione e realizzazione unitaria), individuando nel
Tavolo Tecnico di Corso Marche, operativo in tale funzione dal luglio 2010, lo strumento di sua
applicazione.
Per dare concreta attuazione al progetto necessario procedere alla progettazione ed alla realizzazione delle
infrastrutture sotterranee (ferroviaria e autostradale).
Non si ritiene possibile infatti effettuare interventi in superficie senza la consapevolezza delle trasformazioni
che avverranno nel sottosuolo, dal momento che gli interventi infrastrutturali previsti, sia ferroviari che
autostradali, vincolano in modo rilevante la conformazione del viale di superficie e di conseguenza il processo
di formazione di nuovi Strumenti Urbanistici e della Societ di gestione delle trasformazioni urbane.
Per questo risulta indispensabile una soluzione che sblocchi la realizzazione del corridoio integrato di
Corso Marche senza attendere la realizzazione dellintervento della NLTL.
La soluzione prefigurata prevede laccompagnamento dello studio di fattibilit per lavvio della fase di project
financing (comprensivo di Piano Economico Finanziario, Studio di dettaglio dei flussi di traffico - scambio
superficie-autostrada - Progetto dellopera, Svincoli e Piano di pedaggiamento, Inserimento Architettonico,
Bando di gara per lindividuazione del promotore e realizzatore dellopera) con una progettazione integrata (a
livello adeguato) realizzata in accordo con RFI-ITALFERR del tratto interferito (bivio Pronda Corso Francia),
che definisca le infrastrutture comuni e gli interventi di consolidamento necessari (scavo con TBM se
successivo).
La Provincia di Torino, in attuazione di Accordi di carattere regionale (Accordo di Programma sottoscritto il
03/06/2009) ha affidato a C.A.P. S.p.A., gli incarichi per lo Studio di approfondimento tecnico relativo alle
interazioni esistenti tra il viale urbano di superficie e linfrastruttura autostradale sotterranea di Corso Marche
e per la redazione degli studi sui flussi di traffico indispensabili alla valutazione della sostenibilit (funzionale,
ambientale ed economica) dellinfrastruttura. Lincarico affidato dalla Provincia rappresenta, al momento
lunico incarico in corso di svolgimento da C.A.P. S.p.A. su tale intervento.
Lo sviluppo di unattivit progettuale su un corridoio infrastrutturale cos complesso (unica per ambizioni e
difficolt nella storia nazionale), seppur supportata con continuit dalla struttura tecnica della Provincia di
49
Torino (che allo scopo ha destinato proprio personale tecnico), richiede adeguate risorse per lo sviluppo dei
necessari approfondimenti tecnici ed economico-finanziari quali:
il predimensionamento strutturale di alcuni elementi particolarmente complessi come il Capitol o la tratta
su cui gravano le interferenze della N.L.T.L. e della metropolitana;
il predimensionamento dellimpianto di ventilazione della galleria;
una stima delle necessit legate allimpianto di monitoraggio della galleria e del sistema di pedaggiamento
free flow multilane;
il Piano Economico Finanziario per poter comprendere, oltre alla redditivit dellopera che gi conosciamo
a livello di massima, anche la sua sostenibilit finanziaria. La gara di project finacing dellautostrada
potrebbe avvalersi anche di ulteriori elementi che producono redditivit come i parcheggi.
Per la parte interferita con la rete ferroviaria esistente e con la Nuova Linea Torino Lione la progettazione delle
strutture integrate e delle opere di consolidamento (TMB) dovr essere affidata direttamente a RFI-Italferr
(integrati nel gruppo di lavoro) al fine di verificare e concordare, gi nella fase studio di fattibilit, i tempi di
realizzazione, la possibile compresenza dei cantieri, le aree disponibili e le condizioni poste da RFI per le
deviazioni temporanee delle linee ferroviarie di connessione con lo scalo merci di Orbassano.
La Regione Piemonte la Citt Metropolitana dovranno pertanto:
Attivare le risorse necessarie per gli approfondimenti tecnici/economici e finanziari del progetto autostradale
sotterraneo e per lo sviluppo della progettazione integrata con RFI-ITALFERR del tratto interferito dalla
Nuova Linea Torino Lione (bivio Pronda Corso Francia) che definisca le infrastrutture comuni e gli interventi
di consolidamento (necessari per lo scavo con TBM se successivo).
Concordare con Commissario di Governo, Ministero ed RFI che le opere comuni Autostrada-NLTL, siano
previste nel bando di gara e siano realizzate (se necessario) dal concessionario in anticipazione attraverso
convenzione diretta con RFI.
Avviare le procedure di gara per lindividuazione del promotore.
Costituire la societ per la realizzazione delle trasformazioni di superficie di corso Marche (viale di superficie,
trasporto pubblico, sistemazione aree a verde pubblico).
50
QUINTA COMMISSIONE CONSILIARE
Pianificazione territoriale, urbanistica, protezione civile e assistenza tecnica ai comuni
Le quattro funzioni afferenti alla materia dei servizi al territorio, sono trattate in modo differente dalla legge
56/2014.
Per la pianificazione territoriale, la riforma incrementa le attivit di competenza della Citt Metropolitana
introducendo i due nuovi strumenti del piano strategico e del piano territoriale generale. Inoltre, la funzione
di pianificazione diventa pivot delle altre competenze, poich viene esplicitamente richiamata nella funzione
di promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale ed altrettanto posta a base
concettuale, seppur implicita, della strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici.
Viceversa, le funzioni urbanistiche e di protezione civile non sono iscritte in nessuno dei due cataloghi di
funzioni fondamentali delle province e della citt metropolitana. Infine, le attivit di assistenza tecnica ai
comuni vengono confermate nella competenza delle province, quindi indirettamente anche delle citt
metropolitane.
Per quanto concerne i nuovi tre livelli di pianificazione della Citt Metropolitana, anche in relazione con le
competenze in materia urbanistica, si rimanda alla presentazione dal titolo Primi Spunti di riflessione per
unapplicazione operativa nellambito della pianificazione territoriale, presentata alla Commissione
competente del Consiglio Provinciale in data 10 marzo 2014.
La funzione di protezione civile invece una delle funzioni amministrative attualmente previste dalla legge
24/2/1992, n. 225, tuttora vigente. Ai sensi dellart. 1-bis e dellart. 6 di detta legge, le Province sono soggetti
istituzionali del Sistema Nazionale di Protezione Civile. Il successivo art. 13 definisce le competenze delle
Province nellambito delle attribuzioni generali di cui agli artt. 19 e 20 TUEL. Si tratta, quindi, di una cd.
funzione propria, tradizionalmente esercitata dallente di governo dellarea vasta.
Le attivit specifiche vanno dalla partecipazione allorganizzazione e allattuazione del Servizio Nazionale di
Protezione Civile, assicurando lo svolgimento dei compiti relativi alla rilevazione, alla raccolta e
allelaborazione dei dati interessanti la protezione civile, alla predisposizione di programmi provinciali di
previsione e prevenzione e alla loro realizzazione, in armonia con i programmi nazionali e regionali. E inoltre
prevista la presidenza del Comitato provinciale di protezione civile, di cui fa parte un rappresentante del
Prefetto.
Secondo quanto risulta al Consiglio provinciale di Torino, sono altrettanto rilevanti i compiti di raccordo tra il
Dipartimento nazionale, la Regione e i Comuni, consistenti nellemissione quotidiana dei bollettini di
allertamento, con reperibilit 24/7 e 4 canali (fax, mail, sms, e messaggio vocale su cellulare), svolte in
conformit alle regole di allertamento previste dalla D.G.R: in materia. Gli allertamenti sono certificati e
tracciati da una piattaforma distributiva. Infine, da menzionare il supporto offerto ai comuni per la redazione
dei loro piani di protezione civile. Completano le attivit svolte la formazione e il coordinamento del
volontariato, la gestione dei relativi bandi e interventi specifici ma di assoluta rilevanza, come quelli svolti in
occasione delle numerose emergenze sul territorio.
Nonostante una simile intensit di attivit della protezione civile provinciale, la funzione non qualificata come
fondamentale dalla legge 56/2014, ma anzi qualificata come funzione fondamentale dei comuni dal D.L.
95/2012, e per l85% dei comuni del Piemonte essa dovr essere svolta in gestione associata mediante
convenzione o unione di comuni entro il prossimo 31/12/2014.
Va inoltre tenuto conto del fatto che la Regione Piemonte ha legiferato in materia, conferendo alle Province ai
sensi dellart. 118 della Costituzione le seguenti funzioni, che sono state qualificate come parte della materia
ambiente:
51
AMBIENTE
(Protezione
Civile)
- adozione del programma provinciale di previsione e prevenzione dei rischi;
- attuazione dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi e predisposizioni
dei piani provinciali di protezione civile secondo gli indirizzi regionali;
- attuazione degli interventi urgenti in caso di crisi determinata dal verificarsi o
dall'imminenza di eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) della l. 225/1992
avvalendosi anche del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco;
- attuazione delle attivit susseguenti ai primi interventi tecnici per favorire il ritorno
alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dagli eventi calamitosi;
- vigilanza sulla predisposizione da parte delle strutture provinciali di protezione
civile dei servizi urgenti anche di natura tecnica da attivare in caso di eventi
calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) della l. 225/1992;
- interventi per l'organizzazione e l'impiego del volontariato e l'attuazione di
periodiche esercitazioni e, in accordo con la Regione, di appositi corsi di
formazione.
L.r.
44/00,
art. 71
Fonte: Regione Piemonte, 2014
Fermo restando, quindi, che la funzione dovr essere soggetta a riordino da parte dello Stato e della Regione,
secondo le rispettive potest legislative per materia che saranno definite in sede di Accordo presso la
Conferenza Unificata, si ritiene di poter formulare le seguenti considerazioni, volte a salvaguardare lattivit
sinora garantita in materia dalla Provincia di Torino:
1) La particolare polverizzazione dei comuni compresi nella circoscrizione della Citt Metropolitana richiede un
ente capace di esprimere al meglio il principio di "prossimit" al territorio per la gestione delle crisi e anche per
le azioni di prevenzione. Ne sono esempi, le citate attivit di trasmissione dei bollettini di allertamento, ma
anche il supporto alla pianificazione dei comuni e delle loro forme associative, oltre alle iniziative formative
rivolte ai sindaci.
2) Lazione sussidiaria della Citt Metropolitana in favore dei comuni sia in attivit di prevenzione, che in
concomitanza delle situazioni di crisi pu mantenere attivo il network di rapporti istituzionali consolidati che,
qualora fosse invece smontato, dovrebbe comunque essere sostituito da un nuovo progetto gestionale,
mediante un intervento legislativo regionale di riordino della disciplina;
3) il coordinamento del volontariato (che la vera forza lavoro della protezione civile), con tutti gli
adempimenti amministrativi legati alla tenuta del registro regionale attualmente delegato allente di area vasta,
pu essere garantito soltanto da un soggetto istituzionale che abbia la giusta visione strategica del territorio. In
tal senso, la protezione civile potrebbe essere una parte della pianificazione territoriale generale, che
funzione fondamentale della Citt Metropolitana. Diversamente, si incorrerebbe nel rischio di una eccessiva
dispersione localistica delle risorse a disposizione, con una conseguente diminuzione dellefficacia di
intervento e dellunitariet di azione. E quindi indispensabile che nel riordino della funzione vengano garantite
logiche operative sovra comunali, cos come la capacit di mobilitare la protezione civile per mirati interventi di
gestione delle crisi sovra regionali.
La funzione di assistenza tecnica ai comuni viceversa da considerarsi a pieno titolo una funzione propria
del livello di governo, attribuita dallart. 19, comma 1, lett. l) del TUEL. Gi nei precedenti interventi di riforma
legislativa (D.L. 138/2011 D.L. 95/2012), essa era indirettamente riconducibile alle funzioni di
coordinamento, che sarebbero comunque rimaste alle Province anche nellipotesi, allora ventilata, di un totale
svuotamento di ogni altra funzione amministrativa. La conferma di tale attivit nella legge 56/2014 quindi non
stupisce, poich essa a tutti gli effetti parte della ragion dessere (insieme alla collaterale attivit di
assistenza amministrativa) di un ente di area vasta, che sia orientato a fornire servizi di larga scala a
municipalit particolarmente polverizzate, com ad esempio in Piemonte.
Secondo quanto rilevato dal Consiglio provinciale di Torino, la funzione prevede attivit di assistenza alla
progettazione, direzione lavori e collaudo di opere pubbliche su istanza dei Comuni. Lattivit pu essere
integrata con specifiche convenzioni, se si realizzano le condizioni per la finanzi abilit dellopera. Pu essere
52
inoltre previsto lo svolgimento per delega di altri enti (ad es. AIPO, ANAS, Regione Piemonte, Croce Rossa
Italiana) delle attivit di stazione appaltante.
Questultima competenza, che la Provincia di Torino ha gi sperimentato efficacemente, viene peraltro
esaltata dalla riforma Delrio con lattribuzione di una specifica funzione fondamentale di stazione appaltante,
attivabile previa intesa con i comuni della circoscrizione territoriale. E anche le norme previste dal D.L.
66/2014, in fase di conversione, confermano che il legislatore statale individua nella Provincia/Citt
Metropolitana il soggetto istituzionale pi idoneo a gestire per conto dei comuni le attivit di acquisizione e
gestione di lavori, forniture e servizi pubblici.
53
SESTA COMMISSIONE CONSILIARE
Politiche di sviluppo per le Attivit Economiche e Produttive - Lavoro - Coordinamento Programmi
Europei - Concertazione Territoriale - Agricoltura
Il tema dello sviluppo socio-economico si intreccia con numerosi aspetti dellattivit dellistituzione
provinciale; esso trova unimportante strutturazione normativa nel Decreto Legislativo n. 112 del 31 marzo
1998, per quanto riguarda il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli
enti locali. E per il Testo Unico degli enti locali (D. Leg. 267 del 18 agosto 2000) che chiarisce, allarticolo 3
c. 3: La Provincia, ente locale intermedio tra comune e regione, rappresenta la propria comunit, ne cura gli
interessi, ne promuove e ne coordina lo sviluppo.
In particolare tra le funzioni della Provincia (Art. 19 T.U. c.2) viene stabilito che La Provincia, in collaborazione
con i comuni e sulla base di programmi da essa proposti promuove e coordina attivit, nonch realizza opere
di rilevante interesse provinciale sia nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quello
sociale, culturale e sportivo.
Va qui ricordato che il concetto di sviluppo non univoco. Esso dipende da un complesso sistema di fattori,
tra cui la crescita economica in senso stretto, la competitivit delle imprese locali, la coesione territoriale, la
sostenibilit ambientale. La somma di questi quattro concetti la migliore sintesi di unidea di sviluppo di
qualit, della quale sono aspetti imprescindibili e tra loro complementari. Inoltre lo sviluppo, come la
riflessione accademica ed il lavoro sul campo di molti hanno dimostrato, non pu che essere locale, nel senso
di radicato nelle distinte peculiarit e potenzialit dei territori.
Dal punto di vista dei compiti previsti dalla normativa per listituzione provinciale, questi concetti si legano ad
unidea di politiche per la promozione dello sviluppo strettamente collegate con i compiti di programmazione
dellEnte, e quindi estese in analogia con il Piano Territoriale di Coordinamento per gli indirizzi generali di
assetto del territorio (Art. 20 T.U.)
La legge 7 aprile 2014 n. 56, modifica questo contesto, prevedendo tuttavia specificamente, tra le funzioni
previste per la Citt Metropolitana, quella di promozione e coordinamento dello sviluppo economico e
sociale, anche assicurando sostegno e supporto alle attivit economiche e di ricerca innovative e
coerenti con la vocazione della citt metropolitana come delineata nel piano strategico del territorio
(art. 1, c. 44 lettera e).
Occorre in tal senso sottolineare come il realizzarsi di percorsi di sviluppo territoriale sia strettamente collegato
al buon funzionamento di sistemi locali, strutturati secondo modelli socio-economici differenziati a seconda
delle caratteristiche specifiche delle diverse aree di riferimento. La ricerca ha descritto tali sistemi locali come
di area vasta, ovvero con una dimensione sovra comunale e tuttavia, spesso (come nel caso del Piemonte)
inferiore a quella regionale (Cfr. IRES Piemonte, Ceris-Cnr). Ne consegue che la promozione dello sviluppo
territoriale debba essere preferibilmente seguita da un ente di dimensioni (organizzative e territoriali)
adeguate. Daltra parte tutte le politiche di sostegno alla crescita socio-economica, anche qualora dovessero
essere intese come del tutto slegate dal contesto geografico e perseguite, ad esempio, in una logica di filiera
produttiva, presentano indubbie ricadute a carattere territoriale, a partire da quelle sui sistemi locali del lavoro.
Lesperienza delle Province italiane, soprattutto nel primo decennio degli anni Duemila, ha visto un ruolo
significativo delle istituzioni locali a sostegno di un modello di crescita basato sulla concertazione territoriale
e sul partenariato locale. Questa visione strategica ha una chiave di lettura dal punto di vista metodologico
nella concezione di un territorio che diviene sempre pi attrattivo e favorevole allattivit di impresa attraverso
la produzione di quelli che la dottrina definisce local collective competition goods. Questi ultimi possono
54
essere definiti forme di capitale sociale localizzate e specifiche per un territorio, accessibili a tutti gli operatori
di quellarea e rilevanti dal punto di vista competitivo.
E possibile sostenere che uno sviluppo locale endogeno deve essere fondato sulla produzione di beni pubblici
locali, in quanto grazie ad essi unarea pu migliorare la propria competitivit: in altre parole i vantaggi
competitivi essenziali per lagire di unimpresa derivano, oltre che dalle sue specifiche qualit, dai punti di forza
del territorio che la ospita.
La maggior parte di questi beni collettivi rientrano allinterno di tre classi: formazione nellaccezione pi
ampia del termine trasferimento tecnologico e internazionalizzazione. Le infrastrutture, materiali e
immateriali, tra le quali unimportanza particolare assume il settore del credito, costituiscono per cos dire degli
altri fattori strutturali, trasversali a queste.
Si tratta di ambiti di intervento strettamente collegate ai compiti svolti ad oggi dalla Provincia come Ente
deputato (o in alcuni casi delegato) al governo di area vasta: si pensi alle politiche attive del lavoro ed alla
formazione professionale, alle iniziative a sostegno della creazione dimpresa, come pure in senso ampio alle
infrastrutture di viabilit ed ai temi dellambiente.
In sintesi, uno sviluppo sostenibile pu essere favorito da politiche intenzionali che si traducono nella
creazione di beni pubblici; esse si configurano nella realizzazione delle condizioni per rendere un territorio
favorevole allinnovazione ed alla capitalizzazione del sapere, accogliente per la nuova impresa, attrattivo per i
migliori talenti e le alte professionalit (nel senso descritto ad esempio da Florida, R., per quanto riguarda il
rapporto tra citt e classe creativa).
Pu essere utile accennare ancora a due aspetti collegati ai concetti finora esposti, che si intrecciano
strettamente con le prospettive sullattivit futura della Citt Metropolitana: la ritrovata centralit nelle
economie moderne del ruolo della citt e la coerenza dellagire istituzionale con le indicazioni elaborate a
livello europeo a proposito delle politiche di sviluppo.
Dal primo punto di vista, le caratteristiche delle economie basate sulla conoscenza e la (collegata) centralit
assunta dal tema dellinnovazione tecnologica per il sistema produttivo europeo fanno ritenere alcuni elementi
tipici dei grandi centri urbani, tra cui la maggiore facilit di relazione e di circolazione di individui e saperi,
elementi oggi imprescindibili al tessuto economico e produttivo. Un aspetto questo che occorre considerare
nella logica dei sistemi locali di sviluppo sopra ricordata.
Incidentalmente si pu notare che le ultime evoluzioni normative sul ruolo della citt metropolitana, seppure
dovute in gran parte alle forti difficolt finanziarie dei bilanci pubblici, sono del tutto coerenti con lidea di uno
sviluppo di un territorio che passa da un contesto metropolitano e, di fatto, riconoscono la correttezza
dellimpostazione degli interventi di sostegno allo sviluppo locale costruita in passato da molte Province. Ci si
riferisce cio ad un concetto di sviluppo sostenibile basato sulla creazione di condizioni favorevoli per la
crescita e lattrazione di talenti, tecnologie, processi innovativi in unarea pi vasta di una singola citt e
tuttavia connotata dalla presenza di un centro urbano catalizzatore di percorsi di capitalizzazione della
conoscenza.
Se invece si considerano le indicazioni disponibili ad oggi dal punto di vista dei documenti strategici
dellUnione Europea, tenendo presente limportanza oggi assunta per le istituzioni provinciali dai Fondi
Strutturali nellorientare e sostenere il proprio operato, possibile notare come la strategia Europa 2020, che
mira ad una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva/solidale sia del tutto coerente con la volont di fornire
una buona infrastrutturazione immateriale del territorio nei confronti dei cittadini e delle imprese.
Prendendo ad esempio la programmazione 2014-2020 del Fondo Sociale Europeo, secondo le indicazioni
ad oggi disponibili lattivit delle istituzioni europee dovr essere concentrata su un numero limitato di obiettivi
e priorit di investimento, con la finalit di migliorarne l'impatto e raggiungere una massa critica:
Attraverso le priorit, i Fondi Strutturali contribuiscono anche ad altri obiettivi tematici da leggere in una logica
di intervento attraverso politiche di area vasta:
sostenendo il passaggio ad uneconomia a bassa emissione di carbonio, resistente ai cambiamenti
climatici, efficiente nellutilizzazione delle risorse ed ecologicamente sostenibile, mediante una riforma dei
55
sistemi di istruzione e di formazione, ladattamento delle competenze e delle qualifiche, il perfezionamento
professionale della manodopera e la creazione di nuovi posti di lavoro nei settori collegati allenergia e
allambiente;
migliorando laccessibilit, lutilizzazione e la qualit delle tecnologie dellinformazione e della
comunicazione grazie allo sviluppo della cultura digitale, allinvestimento nellinclusione digitale, nelle
competenze digitali e nelle relative competenze imprenditoriali;
rafforzando la ricerca, lo sviluppo tecnologico e linnovazione, attraverso lo sviluppo degli studi post-
universitari, la formazione dei ricercatori, la messa in rete di attivit e partenariati tra gli istituti
dinsegnamento superiore, i centri di ricerca tecnologici e le imprese;
migliorando la competitivit delle piccole e medie imprese mediante la promozione delle capacit di
adattamento delle imprese e dei lavoratori e un maggiore investimento in capitale umano.
Le considerazioni finora esposte paiono indicare come la Citt Metropolitana possa senzaltro proporsi come
un soggetto titolato a progettare e seguire una serie organica di interventi di sostegno allo sviluppo territoriale,
in modo rafforzato rispetto alla pur significativa esperienza realizzata finora sul tema, ponendosi invece come
agente di sviluppo del territorio attraverso lattenzione a valorizzarne le sue componenti pi dinamiche e
imprenditoriali.
Appare significativo il ruolo previsto dalla normativa di sostegno e supporto alle attivit economiche e di
ricerca in capo alla Citt Metropolitana, che deve trovare applicazione anche nei confronti dei Comuni del
territorio. In tale senso la Citt Metropolitana pu essere chiamata a svolgere un ruolo di coordinamento delle
diverse iniziative su base territoriale, per assicurare processi di promozione delle attivit economiche coerenti
con le vocazioni territoriali.
In generale quindi il ruolo della Citt Metropolitana a sostegno dello sviluppo economico e sociale si situa
nel pi ampio tema dellinterlocuzione come autorit pubblica con gli attori economici del territorio, rapporto
che deve essere collegato a principi di celerit e semplificazione.
A questa considerazione sono connessi ancora due importanti elementi di cui tenere conto:
- la necessit di migliorare i meccanismi di semplificazione dei processi amministrativi;
- il ruolo per gli operatori economici di un territorio dello Sportello Unico per le Attivit Produttive.
Entrambi sono legati, oltre alla funzione di promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale, a
quella di promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in ambito
metropolitano. In particolare la gestione coordinata delle attivit in capo ai procedimenti di Sportello Unico
pu vedere un ruolo importante della Citt Metropolitana nel miglioramento della gestione di questo strumento
sul territorio, attualmente assai eterogenea, soprattutto attraverso lapplicazione di sistemi di informatizzazione
condivisi, efficaci ed efficienti, nellottica dellattuazione del Codice per lAmministrazione Digitale.
MACROFUNZIONI FUNZIONI CONFERITE
RIFERIMENTO
NORMATIVO
REGIONALE
ATTIVITA
PRODUTTIVE
(ARTIGIANATO)
- cooperazione degli Enti locali interessati nella realizzazione e gestione
di programmi regionali attuativi di regolamenti dell'UE o di iniziative
comunitarie riservati alla Regione;
L.r. 44/00, art.
13
- concorso alla definizione della programmazione regionale in materia di
aree attrezzate artigianali, mediante programmi provinciali o
metropolitani;
- partecipazione, secondo gli indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale,
all'individuazione delle lavorazioni dell'artigianato artistico e tipico ed
all'individuazione e delimitazione dei territori interessati tramite le
commissioni provinciali per l'artigianato.
L.r. 44/00, art.
14
ATTIVITA
PRODUTTIVE
- cooperazione degli Enti locali interessati nella realizzazione e gestione
di programmi regionali attuativi di regolamenti dell'UE o di iniziative
L.r. 44/00, artt.
17,18,24
56
(INDUSTRIA) comunitarie riservati alla Regione;
- concorso alla definizione della programmazione regionale in materia di
attivit produttive mediante programmi provinciali;
-attivit di promozione finalizzata alla predisposizione di progetti di
sviluppo di sistemi produttivi locali,incluso lo sportello unico quale
strumento di promozione del sistema produttivo locale.
ATTIVITA
PRODUTTIVE
(INDUSTRIA)
Secondo le modalit ed i limiti fissati dalla legge regionale di cui
all'articolo 19, commi 6 e 12 del d.lgs. 112/1998, alla Provincia, alla Citt
metropolitana, alla Comunit montana, ai Comuni, qualora individuati
quali responsabili del coordinamento e dell'attuazione di strumenti di
programmazione negoziata o di progetti di sviluppo locale promossi o
partecipati dalla Regione, conferita la gestione del procedimento di
concessione di benefici alle imprese il cui finanziamento sia previsto,
nello strumento di programmazione negoziata o nel progetto di sviluppo
locale, a carico del Fondo unico regionale di cui all'articolo 19, comma 6
del d.lgs. 112/1998.
L.r. 44/00, artt.
19
- valutazione di progetti di insediamenti commerciali sottoposti alla
procedura di VIA ai sensi dellart. 4, comma 1, del D.P.R. 12 aprile 1996;
L.r. 40/98
- partecipazione alla programmazione regionale della rete distributiva
per il possibile insediamento della grande distribuzione in ambiti
extraurbani (rilascio parere obbligatorio su progetto comunale).
DCR 563-
13414/1999
- concorso alla programmazione e alla attuazione delle politiche
regionali integrate in materia di sicurezza urbana;
L.r. 23/07
D.G.R. 28
novembre
2008, n. 14-
10194
D.C.R. n 215-
43-184 del 14
ottobre 2008
ATTIVITA
PRODUTTIVE
(COMMERCIO)
- funzioni di Polizia Locale di cui sono titolari, anche a mezzo di appositi
servizi.
L.r. 65/86, art.
12
ATTIVITA
PRODUTTIVE
(CARBURANTI)
Rilascio autorizzazioni per :
- linstallazione degli impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL;
- lesercizio dellattivit di distribuzione e vendita di GPL attraverso
bombole e/o attraverso serbatoi.
L.r. 44/00, art.
53
ATTIVITA
PRODUTTIVE
(MINIERE,
RISORSE
GEOTERMICHE,
CAVE E
TORBIERE)
- funzioni di polizia mineraria in materia di coltivazione di cave e torbiere;
- predisposizione dei Piani di settore dellattivit estrattiva (PAEP);
- concorso alla vigilanza sulla utilizzazione delle cave e torbiere attuata
dalle amministrazioni comunali.
L.r. 44/00, artt.
29 e 31
L.r. 69/78, art.
19
POLITICHE PER
IL LAVORO
/ATTIVITA
PRODUTTIVE
(INDUSTRIA)
- concorso con la Regione e gli enti locali, alla concessione di contributi,
finanziamenti agevolati e garanzie di accesso al credito, servizi di
accompagnamento ed assistenza tecnica finalizzati anche al
trasferimento di impresa extra famiglia, nascita e sviluppo di iniziative di
autoimpiego
L.r. 34/08, art.
42
57
Per quanto concerne le funzioni conferite in materia di agricoltura, si rileva che, pur non essendo questo un
ambito operativo espressamente previsto dalla normativa nazionale in capo alle Province o alle Citt
Metropolitane, molte delle attivit in essere non possano prescindere da una articolazione di esercizio su base
territoriale e, di conseguenza, da una loro riconferma in capo al soggetto pubblico che avr competenze di
area vasta. Le attivit ispettive in materia di antisofisticazione vitivinicola, tenuto conto che gi attualmente
sono svolte sotto il coordinamento di apposito ufficio della Regione e il personale opera su base
interprovinciale, potrebbero viceversa essere oggetto di riconsiderazione organizzativa a livello regionale.
Relativamente alla realizzazione e manutenzione delle infrastrutture agrarie e rurali, servizio fondamentale per
le piccole realt locali, in unottica di Citt Metropolitana rivolta al territorio occorre confermare tale impegno di
assistenza e supporto ai Comuni.
Nel dettaglio, le funzioni oggetto di conferimento regionale sono le seguenti:
ATTIVITA
PRODUTTIVE
(Agricoltura)
- interventi relativi al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie e
alla creazione di nuove aziende, ivi compresi il finanziamento dei piani di
sviluppo aziendali ed interaziendali, per la fase della produzione nonch
della trasformazione aziendale;
- interventi relativi al miglioramento e allo sviluppo delle produzioni vegetali
ed animali;
- interventi di assistenza tecnica, divulgazione e consulenza alle aziende
agricole nonch di formazione professionale, rivolta specialmente ai
giovani operatori agricoli ed ai giovani disoccupati, compresi i necessari
supporti a livello provinciale;
- attivit relative alle avversit atmosferiche nei confronti delle colture e alle
calamit naturali per quanto riguarda le strutture aziendali nonch le
infrastrutture rurali di livello provinciale;
- interventi relativi alle infrastrutture rurali;
- interventi per l'applicazione di misure comunitarie di accompagnamento;
- interventi per l'erogazione di premi, incentivi ed integrazioni di reddito
previsti da regolamenti comunitari e nazionali;
- interventi per la gestione di quote di produzione;
- interventi per l'applicazione di misure agro-ambientali, compresa
l'agricoltura biologica;
- funzioni, comprese le nomine, relative a commissioni e comitati provinciali
previsti da norme statali e regionali;
- rilascio delle autorizzazioni per l'acquisto dei presidi fitosanitari;
- attivit relative ai servizi di supporto per l'incremento ippico, ivi compresa
l'applicazione delle norme sulla riproduzione nel settore equino;
- interventi relativi all'attivit agrituristica;
- approvazione dei piani di riordino irriguo e fondiario.
- svolgimento dei servizi per il prelevamento e l'uso dei carburanti a prezzi
agevolati per l'agricoltura, compresi il conferimento della qualifica di utente
di motore agricolo e l'assistenza agli utenti di motore agricolo;
- vigilanza sulla tenuta dei registri e dei libri genealogici e sull'attuazione dei
relativi controlli funzionali;
- commissioni tecniche provinciali di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno
1962, n. 567 (Norme in materia di affitto di fondi rustici), modificato con
legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari);
- rilevazioni statistiche nazionali e regionali.
L.r. 17/99,
art. 2
58
- gestione istruttorie Misure del Piano di Sviluppo Rurale
- interventi di realizzazione e manutenzione di infrastrutture agrarie e rurali
Convenzione
ARPEA
Attivit
istituzionali di
assistenza ai
Comuni
-istituzione del Servizio antisofisticazioni vinicole, nomina ufficiali ed agenti
di polizia giudiziaria, accertamento delle violazioni in materia di
repressione delle frodi in ambito vinicolo e rilascio del certificato di
iscrizione all'anagrafe vitivinicola.
L.r. 39/80,
artt. 2, 3 bis
- individuazione dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualit. L.r. 29/08,
art. 5
- divieto alla raccolta di una o pi specie di funghi epigei spontanei,
autorizzazione alla costituzione di aree delimitate per la raccolta funghi a
fini economici.
L.r. 24/07,
art. 2
- autorizzazione alla raccolta e alla detenzione di funghi epigei spontanei per
fini didattici, scientifici, espositivi e di prevenzione sanitaria; -
autorizzazioni collettive gratuite in occasione di giornate di studio,
convegni, seminari
L.r. 24/07,
art. 6
- rilascio (facoltativo), a titolo oneroso, autorizzazione alla raccolta di funghi
epigei spontanei in quantitativi superiori a quelli normalmente consentiti.
L.r. 24/07,
art. 5
- vigilanza sull'osservanza della legge regionale citata ed l'accertamento
delle relative violazioni.
L.r. 24/07,
art. 9
- irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie riferite alla citata l.r. L.r. 24/07,
art. 11
- organizzazione di appositi corsi per il personale preposto alla vigilanza ed
aggiornamento professionale del personale.
L.r. 24/07,
artt. 8 e 9
- predisposizione ed adozione del piano forestale territoriale L.r. 4/09, art.
10
- redazione di un programma provinciale di sviluppo per il settore forestale L.r. 4/09, art.
26
- funzioni di vigilanza e di accertamento delle violazioni alle disposizioni
della citata legge
L.r. 4/09, art.
35
- rilascio dellattestazione di riconoscimento della tartufaia controllata o
coltivata.
L.r. 16/08,
art. 5
- rilascio tesserino, previo esame di idoneit, per la raccolta dei tartufi. L.r. 16/08,
art. 9
59
- vigilanza sull'applicazione della citata legge. L.r. 16/08,
art. 13
60
NONA COMMISSIONE CONSILIARE
Politiche Attive di Cittadinanza, Diritti Sociali e Parit, Relazioni Internazionali, Progetti Europei
Nello specifico delle attivit di competenza della IX Commissione consiliare, la riforma operata con la legge
56/2014 riguarda anzitutto larea delle funzioni inerenti i rapporti internazionali e la progettazione UE.
In questambito, la Citt Metropolitana viene individuata come soggetto forte sul piano istituzionale, a partire
dalle stesse finalit generali che lart. 1 comma 2 prevede mediante la locuzione cura delle relazioni
istituzionali afferenti al proprio livello, ivi comprese quelle con le citt e le aree metropolitane europee.
Il legislatore ha quindi individuato un inedito asse di relazioni internazionali paritario su un modello simile a
quello esistente per le regioni, stabilendo una linea di relazioni che vanno comprese come relazioni bilaterali o
multilaterali con citt ed aree metropolitane diverse, anche tenendo conto del fatto che non in tutte le
conurbazioni europee c un identico ente amministrativo paragonabile a quella che in Italia sar la citt
metropolitana.
Una simile attribuzione di ruolo va letta insieme alle successive funzioni fondamentali, di cui al comma 44,
con particolare riferimento alla funzione di pianificazione strategica e di promozione e coordinamento
dello sviluppo economico e sociale. Va peraltro ricordato che, in sede di lavori parlamentari, il testo della
legge stato pi volte modificato in questa parte, eliminando progressivamente dalle finalit e dalle funzioni
fondamentali tutte quelle attivit che avrebbero posto la Citt Metropolitana in diretta competizione con la
Regione, nelle relazioni europee e internazionali. Deve quindi essere riconosciuta al legislatore una precisa
intenzione di valorizzare il ruolo dellente di governo di area vasta: unintenzione non pienamente realizzata
nella stesura definitiva della legge, ma che comunque si rinviene anche nella struttura della programmazione
di fondi UE 2014-2020, che in molti casi dimensionata non sul livello regionale, ma sul livello delle
conurbazioni metropolitane.
In questo settore di attivit, la Citt Metropolitana di Torino erediter le funzioni della Provincia, che sono
prevalentemente concentrate nella definizione e gestione di grandi reti di partenariato, nel supporto allo
sviluppo di progetti europei sui diversi fondi, nella cura di relazioni con realt territoriali analoghe dei Paesi del
bacino mediterraneo e naturalmente nellimpegno rivolto alla cooperazione internazionale verso i Paesi
extraUE.
Sono tutte funzioni endogene dellEnte, che cio non derivano da una specifica attribuzione normativa di
parte statale o regionale, e che hanno nella capacit di esprimere progettualit (diretta o indiretta) il proprio
principale motore di sviluppo. Sono, infine, funzioni strettamente complementari e cugine di quelle svolte dai
grandi comuni della Citt Metropolitana, con particolare riferimento alla Citt di Torino.
Saranno in particolare molto utili in futuro le reti come Arco Latino, cos come la valorizzazione degli
investimenti che UNDP ha fatto sul territorio della Provincia di Torino in merito allo sviluppo locale.
Nel settore dei diritti sociali e pari opportunit, la ricostruzione delle funzioni in prospettiva della transizione
presenta elementi di maggiore complessit. Da un lato, infatti, la Citt Metropolitana eserciter come gi detto
nuove funzioni (da definire e implementare) in materia di sviluppo economico e sociale, seppure limitate alla
promozione e coordinamento, quindi a compiti apparentemente leggeri a basso contenuto gestionale.
Dallaltro lato, tuttavia, ai sensi del comma 85 (nuove funzioni fondamentali delle Province), lente eserciter i
nuovi compiti consistenti nel controllo (in funzione evidentemente preventiva e repressiva) dei fenomeni
discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunit sul territorio.
I compiti aggiuntivi attribuiti ai sensi dei due commi citati devono essere confrontati con le attuali funzioni della
Provincia di Torino, che sono sia di tipo pianificatorio e programmatorio (ai sensi della L.R. 1/2004 e 44/2000)
e sia di tipo gestionale negli interventi effettuati ai sensi delle L.R. 7/2006 e 16/2009.
61
Soprattutto, per, la ricomposizione delle funzioni deve tenere presente che, ai sensi dellart. 19 del D.L.
95/2012 (spending review), tutto il settore della progettazione e gestione del sistema locale dei servizi
sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118,
quarto comma, della Costituzione stata attribuita ai Comuni.
Nellambito della nuova autonomia statutaria, prevista in particolare dallart. 1, comma 11, lett. a) e b), il
consiglio metropolitano potr quindi regolare al meglio le aree di complementarit tra le funzioni svolte dai
due livelli di governo, e razionalizzarne le rispettive competenze, orientando in questo modo anche un
futuro, possibile riassetto legislativo da parte della Regione.
Per questo aspetto, la Citt Metropolitana occasione di ripensamento sulle funzioni di area vasta, sia nei
suoi contenuti sia nel metodo: lo sviluppo economico e sociale va letto come sviluppo di una comunit in cui l
intenzionalit politica e tecnica favoriscano la fruizione dei diritti e dei servizi che devono rispondere a criteri di
uniformit di prestazioni in tutto il territorio.
Da questa considerazione parte il lavoro il lavoro svolto dalla Provincia di Torino, che ha risposto alla
necessit di una co-programmazione sociale e di pari opportunit sui territori, che ha rilevato le risorse
presenti e favorito le reti e le competenze, che ha coordinato ed integrato le politiche locali e di settore.
Il metodo ed i contenuti hanno rappresentato le basi per le scelte, azioni e prestazioni non seguendo solo ed
unicamente il criterio delle risorse economiche, ma perseguendo lapprofondita conoscenza del territorio, delle
sue criticit e risorse sia attive sia potenziali, arrivando ad avere un quadro completo ed utile per una co-
progettazione.
Un particolare aspetto che si ritiene necessario evidenziare quello che vede operare la co-programmazione
in una sorta di terra di mezzo, la dove le politiche di stampo squisitamente sociale e socio assistenziale
interagiscono con gli interventi di tipo sanitario. Lintreccio della Legislazione nazionale (328/2000) con quella
Regionale e, nella fattispecie, le articolazioni territoriali su cui costruito il sistema di protezione attraverso gli
Enti Gestori (Consorzi, Comunit Montane, Unioni di Comuni L. r. 1/2004) e quello sanitario (ASL e Distretti)
determinano che ad interagire siano entit amministrative con dimensioni territoriali e di popolazione residente
profondamente diverse.
In particolar modo queste diversit sono state ampliamente evidenziate dal lavoro di indagine fatto dalla IX
Commissione in occasione della discussione sulla proposta di riforma soppressione dei Consorzi di
Funzione e della redazione del Piano Socio Sanitario Regionale 2011 2015 (vedi slide).
Dallo stesso lavoro svolto dallUfficio di Piano Provinciale (istituito nellaprile 2010 in base alla DGR 28-11-295
del 5/10/2009), articolato su quattro campi di problematiche (casa, salute, lavoro, mobilit) cos come nelle
risultanze delle Conferenze sulla Salute e nella redazione dei Piani e Profili di Salute chiaramente emersa la
necessit di operare scelte che, interagendo nello svolgimento della attivit propria dei vari soggetti
istituzionali (dai Comuni alla Regione), evidenzino ed anticipino le problematicit che i singoli interventi
possono avere rispetto al ben essere dei cittadini.
Allo stesso modo, devono essere considerate buone pratiche le seguenti realizzazioni della Provincia di Torino
nelle attivit connesse alla cooperazione e alla gestione del volontariato, compresa lerogazione di contributi, e
nelladozione degli indicatori territoriali per i bandi, nellInformatizzazione delle pratiche, nella realizzazione di
unintesa di scambio dati con lAgenzia delle entrate e nella pubblicazione dei dati sul volontariato.
Inoltre, sono state registrate buone pratiche nella gestione dei bandi nelle due sezioni sanitarie e socio
assistenziali.
Altrettanto, va registrata la formazione di base degli operatori dei servizi sociali. La funzione che si riferisce
alla formazione di base, riqualificazione e formazione permanente degli operatori dei servizi sociali, sulla base
dei bisogni rilevati dagli Enti gestori dei servizi sociali anche in raccordo con lUniversit, una competenza
attribuita alle Province a seguito dellemanazione della L.R. n. 1/2004 Norme per la realizzazione del sistema
regionale integrato di interventi e servizi sociali.
62
I percorsi formativi di Area Vasta, individuati in base ad unanalisi dei fabbisogni effettuata sia allinterno del
nostro Ente sia attraverso il confronto con operatori appartenenti al gruppo di coordinamento sulla formazione
degli operatori sociali, sono i seguenti:
- Corso per conduttori di Gruppi di Parola per figli di genitori separati-Aggiornamento,
- La mediazione interculturale: uno strumento per lintegrazione degli stranieri,
- Il Sistema Informativo dei Servizi sociali (SISS): modalit ed integrazione,( Gli Enti gestori istituzionali
dei Servizi Sociali adottano principalmente due differenti piattaforme operative per la gestione
informatizzata della cartella sociale e del sistema informativo (in particolare SISS-Web o SIS CADMO
Infor). Lobiettivo generale del percorso la definizione di opportunit, regole e strumenti per rendere
interrelate tali piattaforme che gli Enti gestori dei Servizi sociali utilizzano per la gestione delle cartelle
sociali).
- Affidamento familiare: il lavoro progettuale con le famiglie dorigine
Nella tenuta del registro Associazioni di promozione sociale: funzione attribuita da legge regionale 7 del 2006
art. 6 e 11 e nelle competenze in materia di associazioni di promozione sociale, per favorirne lo sviluppo e
controllo sullattivit. Lesistenza dellAlbo della Cooperazione sociale (legge regionale 1 del 2004) si rivelata
molto utile anche la collaborazione con le centrali operative (lega e confcooperative).
Per il settore giovani e il servizio civile nazionale volontario (politiche giovanili (legge regionale 44 del 2000
art. 131 e 133), si auspica la revisione dei criteri regionali.
NellUfficio di pubblica tutela (funzione trasferita dalla legge regionale 1/2004) si svolgono compiti di supporto
a favore dei soggetti ai quali conferito dallautorit giudiziaria lesercizio delle funzioni di tutore. LUfficio
tutele si fa carico di promuove il raccordo tra il giudice, i servizi sociali e gli interessati e ha delega anche su
singoli casi. Favorisce il servizio, la semplificazione e loperativit del Tribunale, sia di Torino sia di Ivrea.
Opera su convenzione con il tribunale dal 2012, tacitamente rinnovabile. Sono attivi: Interventi sui minori, nei
casi di separazioni, promuove la tutela del minore anche nei casi in cui questo sia audito dal tribunale.
Lo sportello, raccoglie le richieste, fornisce informazioni giuridiche sulle problematiche inerenti le istanze e le
rendicontazioni. Dal primo anno le richieste sono raddoppiate.
LAlbo dei tutori volontari, promuove il rapporto individuale sui singoli casi, si occupa della formazione base dei
tutori su normativa e lavoro, in collaborazione con i giudici promuove le nomine dei tutori volontari; predispone
elenco delle persone che si sono formate. A oggi sono presenti elenchi di tutori volontari su tre zone: Citt
Torino, Val Susa, Zona Nord- Ivrea, in fase di formalizzazione sulle zone di Rivoli e Moncalieri.
Lelenco tutori volontari ancora informale, il ruolo volontario senza rimborsi e/o retribuzione ma ha il grosso
vantaggio di ridurre il carico di lavoro ai servizi sociali. Si in fase esplorativa per unificare/ rendere omogenee
le procedure per le Agenzie bancarie (ABI) e albo geometri per la gestione degli aspetti finanziari e
valutazione dei beni dei soggetti sotto tutela.
Nei Piani di zona, nel piano locale giovani e nella gestione dellufficio informativo si realizza il coordinamento
della programmazione locale previsto dalla legge 328/200 . Programmazione integrata, supportata dai diversi
attori sociali dai dati statistici e dalla sensibilit territoriale, i Piani di Zona sono mirati a:
- accompagnamento del territorio nel percorso di avvio, programmazione, attuazione, monitoraggio e
valutazione (attraverso la capillare presenza nei locali Uffici di Piano e la predisposizione di modalit e
strumenti ad hoc per monitorare lefficacia dei progetti, degli interventi e dei servizi, e lattivit di
formazione in favore degli operatori sociali);
- a favorire lintegrazione, linterconnessione ed il raccordo tra le singole programmazioni zonali e la
programmazione di area vasta nelle diverse competenze della Provincia
63
La salvaguardia delle buone pratiche citate rilever in particolar modo nelle decisioni che potranno essere
assunte in sede di eventuale riordino a opera della Regione Piemonte delle seguenti funzioni:
POLITICHE
SOCIALI
(compresa sanit,
associazionismo e
volontariato)
-interventi per l'integrazione scolastica degli alunni disabili o con
esigenze educative speciali
nel quadro degli accordi di programma di cui all art. 17 della LR
1/2004 diretti ad assicurare l'accesso e la frequenza al sistema
scolastico e formativo
L.r. 28/2007, art.
15
presentazione di proposte per lelaborazione del Programma triennale
regionale;
predisposizione annuale dei rispettivi piani di intervento per i giovani, al
fine di favorire una politica coordinata sul territorio in attuazione del
programma regionale;
gestione degli interventi di politica giovanile secondo quanto previsto
dalla normativa regionale.
L.r. 26/2000
Sistema informativo, servizi e supporto di area vasta nella redazione
dei Piani di Zona
L.r. 1/2004 art. 5
15- 17
- concorso all'elaborazione del piano triennale regionale in materia di
diritto allo studio;
- svolgimento di funzioni in materia di istruzione secondaria di secondo
grado di cui all'articolo 139 del d.lgs 112/1998;
- promozione della stipulazione degli accordi di collaborazione tra gli
enti territoriali, le istituzioni scolastiche autonome e le agenzie
formative accreditate con il coinvolgimento dei servizi sociali, sanitari,
culturali e del lavoro di cui all'articolo;
- predisposizione ed approvazione del piano annuale degli interventi in
materia di assistenza scolastica;
- predisposizione ed approvazione del piano annuale degli interventi in
materia di prevenzione e recupero dellabbandono scolastico; ;
- predisposizione ed approvazione del piano annuale degli interventi in
materia di dotazioni librarie.
L.r. 28/2007, art.
30
- competenze in materia di cooperative ed organizzazioni di
volontariato, compresa l'erogazione, controllo e rendicontazione dei
relativi contributi; la cui gestione dei finanziamenti a favore delle odv
L.r. 1/04, art. 5
64
ripartita con modalit differenti a seconda che i finanziamenti siano
attribuiti agli enti gestori o citt (tenendo conto di specifici parametri
territoriali), alle singole odv con programmazione non integrata e alle
odg di vasta era.
Informatizzazione rendicontazione annuale per il mantenimento
delliscrizione al registro.
Intesa con agenzia entrate x scambio dati e verifica della non
lucrativit delle associazioni delle ONLUS.
L.r. 38/94, artt. 4
e 5
- formazione di base, riqualificazione e formazione permanente degli
operatori dei servizi sociali sulla base dei bisogni rilevati tramite gli enti
gestori istituzionali e anche in raccordo con l'universit, compresa
l'erogazione dei relativi finanziamenti. In particolare si rilevano i corsi
rivolti allarea vasta per creare competenze comuni a tutti i territori, su
temi di rilievo.
L.r. 1/04, art. 5
- competenze in materia di asili nido comunali ed erogazione dei
relativi contributi.
Sportello di informazione sociale e Sportello informazione disabilit
usufruibile sia via internet che presso lo sportello
programmazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali
quali enti intermedi e soggetti di programmazione decentrata delle
politiche regionali e di coordinamento del territorio. Piani di zona,
Ufficio di Piano, tavolo affidi famigliari,
- istituzione dell'ufficio provinciale di pubblica tutela, con compiti di
supporto a favore dei soggetti ai quali conferito dall'autorit
giudiziaria l'esercizio delle funzioni di tutore;sezione decentrata presso
il tribunale, (assistente sociale) il servizio, la semplificazione e
loperativit del Tribunale, sia di Torino sia di Ivrea;
Opera su convenzione con il tribunale dal 2012, istituito elenco dei
tutori volontari , in fase esplorativa per unificare/ rendere omogenee le
procedure con le Agenzie bancarie (ABI) e albo geometri
- competenze in materia di aziende pubbliche di servizi alla persona e
nomina dei membri dei consigli di amministrazione
L.r. 1/04, art. 5
L.r. 3/73
- realizzazione di altri interventi per la promozione e l'integrazione dei
servizi sociali locali;
- istituzione dell'ufficio provinciale di pubblica tutela, con compiti di
supporto a favore dei soggetti ai quali conferito dall'autorit
giudiziaria l'esercizio delle funzioni di tutore;
- competenze in materia di aziende pubbliche di servizi alla persona e
L.r. 1/04, art. 5
65
nomina dei membri dei consigli di amministrazione quando questa sia
attribuita dagli statuti alla regione.
- competenze in materia di associazioni di promozione sociale (favorire
lo sviluppo dellassociazionismo e controlli sullattivit). Osservatorio
della APS ha elaborato una proposta di regolamento, importante per la
verifica degli organismi democratici (funzione a regia regionale)
PARI OPPORTUNITA e POLITICHE DEI TEMPI, attivit svolta cin
fondi trasferiti da regione e UE: piani territoriali, gestione sportello
provinciale Unar, rete provinciale, coordinamento banche del tempo,
gestione e coordinamento tavolo provinciale maltrattanti, consigliera
provinciale di Parit
L.r. 7/06, artt. 6 e
11
l.r. 1 /2004 art.
5, c2, let. b,e
Fonte: Regione Piemonte, 2014
Potrebbero piacerti anche
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeDa EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeValutazione: 4.5 su 5 stelle4.5/5 (20028)
- Pride and Prejudice: Bestsellers and famous BooksDa EverandPride and Prejudice: Bestsellers and famous BooksValutazione: 4.5 su 5 stelle4.5/5 (19653)
- American Gods: The Tenth Anniversary EditionDa EverandAmerican Gods: The Tenth Anniversary EditionValutazione: 4 su 5 stelle4/5 (12948)
- The 7 Habits of Highly Effective People: The Infographics EditionDa EverandThe 7 Habits of Highly Effective People: The Infographics EditionValutazione: 4 su 5 stelle4/5 (2475)
- Art of War: The Definitive Interpretation of Sun Tzu's Classic Book of StrategyDa EverandArt of War: The Definitive Interpretation of Sun Tzu's Classic Book of StrategyValutazione: 4 su 5 stelle4/5 (3321)
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeDa EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeValutazione: 4 su 5 stelle4/5 (5795)
- The Iliad: The Fitzgerald TranslationDa EverandThe Iliad: The Fitzgerald TranslationValutazione: 4 su 5 stelle4/5 (5646)
- The Iliad: A New Translation by Caroline AlexanderDa EverandThe Iliad: A New Translation by Caroline AlexanderValutazione: 4 su 5 stelle4/5 (5718)
- The 7 Habits of Highly Effective PeopleDa EverandThe 7 Habits of Highly Effective PeopleValutazione: 4 su 5 stelle4/5 (353)
- Habit 1 Be Proactive: The Habit of ChoiceDa EverandHabit 1 Be Proactive: The Habit of ChoiceValutazione: 4 su 5 stelle4/5 (2556)
- Habit 6 Synergize: The Habit of Creative CooperationDa EverandHabit 6 Synergize: The Habit of Creative CooperationValutazione: 4 su 5 stelle4/5 (2499)
- Habit 3 Put First Things First: The Habit of Integrity and ExecutionDa EverandHabit 3 Put First Things First: The Habit of Integrity and ExecutionValutazione: 4 su 5 stelle4/5 (2507)
- The 7 Habits of Highly Effective PeopleDa EverandThe 7 Habits of Highly Effective PeopleValutazione: 4 su 5 stelle4/5 (2567)
- Wuthering Heights (Seasons Edition -- Winter)Da EverandWuthering Heights (Seasons Edition -- Winter)Valutazione: 4 su 5 stelle4/5 (9486)
- How To Win Friends And Influence PeopleDa EverandHow To Win Friends And Influence PeopleValutazione: 4.5 su 5 stelle4.5/5 (6521)
- The Picture of Dorian Gray: Classic Tales EditionDa EverandThe Picture of Dorian Gray: Classic Tales EditionValutazione: 4 su 5 stelle4/5 (9756)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItDa EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItValutazione: 4.5 su 5 stelle4.5/5 (3279)
- The Odyssey: (The Stephen Mitchell Translation)Da EverandThe Odyssey: (The Stephen Mitchell Translation)Valutazione: 4 su 5 stelle4/5 (7770)
- The Picture of Dorian Gray (The Original 1890 Uncensored Edition + The Expanded and Revised 1891 Edition)Da EverandThe Picture of Dorian Gray (The Original 1890 Uncensored Edition + The Expanded and Revised 1891 Edition)Valutazione: 4 su 5 stelle4/5 (9054)
- Wuthering Heights Complete Text with ExtrasDa EverandWuthering Heights Complete Text with ExtrasValutazione: 4 su 5 stelle4/5 (9929)