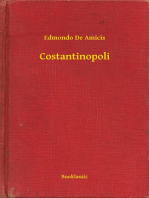Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
I Poeti Davanti Al Ritratto
Caricato da
lucaraschellaCopyright
Formati disponibili
Condividi questo documento
Condividi o incorpora il documento
Hai trovato utile questo documento?
Questo contenuto è inappropriato?
Segnala questo documentoCopyright:
Formati disponibili
I Poeti Davanti Al Ritratto
Caricato da
lucaraschellaCopyright:
Formati disponibili
FEDERI A Pr H
I POETI DAVANTI AL RITRATTO
D PETRARC A MARI O
maria pa ini f azzi ditor
ggggggggggggggggggggggggggggugggggggggggggaggg
~ .
I olwue pubblicalo con il contribulo della , cuoia .\'orma/e 'uperiore
o p ~ riaht ~ O 10: mari a parini faui rdi1or1
\ ia dflr \naplo Cu to<lc. 33 - .5'.'" 100 Lnrra
''" \\.pacinifazzi.it
mpf@pacini razzi . il
Priuted in //(J(y
Propriet le11crari11 ri . rrva1a
I. Il'\ 978-88-6.)30-001-9
F EDERl A PfCTI
IPOETID V TI L RITRATTO
DA PETR R AA IARI O
maria pa ' ini fazzi ditor
Premes a
ota al testo
INDICE
CAPITOLO PRI 10. PRIM DI PETRARC
7
13
15
1.1 Mitologia e prei toria del ritrntto 1-:-
1. 2 L'immagine nel uore 31
1.3 Laura (Petrarca) 43
1. 4 Il rin atto di Laura 54
1.5 Il rtratto di Laura nei commenti quatno-cinquecente chi e nelle 65
illustrazioni del Canzoniere
1.6 Il libro innamorato e il corpo del serpente 79
WPITOLO SECONDO. L'EREDIT QUATTROCE" TESCA
2.1 Dopo PetTarca
2.2 omini illustri, medavlie e g nealogi
2.3 Polifonia ortigia.na
2.4 Occasionj de1la poe ia d' amor
2.5 Il ritratto dell amata
2.6 Idolatria
2.7 Lomhra dell'amant
2.8 Il pittor torna ulla terra: rifessioni poeti he ' tl arte
CAPITOLO TERZO. DALLA CORTE ALL'ACCADEMI
3.1 Mandatemi la vostra imagio, vi pr1ego
3.2 N in ci me. ol, .ma l'arte inseme, accuso
5
89
89
92
103
117
122
135
141
148
165
165
7 ~
:t-t
tratttrie retorichr della pr senza
Lontananze
. \ corte. in 'illa e in accademia :3 .;)
:3.o. l
:t6.:2
:3.o.:
:3.6.-+
Il onctto su I ritratto tra elogio <:> dc. crizio11r morale
Ritratto ('Ome elogio
.\rmi e irnpn'se ' CTtte n i Yolti
L'elogio del ritratto rome elouio drlla por. in
Brllr> -,rnza nome
C\PITOLO QC\RT . IL HITR\TTO C Pl'.. HA 0'.\HTE
-+.I Dalryd a> al con. igli al pittore
-t.2 .llores animumque
-+.3 Per una fcn mrn I gia p etica dell'anima Yi'>ibil
-+.-+ L parole m \OC come anima
-+. I poeti darnnti al ritratto
lllu trazioni
Ref erenz fot urafich
Indi e dei nomi
,\bbre,iazioni
Bibliografia
.....
6
181
183
191
198
202
212
22-+
228
2-+ 1
2-+1
2?0
288
:300
308
:319
321
:323
338
339
PBEYJE.'. '
!Je111oiselles de Rocluforl di Jacque Drm). un romantico marinaio-pittore ri-
0110. cr nella l_>io11da Drlphin la donua di C'ui .. rnza av ria mcti vi ta. ha dipinto il
ritratto: la donna ('hr aspetta a e hr. sapeva. fatalmente auebl amato . . on olo
I" arte. attravcr-;o la fantasia, anticipa la vita. ma l'am re i annuncia e me amore
di un 'imma
11
i1w. di un idolo pi eh di 1111 r .. ere umano. :Iw ua a prima ancora
dell'incontro tra i futuri innamorati o. pi comun mente. quando i loro ..,auardi i 1-
crociano. il imularro mentale o dipinto d Jr ougetto amato ha un rnolo enzial in
mmi ' toria d. amore e . di on-, uuenza. qua i in oani narrazion . pri\'ata letteraria.
d lrarnor
1
111 poe ia si a. si t a un fenom no pi ompl o. rh ha i tratti li una
\'Cra r propria fo11dazi01u idolatri a: in quanto po sia d'am r , p ia d l de id rio
e dell 'a sf'nza, la liri a occidentale per eccellenza poe ia del ritratto. .o truita
intorno a un oggrt1o a sente. che vanamrnt tenta di YO ar e rappr entar . a
tro,a nelle ffigi dipinte' o ' C lpit daa!i arti. ti altrettanti p hi n i quali tudiar i
propri I ot ri r i propri limiti.
Cos. p r i p rti il ritratto in..,ieme un.op ra d"a11 w1 o tituto cl Il' g!!ett
amato. tm h1oao dcl paragon 1u1 mhl ma d Ila e ndizi ne liri a .. \f a-cinata
da quc to leuarnr eletti, . ho dr i o li ri,olaere la mia art nzion a un pi lo u n -
r portir a luncro tra. curato dagli . tuclio-i <li I tteratwa: onetti. canz ni. pi!!ram-
mi e madrigali dedicati a ritratti e compo ti tra Quattr r .inqu ento. nei ecoli di
ma simo viluppo della ritratti ti a fiauratirn. La prima ri op rta di [U ti te ' ti.
pe o 'eunalati t1i da e ntcmporan i rome \ 'asari e L mazzo. merito della !!ran-
de toria della critica c1 artr: dai rei rt01i pi nicri tici di ' hl ., r Cola anti alle
fondam nta.li rirerrhe di Paola Barocchi e dci su i alli ,;_fin a1la urand ' tagion di
<
tudi ull 'ut pictura poesis ulla ri ezi n delle opere dane
2
. \lichal.'I ha
ottoliu ato le ompon nti rct ri h d 1 di c r umam tic ulle arti. I and e Freed-
man hanno i11daaato lo . guardo cl i contcmp ran 'i di Tiziano. h arman h. ra olt
lr f nti lrttC'rarie rrlativr a Raffaello r ha rillf't1nto mauistralml.'nte sul rapi rt
I Prr un' affiNin111111 1rn11111i111u di qw ti ttrni . rfr. B1rr1\1 mu 1111d1t \ \\181' 197?.
' t11LO i> IR IQQ?. :01 \'>\\Il IQO.+. B\ROU lii t<)8.+.
<lC'll"art ri11a"ici11H'lltalc con lo p ttator . mcntrl' a Kri Knrz. a Kranz Pommi r
dobbiamo rie hi:,simi rcpC'rtori di topoi d e.rempla ricorrenti nelr logio dclrarti ta
('del ritratto:
1
., ul fronte l tl rario, rinter ' C ' i r im'l:'C C Il C'lltl'llO i11 modo qua i
<'' lu-iYo sul ritratto intr ' o com descriptio verbale, topos e' emplarmc11tc stu lia-
to eia Ciornnni P zzi". Proprio quc to oricnt amcnt ha ' focato una disti 11zio11e chC'
I t , o Pozzi mcrn in li ato con grande chiarezza. 1uel1a tra il ca11011e come
..,i,.,tema d :,, ritti\' il rihatto com t ma lirico:;: un quiYoco e nrC'ltualc eh ha
c n<lairnat il -e ondo termin a un p r it'ltCrH bli critico.
,\] biYio tra una n idrrazione trurnental dei t ti. int i com d cumcnti
o f nti. tmo tudi riaidam nt ori ntat , ui topoi. ho pri,ileaiato un appro rio
att nto alle raaioni letterari della poe ia ul ritratto itrieme aperto al confr nto
con le immaaini. a ri cr a ul campo. h mi ha penne o di rac ogli r un ampio
co1pus di te ti. ha in ontrato qu tioni m to loloaichc entrali nello tudio ciel rap-
porto tra 1 tteratura e arti fiaurntfre: ' po ibil ricorr re ai te ti p tici per studiare
lari zione cl lJ op r d'arte. per datari e int rpretarl ? In che mi ura la tradi-
zi n r rmi a. il c dic liri o 1 atte-e cl i committenti ori ntan co t rui cono il
di cor-o p ti o ull immaaini? A que te domand prorn a ri p n<l r il I r or
dia roni o del libr . h centrato ui e li di ma ' ima fortuna della p ia . u ri-
rratto (Quattro e inquc nto) ma non tra ura i pr e denti ami hi m <li e mli. La
rico truzione condotta ulr a e d ila crono! aia i ' intrecciata con l 'indiYiduazione
di filoni tematici (ainoro o. encomia ti o. filo fico), h aiuta a chiarir , ul piano
incronico. que tioni oli rnt dallo '1lupp t ri della forma.
Prendendo 1 mo e dalr pi11rammatica <rr ca e latina. il primo capitolo rile11ae
du pi odi cru iali nella prei toria del a ner : i marmi parlanti l I Puruatorio
r ffiai di Laura dipinta da im n I brata da P trar a
n I an::::.oniere. m d lii in !udibili per ani rittura ul ritratt laborata n i du
coli u e ivi. L paain dedicat al uattroc nto i con entrano ul rai porto
tra i po ti ali arti ti n l conte to dell corti. 1 nendo e nto della Yita mat cri aie dei
te ti e d ali ogaetti eh li i pirano. Com m tra il t rzo capitolo. nel I secolo
l'elogio poetico dell'arti . ta ' un fen meno di cui i ha chiara o cienza tori a,
mentre n i te ti i pr e dimenti i 11e ti d ll"art . rid tti a un rana nzialm nt
metafori o. mbrano p rd re il ruolo di aut ntica ontr prui d Ila po ia. I
pi no inqu c 11to la liri a cl di ata al ritratto ' imm r a in una r t di ap ri
lraati all'e pr ione <l lrindiYiduo d l u mondo interi r : la fi . ioa11omica. la
trattati tira. ul r m1 ortainento. le rifle. ioni filo of he e l lterarie , tdl'arnore e
3 fh\wHu 199-+. L\\D 199-t. FnF.t:DMA'I" 199;-. ' 11EARM '" 1993 !' 2003. Kn1. I' K1 R7 1980. K1 '<Z 1981 , P0\1\111'.R
:2003.
-I Pour 1993" 1996. Cfr. anclw Prn 200-t.
:; [ ... ]il 1anonl' un topos ll'l1trario la rui indipenrl nza dal motiH> d1I ritratto pu e-, ere dol' Ullltntuta ( ... ]
Pozzi 1979. pp. :}-6 ).
8
ulla bellezza. ,' ulla corta di que.-ti temi. il quarto ultimo capitolo affronta.
a.ttra,:-r:o lo. sguardo dci po:ti. una rric di que rioni cleri ivr per la . toria d Ila
ntralt1 llca: il problema d Il imitazio111-. il lavoro concettuale chr pr crde re er11-
zio11c' clel l' op ra d'arte, la po. ihi I it di tare il JJ1011do moralr r r anima
in un ritratto dipinto o colpi10.
_di vi la t oric?, la t _ 1imo11ianza dri t ti mi l1a inroraagiata a met-
tere m <l1 cu.- 1011 la e ntrahta dell C'cfra i 11 Jla n'lazionc tra ritratt poe ia. ot-
tolin anelo il ruolo f ri ritario d ll'rnromi) e il rilievo cu e pC'dicnti r t ri i chr
ri\' lan 11011 tanto la vicinanza quanto il conflitto la <liffonnit tra lr du arti.
La tra posizione po tira di un contenuto 'i. iY reale o imma<rinari . di fatto. un
procedirnrnto marainalr. e . on tti e ritratti pi1 lw imitar i mbrano condiYid re
1111 r prrtorio: il loro rapporto i drfiniBr cio in termini di circo]azion piI eh di
rispcccl1iame11to <' , i manife ta nei meccani mi di co truzion del ianifi ato pi
che nella nwmoria di Hingoli ogaetti <' i11aoi<' ituazioni . . ri te ti !"indubbia eco di
tipi. generi e funzioni ricon lucibili a immagini a orca ioni rrali i arrirn m diata
e pe .. o tra,olta da un codice p eti o riaido e definito a priori: darnnti al ritratto
figurati\'O il p trarchi mo non abbandona I<' trateaie ret ri he pr pri della poe ia.
e pri,ileaia in partirolarr quelle eh n riaff nnano il ruol ocialc e m morial .
Il repertorio drflnito dalla tradizion letteraria m della intimament rappro cio
lirico alle immaaini. ma que to non e dudc eh i poeti, al mom nt di e mporr
1111 -ouetto per ritratto. ave ro in ment dell 01 ere preci e o un.iconoarafia at-
te ta1a. r.: al itudine a l<'
11
ger i te ti attraver o la I nte della t pica pu far pa are
sotto 'ilenzio dati importanti. talrnlta da pr nd re alla l tt ra: le m tafor hanno
uno pe . ore e un rappono con la r lt e. "it11lo moa n od lla tra<lizion .
bi ogna rie uo:. ccr<' le zone dei tr ti in ui pi odi e n uetuclini mat 1iali i riflet-
tono con. rvando qualcosa cl Ila propria I cifcit e on r t zza. P r qu to h
empr p n:ato lo . t ud io dci topoi non o lo c m anali i d Ile f rm del contenuto
ma anche com un tra i pi mples. i avvin enti della , t ria d lla cultura.
Tra di ' Continuita puntuali e pcrmancnz di lunaa durata. la te timonianza lei te ti
rin a ci meu tali ri sulta vi\ a parlau te proprio e accr1fiamo di non ttrarla al con-
te to ibrido al qualr appartieu . una cultura n Ha 4uale non olo la po ia o errn
le immagini il filtro d li proprir m tafor . ma quelle t , metafore
ono mal rialm 111 coinvolt 11 Ila o truzi ne del! immaaini: rii tta in qu
chiave. la prc nt. zi ne po tica d i ritratti pu aiutarci a irnmaainar la \i1a di
qu ti oagetti prC'zi quotidiani. Mi quali J'em zione J'e pe1ienza i nJen a-
110 attrav t" O li11guag i odificati.
Os. rrvata !alla di stHnza r ala dal t mpo. ogni fa ' e del lm r di ri rea ha
la iato una tracC'ia ensibile nellr stratifieazi ni li qu t W>r , un percor o "tilla
mappa di5<'ITTJata lai t ' ti dalle i111rnaai11i r dai eon tti. Cia un li coloro che.
anch p r que:to qui " ali ringraziar , p ro i ri ono, cer in una in molt delle
9
pagiue che , O'uono. La prima idea di qu t lavoro ' nata nell' ambito di 1u1 cmi-
nario d dicato a P trarca e k arti lO'LffatiY , oraanizzato pre o la cuola Normale
uperiore di Pi a. da Lina Bolzoni. . iuliana Crerntin Donato: in qur111oc-
ca ione a\' rn indaO'a1 la fortuna dei sonetti p trarchc chi . ul ritratto di Laura nelle
liri a quattro-cinquecent p ca. L'anno u e s ivo. partecipando a un cor o tenuto <la
alYatore etti e dedicato a Ci rO'ione e .aravaaaio. ebbi I a ion di ricon idt'-
nue i ri 'tiltat.i di quei primi , ondaaai, promett nti p r quanto ca uali e pr liminari ,
a una erie di inunaaiui eh mi uggerirono po ihi]i sYiluppi d lla
ricerca in direzione del onfronto on i ritratti dipinti. Il tema co me o a fuoco '
p i div ntato l'argomento d Ila mia te i di perf zionam nto di cu a alla cuola
, ormale nel lualio '....006.
percor o eh mi ha portato da quelle pa()'ine a quc te fondamentali ono
tari ali interYenti dei re.ferees in cde di di cu ione (rinarazio tcfano arrai,
Elizaheth Cropper. la imiliano Ro i. ero-io Zatti e in particolare .\!aria Pia
Ell ro. eh in qu ti anni' p r me wnterlo utrice att nti ima prezio a).
ma oprattutto il laYoro di ommento e inhoduzi ne ai t ti per la eziouc anto-
loai a di Poesia e ritratto nel Rinascimento (...,008). che ho curnto in i rn a Lina
Bolzoni. Da Lina. he da pi di dieci anni eaue le ne ricerche. ho imparato pi
di quanto potrei mai pi O'ar ql: il ri()'or mai , parato dalr autentica pa ion
per la ricer a. il alore anch morale d Ila chiarezza. n I di cor o e nella crittura.
la ne e it di dialogare di metter i co tantement in di u ion . il ri.6.uto delle
di tinzioni e dei tracciati d'indaO'ine impo ti dai confini di iplinari. Le ono gra-
ta per omc ha aputo O'Uidarmi e incoraO'giarn. on fermezza ma an be nza
pretendere di cambiar il mio punto di vi ta il mio temperamento. olo la ua
aff ttuo a o tinazion poteva a'' r ragione d lla mia.
In ieme a lei. devo iinO'raziare O'li alli 'i del erninario di L tt ratwa Italiana
della cuoia Xormale negli anni 200-t-2010. che ono tati i primi. fondamentali
d tinatari del mio lavoro. ali amici e colleghi che al Centro Elaborazione Infor-
matica di Te ti Immagini nella Tradizione Lett raria della cuola Normale on-
dividono con m I' cntu iasmo e I' impeano della ri crea: rigoro amen te in orcliJLP di
crivania . erena Pezzini. Mart yna "rbania.k. Giovanna Rizzarelli. Carlo 1herto
Cirotlo. Andrea Torr . Ale anch-o Bena . i. mico Po enti. Daniele L ce e. ln-
fin . non ho mai dimenticato la !!rande O'entilezza di douard Pommier. eh a un
com' gno fiorentino n I 2002 a colt il mio intervento pp rivolO'er. i a mc e n
la emplicit di un coli ua. nono tante la ua traordiuaria comp t nza in materia
di ritratti. In qu lla te a o e ione Elena Porciani mi aiut a immaginar qnPllo
he. in fondo, ancora il nu leo fondamentale <li qu to lavoro. Antonio Fcmia ha
a uto la pazi nza cli rived re le mie trnduzioni dal latino oprattutto di in i t r ,
a lunO'o e a ragione. perch i capitoli fos ero quattro e non tr . lnGn dav ero non
o ome ringraziare Cri tina avetticri. che ha letto e miO'liorato eia cuna di que te
pagine. nate iute .. pc o, clal nucl o vivo dellf' no tr con er azi ni: on lei
10
condivido passio11i. dubbi r iclrali st>nza i quali qui'. to libro :ernplic meutr non
csist l'rebbr.
()ursto libro(, <lrdieato a mia 111adr e all a memoria di mio padre. chf' devo rin-
graziare per infinite ma prr una pit1 che per ogni altra: hanno sap11to voler-
111i brnr sr111prr srnza mai dcC"idere al posto mio. La loro one 1. O'en ro a, i:tintiYa
e . rnza compro1nes. i - 011rst chr r da Pro di un altro trmpo - tata ccl ' per mr
i I modello pi prezio. o.
F. P.
11
(; PJTOLO PRl\10
PRl\1 \ Ol P , TR RC
1.1 ilfitologia e preistoria del ritratto
La tradizion drlla poc::,ia ul ritratto affonda in un compie o retr t rra di e pe-
rienze del!" autichita grecar latina. che i o ~ t r porti del 'ledioc o d I Rina im n-
to conobbero dirC'tlam nt o p r tradizionr indir ua
1
Di que l rie o material ci
intere a ' Oprattutt quanto pot rn ser C'ffrtti\'amcnt pr nt n lla m moria
n Jr officina dci po ti. e il modo in cui la lirica n ' appropriata n i ecoli nell
forme. . ndam ntalC' . fin daL\lt>di C\ . ' r app rt della .\'aturalis JJistoria di Plini
il Yecchio (I c. d. ..). il cui libr , , X\' in parti olare tramanda i pi importanti
aneddoti ' ugli artisti antichi mili fondatori p r la toria d lrart tout courl e per la
toria dcl ritrallo in particolare
2
. pili c lehri tra iue ti nomi i a ociano piodi
e emplari. o p si tra toria e mito depo i tari. in as enza di una t oria dell'arte. di
e ntrnuti :-;peculati,i ed C' t ti i eh aranno rac olti rip n ati in forme pi t -
matich daJla tradizione uc , iva: iamo n !l'ambito di qu Ila eh Baxandall ha
chiamato cruitoloaia della toria deirac1 :
1
In Plinio i topoi cclebraU\' f ndam ntali p r la tmi.a d 1 ritralt i novac10 e pr ' i
in fatti e . l ri . Jaddo' la p eia tend ra a condrn arli in formul ntenze: apa it
illu i ni tiea dell'imitazion , rapp rto ostilutivo tra ritratto originai . ruolo e ntrale
dell parole per la fortuna 1 er la dnrata delle oper dact . Aprll . Z u ' i. Protocren
crli altri compaiono. n Ile pi yarie combinazioni. in ,. 1 i 1ualtro-ci.r1Cj11 nt ' hi h
celebrano artisti e hrll zze conlemporan e: s no n mi hc oncrntrano in una leP"-
a nda. nomi-e.rrmpla. radunati a f rmarr I nchi arche1ipici ( Z u i. i ipp . P re -
til At llc*). I criteri h oraru1izzc no que. le emuu razi ni. ra br ,; - in aen r in
.' d e rdialc - ora piu ampi . uon emhran ten r nlO d lle eara11eri tiche tracna.n-
datc p r ia cun arti la. ma 'Olo. e non m1 r . della corri. ponci nza tra i materiali
I l
1
n buon r<'pl'r10rio di u-.1i n111ichi ancorn offl'rlo dn REr\\Cll !<>85.
:.! PLI\10 198:.!- 1988 [ \/ !] .
:3 13\.\.1">111. 199i. p. C>O.
.. CORRl.GGIO l %9. 18'>. \, I .
1:-
le . inaolc art i di a1 P< 11rn nza ( ual Zru;.. \p<'ll . qual pirlor piu dc crno./ . I rn
ritratte mai d tmo huom figura?/ Qual Pra it<'I mai fiwe iH p tra dura/ imaginr pi
,rra 'ol ' llO iJwr<1110?: ual Fidia. qual Lisippo o qual Ap Ile/ piw infu r o ('Olpio
forma o fi!mral in t la, in oro in marmo. ( ... ];). L'r crnplarit di cui i 11 rni sono
pm1atori LU1 arattrrr pi uniYer ale, ernhra val r in riferimento alle arti Iau-
ratiY in g n ralr. l ' na cl Il modalit principali deir I aio di dipinti e scultme :i r a-
lizza attrm n. il e nfronl tra i ,cechi e i nu ,; campio1 drllartr. che f arrn
ri,iwr in '. i arandi prede ori (alter lpelles. notus ... ). dand e rpo ali' ipot ..,i
<li tm imma!!inario ritorn d i maetri. di n nna rn ato. e m limit impo sibilit.
in conte ti enc mia lici ( Ritorner bb al . reo! n stro indarno./ p r trarne empio.
di Zeu i rinaeano/ 11 ali altri hebb r fama di qu Irarte
0
) . om ,. dr mo. da un
i1 m mento in p i. ai n mi della eia ieit cl ll'ell i mo i affiancano quelli di
m1i ti del recente pa ato o addirittura <lei pr cntr ( iotto. Cimabue. r poi Michclan-
a('] Tizian ): J e ll nza si diinotrata attingihil anche nella contemporaneit. e.
di 01re!!uenza. anch con paradiami to1icamente pr uni h i mi ura. nrlrdoaio
po rico. il talent di infiniti pittori ,enza fama addirittura nza nom .
Per Plinio non' . i tito mae-tro pi !!rand di ,\p il (XH .. ' XY . . 9-9. ). famo-
..,o per i uoi modi affabili p r la crrrazia> cl Ila -ua I ittma ). autore di una drlle
opere pi cel bri dell' anti lt. LVrodite .\.na<lyomen . ma anche di . tra0tdinari
ritratti. P r qu ta ua lot fu celto da .\le '.'andro \la ano om 1itratti. ta ufficia}
(per la pittma. in j 111 a Li ippo per la ' Cullura a Piraotele per la a}ittica): per lea-
11e. a ne un altro era n entito dip:inaere l'immaain d l O\TlllO mac donr. Que ta
,; nda fonda un I aradi!!ma celebratiY f ndam ntale. che e prim il rapporto di
cambio tra du e cri! nz . qu Ila deffartc e quella del pot r . che -,i aaranti cono
r iproca fama irnm rtalit. In qu t l o i in riYe. come p1u 'i to amen te
di aJni. il fortwrnt dalizio tra Tiziano 'arlo Y. e i afferma l' u o della rappor-
tatio tra arri mat riali come 611ura trutturante p r i componim nti d'encomio
( e Li ippo d ,\p li 1 grande Omero/ ol martcl. o i lori con rin 'hio tro:
dico 'irgilio per rit rari a in carte./ pelle i11 t I Fidia in marmi vivi
7
) . La
embianza d l r . la pos ibilit o meno di rappr . cntarla. ' ntral nrlla ' toria
d Ha ritratti tica n Ila poe ia eh la l bra. daali umani ti a or11e dc ,' ud' ry.
Fin da P trarca. ritratti ono innanzitutt qu lii d ali imp rat ri d ali i1Ju..,tri
8
. e
:; . TF B\'.:i:;o nl/2. 5;- 6. n . 1-i: Carlo llirrio. Q1111I Fidia. qual Li ippo o qual 1p1//1>. n . 1-:t in
R1111e 1:>60. p. 1. 8. Con11 ndremo. i ca i in rui qu""li u i non '0110 generi i appaiono rrr11ioni. mo1i,atr dal
l'IJllle lO.
6 CoPPETIA 1912, LX\Xlll. n . 9-11.
7., \ inr1uz2 \lanrll}. ''e Us1iJpo ilprfle <' 'l grande 0111ero. vv. 1-2. in Hi111P 1545 (200 I), Il, I (p. 15); Frmu1t1
Carrafa. T 111re ogn or la /Jelto, 1mre se stnsa. vv. 9-1 O. in Ri111r 155:3. c. I 96r.
8 Per !?Li i numi 111111ici di Petrarca. a111 tati. ad p.,rrnpio. da alc-unr lrtt r del 1:355 a Frtmcr"ro \ pJli , cfr.
\Il .' 1998: nc1Hemm111emom11darum libri. 11 propo.i10 di \'r,pu.,iano. ,,j <';prime l'idea ciel ritrauo 1ornr prova
,1onca drl raral!('rt' d1i '0/(!(<'11 i 1ffigiati.
16
la prima !iip;nificati\ a irnprnnata nrlla produziour di v r i dedicati al ritratto. n I
Quatlro<'ento. i lcga proprio alle rffigi cl i potrnti. na crndo in m rginr ai profili di
duchi e. ignori imprc:si sul) mecla11lie'1.
J 11 nte di prJle P legato aneJir UJI pi odio clw apparii ne a lii! altro capitolo
della toria drl ritrailo. doYc non . ono in 11ioro tan1o il potrrr la gloria. qurullo
l'amore e la bcll<'zza. I andro con('<' ' e ad p llr la pr pria fa orita Pa11 a pe.
dr Ila quale l'artista ali av rn dipinto un maanifico ritratto (, \/ J , \'. 86-8. ).
Que t aneddoto. ripn so. tra ali altri. da Ca tigli n . \'a ari e Band Ilo. fa I va ul
rapporto tra ritratto d iclerio e intr durr un nuovo p r. onaaaio nel trianrrolo tra
op ra. pitton' committ nte: la h llrzza in carn do 'a. Proprio Pancasp . in ieme
a Frine, ar bbr servita da modello per la forno a frodit u rent dallr acqn . eh .
o serva Plinio. fu Claltata inveri up .riori al quadro te .. o (ivi. 91)
10
: la po ia vin-
ce il quadro ma gli assicura la fama (vieto cd inlu Irato) e la . opravviv nza nel
tempo, indicando uno dei po ibil tracciati . ui quali. per e li. p e ia arti fi!!llfa-
tive i in ontrcran110. La fida tra le par le e le immaaini cm ra . in un altra chiav
e con e ito oppc ..,to. a prop ito di un quadr eh rappr entarn Diana nel coro del!
,crgini sacrificanti . 11cl quale Ap li a\r bb up rat perfino la <le ciizi ne me1i a
della st s. a se na
11
Apelle trionfa nuovamente in un altro confronto paracli!!matico. quello con la
l\atura, dipingendo un cavallo talmente rf'ali tico da far nitrire. in 'Ua pr enza. dei
cavalli in carne cd o -a (i .. i. 95 ). La reazionr di pettatori umani e ru1imali defu e
una d Ile videnze fondamentali drlla capacit illu 01ia d IJ'art , che fa r dcr ,. r
ci' che non lo ' . L uva dipinta da Z u i attira ali uc Ili ma. on pi mirabile prova.
la tenda di Pa1Tasio inaauna il pittore t s o (i,i. 6.) ). Il limite tra illu ion e realt.
ul quale molt e cli qu<> t op r r tauo o I . per la m rm ialia di l auarda. pu
e ere uprrato dalLrrtista-maao eh a d nar \ita aniJna alla pr pria cr azione.
fondati\ per la ]erraenda cl Jr ar1i..,1a-maao e per fayyeutura l tt raria d l
ritratto infatti qu Ilo di Pigmalione. nan-ato <la Q,i.dio e ntral gi n Ila ritle io-
n m dicYale
1
'.!. La storia dello . enltore he i innamora di una propria op ra (una
belli. sima statua da\'orio) e oltiene da\ J1ere eh quc ta prenda vita. rappre' nta
una er. ionr a <1111: dcll'archctipica 't ria a trr ( amant . amata. ritratto) eh fon-
da la ritratti tira: Plinio (.\'H\X\Y 1; 1-13:i) attribui rin\'cnzione delle arti
pla tich a un vasaio cli , i ione. Butadr. che U\T bb plasmato un ritratto d lruomo
9 crr. infra, ntp. 2.
IO Qui Plinio ru riferi11u1110 H"li f'pigrmnmi di Lro11idu ( Palatina [ I/>] I\'. 182) ('di \mipalro di idom'
(ivi. 178) fn11t0;, i 111tra111hi , if primo p!'rd1( clrtl! inizio ui componimr111i rcfrm,1id ul quadro, il :.tt'OJHlo 1wrd1
fu 1rado110 du Auso11io. h11f{m111111i. I 06 (.VI I. p . . '389, 11otu 91 [ \ . CoNi] ).
11 Omero 11011 solo ' il potta Jll'J' ('('('t"llenza. Jll(I '. ud l'l'lllpio. raurnri1 o 111 fonte pili freqm'llll'lll!'llll' t'\OCtl((I
per i quadri desni lli ncllf' l11111111gi11i di Filo.trato (p1r cui rfr. infra. i11 qut'>lll paragrafo).
12 Cfr. K1u. e KLR/ 1<>80. i11 partirolar!' pp. 07-72, 1 , TOIClllT\ 2006.
l .
amat dalla fi<Tlia. e ond Bettini gue ta ,-iccnda. n Ila quale !"immagine c011 ola
delra enza. tar bb anorigine non olo della ritratti tica, ma delle arti figurativr
in g neral
13
.
U ve1"an1e amoro o della toria po tica d l ritrailo. che si -franger in i11fi11ite
e anoime variazioni. ' dunque profondarnemc leO'ato alle ori
0
'ini toriche e an-
tropolocri -be dell'art di prodmre irnrnaO'ini. e Pigmalione in arna la pi comune
direzione lirica del de id rio, dal pocta-amant alla d rma. quella inver a. che dalla
fiO'lia d I rnsaio porta alla Fiammetta di Bo ac io al! po 't " ed l Rina cimento.
trova un ar hetipo nella prematma olitudine di Laodamia. 1 ella ver ione ovidiana.
la tatua di cera con cui la donna i con, ola dell' a , e11za dello po o e i te prima
an ora della partenza cli Prote ilao per Troia dove ar iJ primo a cadere:
Dum tame11 arma gere diveco rniles in orbe.
Quae refernt \1.tltu e t mihi cera tuo' :
Illi blanclitia . illi tibi debita vcrba
Dicimu . ampi xu ac ipit illa meo .
Crede mihi. 1 lu e t. quam quod ,ideatur. imago:
Adde souum cerae. Prore ilau erit.
Hanc pecto teneoque inu pro coniuae ,. ro.
Et. Lan1quam po. il ,erba referre. querorli.
In que ti ver i si defin ce W10 chemanarrativo e lirico. ntrato ulla finzione epi-
tolar e ulla yoce femminile. he emer la t01ia del ritratto in po ia e nel romanzo.
I dov ri militari po1iano lontano l'amato, il ui a petto ' re tituito dall'imrnaO'ine in
cera. OO'aetto delle amoro attenzioni cli olitori ervate a colui he ritrae ( pro coniu-
O'e vero
15
): parole tenere abbracci. tm iito priYato n l quale O'ioi c la i ta ma anche
il tatto (Y. 1-8). e del quale i ri order Cm tiglione. immaginando una l ttera critta
dalla moulie lontana
10
Il pot re dell'immaO"ine up ra il pmo dato,; ivo, nrllc capaci-
t pr free neO'li affetti che u cita. Alla ua verit manca olo la vore. il uono. al
13 fl rimpianto per la perdila della persona arnaia (owero la rrrazionr cl I primo "ri1ra110 drll'a111a111r ") po-
trrbbc 1antare il pri1ilcgio di al'rr dil'ruamrnte l'art!' di errar!' immagini: qualsiasi tipo di in11nagi11i
(BErn\11992. p. 10. con riierimrnto a Xl/ 35) .
1-t cTuna1ia. linumto che tu. da oldato. ponrrai lr armi ir1 un mondo lontano. ho 1111'im111aginr in cera clw mi
rrumnrnta il mo volto: io I clic-o tl'1wrezze. le parole eh ti ono do1ut . ed e oa ri1r1r i mi ri abbracC'. Que'>t'i111-
pi1 di nou crnbri: aggiumti alla cera la \'Ocr. e oar Prot e. ilao. lo la guardo e al pt>llo la
tnngo l'Olllr il ID.lo vero manto, e m1 lamrmo on e a come e pous8r ri'ipondenui (I leroide.y. 13. 11. 1-1-1 8,
trad. C. Ro ati. in Ch1010 1989 [ller]).
1.) B ttini ricorda rhe Laoclamia a1'r1a posto la starna nel talamo fi1111 ndo rhr ,i tratta se di un' inamwim sacra
'." 1'011 il di t . timonianzc iconografi he. sottolinea il rapporto tra fant:i sma (' ritratto: r anche
11 l<'gamc I 1rnrnagme sognata: Laodamia lralla lr immagi11i notturne esa1tanw111 c come il si11111lacrw11 di
l'hr cornr idolon, sim11lrtcrwn. imago. po sono rifrrir i irHliffC"rcutrnwntr , ia
aU 1rnrnag111r onmca 01a all f/1uir ncata da 1111 artista 1992. p. 16).
16 Cfr. Bo1..zo:;1 2008. pp. 134 138.
18
punto dw Laodamia I< parla. conw se la cera potr seri. pondft'e. Jn que 10 colloquio
i11tirno e intpos: ibile s1wcchi<'r P trarca davanti al ritra1lo di Laura. ipo tatizzazio-
11 e di 1ltl dato interiore e i11 sic rne materia storica, oc'C'a:ion rcale
17
.
cl Filocolo (IV. . 9) di Boccacf'io la icc11da di Laodam.ia ' 'iene ricordata com
e:re111pltw1 per dimostrare la 11at ura <loloro a dcl la lontananza tra gli amanti. con1 ro
il parere di Fiammetta. rhr aff rrna i11vere i vanta"ITT di un pe11 iero amoro. o lib ro
dai tornwllti drlla prese11za fi sica. Proprio lo lato d'animo <lelratte. a trepida e la
fedelt i11rrollabile drlla posa dovevano tra parire ul volto deUa P nelop di Z u i.
in qua pinxi se morr vidct 1u
18
. A que to grctndi" imo pittore (.YH XXY 61-66)
tiarehbe dovuta l"i11trod11zione delJ' u o di ricorrere a modelle per i nudi femminili.
conw poi nell'Afrodite C11idia di Pra 'oitele (ivi. X VI. 20-22) e nelJ' nadyomene
di pelle. li celeberrimo aneddoto del <]uale protaaoni ta (ivi XXX . 6-i). da Pli-
nio erroneamente riferito agli AcrriO'entini non ai Crotoniati. lcO'ato all'e cuzion
di LtJI quadro. quasi certamr11te di Elena. la pi Lella delle mortali. p r realizzare il
quale egli in pexerit \'irgi11r eorum nuda et quinque elegerit. ut quod in quaqu
laudati simLun r !'>C1 pictura redderet
1
'1. La fortuna d ll'an ddoto di Zeu i e le fan-
ciulle di Crotone particolarmente omr le a perch in e a topoi dell'encomio
dibattito uff imitazione . i intrecciano in uicabilmente
20
: ome Yener tTa le de ,
cos Elena tra le donne mortali termine di paraaon l 1 lo durevole p r la bellezza
femmini1e: al tempo ste tiO, l'operazione compiuta da Zeu i con egna il m rito d !-
l'arte non alla perfetta riproduzione di un corpo natmale. ma alla rappre entazione
Ji un corpo ideale a partir da un imula ro eone pito nella mente. La compre enza
di queHt componenti e il con ueto frazionamento d crittirn cl l coq o. pr c1itto
dalle artes m dievali e fatto propri da ll a poe ia. ' pi O'ano re,idente predilezione
dri poNi prr questo rpi. odio. in particolare per la ua roYe ciata: il piitore
non lia bi sorno di fare come Zen i. cioe cli ricorrer all'imitazione el triYa per dar
corpo all'ld:a. perch la bellezza che deve riprodmT ' !!i perfetta. Alroppo to d ila
pluralit di modelli , 1a rtdea incarnata. la b li zza ideale. che raris imo, ma non
impossibile - nel reO'ime iperbolico cl ll ' logio - trovare in terra.
In ieme ad pelle e Zeusi , il terzo grande eroe di qu ta pr i toria ' anche il
piL1 precocemente ri coperto. Poli lcto. ,elebr per aYe.r pr o le.
in un'opera d'arte. il Doriforo (il co. iddetto anon ) rn bronzo (1\H Xn , 5-
1? \ el 'ff1mph11s C11i1idi11is. I. 1. H2 si lrggr: r Laodomia _t:3Q) (1'. il
Prothe ilao (1\.TR\Rt i 19%1i [1-i0t!{i]). Il rapp rto tra R1f LXX\ 111 r I ov1diana e11 ola cli a P10-
1c,ilao trn ,11110 bugg1rito gi dn 1111 comm ntatorc co. Daniello. a d1.
( D1'\1J::t.LO l!i-+ I, I'. (l2i) : cOndt' 01'idio iu pt> r,ona di l.aodanua: Crrdt' 1111111 plti-; rst. quam quod 11drauu tma"o.
i\d<le so1u1m Cl'l'fll'. Prorl1rsil11m; rril >.
18 unn Penelope nella qualr sc111hrn nwn1c dipint lr cprnlit interiori (,\'/f X. xr, o3 [rrnd. R . .\lugdlc,i]).
19 volle prima e aminare le loro fauciullP uudr, quindi ne serbe ciuque conu' rnoclell affinch la pittura rcndl\' -
c ci rhc c' era di pi1 brllo in cit1st111J11 di loro {il i, 6-+).
20 Cfr. S.11mrn o 1997. PoMMIER 2003,
0
t'01r.111T.1 2006 e infra. 'i. J.
19
.-6). fin dal .\I dioC'vc lo rnltor rappr. nta un paradigma a Iulo di grandezza
m1i,tica. indipendcntemcnt !alla ua art<' di appartcn nza. uittonc d' ,\rczzo, ad
esempio. lo evoca com pitt r ( h la natura cntcsa/ fo di f rmarc voi. co 1 b n
pintor .IP li r to f de la ua pentura'.!
1
): P trarca. in apertura dcl . onctto L ' VTI.
cmbra fare lo ' te o, . n n he, om hanno 'Ollolincat B ,ttini antagata. in
qu to e ordi P li I t c nta in primo luocro om rapprc entantc (\ clllplarc ci 11,
arri wttc. contrappo t alla 1 ia ( cP r mirar Poli 1 t a prorn fi , o/ n
crli altri h bb r fama di qu Jr art f
2
. Petrarca. dC'I r ,,10. n va altri nomi di
m1i ti anti hi. al uni compaiono in altri luocrhi cl 1 a11:;011ier
1
\n hc I r quC'. to.
come vedremo. difficil I en ar h n lla . elta di n minare P liclcto a I r posito
lei ritratto di Lama n n ri uoi un ri ordo dant o.
n valore mit logi o' analocro a quello dcl confronto con i mae tri dcl pa ato
pu aver la menzione. per paralleli mo op r antifra i di arandi oprrc r mcravialie
d ll"ami hit. om la citata rodite Anady m n di Ap JI o lo rriso lcfanti-
no di Fidia (XH'\XXTY :- -t). La funzione di imili rif rimenti e aia chiara nrlla r -
torica ta.rdoanti a. condo i pr tti pidittica di \lenandro retore ( m-1\" . c. ).
n i pan miei di itt di f t non d Y mai man ar un'ekphrasis cl Ila tatua d I
dio. che forator d ,. para a na.re a.110 Zeu di limpia o a.U. _\t na d Jr \cropoli
loda.re fino a.lJ'ip rl ole. uaaerendo che p ra di O dalo. il miti o inY ntore delle
arti. o eh ia caduta dal ielo
2
i. X l di cor o n omia. tico on l poemetto c lcbrati-
vo, un opera d'art di qu . to luogo di qu t tempo defin ceco ' la sua grandezza
in rapporto a op r cl I pa ato e a un'mi!!in traordina.ria. ovrwnana p r I doti
deir artista o per h' donata da ali dei enza m diazion mortale. :\ I pa saggio alla
liri a in en o tr ti . la topi a d Ir loai uhi e agaiu tam nti rifunzionalizza-
zioni. La Yen r di ,\p Ile ' rn ata. ad e mpi . in un on tt di orquato Ta. o.
a propo ito d l ritratto di wia donna amata da Yircrini r 1m. mmitt nte del
ritratto e del on t1 (quale p ile la di,a in ar1 fin ./tal l'av t p r man d"altro
pittor ):!.'>. Il ampo d I paraaone. qui contato. J'r ezionale belll.'zza eh a omu-
na la dama la dea. Un eff tto pi marcatamentr iperbolico produce. in 1111 n tto
cli Antonio Tebaldr . I" lenco di p rdut OJ ere colo ali d Irantichit nrl conte. to
d Ila e lcbrazioM di un I u to marmor o ( D Ci ,.e Olyrnpio il imulaC'hro r p('r. o/
rIIercul d Li ippo. u pi mira/ Rhodi la tatua de C'Olui h aira/ col . 110 carro
illu tra.udo f uniy r 0:>
26
).
::! 1 'i 1rana dri n '. 10-12 di Ila canzone . ' p 1oi. donna geni<' ( ,1 11ro,t o \.REZZO 19-+0. I). Il paragorH' qui 1 ra la
natura e il pittore(!], LIII la clor111a e l'imrna"inr dipinta.
22 Pr il sonetto e i prolil1111i intrrpr Jali\i clre ollrva, cfr. i11fr11. 1.-+.
2:; Cfr. Bn.1 '\DUL 199't !' 2005. pp, 128-1:35.
2-+ \b \."IDRO HTORE 1981. 011 epideictic. Il. pp. 220-222.
2:> 'I\ o 199-+ [fl7]. 1:; 10. w. 7 -8.
2b 1989-1992. (I/ I. 229, n. 1-4.
20
Cn ntributo senzial . a partire dal X re lo. ' off rto dal!' ppendi:r Planu-
dea, raccolta di <'pigrammi areC'i dal!' t al , andrina al YT olo. C'h i. pira e ali-
menta r oprra di 11111a 11 i. ti e porti neolatini e olgari tra Quattro e 'inqnec nto (pi
visibilmcnt dal 1.) 15, ad rs rnpio 1wgli . tram botti di ccolti e in lamanni). ma
e crcitcr la propria ma ima influenza tra il 1.)50 e il 1610. in particolare nel ma-
driaale17. um<'rosi <'I i
11
ramrni di qu ta :illoa . ri coperta necrli anni e :anta d I
Quattroc 11to e . tampata p r la prima v lta 11 I H9-t. venaono traci tti e riadattati
dai po ti ali' rlo
11
io di oprr e nt mporan :!S_ on v ri propri al hi. che po ono
funzionar p r il prr C'nte I erch' n I conte to ernpr ripetuto <leir en mj ali l -
menti indfridualizzanti no. di fatto. intrrcambiahili. La maa i r pa11e d Ile fomr
dipinte o olpitc cui ali epicrranuni i rifcri cono apparten no alla mitoloaia. ono
roi e divi11it (1 iohr, Ercole, Medea, rianna Poli ena. Z u . \'enrr ...
2
q), ma non
mancano ri1 rutti di rno11ali :
1
o. Ricordo ad e rrnpio la lunaa e rie di omponimenti
dedicati allr . tatur di auriahi vin i.tori. \ r i che. alm no in pmt , fmono in ritti
u 111011um nti (11P X\'I. 33- -38-t). Da qu t patrimonio di narrazioni tereot1p1.
pr enti \ariati an h ndl"Antologa Palatna (n ta a partir dalla prima met
d I XYII . ec. largament 'O\Tapponibile alla Planudea ). derirnno m tfri poetici
di luncra durata. eh ,il up[ ano il t ma deirillu i n d Ila ,-ita nf rita alr opera
dall'eccezional e abilit detrarti ta: l"inarumo pr dotto in p ttatori umani animali,
il tox sola deest (manca solo lavo e) il rapporto tra parola imrnauin 1 tto om
rapporto tra anima e corpo.
Co la cagn tta cli Taumar ta cred di a r dmanti la propria padrona in cam
e O'sa. 11011 la sua iuuna!!ine (AP L . 60-t). o, r ipro a.ment .. \lcimen rea.cri e
a una riproduzionr . omialianti ima d l I roprio ca.n e m r animai fo e Yi.vo
(,1P \'l. 1?:- r
1
. L fonnule eh comprrndono l'aaa ttivo c\-fro> a.ranno tra I pi
frequenti nrlla crlrbrazione di ritrat1 i. anche ulla corta di Yinrili ( x udent alii
pira.ntia molliu!'l aera/ (credo equidem). ' 'i\'O ducent de manu r rnltu
3
:?). razie
alfoprra degli arti ti . il bronzo embra re pirar , il marmo i dir bb ul ptmto di
27 P<r l'tn<lit mttrica dtll'<pigramma rl!'l madri;wlr rfr. infra. rap. 3. passim: cfr. I hTHl' I pp. 56-5-:' r
prr \(arino dr. C1Rt o :!002.
28 crr. I ltno' J 9:35. pp. ;j ;j ( . ;j :j ;j_
29 l-+:i (, \riaima). J51 (Diclonr). Cfr.11ndwi1i.9-.105.
107. l IC)-U2 (,u \11--1111clro ,folpi10 da Li,ip1o). 127 (,1a11111 di Lirnrgo).
:30 ' 1tl.1R\11"1 199;) (p, 11-+) 1111110111 rh cTra gli irnniri ?elr.tntolo!!'ia un ch_e
rigu, rda i rilrnlli : !-.OllO <'pirn111mi dw t>prirnono propno lo . tornggrnrnem eh prmw11 Ghrrlandaro: e lo il
pi li ore li av!'SS!' 11ggi1111to pnrola. ,a1'<'>ri dawrro tu sH'o'u (cfr. il gi citato rpigru11111111,JP \' L ;3;2).
31 Qursto <'ttrw sapie111r di forti b11ttute di rneeia/ :<colp Liront'. \lcmene Critirht 11011 nr trov._ l'off-
rente: vedl'ndo dre in tutto/ ri>pondl'\ a J'in1111agine 11l 111oclllo. ror1 un collare or fec<' da pregando L1conr:/
Fa' dw ('11111111ini ! Che ahbain. lo o (. IP \ 'I. 17.'l [ la!'l'Cloniu rori-ole] . CT"ad, F.\I. Po111a111)
:32 e Forgeranno altri con maggiore rl "'llllZH ,pirante bronzo.I rndo di cerro. r tr11m111no dal manno \'iY miti
(\mcn.ro 198.) (, len]. \I.'' 8-+7-8-+8. 1rnd. L. 'anali ).
_1
prendere Yita. In linea con l adagio attribtto a imonide:
3
\ a una rappresentazione
co nro' imile manca olo la parola: e il ritrntto di gatarchidc ave la voce, sa-
remmo in presenza di lei in tutta la ua verit (AP VI, 352)
3
;: alla , tatua di Omero
manca olo la voce. che al pittore non dato rubare al modello. L'ru:tc in grado di
raffigmare l , mbianze le Iorm , ma non pu oltrepa ru i limiti del corpo (Di-
pinaere 1 arrima oo-liere le parvenz esteriori facile:i.;) . Pu afferrmlrlo il
poeta, pro domo sua (Pittore. tu puoi rnbarc soltanto la forma, ma non [ ... ] cattu-
rare la Yoce
3
<
1
), o l'artista te o ricono cendo i limiti del proprio lavoro (Io che ho
dipinto la forma vorrei aver potuto dipino- r ru1che il carattere, ma i limiti dell'Arte
ham10 frenato la mia ambizione
37
): qu to uno scambio di voci in ver i, di norma
fittizio e co t:ruito dal poeta che ar ripreso e variato per secoli. A immensa fortuna
de tinata la versione del topos 'h dobbiamo al pi celebre autore di epigrammi
della letteratw:a latina)vlarziale (I ec. d. C.):
Haec milri quae olitLu- violis pictma rosisque,
quo reforat voltus. Caecliciane, rogas?
Tali erat Marcu mecliis Antoniu anni
Prmu : in hoc iuvenem se vid t ore enex.
Ars utinam mor animumque effingere posset!
pulclrrior in terri nulla tabella foret3
8
_
All'amico Cedicano che gli chiede h rappre enti (lett. quale volto riprodu-
ca) l'immagine (pictura) omagaiata con viole e rose, il poeta risponde he ritrae
Marco Antonio Primo nella mezza et; nell1a petto (ore) che vede raffigurato il vec-
chio ritrova se stes o giovane. Plinio racconta che os ervando i ritratti dipinti da
33 Il <letto di imonide ricordaio da Fiuta.reo (Moralia, lJJ_ 346(-347 e), Cicemnc ( Orator. XlX, 65 ), Qui11 !ilitmo
(l11stitul1 oratoria, XI 3, 67). ma cfr. ancbe Lucano ( omnium. 8 e Eikones, 8).
3-+ 'T'ratci di gracili mani. Ci sono_ Promteo dile110./ persone wnaJle pari a tenelra1t ./ S chi dipinse r rffgic vera-
ce le dava la Yoce} Aaat.rchide aYre1mno vrva e v ra (AP \Il. 352 [Erinna), trar!_ F.,VL Ponta:ni )_ li libro VI dell'A11-
tologia raccoulie epigrammi \'OtivL bialietti per accornp3f,rnru doni in occa ioni .reali o meno. auguri per ricorrenze.
con cararteii che a.ranno condivisi da rnolci testi sul rioatto. Cfr. ad e . un epi"rarmna di Leonida di ' lranto, a
di un ritrar10 di scarsa qualit: \'olle la madre r effi"ie parlaJlte di Mcito. A Barco/ questa ero ta regala (
tanto )/Ora, Bacco, fa' tu eh Mcito cr ca. Una ero tal il dono? La mi eria questo l (ivi, \rJ, 355). Cf r.
anche i,i, \1. 338. vv. 1-2 (Eccovi, '.\1use, la tatua di rnarrno che nocle dona/ a tuff 'e nove. per riconosce11za ).
35 Lanima arduo ritrarla: ua ciare una forma riesce/ me,,lio. Per te va tutto al la rove eia./ Evidenzi ' la 'lor-
tura tua la.Natrn'.a,/ la.rec ndJa fcra del meni re il pasticcio di quella tua forma., gurl fi ico
olnau1110/ chilo traccia, e l'o duo ne nfogae? (AP Xl, 412 [Antio o]).
36 <AJrro non puoi carpfre che forme, pittor . La voce,/ obbedendo al colore, non la rubi (A P XL, 433 [Lu-
ciano]).
37 Cercai di dare. pi che i tratti, l' indole, ma i de idcri l'arte mia 11011 econrl ( P IX, 687, vv. 1-2)_
::is chi _ il ritratto che adorno di rose e di vi le? Vuoi aperlo, Cediciano? Que te erano le sembimiz di Marco
nel ])J('fl? dei. suoi anni: in questi uani lui vecchio si rivede giovao . Pc:aesse l' arte riprndu1Tf' i
wsruun e il, carattere! Non VI archhe al mondo w1 quadro pi bello (J:,pigrammi, X. 32, iJr MAllZJAl.E 1996, Il,
trad . .\f. Scandola).
22
Ape.Ile era possibile risalire all et dei oggetti rappresentati, e addirittura per chi
sapesse iJ1terpretare i segni nei tratti del volto, predire quanti anni ancora sarebbe-
ro vi suti ( 1-1 XXXV, 88 93). Talvolta nel Cinquecento i ritTatti dipinti saranno
accompagnati nella cornice o dentro il quadro stes o dall'indicazione dell' et del
oggetto al momento dell' esecuzione del ritratto: questo l'unico dato materiale che
1 immagine non pu cornunicare con preci ione, mentre in grado di illustrare pro-
venienza e estrnzione sociale attraverso vesti, arredi e attiibuti. Il poeta Niccol da
Correggio, muovendo dalla constatazione della deperibilit dell apparenza visibile
a fronte dell' immortalit dell'anima (le parti invisibih L antepone la scritnu-a alla
pittura per la sua capacit cli superrue la breve durata della vita umana, annotando,
a beneficio dei posteri, origini familiari ( origin ), condizione ( tato) ed et della
persona ritratta in questo caso una donna premattll'amente comparsa:
Se a gli omin mo tri qual tu fusti viva,
morti lor como te, nulla vedranno;
ma le parti invisibil tue taranno
puoi che dii secul que ta et sia p1iva.
Laudo il pictor, ma pi laudo un che criva
quello a' futuri che i presenti sciauno,
origin, stato e che al triseptimo anno
. b h . fi . 39
morte spen e ogru en e e m te onva' .
Per farziale il ritratto dipinto ha il potere cli custodire le embianze al di l del
loro mutare nel tempo ma gli negato il privilegio di spinger i oltre la uperfcie del
corpo: se com i er i au picano, l arte pote e rappre entare i costumi e r animo
non esisterebbe in terra dipinto pi bello del ritratto di Marco Antonio Primo. Non
tu1te le opere d' arte, per, sono imperiture, e solo la parola ha o a una vera
eternit, come all ' anima:
Dum mea Caeclio formatur imago e .anelo
spirat et 1rguta pi 'tu tabella mrum,
i, Jiber, ad Geticam Peuc n Histrumquc iacentem:
haec loca perdomitis gentibu ille tenet .
P;uva dabis caro, sed dulcia, do11a odali:
ceri ior in no tl'O carmine vo!tus erit;
casibns hic nulli
1
nulli. del bili , annis
Il
. -!O
vivet, Ap eum cum mon tm opus .
39 GonHEGCIO 1969, 51 vv. 1-8.
40 Mentre prende forma il .mio ritratto per Cecilio . ec?ndo e il piccolo emh1:a all'abile
mano [dell ' artL ta] , va' libro, verso la getil'a Peuc' e 11 rnto 1 tro: ono 1 che, c?l , !
I
. 8' ' . l 1 1 l I f ' -o) 111'0 COJD'P""l10" LI volto ara pw onuabanten I rrue.1
eg 1 governa., ara pie o o ma gn1< 1to t < ono e 1 ,ua1" 1 "m "o , o
23
L" piornnuna t un parallelo trn due immagini di che il p eta invia m
dono atr amico .ccilio condo. he i n va lontru10 da Roma, nella terra di cui r
a Ycrnatore: tm vivace ritratto dipinto e lUl libro di wri . ln quc to duplice omaugio
umi le ma caro alrami o, ruru1110 le poc ie a cu todire in modo pi preciso (' icuro il
Yolto i chi crive. eh n li paro! \'vr al di l d gli mrni e deali a cidenti, molto pi
a lunao del deperibile ritrntto. Que to potere memoriale, onaiunto a qu Ilo di rfrclare
aire1erno l'interiorit.' p o attribuito alla crittura pi tolar . Peb:arca chiuck tuia
Familiare rirnlta all ' ami o Ci \'filmi Colonna preaandolo di mo t:raiali"i ( t ip um
nobi o t nd ) empre con a idu cai1ibio di lettere ( literruum [ ... ] frequenti
collllllercio-1
1
). Per Annibale Gua co. un po la piem nte d l pieno Cinquecento. I
l tt r che la moalie lontai1a ali imia co titui no il pi autentico e pr zio o ritratto di
lei
42
. Il topos. qui declinato in un conteto intimo e privato, trova un orri pettivo pi
mondai10 e olenne n lridea. forttmati ima. che le opere di uno crittorc ne couser-
\WO J'immacrine mealio di un dipinto: tra i molti po ibili. ricordo un farno o e empio
t::raniero. f epiQ'ramma To the Reader compo t da Ben fon on p r accompagmue il
ritrnlto di hake I care (di Dro hout) tilla prima edizione in-folio delle uc opere
(1623) (O, could be [th GraYer] but haYe dra"'ne hi wit/ " elJ in bra !?e. a he
hath bit/ Hi face: the Print would then urpa e/ AH. that wa euer writ in bra c./
Bue ince he cannot. Reader. look I . ' ot on bi Pi ture. but hi Book -1:i) .
L'iperbole e la negazione. fin qui leaa1e alrimpo ibilit di rappr entare rint -
riorit. in realt tracciano anche altri, pi ri tr tti. onfini: quelli che l' arte non pu
travalicare, per ralt zza del ogcretto, perfino re tando nel proprio dominio naturale.
cio' il ,1 ibile. Il paracrone on la luce del ole. talvolta col legato alla difficolt di
dipingere ranima (AP XVI. 32). pu e primere an h rimpo ibilit di imitai per
intero. nei pi ublimi dettagli. la bellezza originale, com in w1 epigramma di Paolo
ilenziario (i'i ?7): Gli o hi oltanto il penn ilo ha re o di lei. non la clorna/ n,
qu 1 chiarore della p lle e nemo./ olo chi rend re I u col pennello il harbacrlio del
olei dipinger il barbaglio di Ti odora. Pi aitifcio a la variazion te timoniata
dalf epiQ'frunma ucce ivo. anonimo (ivi. 8). dov i propone uno d i mairra1 i
. tratagemmi che nel Rina cimento la poe ia uggerir alla pittura. dubbio a e re-
ticente davanti a pa11icolari troppo difficili eia r nderc: fovidio o pennello. he a
quanti contemplano negl/ i rirci doro eh la cuffia cela!/ e d' una t ta : upr ma la
erra.zia uprcma na condi./ non farai fede alla belt r tant ./ Ouni perni Ilo le forme
wr !'n gli cwa n 1rli amti potnumo rancl'llarlo ed e o vi\,r quando pcrir ropcra di Apelle> (f..iigrammi. \'Il.
8-t. 111 \hRZl\I. E 1996. I. trad. cndola). A que Lo t lo. illlerc ante rwr come oi lr 'a al tema drlhi lo11ta11anza.
della l1ttera e d1I rapport o tra ricordo cu5todito dalle parole o dfillc imma<ri11i. toruerrrno a propo5ilo di :\avarro
I' T baldco (cfr. infra., -t .4 e BoLZO'IJ 2008. pp. 131-133 . 1-t2-H:- ). t- n
-t I Pi:THARU 1970 [Fam ]. 11. 6. 10.
42 Come VE'dremo, il motivo vie111 amplificato in un vrro e proprio tour de force sonl'tli tico: fH'r i quararna rroli
d1c lo compon11ono rfr. infra. : 't.4.
-t3 This Figure, thai thou here seest p11t , vv. :i-1 O. rii. i11 l'rl\ tF.11 198-t. p. 27.
24
Jusiricra , ma tu stranamP11tc/ rubi a 1 odora un po' del uo fuJuore,, . 'el grand tema
d lrirnit aziouc irnpo sihile,, e implicito u11 clo io del ou11 tto da rappre entarct4.
ma anche r 11Ull<'iHzione obliqua. da part della poe ia, di 'JU Jle te e
degne di . ere idolatrate com le tatue degli dci:
Dov' r Pra itcle? Dove ono le mani di Policleto
che alla loro arte da ano vita? Chi apr riprodurre
i capri li profumati di Mclite. o "li occhi ardrnti.
o la lucr dcl candido collo? Dove pu e effi
chi la modelli . chi la rnlpi ca( A que ta b llrzza clo\T mmo
con aerare un antuario. come alle tatue d ali immortaLi
4
:;.
Le chiome, o-li occh i acre i e il collo bianco ono bellezz irrappre entabili che la
poe ia nomina nel momento te o in cui. con w1a ta ita rivendi azione di up riori-
t, le nega agli artisti dcl pre ente. r grandi ultori del pa sato apevano infondere la
vita alle propri cr azioni. e olo un loro ritorno potrebbe prodtme un buon ritratto
della meraviglio a Melitc.
'ella Planudea. che i po ti del taido Quattro ento del Cinquecento poterono
cono cere. ono atte. tati modelli enunciativi topoi de rinati a grande fortuna nella
celebrazione poetica del ritratto. Limmagin parlante che pr nde ' :oce nella fin-
zion dci vcr i ( n lottatore on io . .. ; Pro o di Pa lo on io ... ; E un ameti ta
la pirtra; Dioniso on io- bevitor :/ e non fa ob1io me, i borni lei"t>), fida i limiti
dell'arte ccondo modalit che, di fatto. riaffermano la uperiorit della poe ia. e
tal olta coinvolgono il cmmnittente, alludendo. eppur vacramente. al conte to in cui
fopera fu richie ta ed e eguita (Fui meretrice a Bi anzi - la Roma del Bo foro: a
tutti/ io feci div nale amor dono./ ono Callro . un capolaYoro. Pazzo d'amore./
quei nel dipinto po e me Torna ./ ome a mo traie che brama nell.anima cova: i
trucrge/ come la cera che i trucrge. il uorc
47
). La dei i, attraver o dimo
e inviti alla vi ione. rimanda alla oncr tezza di una pr enza. facendo paz10 al-
l' innna11ine senza abbandonaie il recrime Yerbal (Guardalo: que t' Teo!!11eto ... :
Di o di Cipri dorata tu vedi 1 effigie: Anche di l i capi ce che rende,
l'immagine. a pieno/ la belt, la crrai1dezza di ab 'tide./ Guaidala: qu ila aggezza
di lei , 1u ila grazi milludo/ di ora r . B ata donna. al e!"'
8
). Ila te a a cen-
H , i tratta. i11so111ma. di un lopo.v c!Plrcncomio. P r il rapporto Ira rdogio epidittico e la po
rii rullo cfr. infra. 3.6. La ,ezione :32-3'.34 della Plarwdea in. oriuine ez1one ep1.u1.1t1 a
drlr 11110/of{ia Palalina (libro IX). dO\ r r elogio ingegno-o I rsrrc1t11z1ont' che ncorr a tereotJpt per
pnrlar dei . oggc11 i pi1 disparali 00110 111011eia 01Tcnt >. .
-t3 AP V, JS (Huftno] , per il quale 11do110 la traduzione di Guido Paduano {in erotici 1989, ad loc.).
46 lvi , XVI. 1 -t8, L\ , 748.
4 lvi. X\'I. 80.
48 lvi I. (' 79, \'I.
2
lenza :si po. ono a criwre la ' truttura e ri pirazioue ' e ria le cd cpigrammat ira di
molti componim .nti quattro-cinquentc chi -ul ritratto, i pirazio11e ewntualmcnte
gnata da] rapporto con uni -crizion ,. rn e propria. oltr eh con r cpigrann11a
on l'epitaffio inte i come generi poetici. L'originario lrgamr d !l'epigramma ('On
un upporto matrrialc all origin di alcunt' modalit cmmcia1ivc che soprav ivo-
no anch quando il riferimento al dato oncret re ta . olo conY nzionalr: ru o di
dare la YOC , attraver O il te ' tO. a orrgetti e 'tatu , C rc\'entuale apo trofc a] lct1o-
r - pettator orientano fortement il te ' to sulrimmagine. o meglio sulrann u ncio
d lrirmnao'n . Il rapporto trn autor de tinatario una pc uliarit dcl rretH'rT.
L epirrramma un gener so tanziahnente dialogico
4
1) e. aggiungerei. almeno nel
1;otro cao. proteo ulla realt e-terna. ul 111011 I d gli gaetti e delle immagini.
E n que ta fom1a. e nl uo imuJacro oprawi uto in altri metTi. che fa leva il
ponte te o tra runiv r o lirico e il ritratto. la po ibilit retorica che l'effigie faccia
il 'UO nO"r ' O nel te to.
eh nelr nto/oaia ompaiono in r lazione a fiaure mitologiche. n I Ri11a-
imento Yerranno riferiti a ritratti di p r one in arnc <l o ' a. Ad e empio la orte
della Yenturata . 'iobe tramutata in pietra. che lo cultor Pra it l ha riportato in
'ita. row ciando la condanna pronunciata daali dei (AP XYL 129:>
0
). attende tal-
volta il ritratto d I poeta aiunto alla pre enza della donna. che ali ridona lo pirilo
che ali ayeya ottratto
51
na tatua he embra \iYa ma , cli fatto. e anime. non e
oagetta all pene e ai peri oli che tormentano i mortali: e, come l"dfiaie del re che
merit il ca tigo di Zeu p r aver cercato di imitar il tuono ( M Polianoto di l o
Te: almneo on io [ ... ]/ferma. e daffira de i ti. B r aalio inanjme ono:/ con
mnagini morte non lottar [AP ,1, 30. \T. L 5-6]). o ome il bu to marmoreo cr-
lebrato dal Tebaldeo
52
. i proacnitori deff umanit fo ero. tati -ratue. for il ca ti110
la coprendo i in apaci di ucciderli. avr bbero ri l armiato gli e, eri umani
in carne ed o a. L te pu uperare la Xatura perfino ul piano deffereditari t.
quando a tra mettere w1a embianza che. parado 'almente. appar pi1 omiglian1e
del modello in carne o a rreuerato da un padre: i11 altri termini. quando a dare
\ita a tm ritratto che ornialia alroriginale pi di quanto l'originai omigli a e
o (Pi di Timma o. ia e. che non di tu padre ei figlio./ Art in-e
,\el delirio/ e
11
li ti vid . e fwente divenne la mano. quel pianto/ dipinto tutti i tuoi
colori fu e;;.
3
). Lid a eh rarti ta debba oltrepa. ar i limiti d ilo guardo della
-+9 RLozz1 2001. lnuoduzione. p. \L Cfr. 1u1cl1r il rapporto tra epi"rammi ed r111ble111i. !>ia a li\'l'llo di fonti cht
di morMli di lrasmi ione dcl i!(1lilieato.
50 Trado110 da u 011io (Fpigmmmi. LXJIJ) r ripr o ad rsrmpio da Celio Calra.,nini. fr. I h no\ 19:35. pp. 146
(' 632.
51 Cfr. \QLil.\l'iO 200:-' 16.
. )2 Cfr. infra. 2.3.
53 AP X\ I. 83. 1momaco un piuori dtato in \'fl \ 'Jl . Cfr. AP IX. ?38. dw fa pai1e drlla rric Mi ll a vacTa di
26
mano rnortali per a rapprcsrntarf' soggrtti divini gi in un epigramma chr
celebra il famoso Zrus di I< i dia (Verme il dio sulla IC'rra dal ciclo a mo trarti rcffi-
gie./ o tu andasti a mirarlo. Fidia. in cielo:;"'); ro. servazionr del moclrllo avvenuta
in condizioni eccezionali. fuori dal comune, o. ernndo ri11tcrpretazion<' di Plotino.
urlio . pirito delr artista: Fidia 11011 lia cr ato il suo Zcu sr ondo una rralt vi ibile.
ma cosi come ZNt. tcs. o apparircbue e i vole sr man ife tar aO"}i occhi no tri:;:;.
Ancll(' il ecolarc intreccio di effigi concrete e immagini i11teriori eh a compagna
la parabola poetica del ritratto sembra trovare un precedrnte. ad e empio. in due
epigrammi di (AP X Il ;)6-5 7). costruiti u una doppia omonimia. a parti
im erti te. tra scultori e . ogcretti ritratti:
Pra::.:.itelr ha srolpill in marmo pario una tatua cL\rnore.
riproducendo l"a:;prtto dC'I fi11lio di Af roditC'. ma ade so
\morr, il pi1 lwllo fra tutli gli dci. ha pia mato Pra itclr
a sua imma<riue. u11a . tatua ,ivente: iu tal modo
l'uno pargc i uoi incanti tra <t)j UOIIlLni. raltro nrlrrtcre.
r i dr idrri gmrrnano in ien1e la terra e i heati.
Felire la arra citt dri che ha educato
il nuorn \morr. il figlio di un dio. il re dri crioHtni.
L' antico :cul1ore Pra. modell una tatua di delicata fattura.
ma enza vita. 111111maginr muta della bellezza.
dando forma alla pirt ra: il 11110,o cultore.
ar1rftce magico cl' esseri ,-ivi. mi ba pla mato nell'anima
,\more il rr dei furfanti. U nome lo te o.
lr operr assai pi1 grandi. perch non ha tra formato la pietra,
ma lo spirito. Po heni11nam nte pia marmi il carattere.
co da avere cl ntro di me un tempio d",\more:;b.
L arti ta Pra ' itcl ha colpit un ,upid nel marmo. ma Ero te o (il dio) ha
pia. mato un ritratto ivo (lctt. tilla . tatua \'ivente ). un nuoyo Ero- in carne d
os 'a. il b Ili imo Pra itclc. Co le due 1atue, di marmo e di carn . e ercitano il
loro fa. ci no in i lo in terra. Nel econdo epigramma. he CO' titui ce una d bole
variazione ul primo. il 11onH' Pra sitele de O'na inv c due cultori. LUlO alla lctt ra
e uno per rnetaf ra. ai quali ono don1ti ri p ttiYamente un Cupido
un'irnmaain di Amor<' che occupa ranima del poeta. La conda opera e la p1u
uote il ruat eriaJe nel qual ' tata e-eauita ' I -pirito. non la pi tra: e
\lirn11e: cln que!.ta 1 arra. :'laturn con l'Ane sovrnna t'Oli! "e./ D' equo le dot \lironc:/ se. per chi guarda.
a Natura fu tolto potl'rr dall"Artc./ la '\atun1 r natttrn pl'r chi t()('<'11.
!i.+ lvi , X\ ' f. 81 .
." 5 /:,111eadi, \ ', 8. I, cit. in I\ \OFSJ..\ 1996. pp. I'.!- 13.
.-6 /Il' .\Il. ;-(h)7. secondo la 1ruduzio111 di Paduano (F.pigmmmi emtici 1989, ud /oc.).
')
_,
il po ta. innamorato dcl gi vane b llo OUH' un Cupido. ha nel petto una , tatua di
Ero-, que to pazio i11l riorc diY nta un l 1111 io consacrato al di0';
7
.
Tra i materiali anti l rielaborati dalla p ia cinqueccnt ca sul ritratto i
contano anch due te ti pi ampi. appartene11ti al co1pus erroneamente ri f rito ad
Anacreonte. le odi. xVTU-/ L '
8
. Ri cop rte ver o la m t del XVI rcolo eia l l n-
ri E tienn ( tephanu ). in w1 quaderno agcriunto al mano ritto dell'antologia li
Cefala po eduto da John ,lemente a Lornnio - quaderno ocrcri a Parigi - le odi
p eudoanacreonti he furono da lui r note anch in It alia e poi edi te nel 155;.:>CI. I
omponim nti. che I umani ta cmmn nt te 'ament . rimandando a modelli e 1if -
rimenti. bbero wmm diata forhma. pr ocemente imitati. in Fran ia. da Belleau
(15- 6) da Ron a.rd. Le odi " xvIII-XXIX, in ui il poeta-a.mante hiede al pittorr
di ritrarre frpetrivam nte la fanciulla amata e J'amaio BatiUo. in Itali a incoracr-
giarono lo Yi.luppo d Irattitucline dida alica e pre crirtiva frtiziam nte a unta
dai poeti nelrapo trofe acrli arti ti, e tend ndola dal pa ' O breYe del onetto alle pi
ampie ampitur della canzone
60
.
e po iamo enz.altro con iderare la .Vaturalis Historia e la Planudea fonti
e reperto1i di mod Ili p r i poeti eh criYono di ritratti. l'apporto cl Jrekphrasis.
iute a come e p cliente del di cor o e ome crenere anti o. ' molto difficile da sta-
bilir . Que to fatto pu apparire parado per h u o omun con id rare
pacificament ecfra tici i mat ria.li poeti i di ui i occup remo. IJ punto che
una irnil definizione valida olo in enso molto lato. perch que ti 1 ti ricruar-
d:rno opere d'arte ma non ono de crittivi. La nozion oricrinaria di ekplzrasis (>,
d :iID_'a r.arte. ben pi comple a di quella vulgata di 'de crizion di un.opera d. ar-
te : n_ dal no tro u o del termine a quello antico imifica mettere in campo
que t10ru di lunga durata al contempo e plorar i marcrini della tellazione del
ritratto-_ inte a in en o tretto era uno <leali ercizi pr liminari cli
compo iz1one (prog> mnasrnata) pre ritti dalla teoria retorica antica: w1 discorso
crittirn che mette il oo-getto davanti acrli o chi in modo vivido1>
1
Le parole cJel-
1 ora tor dov Yano pr entare alla vi ta d li" a coltatore o del lettore i che
non poteva fruttando la ua capa it di immacrinazion . cio la facolt di
produrre immagini mentali.la poe ia e la r torira hanno il potere di crear effetti
.ar?hiutt ure delri?tcrio:,it nel :\l ed_i OC\'O cfr 1999. Cfr .. in Pf'trarca. eia portai dr l'alma (Rif
\. 6). c1.
1
e d(igna J o u]1 o? hJ. f' 11 para"OllC tra !"immagine di Laura f' la domiua
11c a ua dimora (Come donna m uo albrrgo altera ven [fbid., v. 9]).
58 Cfr. Cam1ina 1nacreontea 198-t. 16-17.
09 \.'iACRfO\'Tt ] 05-t.
395-t2-t: P _e iii . particolar<' pp. -t02-40-t: cfr. anchr DELBOULLE 189 1 e O'R1m,N
j
' .
1
1
1975. Ta o 1 11 pruno poeta di rango in Italia che imiti IP orli p e11doanacrcontidw.
c1 a tre mJJtaz1om cfr. mfra. 4.1.
6 I la d d<'i Progymnasmata cli 'n1con, un di coun; qui prrsrnte e11 rt rn<t 0 11 b y< nx
d faon cnde11te ce qu il donnr co11naitrc (Trn:oN 1997. p. 66, tracl M. Pa1illon).
/
28
di pcrcczion imili a quelli pro lotti dall arti vi ive proprio perrh acri cono ulla
fa ol t di visualizzazione rnent alr ((antasia Y'i. Quintiliano (Jnslilutio oratoria. 6.
1 .. 32) di sapprova l'u o di alruni oratori che, p r impre ionar il rriuilice. portano
in aula quadri raffiguranti i fatti in cliscu ione, p r h un buon oratore dovrebb
saper uscitare lo tesso effetto con le paro] enza a pettar i che un'irnmagin
muta parli al uo posto. L'ekplzrasis era un e er izio ron cpito preci amente p r
viluppare quc ta capacit. e oggetto ne pote ano e ere non olo oper d'arte.
rna per on , eventi. tempi luoghi cateo-orie imili a quell pre critte per renko-
111ion61. La cont iguit. ncll ercitazione e nella pratica retorica. di ekphrasis cli
enkomion. un dato ianificati o e per i t nte, eh trova un doppio in poe ia,
nell'intreccio tra topoi ncornia tici descriptio. e i rifl tte. ad empio. nella
concezione di un.opera come i Rilralli (1524) di Tri ino. dialocro i pirato alle
Eikones di Luciano<>-1. Come vedremo nel or o dei coli. tanto sul front retorico
quanto su quello lirico, per rao"ioni eparate e diver c. i a i t a uno po tam nto
delr a e di q ue to cqu i libri o in ilirezione delf encomio
6
;.
La tradizione ecfra ti a. inte a in en o lato. comprende ali innwnerevoli epi-
gramllli dc crittivi dcllAntologia Palati11a
06
. poemetti cli impianto allecrorico opere
in pro a. come lcEikones di Filo tTato (II-lll e . d. '.). In que (opera. la ornice
p r introdurr due erie di de crizioni (31 pi 3;. ) di e!!nata da un finto cont to
narrativo: nel proemio il retore rievoca una lezione tenuta a u ri chie ta del
ficrlio del uo o pite che gli avrebbe cbie to di int rpretare. per lui e per i uoi am:i i .
i quadri collocati lungo le pareti cli un portico che da,a ul mare. La me in cena
serve a tenere in ieme una eqncnza di di cor i che i fingono pronun iati davanti
a un pubblico ed o tenuta dall 'atteggiamento elida calico e mai utico d I per o-
nagcrio-Filo trato. che coinvolge gli a coltatori nel tcntati\'O di de ifrazione delle .i.nl-
magini. ;\Tell ingol ekphraseis ricorrono deittici. cerba cidendi e richiami a tutti i
en:i . soll ecitati dall 'incredibile 'ivacit dei dipinti: prima di identificare il ocrcretto,
pesso il retore fa rifcrim nt alla ver ione omerica d Ir epi odio ef.ficriato e ortand
i gio ani allievi a tornar , con la m moria a m1 r p rtorio noto, che li pu oc orr r
n lla lct.1ma dell'immagine ( ... Omero che c Io dipincre ... : Qu ti ono i quadri
di Omero: eque tor il sogcretto trattato dal pittore
67
).
62 Ekphra is a particular l'xploitation of che mental imaaes which \Wr(' 1hough1 to be e emial to ali
nwntal activitp (\h:ss 1992. p. 52).
63 d esempio i11 rl'ton.
6-t Cfr. 14ro. 2.3 e :3.6.-t.
65 Huth WC"hb ha o scnato che nei tncrnto mmi o pi rhe epamno l h1honios d11 Theon l'!'kphrasi appear to
have shiftrd fru111 I eing o l)'pe of ,.i,id narrati\'I' to lwing clo ely link d with enkomion 1992, p. 5-t).
66 111 pnrti colarr la seconrla mr1 dcl lilmi X raccogli!' descrizioni d palazzi e h10..,hi ameni e la elcbr ltmga
serie di epigrammi per In vacra di
67 faosTRATO 1997. 7.
29
Anche nel Rina cimento. come ha ottol.neato Ruth Webb, I Eikones nou era-
no cos note com ' i pen a
08
. ono tat tudiate oprat1utto come font.e iconografica
e come fonte letteraria. e in e e vetlana lpers ha rimrncciato uno dci modelli per
la d di opere d'arte nelle Vite di \a arib
9
. La lezione di queste e perienze
appare pi evi.deute fe onda per la pro a di trntta1i e lettere ( i pe11si ad Aretino)
che per la poesia. ma ad e sa i legano. almeno in parte, i modi in cui la poesia ste,sa
dipinue e ri.tlett Lle proprie capacit rappresentative. Fin dalrantichit, infatti,
le arti :figmative ono tate tra le pi ricche fonti di metafore di testo:
0
. L'esplicila-
zion deJrntento mimetico ' segnata da un u o i11 i tito ed e te o del le co dell
1
ru1e
come metaliuguaP"go , in poe-ia come in prosa. le sezioni propriamente de crittive
ono pesso precedute e eguite da topoi di modestia e d elogio, oglie di tm ritrarre
in parole che in e e rima.rea la propria nza di .
In Filo trato Yespo izione, pm omportando. per la ua propria vivacit, una
" imwtanea testimonianza vi iva", non pu tuttavia fare a meno d rinviare [ ... J
ad <ogg tti a enti' ,. pa a.ti , futmi. Sono oggetti che, dunque, sono s)
' pre entati. ma olo in quanto 'rivisti immaginativamente, [ ... )con gl occhi del-
l'intelletto
71
. Torniamo CO alle immagini m ntali che roratOTe deve imparare
a fruttare e a quel protender i verso il mondo degli oj)'getti che abbiamo ricono-
ciuto come caratteri tico dell'epigramma. Il di corso adop ra prncise strategie
retori he (dei si, invito alla visione, appelli e imperativi. al lettore) per definire
la contiguit :li.sica dell'immacine e per rendern, letteralmente, pr sente ci he
a sente. Per poter de crvere un'immagine vista, chi compone il di cor o ha bi-
ogno di ritrovare in l'impronta che e a ha lasciato nella memoria, il doppio
della realt prodotto dalla fanta ia; al tempo te o, deve . ap r metter in azione
la facolt immaoinativa dei lettori, inducendola a formare il imwacro m ntale di
qualco a che i loro occhi non hanno vi to. Que to processo muov dapprima dal-
l'e terno all'interno, da.Il'ogg tto reale, p rcepito dalla vista, aJ uo imulacro n Ila
mente dello crittore quindi dall'interno all' e terno., alla rappre entazione verbale
di que to imuJacro e. alla ua comunicazione, e di qui., infine, a un altro simulacro
prodotto da.Ile parole nella fantasia altrui. Alcuni di que ti pa saggi i ritrovano,
ad esempio, nel topos lliico e romanze co delFinnamoramento per fama, econdo
68 Laldina delleEikones del 1503 e la prima menzione in un'opera dedicata unicamente all'art ' nel De sculjJ-
lura (1504) di I riferimenti a Filo trato nella letteratura del XV secolo sono pochi. e pi[1 in
ontesto p dagog1co che artistico, con alcune ccezioni. prevedibili (ad e . nel De politia lilerw"ia di Deccrnhr.io ):
serondo t:"!to Deceiubrio che Gamico e Ca tiolione, per tudi e frequentazioni, potevano avere acces-
so alle Eikones nell originale greco, in particolare nel caso dl 'astio-I ione e di Cauric i pu irnmagir1are come il
t"to passare dal pubblico rstretto delle cuole di gramma1ica al pi ampio contesto clella teoria artistica;
per contro, 11 fatto he entnunbi facciano riferimento al proemio dell 'opera i11dichercb1e la sostanzi(C estraneit
del testo integrale a queste di cussioni (WEBB 1992).
69 Cfr. ALI'ERS 1960.
70 Cfr.
71 Co. Fanizza nella sua introduzion a Fn.os1'RATO 1997, pp. 13-14.
30
r
il quale possibile concepe una passione per qual uno che non si ma.i vi to,
.invaghirsi di un ' immagine mentale nata sentendo lodare le beJiezze e le virt di un
soggetto
72
. Nella finzione dialogica messa in . cena nei Ritratti di Tri. sino, facro
descrive dettagliatamente una bellezza impareggiabile, che ha visto e ammirato.,
ma della quale gli ignoto il nome; nell 'immagine tracciata dalle sue parole Bembo
rconosce senza esitazioni la ignora Marche ana di Mantova, I abella d'Este.
A un' analoga con ezione risponde l' idea che attraverso le parnle i possa comu-
nicare anzi ' rendere vi i bile' all'arti ta un modello as ente, lontano o scomparso,
ottratto alla vista ma vivo nella mente dei uo cari. 11 poeta Giuliano Goselini
ompose una lunga serie di onetti per ringraziare il. pittore Francesco C1ivelli, che
gli aveva lipinto un ritratto del figlioletto morto: se l'artista, senza aver mai vi to il
bambino, aveva potuto realizzare un immagine viva e somigliante, era tato grazie
alle parole della madre, eh gli aveva de critto efficacemente quanto ricordava del
figlio (vivo ' l serbaste entro la vostra idea:/ quinci vivo il ritra se e no 'I vedea,/
lo stil, che '] prufar vostro ebbe p r ducen) .
Proprio 1 que to intrico di retorica pensiero ed espe1ienza i rafforza un ne o
l ci ivo per la s1oria che stiamo trac iando: quello tra iitratto, de cr.izione e im-
magini mentali. Per La.oda.mia, dopotutto, ognare Prote ilao o abbracciare la sua
statua sono consolazioni eh apprutengono allo so ordine di reaJt.
1.2 L'immagine nel cuore
Credevo che fosse nece..ssa:rio cono ceTla e amarla come la cono' co l' amo io, per
saper scopi-ire in lei la ua e pres ione pi imima e pi dolce" pen ava Vronski, sen-
za rendersi conto eh' egli tesso non avrebbe notato q o e ione dolce e intima,
se nou gli fos e stata rivelata dal ritratto.
Lev 1blstoj , Anna Karerzina
ella no tra ti-adizione poetica il ritratto innanzitutto il ritratto dell amata. Non
una tatua o un dipinto, ma un imulacro interiore del quale i poeti parlano, per,
come se fos. e una statua o un. dipinto, cio attraver o il l sico dell' rute. B 11 p1ima
di consolare i ensi dell' amru1t on i colori della pittma o con la levigatezza del mar-
mo, il r.itratto conforta gli occl d Il anima. una pre enza mentale che si forma con
la vista e. i al:im nta fino a diventai- talvolta, l'ogP"etto ste' o
dell' runore: amore non transitivo, perch amore di im'ombra, di un fantasma che
continua a produr i anch in a enza dell'orio-inale; amore di lontananza. h i ap-
Ah1:e vnlt c l'amore da lontiu10 u citaf'o da un ritnuio.
73 Go, icu, .1 1:-88, S(iconda pmte, CL, X.Xli , vv. 6-8.
31
paO'a 11el cerchio chiu od ljoi7
4
h1 que ta chiave AO'amben ha pi gato !"importanza
d i mili di .\'arei o e PiO'malion n I Ro111a11 de la Rose nella poc ia prownzalc. La
toria dello cultor eh i innamora della tatua d'a\'orio labili -cc un paradi gma
fondamentale per 1 antropologia e per la teoria dcl ritratto. ma costitui et' an he un
embi ma traordinariamcnt ffieac p r fiO'urare il rapporto tra il poeta-amant e
e l'amata fi it:amente a ente e al contcmp in opprimibil c dalranima. oggetto di
immoderata cogitatio e in awibile font di tonnenti di poe ia (poc ia di torm nti
e po ia cli lod ).
Il le11ame d ila poe ia che elebra i ritratti ' ti e le loro op re con 1u ta ori11ine.
amoro' a e m taforica. non verr mai ompl etam nte reci o, i pirer, al contrario.
t ti fondati ulia contrnppo izione tra inunagini dcl]" arte e imma11ini del uore p r
poi riemergere. in rapporto al eone tto. in pro pcttiva platoni a. Quando i vrr i
ri11uardano imulacri interiori. i parla pur empre di effi gi o titutive. di er e dall
opere d li art ma a] pari cli quelle attrav r ate. pe o p r a" enza. dal fanta ma
della :figura umana e dal tentati"o cli riprodurla. In e e la nume i non prc u1 pone
tm.inrenzion arti ti a, emplicemente accade nella mente nel cuor . :;ecou lo m c-
cani mi che la poe ia a i.mila con f rza e ontimt a quelli della cultura e della
pittura. Que to aV\1. inamento i realizza attrav r o l'attriliuzion del ' imulacro a
imi iliili arti ti come ramore. il de iderio. il peni ro. la memoria. il ogno. L'as o-
ciazione tra ge ti e trumenti del pro e o cr ativo e fa olt interne. anonime natu-
rali, interiorizza tra pon u un piano metaforico la relazione tra il po ta e !'arti ta:
nel confronto con la f11wa nel cuore la poe ia ripen a il proprio og11et.to e la propria
origine amoro a pi cli quanto i guardi attraver. o lo pecchio dcli" art . La pro pet-
tiva cambia e. nello te o te to o nella te a ra olta, ono in 11ioco alt.Ti ritratti ,
dipinti o colpiti. Com vech-emo ubito. ' per una via tutta intrrna e metaforica che
il linruaggio dell 'e perienza f!!urativa. dapprima in rto e in \'ia cli definizione, i
fa trarla nella liri a, per aprir i. con P trarca, a una vitale e de i i a interazione
tra un ritrarre tra lato un 1it:ra:rr pienam nte letterale: da que to momento i
daranno po ibilita di combinazion variazion pre och infinite. ori ntate ora ul
fronte interiore, ora ui dati e terni, ora ul loro equilibrio irnmetrico o incrinato.
. Per re perienza cono citiva ed erotica eh pre uppone, tra memoria malattia
d amore. il l game tra f immao-ine nel cuor e le metafore fiaurativr ' potente e
tabile. na ce in i me alla concezione eh illu tra e in una certa mi ura oincide
con e a
75
. La fi
11
ura nel cuore le11ata al pa a1111io delrirnma11in attra r o O'li
occhi e alla formazion del imula ro interior nella fanta ia. i ella rn moria t a
d I luogo comune. memoria tratificata di ap ri medici e filo ofi i. e istc dun-
que una co tituti a componente vi iva iconi a. che i poeti po 0110 valorizzar o
?-! Cfr. AcmBE!\' 1977. p. 152.
75 ,\GA}IBEX 1977. Cfr. anrh l3n1x1 1988. \L\SCl;\11988. C1wo1.EtLI 1992, BOLZONI 1995, .flcrn 2000.
32
111eno. pri vilegiando ora !"aspetto pi a. t.ico e r ativo della vita deWimmaaine. ora
sua. collocazio11 (11 I .cuore, n nrlla rncnt ). he ia pittura. impre _
1011e in rera o s ult11ra m il . unulacro ha una piccata dimension [i ica
an hc fino al grotte co
76
e pu e .. ere un o tituto rotico pi
0
meno
inten o ed cffrcace.
Qu lii di Narciso Pigmalion ono miti e enziali p r la toria della e.figura nel
cuore, ma anche prr la del ritratto per l rifl ioni teori che e po tiche eh lo
riguardano. Per il Medioevo I amore cli " arei o amore di un' ombra pi che amor
di e ste 0
77
, e per que La ia . i intende la continuit tra la ua vicenda quell cli
PiJJmalione e cli Endirnione. ignil ativamente ri tabilita, n 1 Quattro ento in pro-
p tti a neoplatonica. in un onct.to di Lorenzo de Medici:
olea gi dil eggiare Endimi'one,
la 111ltizia acr u ar dcl bel \arei o,
prender admirazion eh tanto f o
mir l'imagin ua Pigmalione.
La cOL il mio vaneggiar con men ragione
condotto ad amar ta1llo un pitto \-i-o,
clw non pu con parole o con un ri o
quetar quel gran di io eh nel cor pone
78
.
Quelli di Endimione per un'inunaP"ine 011nata (la Luna, che gli dato amare
olo n ] onno ), cli arei o p r un rifle o, cli Pigmalione per una tatua e del po -
ta p r un pitto vi o sono innamoram nti accomunati daffillu ione, da un rror
cono citivo, e u que te ba i i api ce bene p rch' il ritratto diY nti p r ccell nza
l' og11etto o l' embl ma di un amore ingannato fru trante. Pietro Bembo hi e in
dono all' ami co Bernardo Dovizi da Bibbi na una tatuctta cli Diana-luna n lla qua-
le avrebbe creduto cli ri corro cere l'immagine dell amata. Lucr zia Bor ia. fredda e
in ostant e come la luna nel onetto che rievoca que to epi dio non poteva mancare
il pa tore amante della Luna:
6 Conw accade, ad (" . in una srri r di ott ave di \1ich lan.-.clo: Tu m'entrasti prr li occhi. ond'io mi spar"o./
conw "rappol in 1111' ampolla./ [ ... ]I co l'immauin tua. che fuor m"immolla./ dentro per li occhi cresce.
ond'io m'allargo/ conw prllc ow gonfi a la midoUa;/ [ .. . ]/Come q1111nd'entra in una palla il v nto./ [ ... ]/ co
l"immagiu d 1 tuo volt o bdl a/ per gli occhi dentro all'alma venir sento: (Bro. lRRon 19Q8. 4. n . 73 74. O '?8,
81 , 8-!-85).
77 Come .' fa rcis i, in ua pera [immagine rifle -a (Conrini )] mirarnlo/ "inamorao per ombra a la fonrana
(Chi11ro Davanzali , in Poeti del Duecento. I, p. -!25 [JX, vv. 1-2]).
78 Mw1c1 1991 LXXXIII , vv. 1-8. Q11es10 1rio di amanti idolatri sar ripre. o dn n Ila Galeria
1979], nrl co111ponrnrnto che clriude la srrir drdicata al ritratto della ua Donr111 : D' un foJ o oguo ndinon
fu vago./ d' un rmbia111e spr<rhi11to arse Narriso./ Pi1r111a[ione una lcagiadra imago/ d"avorio am, da dott.n 1111111.0
inci o./ lo, che non mrn di vanit 111pp110'o./ adoro l'ombra d' un dipinto vi o,/ es orto ognor da volontari nron/
rg110 i miri folli , e fuggitivi urnori (i1i, Rellicose. e llrtuose [IO], L'imagine rmdele [ tanza \ ', "" 3+-tO]).
33
Mentre 'l fero destin mi toO'lie e vieta
veder Madonna e tiemmi in altra pmte,
la bella imagin ua veduta in parte
il diO'iun pasce i miei sospiri a qu ta.
Per s'a l'apparir del bel pianeta.
che tal non torna mai qual i diparte,
ebbi conforto a I alma dentro, pru1e
ri tetti in vi.sta desio a li.eta.
fu, perch 'io 'J miro in vece et in embanza
de la mia donna, che men fredda o ria
o fugace di lui non m:i i mo tra;
e pi ne avr, se piacer vo trn lia,
che 'I om10 de la vita, che gli avanza,
si tenga Endimion la L1ma vo tra
79
.
Gli occhi, digiuni perch lontani dalla donna, i nutrnno della vista della tat11a
(pi precisamente della bella ima gin di Lucrezia in e sa riconosciuta) e della luna;
il poeta-amante o erva {miro) il bel pianeta continuamente mutevole proprio
come e gumda se un ritratto perch in vece ('al posto di ', pro-traho) ed in em-
bianza ('per somiglianza re-traho) dell'amata. Il uo conforto ar mag.oiore la
statuetta del Bibbiena rester per empre con Endimione, :figura del poeta forse
anche oggetto rappre entato in una tatua da lui posseduta {Dionsotti).
Come ha egnalato Silvia De Laude, a rigore il tema del ritratto presente nel
nell'anima ginell'AntologiaPalatina (V, 155 266 274, 232) . anche se le
onglll del topos nella nostra lirica da cercare in te ti in volgare:
Den:o il mio cuore Eliodora che parla co dole mente,
anima della mia anima l'ha fatta Amore mede imo. (AP V, 15-)
La mia immagine, che Amore audace aveva impre o
un tempo nella calda profondit del tuo cuore
ahim, l'hai putata via; d io n n me lo aspettavo,
e serbo in me intatta l'improilta del tuo pleudore.
Barbara, la mo trer al ole ed al dio dei morti.
e contro di te chieder giustizia a Minosse. (ivi; 274)
.B.EMll.o XCL per Corni umani tica ul terna "l unare" del sec ndo sonetto pe-
traichesco a nnone (Rvf, 78) (P?e/7. Cinquecento, comm nto ad. loc.). 'el suo cappello introduttivo al
2,0?8, 1?4J, D{Jnrum nporta. un onet.to e un epigramma ckl Tebaldeo i pirati a q111;sto cpi-
o,
1
.n parncol.a
1
.al da parte del B1bb1ena di consegnare la ta1uetta; la prima quartina del S(ll10tto
l
11
umphi al mondo venne) rnwoca l'aneddoto di Ales andro Magno, A.pelle e Pancaspe (cfr.
34
I
In entrnmbi gli epigrammi., rspetiframente di Meleagro e di Paolo 'ilenziarioi
che riporto nella traduzione di Paduano (Epigrammi erotici 1989, ad loc.) , autore
del ritratto Amore e Ia presenza dell'lmmagine legata alla condizione del poeta
.muunorato; nel econdo testo per i fronteggiano in un confronto ineguEt.le., due
simulacl'i interiori uno a ente e uno pr sente: l'immagine del poeta non pi ne]
cuore dell 'amata dove un tempo era impre sa mentre l' impronta della donn.a
ancora viva nel petto dell'amante, che pu e ibirla come prova di un' inalterabile
devozione. L'operazione presuppo ta da queste effigi un'impressione, come nel
metallo o nella cera e ondo la metafora platonjca del sigillo (Teeteto 191 d-e) ,
presente in Dm1te, in Petrnrca e poi rilanciata da Lorenzo de' Medici
80
.
La storia romanza del topos comincia per con i trovatori. Il ritratto nel cuore
nasce com manifo tazione del grand tema lirico dell' oguetto amato pre ente e
assente e come metafora della corrispondente condizione interiore. La presenza del
imulacro descritta ora empli emente come uno tato o un po e o (porto)) ,
tengo) , ora come la conseuuenza di un proce so, un fenomeno che discende da
una precisa origine visiva e amorosa. In Bemart de Ventadom e in altri trovatori
il poeta porta la bellezza e l'inunagine dell' amata nel cuore (e port al cor, on que
m stei,/ sa beutat e sa fachura )
81
In Sordello da Coito 1 insediar i della fgma
nel cuore esplicitamente collegato alla prima vita della donna- e dunque all'in-
namoramento e presuppone un intaglio>> lacerante ( Dompna, al prim lans/
q'ieu vil oen cors de vos./ vostras faisso I m'entaillet per emhlans/ al cor, tren-
chm1s I . , p r ui datz/ a o qeu platz/ fin ferm a totz mo an )
82
;
il pur evidente riferimento a un procedimento delrarte (l intaglio) qui dominato
da una componente ' pre-iconica', che molto deve al topos della feiita d' amore
83
.
La folgorazione di un esperienza visiva enza precedenti. .I irnmagn:e
a sua volta doloro amente in i a nel cuore determina la dedizione e la fedelta
80 In Pla,one si trov11 l' immagine della cera della qual le no tre cope.rte e. ulla quale 'im-
primerebbero le sensazioni : avremo memoria di i che ' imprirne Jmche ne l 191
d-e). Su questo tema e sulla metafora del igillo, in ar;bit? filosoi1co, ba gli. cola_ oc:i, e presente
in Dante ( ALIGlllEHI 1994-1997, Pwgatorw [Purg], X r_n, I'. 39 xxx_m, "". 9-31 J I cera da
sucrirello,/ che la fi"11ra impressa 11011 trasmota/ rnato e or da voi lo nuo cerv Ho]). {1. \VEm1rn..:R
che, dopo er parlato del Menone, della tavola . rn della .. ogru anuua
paragonabile a 1111 blocco di cera eque to e 1111 re"alo per il de,.ono la dea
m moria>, .ma la tavola di grandezza varii1bile a seconda d gh ind1v1du1 e la cera e d1 purezza dur zza
anch'e. se variabili (ivi p. 34).
31 l3.ER AllT ne VmrADO.llN 191.5, XXIV [Bibliographie der Troubadours, 70.24], w. 39-40 (e porto ne! uore.
ovunque io , tia, la sua .bellezza e la sm1 immagine (trad. n:a]) . Bcrnart. olITC eh 1 g" nda Tnsmno e
ai romanzi di Chr1ie.n de Tr yes, i deve 1Jna parte con i tr.nte della fortuna del rnotl.vo cl l cuo1-c m molte uc
varianti (D.1 Gmot.AMO 1988, pp. 32-34).
82 OJ1DELl..O 1954 Xl [ Bibliocrraphie der nonbadours, -:!:37.3 ). w. 71-. 8 (. ignora. momento in CLL vidi .i,1
' A J I . I . do 1'1 ' '<> t1a 'ut11na""' 1cchc m1 ono d d1cato a c10
vo uo corpo gentile more nu ia mc1so .ne c.ume, aceurn , ' s . a" ,
rhc a oi piace, leale e (:ostnnte, per sempre (trad. D1Gntoi..AMO1988, p. H ]).
83 Per il legarne tra ferit!l d'amore e figura nel cuore dr. J,1c;En 2000, pp. 70-71.
35
dell'amante. In que to n , o i radica la nozione di una tabilit naturale. fi sio-
logica imaainativa del entimcnto amor , . stabilit che mbra trovare nel
ritratto interiore la propria videnza fi ica. l ' interna e tangibile 011 JU ta d Ilo
-pazio del cuor da part d !ramata ha una controparte e t ma n I dono del ri-
tratto materia! . al qual poeti narratori altribui cono un igni ficato imbolico:
la onc ione, ri rrnta e pe o differita. d Ila propria embianza ' innanzitutto
una prom a un 'ammi ion d"amore.
Leaata a qu ta pr enza int riore an he la o tanza del ri ordo, p r i ten-
te proprio perch' a icmato dalrincanc llabilit delfimmagine ( Ja d mon cu r
n 'i tra maiz la amblan ./ Donc me conqui t a ' mo plainz cl douour/ clc qui j'ai
du tout en ramembrance./ i qu me uer ne ert d'autrc labow )
8
"'. La sembianza
amata non ce n potr mai u cir dal p tto dell amante. mentre, come abbiamo
vi to nell'epigramma di Paolo ilenziario. pc o la donna non e ita a ca ciare dal
proprio cuore l'immaaine di olui che un tempo ha amato. Cos. n I Filosfralo di
Boccaccio, Troiolo ac u er ri eida di aYcrlo in,11iu tan1ente allontanato dal pr pno
petto, per a coglieni. Lm altro uomo:
Del tutto \'ea!!io eh m'hai di acciato
del petto tuo. ed io oltre mia malia
nel mio ancora tengo effigiato
il ruo bel ,1 o con noiosa doglia.
[ ... ]
Tu m'hai cacciato a torto della mente,
l dov'io dimorar empre credea.
e nel mio luoao hai po to fal amente
D
. d' [ ]8.)
wme e ...
C" un divario incolmabile tra le po ibiliJ once alla donna (o, per la pre-
ci ion , a chi' amato al tu d Ila comuni azion lirica) , che pu re idere il legame
o bandir il imulacro dal proprio uore: e la condanna enza appello delrarnante
(l io). che anch conno la propria volont (oltre mia oglia ). d v conviver
con un'immagine che lo o e iona. L'impo ibilit di cacciar via dal cuor la
bellezza delramata i intreccia con un ervizio d"amor h dur r quanto la vita.
nza p ntimenti. com in ordello e in Guitton d Arezzo ( Tant aggio en amar la
8-t C1u DE Coi.:c1196-t. 7. vv. 11-14 ( cMai dal mio r11or uscir la embianza con la quale mi conqui t C'On
parole p1cn,. cL.dol ezza colei ricordo bene. cosicch il mio uorc non ervc ron altrn falica ). Cfr. Cuillaw11e
.\fachaut, Da de la in appendice a FR01 SAHT 1979: e Et dc pcn rr a a donrr . anla1m/ Qui figure I
E,t rn mou cuer par 1 noblc ordrnance ( cE di pensare alla sua doler sembianza che rnffitrurata nrl mio ruore
con una cos nobile armo11ia (vv. li7-149)).
0
85 Filoslralo. Vili. 15. vv. 1-4e16. vv. 1-4. i11BocCAcc101964. BRu 11988b ron idra !'ffiuia10 1111.i11novazio-
nc di Boccaco: cfr., 11clfElegia di Madonna Fiammella (I 10). imaginata effigie.
36
oglia pe11ta. [spinta]/ e tanto ua piag nza in cor m" p nta. [dipinta]/ eh mai
d . cr ir lei non redo penta [di pentinni]/ n ia de me la sua figura emp n1a
8
u).
cl Cabine! de Monsiew de cud1y (1646) ' un te. to d dicato a un"immagjue
di Didone, nel quale il poeta invita 1 infelice regina a gettar nelle fiamme il ri-
tratto di Enea, clic l' ha abbandonata, ma le raccomanda dj eliminar anche le
p rtrait che ' nella sua rnent ( Jetez, jet zA dan la fiamme/ Le portrait d"un
incon 1ant/ clui qu' il mit dan votre ame.// Otcz de otre mmoire/ Cet indiane
ana d'Hector;I C n t qu' en J'aimant en or/ Qu ou off n ez la
proprio Didone il oggetto di quel ver o irO'iliano ( illum al en ab entem.
ditquc vidctque [Aen. I . 83]) che Petrarca riprend , nel ecretum. per defirnr
il trist privil gio d gli amanti. cio' quello di vedere e udire r oagetto amato onti-
nuamcnte, anche in ua a enza ( t. quod e t amantum infam privilerrium. illam
ab entem ab en. audie et vid bi '
88
). Di qui la necc it di liberar i ri olutamente
anche della traccia rima ta nell" anima.
il 1 otaro Giacomo da Lentini. funziona.rio alla co1te di F derico IL a introdur-
r la fiaura n l uore nella no tra poe ia. Nella ua pi elcbre canzonetta. he rie-
labora bun motjvo prc o. con ogni probabilit. dal trovatore Folchetto cli Mar ialia
89
.
[immagine interim del!' amata de critta. metaforicamente come fiaura> che il
poeta-amante tiene dipinta nel uore:
Mera,igliosa-mente
un amor mi distringe
e mi tene ad 0<111 ora.
Com 'om che pone mente
in altro exemplo pinge
la imile pintura,
CO . bella. fa c" CO
che nfra lo core meo
porto la tua figuraq
0
.
86 GorrroNF. D' /\Rv.zzo 19.+0. Xli. I' \. 19-22.
87 c(;l'Oati. " ' tiatc ndla finmma il riuauo di un incostante. quel ritrnlto che egli mette nella 10 trn au111L
0
d 1E1t e 1011 e' che amandolo anrora rhe offemlcle la
Canrt' lla1t' lo dalla vostra mcmona. questo m egno angur < .. or . 1
gloria(. crnF.R1 1991 . XXX. v, . '.37-.+2 [trad. mia]).
88 ' dancro tribtC privilr"io drcrli amami, pur lontano da lei. lei udirni e. vedrai, se andir lo11truia
199,, [' . . / ] Ili 9 ? tratl L" Dotti) cfr fmiliares. XITI t, 8: lrigm quodam rt amantum pn11- ,> e< 1e 11111 , . . - .. . .. , ,
lcgio ah:.rntr111 ab. cn. a11di>><111e videsque 19'.33-19-t2. lll) .
89 Cfr. FotQlJF.T DE M,i.RSEIU..E 1999. \' chanlan m 'an!n a membrar), w. I O: qu 'i.nz e I e r po:t, do,mna.
' [ 'I po to donna 11 10 Lro 11 o/ clic m1 orta <1 non
1ost ra fai5son/ qw.' w cba t1a q11 en 11011 vir ma ra on ne cuoi 1 , ,
I "1 .
1
J Oa Fokhrtto (h'i, VIII. 11. t 1-50) mbra dip<'mkrc anche Or come pote, 1 gm11 donna
cam 1in11 1 11110 111, n o . . , , ( , ) .
1
, "' h '
11
nto dRli occhi al cuore
enltW'<' dove il ot11ro tl1cr rht" porta la donna con'" 01' unqi.1e 1a 1. t t le no e e P "
non ' la persona. 11111 la sua figura ( . 12). ,fr. A "\TO :ELLI 1977, PP 62-65. . . .
90 Cii1coMo
011
LEl\ltNI 1979, 11, w. 1-9, ma c:fr. ant'he le ll grazio11i r il e nunento in Poeti della cuoia s1cilw11a,
I, pp. 39-6!), oltrr d1t' Pcwti del Duecento, I, pp. 55- -
37
11 topos si pr cnta dii'.pi gat . n Ila f mm di un para
11
011c tra il pittore'<' il poeta-
amamc (Com ... e ). e ribaci iii e la co ta11za clell"amon' eh<' ani11c e do111ina il
pota (n . 1-: ): l'io. che porta rim111agine dcJramata Il 1 CUOI'(' . fa proprio COlllC chi
cruanla ali 11tam ntc' (Contini) un mod 1l ( .\empio) e ne dipinge 111rn riprodu-
zione ' Orniglia11te ( la pintura) . i awcrt una di sparit tra L1zio11r liua-
mi a dclrani ta e qudla. non ancora esplicitata. dcl poeta-arnant ( fac(''co ). al
qual 'attribuita. per il m m mo. una e ndizio11 , tatica (tenere l'immacrinc cl ntro
di ''). La imilitudinc tabili c p r l'ordo p r le du ' trofe su('CC ' i\ :
In eor par eh eo 'i porti.
pinta eom parete.
e non par dif r .
O Deo. c mi par forte
non o lo apele.
on Yamo di bon core:
clo li ' \ ercr gnoso
ca pur,; !marcio aco o
e non,; mo tro am re. (YY. 10-18)
Attrav r o I o illazi ni di ignifi ato del ,. rl parere. id ntif ate con icur zza
da 'ontini. i d finis on I caran ri ti h delrimrnao'ine che il pot'ta ' embra ( par)
portar Il I u re: ripr du e fed Lnent ra petto della donna (pinta Olll parete
[dipinta ome apparir . ondo il \ 'O Lr a pett ')) non si wd (pare) alr temo.
Tr t mi orr lati (la pinura. la omioJiama e l'atto di ruarclarefreder ). intr dotti
n Ua prima trofa. Yeng n co ripre in ila e nda proscgu no nella terza:
.hendo !ITan di io
dipin i m1a pinlura.
h Ila. mi imigliante.
" quando voi 11 n io
guardo n qurlla figura.
par eh o v agcria davant :
ome quello dii' crPde
i per ua f cl .
a11eor non "rggia inanti'.(' . 19-2.)
Sei pa acr!!io dal pr nte al pa ato razi lH' d l dipincrrre"
1
Yi rw attribui-
ta direttam nte alrio ( dipin i>). che ha r alizzato int nzionalm nt la pi11t ura.
u11.irnmagi11e omicrliant (com qurlla del pittor al v. 6). con funzione o tit11tiva.
colmando 11 una diver a e illu oria \'i ion (par b'eo aggia davant ) il vuoto
91 t'<'omlo Bai"' 1988b {p. 92) l'w.o d I \'erbo d1lla piltura co ti111i"1 la \ariaziorn pi1 ii.,rr1ilirn1i,n i111rodo1tll
rial \ 01aro 11rlla -.1oria del lopos.
38
eh si apre ali guardo in a e11za cl li' amata (quando voi non vio ). L' n imula ro.
invi ' ibil o materialc
1
r
2
con la l'arnant cl Ila lontananza di colei ch . in pr nza.
egli guarda oltanto ( pw) di na co to. celando il proprio d iderio. L'illusione di
vcclne r paragonata alla ondizionC' del cristiano, hc couvinto di al\ar i perchr
r cl . b nch non , hbia innanzi agli occhi !"oggetto drlla . ua fede (Couti11i). n
man a dunqu una spia. per quanto marcrinalr e indir tta. cl Ila comp n nte idola-
trica dell 'amor . rin parti olarc drll'amor cantato dai p ti. Que to a pett . m lto
ttolineato da Acrambr11. dc tinato ad arccntuar i. fino ai limiti di un'adorazione
bla. fcrna. nella por. ia corticriana. JJ motivo della ,.i ion con echi intrrni o e t rni.
d l ,-i ihil e dell'invi. ibile. I rcorre le tre tr f c n una trama alt rna fitta: il
pittor o , rva il mo I Ilo (v. -+).la ficrura non . i \'ed aJre t m (\-. 12). il poeta
erYa la donna senza far i vedere (v. 17), quando non la vede erva la fiaura (vv.
22-2:3). Qualco a di imile ace ad . ad e empio. in LUl , on tto del rimat r pi auo
Panucci del Baano (12:-1 ca.-1276). d ,. i contrapp ncrono appanr r
na co ti" (Amor pri. o in m \Tapotenza./ e ua virt. eh par f' r. na coza.
[per cpianto na co ta, appare di fuori (nel mio vi o) p r i u i ffettf (Acr no)]/ la
fornra di tua gran I iagienza/ formata nel mi' cor errati za./ che e 1 ol pare over
eh I ia na cozo./ on-o up zo. ovunque io mpr ia./ tua forma nel nli cor pia-
gente. cruard :/e quando te v <l r. la o. , no ozo/ n v d r p o. mir . in fede mia./
dentro al mio core ove io te porto e cruarclo
9
.i), nella na d !l'innamoramento
ncll'E/eO'ia di Madonna Fiammella (E cri n Ila mia m nte endo l'effi!ri. della
ua figura rima a. non o con eh ta ito cl.il tt m co la ri!!ua.rdava. [ ... ] ontema
cl.e .ere da lui riauardata. talrnlta cautam nt e o mi ricrua.rda miramll-t).
Il po rs o di un"immauin m ntal dell'e re amato. la vagh gcriare nza divieti
cnza o tacoli. costitu ce in fondo anch una ver ion pr t rint nzional . non
p rseguibil . di un crimine cornm . o da molti amanti romanze hi. prima e dopo la
Prinresse de Lce : il furto d 1 ritratto.
In MerrwiO'liosa111ente I' azion di dipincr r ' un termine di paracron per prirn r
o , I
la prod11zionc di i111ulacri imrnaainari. e il pitt r ' un alt r-ccro dell amante piu 1c
d I poeta. 'on di,cr o u o metaf rico. in ,\fadonna, dir 10 roulio Gia m paragona
92 P r Ull .i11trrl's>anlr i111l'rpn111zionc dclln rnmmnetta. rhe intl'lld1 lu pintur 1 drl , .. 20 in Ul'l'(Zillll!' m11t1riale.
ri mi a M 1 "1.c11 ElTt 200.).
9:3 P\'\L tuo ou. lhc:'lo 1977. I." 5-H. Il pro,enzali mo piurienza indica gnuio. flbcino. hdltun. do1i ama-
bili . Il mutho, r he derirn din1tanwnte dal \ otaro. pre,'1111 !llll'he i\i. \ '. n. o 1-b2 ( Do1u1a. poi 'nma!!U1ai/ la
pia r111e di, i nd cor ligora), \la. " 19-'..W aHndo/ nd core[: .. ]) o:l-6-t.(ma
poi <'h ' io. lri amane! , ' magginai/ In :iua formu li hgura ). \ \ , '':". 1.3-18 { mnorozo n]de l alma
porlo forn1U./ come:. I vulcn vr1ro./ conw ligurn i guardo.I 1n1ro 11 me. 1 n 0Jfom111/ ('lii sC'g111 111111
['Coll'i d1I ('ui m1pe110 arnoro-.o porw la for11111 11ell'11ni111a. 1111ri> in 1111 ro1111 il ,ole {pt'nctra) nl'lln r 10 m
ritrncro 1111'i1111nagi11 d11 mai llllO 'Jl<'C'l'hio 1um rit11111e (pi1 .fedele di '[!"'l!n d? uno
Il 1om11111110 (I(/ foc. rim in a Pil'r della \ 'ignu. tmando co11 J111 mn ( 1 m 1'[-1r J figura al rore [ '
9] ). t' u n1ol1i 11hri poe1i . 11 1whe pl'(>H'llzali.
<i't Bocc1C<:10 1987. 1, p. :38. Sulla delln ' prima visw 1wl romnnzo cfr. il clos,ico Hot 'ET 11>81.
'9
lo conforto di n n aper dire con e altezza il proprio ntim nto c n la fru trazion
dcl pittor che int ni ne continuam nte -ulJa ua opera, re tandone empre dclu o.
perch non attina lma ornialianza perfetta (Lo non-poter mi turba./ com 'on che
pinge turba./ e pure li di piace/ lo pina re che fa , - e riprende./ he non fa p r
namra/ la propi:a pinttua%). La yana ri era d ll'arti ta in que to caso corri ponde
al tentativo poeti o di rappr entare l'an1ore, ma pi pe o la imilitudinc d igner
lo -forzo di cantare l'ogaetto amato, di 1itrnrlo con le parole.
on i poeti d llo tilno o la oppia oc l- uore a impor i, m ntr il motivo
elrimmaain portata d ntro di 'coinvolg ra iJ uor ra la mente
90
. Lapo Gianni
ceglie la ment ( [ ... ] 'n la mente/ 'i porto pinta p r non ubliare. [HL "'' 3-4
cfr. L\, \T. 2 -2 ]Q
7
), m ntre Cino da Pi toia alterna cuore e m nte (I, vv. 1-2, dove
-ono ali occhi t i ad a er dipinto), perirn ntando i pi vari rnotiYi contiaui, al-
uru aia mcontrati di lunaa durata: l'inalterabilit d Ila :figura. eh neanche il uo
autore potr bb di trugaere ( 'Amor mede imo n ' a e e olcre./ non di farebbe in
cor la ua pintura [VL ' " -6]). il aelo o na condimento all 'e terno del imulacro
eh i cela nel uore ( vano guardo a falsi embianti/ elo olei eh n la mente
ho pinta [ VI. vv. 1-2])- la \icinanza dell'immaaine all'oriainale. eh p rmette
una o tituzione con olante (Lo intelletto d'amor eh 'io olo porto./ m'ha 1 dipinta
ben propiam nte/ qu ila donna aentil dentro a la mente./ h'i' la veaaio lontano e
mi conforto [ IV w. 1--]; E e non fo e che p o ricorro/ a la faurn ' n ua
embianza pinta./ fOra dango eia la mia vita e tinta [CXLIII,' . 9-11]).
Al Dant dell Rime oprattutto della Vita ova i de e un' inno azion igni-
ficativa per la toria del topos: l'attribuiion deff immagin interiore ad Amore
98
.
Xelle Rime la figura pu collo ari tanto nel cuore (nel mio cor pinta [R 6 . v. 3])
che nell'anima ( Lanima folle che al uo mal inaegna./ com' ella e bella f' ria/ co
dipinae e forma la ua pena [R 15, vv. 19-21 ])- mal bell zz amate ono cu todit
in modo privilegiato dalla mente. che ricorda e immagina:
eh Lii m' ofonto fero nella m nte
e pingevi una donna gentile (R 45. vv. 9-10)
95 DA LE-'Tll'\I 1979, I. vv. 41--+6: a propo ito drl \. -+2 Contini a11nota cdipin"c e cancella. rif. e ron-
Linua a piacergli la ua pittura. e i rimprovera di non aprr perfettamrntc elaborarr una riproduzione esatta
(Poeti del Duecento. 1. p. 52).
96 ul problema di quc tao cillazione, leaata alla disti11Zione tra ori"inr \'ital e sede drlri.mmagi11e, cfr. 801..zo 1
1995 e ACA.\IBEN 1977.
97 La numerazione che adotto per i te ti di Lapo Gia1111i <> di ino. salvo diverse indicazioni, i rifrri cc a qu Ila
di .\larti in Poeti del Dolce stil nuol!o.
cfr. la anz?ne di 1Le1:10 da sa di \laremma Donna. mro core in parie. i11 Poeti del Ourcento, I, pp.
3.?9-361 ( lo vo ':a pc110/ e I amoro a e ra/ more in cormi pingr./ ond gioi re aspetto [ vv. 63-66]) il Dello
d'Amore [Dello d amore 198.3), poemetto da alcuni attribuito a Dcrntr. <love si lr""'C: M'Amor l'ha s a punto/
mia mente pinta.I i la mi wggio pinta/ nel or, 'i. dormo o ve,,lio (vv. 256-259). Tutte le ritazio11i dalle
limze darne he C"uono I edizione De Hoberti ( LIGHIERI 2005 [R]).
40
Quan10 nrll'css1r suo bella crrntile
n crli atti cd a111oro. a.
tanto lo nmaginar clic 11011 i posa,
r adorna nella rncn1c ov.io la porto; ( R 5. vv. :31-34)
I paragoni( ome ... CO ' [R 15]: Quanto ... tanto [R. ]) fanno ri altru. an-
cora una volta. la omigli anza 1ra la donna in carnr e a, con la ua bellezza con
i uoi atti crudeli o g rllili , r l'immagine he i trova nel p tto dell'amant . dipinta
dalJ aruma dalfimmaainazione ( imaainar ). Lidea tatica. 11i provenzale e ici-
liana. cli portar la fianra in s, si a ocia ormai con forza a una componrnte di-
namica. legata alr oriJJin alla formazione cl lla fiaura tf' , a in i me. all"indivi-
duazionc di un e ecutorc. L po sibilit metaforich offerte dall arte aJr e pre ion
di quc 1i procedimenti interiori fanno eh i tal)ili. ca una pi viva corri pon lenza
trn le facolt dcll ' anna e ali ruti ti. che i affianca e i intreccia a un topos !!i attivo.
quello della Natura o di Dio come arte:fici
99
. In Dante rarti ta che e eru la pittura
intniore i identifica pi volte con Amore. ad e empio ne La dispielata mente:
E crno la docrlia pi miu ende
quand'io mi prn o ben. donna. eh vui
per 111a11 d'Amor l entro pinta te:
co e voi dovete
vie maggiormente aver cura cli lui,
ch Que da cui comien cl1t> 'I b n sappari.
per l'imagin ua ne lien piL1 cari . (R 12, vv. 20-26)
li dolore del cuore tormenta il poeta con fimnrnf' pi a pre al pen iero che la donna
dipinta l entro. per opera di Amore: di n eauenza. a mag!ri.or ragione l i d ve
aver cura d l cuore ( hu )- I erch noi simno pi crui a Dio per rimma11ine di che ha
voluto la eia re rifle a in noi. Co, in Cino da Pi toia Amor -pittore non pu di truager
rop ra che ha realizzato nel cuore del poeta (Yl VY. 5-6) e a[j impon una doppia 'i io-
ne dell'ogaetto, a sediando enza rimedio ali o chi della fronte e ali occhi delranima:
O\'r piangrr mi fece il bel cmbiante.
lr trecc I iomr e 1 Jolcr sguardo fin
eh.Amor con l'una man mi pon avamc;
e mir altra nella [mia] ment J 1ge
a imi! di piacer bella foggia
che l'anima guardando sr 11 ' estin"e
100
.
99 Per la ll!lllU'a !lShirni lnta l'fr. LAlDE 1989-1990.
I 00 Sigt101; r' 11011 pass mai peregrino (Poe/i del Daecenlo. Il , !ll). \ v. ?-11 _(di qui R!f n.
35 ). dia ezionr ci11ia11a di Poe/i del J>11ece11/o rg11aJo anch Xl\,\._ 7. dov tmagmando> t' ternun<" tt'C'lll('O
-+1
... & .................................
Amor 'On tuia mano gli pre ' enta allo .:ruardo ( avante) le b il zzc della don-
n:L C n raltra gli cliping 11 ila mente, dunque ab nefi io dcc:r)i O hi interni. un
aspet1o bello ( fogofa) o imil a qu llo reale (a imi] di piacer=' on bellezza
id ntica' [ ontini]) che l'anima , i truaae
101
. La bipartizion tra ouoetti e oggetti
di que to doppio atto cli p r zione- ompren ione, tra auardo en ibile e auard
i..nt riore. qui m a in relazi ne on il a to di uore. ar viluppata da P trar a
nel motivo del Yelo e poi complicata dai poeti ortiaiani, anche in virt dell'allar-
aamento tematico uaaerito dalr peri nza del ritratto faurativo.
Xel petrarchi mo Amor -pittor ar affiancato da altri artefici int riori (p n-
icro. d iderio. oano ), come n ila dante ca anzone 'montanina (Amo1; da che
concien pur eh io mi doalia). doYe la Yi ione int riore della donna' inevitabil com
il pen i ro:
r non po o fuuru eh' Ha non veuna
nell'imauine mia
e non come 1 penier che la 'i mena.
L'anima folk eh 'al uo mal 'inuema,
com.ella bella e ria
co dipinue e forma la ua pena:
poi la riuuarda. e quand'ella b n piena
del !!fan di io che degh occhi le tira,
incontro a adira.
c'ha fatto il foco ond'ella tri ta incende.
[ ... )
La nemica figura. eh rimane
vittori:o-a e f rra
e ignoreg!!ia la ' 'ert chr vole.
yaga di mede ma andar mi fan
col dov.ella ' 'era.
come imile a imil correr le. (R 15. n .16-25 e 31-36)
Qui e l'anima eh clipi.na la donna proprio com'. bella e pietata ( 'ontini) e poi
la !!Uarda. rinfo olando la pa ion tormento a (lett. ' i crea da e 1e a il proprio
tormento (Contini]) per cui la <mimica figura domina ramante molto pi di quanto
lo con oli. La tirannica ignoria dell'irnma!!ine, h qui i rci1a ulla facolt volitiva
cli asrendenza leminiana ('co111c111plando fi amente in immaginazione (il'i. p. 659]), e , X. vv. 1-i: cA vano
e a fai i embianci/ celo colei che nrlla meme ho pintaJ e covro lo desio di tal infin1a./ h'altr non a di
qual donna eo mi canti (ivi. p. 668).
101 'fr. quando potr io dir (ivi. XXVl],' . 16-18 (lncrr <'ali la "U<'rrn della mfnle./ J dove tu dipingi/
quel rhc nmua I mteUetLO accorto). e in Poeti del Doler stil nuovo. i onclti Lo intelletw d'amor eh 'io solo porto
[ J IV]. \'v. 1-3 e .i Amor del suo piacere [VJ]. \'. 6. Per la fortuna ciuque emr r.a di que ti motivi cfr.
ad P un son tt? B Mentre la bella imago. che nrI petto/ gi di ua propria man m' impr se
Amore/ traggc licu 1 rn1f'1 pll'u 111torno I r{)rc/ a rimirar il uo chino aspf'tto; (CAPPW..O 1997. XVI. vv. 1-<t ).
42
(v. 3:3) torna iii Per quella 1 ia che-lla Bellez:::;a corre (R 47). dove ad Amore vif'ne at-
trilmita l' iniziativa cli un.irrvc titwa (ch quella donna he dibopra iede./ quando di
ignoria chiese la verga/ corn ella voi e, to to Amor glie I di de [ vv. 9-11]) o di una
' collocazione', come in E' m 'incresce di me: Limagine di que. ta donna iede/ nella
rnc11tc ancora./ l ove la p11osc quei chef u ua guida; (R 10, vv. -t3-4.'").
e1 traUo eh cpara Dante dai provenzali. la lunga storia d ila figura nel cuor
attraver ata da du o cillazi011i tra poli contrappo ti. eh . aranno in pa1te re-
di tate da Petrarca: l'immaain ha un Ga.rattn o pe o tra la natura di tato e di
processo e la ua ede re ta incerta tra il uor e la mente. Pi 1 agibile. nono tante
durature ahernanze, la predilezion accordata ora alla pittura ora alla cultura
come 11:'rrnini di paragone p r l' attivit imrnaainativa. e. in ori!line. la figwa
impressa o intagliata n l uore, vero imilrnente per l'influ o cl terminante di altri
topoi. la cera dell'anima la f rita
con la uola iciliana. la t cnica pi
frequ('ntl:'mcnte richiamata cli nta la pittura io:
3
Il modello pia tico- ultoreo. eh
in Petrarca e n ivc con quelJo pittori o. tender poi a oppianta.rlo. probabilm nte
in ribposta al contemporaneo emeraer . come oaaetto di poe ia. del ritratto inte o in
sr nso lett rale. La pittura cmbra allora far i portatric d Ile i tanze pi leaate ali
impr<' . ioni terne e oncrete e aali effetti ui cn i. mentr la cultura i pr ta ad
e primere l' immutabili1a propria cl l imulacro amor o e memoriale. Alruniform.it
dci colori , qua i univer almente impieaati dalla pittura. i ontrappon la vari t
di materiali nei quali l'irmnagine int riore' in i a, dalla pietra alla cera. dal marmo
al diamante. spes o con connotazioni imbolich oltr he fi i he.
1.3 Laum (Petrarca)
N I 1987 Miquel Bare 16 ha dipinto un quadro che mo-ua un corpo femminil ti-
lizzato nudo come quello di va: a ini tra d Ila fiama. qua i <Traffita tilla co ta
di un libr paO'inato. i 1 ggc la 1itta Petrarca. L:arti ta d forma emblematica
all'incolrnabil di tanza tra l'amor e il uo ouaetto (il titolo dclr op ra Petrar a.
non Laura) interpretando, for e incon apevolm nt . Lma tendenza alla cli incar-
11azione e ali autoriile ivit molto forti nella no tra tradizione po ti a. L fatt zz
102 Long aft 'r th uuubadour,. thr hC'art could coma.in d!>ual image repre rutin" rrelings or memorie.
imagt'' 1hat \\'(.'f(' \'ariou ly likenrd IO lh(' or sculpting. rugrming. or paimu1g. [ ... ] Pary a a rcsult or Pc-
trarch's i11fl11encc. imilar pi c1orial nw1aphor continurd to appc 1r in IO\' lpi thrnughout th Renai:; ance. Fn.im
the corly 1hincen e ntury. ho\\PV<'t". lyric iu1d r<nnunrP be!!}rn 10 portray 1hc lowr' heat1 al -o in t:.'l.pre li tex1ual
ttrms ( ... J lnstcad or ontainiug a wo1111d or an imn"t'- 1hr hcart now spdled out th tbc b'loYc?
or rarrird 11 wriltcn trru1btripl of du lowr's thought s. [ ... ] 2000. pp. cfr. p1u m, "'neralc il
capitolo -t , f,o,.ers. che riguarda la secolarizzazione del libro del ruon'. dow srnw Cupido. I amame o I amata}.
103 Nn111ralm nte esi tono eeet'zioni. rfr. ad t'>. ,'.mozzo 1965. IX. w. 65-6(): [ ... l il hrl ,.i o/ che m' , colpito
111 J CtlO>.
43
della donna cantata n i Rerum f'ulgariwn Fragrnenta sono s1ate inseguite da gene-
razioni di poeti e di appas ionati, vagheggiate for e pi di qualunque altra reliquia
petrarchesca. Il desiderio di onoscere l'a petto di olei .he nell otti a biografi tica
dei commentatori e di molti lettori ed emuli avrebbe i pirato la pi grande poesia
d amor di tutti i tempi, port i petrarchi ti francesi, come Marot, in Provenza ulle
tracce dei due cel bri amanti e oli it la rie r a di un 'immagine concreta di un
ritratto he re titni ,e fedelmente i tratti di Lama. La complicata vicenda di que to
inseglmento, fatto di le<rnende pelleg1inaggi fal e identificazioni, prende 1 mosse
dal Canzoniere tes o, o meglio dal modo in cui i primi 1 ttori di Petrarca hanno
interpr tato i sonetti LL'XVII-LXXVID
10
-i .
Il Canzoniere che in alclllle edizioni cinquecente che i intitola proprio Il Pe-
trarcha un mondo di p echi nei quali Lama riflette Wla moltiplicazione di
imulacri attrave1 ata da una di continuit radi ale senza ritorno: il passaggio
che conduc Madonna, oggetto dell amore e della poe ia, dalla vita alla morte. La
diffrazione dell'immagine amata nei luoghi e nelle parole dichiara impo ibile la
rico truzione dell'intero e rinvia indefinitamente, a un tempo che non quello della .
vita mortale, il ritrovamento della forma vera. In que to a tello di Atlante il mago
Amore e il cavaliere enante procede come un pell(\,orino, gravato non dell'armatu-
ra, ma del corpo e delle pa ioni. La prima impressione (alla lettera) provocata dalla
vista di Laura fatale, erna il destino del poeta e il suo rapporto con le altre n-
magini, co tringendolo a cercare o a ritrovare la sembianza della donna in tutto ci
che incrocia il uo guardo. La fu azione amoro a che conseaue all'esperienza visiva
della bellezza si esprime come cultura interiore che non dato alterare o iimuovere
oppure come visione per istente, interna o proiettata sulla natura e u volti nei quali
ci i illude di ricono cere quello amato. La vista della donna cui tutte saranno infe-
riori produce nell'amante un immagine che lo pervade, e trornettendone ogni altra
e pe o an.ivando a compromettere le facolt dell anima, tanto che gli piriti vitali,
cacciati, i tra feriscono nella persona amata
105
:
Quando giugne per gli occhj al cor pr fondo
J"rrnagn donna, ogni altra indi i parte,
104 La otoria delr immagine di Laura stata rico truita con rande ricchezza di documentazione da 1!APP 2001 .
Tutte le citazioni dal Car1Z011:re aranno tratte da PETRARCA 1996a [Rvj].
105 Jn caso di reciprocit, emrambi gli amanli dovrebbero. ubire lo ste o tipo cJj vuotamento, come non accade
onetto petrarchesco, i1 cui mod Ilo agir, ad esempio, 1J cl Go. elinl di Com e che morto in se stesso 1 in. due
(CosELl:-<J 1588, P.rima parte, CCL). Per la prepotenza dell'immagine ricordo un fra mm nto di sonetto di
Michelangelo (<Q1J.and'Amor lieto al ciel leva1mi ' volto/ cogli occhi di co tei, anzi col sole./ con breve riso ci che
e dole/ del cormi cacci.a, mettevi 'J suo volro; [B1:0N.1nnon 1998, 40 vv. 1-4)) e un suo madrirralc in 11i
l 10 che attende di , serr: riempita dal metallo fuso ( lt:a donna e gradita/ iJ1 discende
per si br trarla fuor mi rompa e trazi> (ivi , 1-3, w, 10-12]); egnalo anche un sonetto di
e t0 vo, sto, gentil madona mia (CXL]) in cui l'os essione delramm1te per il collo della donna
sfocia m una v1s10ne continua e torm.ent.o a (cit. in BL\M;m e rfonnE 2003, pp. 183-184 ).
44
et le ert che l'arma compartc
lascian le membra, qua i irnmobil pondo.
Et del pri.mo miracolo il s condo
nasce talor, che la scacciata pa1te
da e stessa fuggendo arriva in parte
che Ia vendetta e 'I suo ex.ilio giocondo. (Rvf CIV, vv. 1-8)
L incancellabilit del snu.lacro interiore ( l'imagin donna cio 'padrona }
tra i fattori che ne determinano la natura di prova d amore, assicurando la crudele
permanenza della passione. n tormento che chi ama spesso 'i procura da , cer-
cando di fissare il volto desiderato nel ricordo o con pi colpevole cedimento, in un
ritratto vero e proprio la superficie dipinta o colpita si offre all'appagamento dei
seni aggravando il gi infelice privilegio degli amanti
106
. L'immagine inci a nel-
1 anima co salda e ine orabile che pu es er eliminata olo con la morte di chi
la porta in s:
Misero me, che volli
quando prinrier fi o
gli te1mi nel bel vi o
per iscolpirlo imaginando in pmte
onde mai n per forza n p r arte
mo"SO sar, fin eh 'i ' ia dato in preda
a chi tutto dipaite! ,
T so ben ancho che di lei mi creda. (RifL, vv. 63-70).
La prima contemplazione del bel vi o ' continuata e intensa, ed caratte1izzata
con ]o stesso aggettivo in funzione avverbiale eh ar riferito al mirar degli arti ti
( <<fso )> cfr. R1f LXXVII v. 1) que to rruardo protratto alimenta intenzionalmente
( volJi) l'immaginazione producendo una cttma i:nt riore che potrebbe . opravv:ive-
re, per iperbole, perfino al corpo eh la conti ne. Altrove, tilla scorta di Dante e di Ci-
no107, autore del simulacro Amore, che nel cuore dipinge o scolpi ce crive o detta:
Ch' aver denlro a lui panne
un che madonna empre
l l 1 l (R
J
XX ' rv, V". 33-' 5)
108
e ep:inO'e t e e ci par a: v ,
106 1lL, quod st amantum infame privlegituu, illam ab-entem ab en auclie et videhi ( ecrel.wn. llI, 9.2).
107 Cfr. R 45, . 9-1 O e Marr Amoroso, vv. 41-4. (voi vedereste la v tra lgLtra/ dipnm Il 1 mi .
con),/ e lettere dintorno ehe diriano in qnesta ui. a:/ v'amo, d"'a, h non faccio DeoJ e on pw vostro a ai
che 11011 son meo" [Poeti del Duecento, l, p. 488]).
'108 ccoodo Santag111a (in Prr.mAnr .. 1 1996a, p. 570) qui e inR1!fCLV il topos embra_ dipendere da Cino. mtt cfr.
andH) R 12, vv. 21-.:.2:, m()difica p1:trarchc. tu l'aggiunta l parla a depmge (p.
4
Quel doler pianto mi d pin e .\ more,
anzi colp , et quc' detti oa,;
mi cri e entro un diamante in mezzo 1 rorr:
on, con alde ed ingcgnos chiavi
anchor torna sownt a trarne for
Jaarim rar ' et o pir" ltmghi et gra,; . (ivi . CIX. \'\'. 9-1-t )
Il I a aggio. on correzione o ripen amento (anzi ) dalla pittura alla Tultura
(iYi . .LY' . 9-10), tradi ce un re c ndo nella re i t nza attribuita al ri rdo dei
lamentj ed ll paro] dell amata. culminando n Ircvocazione d l ruamant c: il matr-
riale inru truttibile per eccellenza ricorre anche in una Familiare. emprc in rapi orto
a tma prima vi ta:
Reliq11um erat ut te memori animo re ommi um haberem: iuvat e11i111 verbi. eti am
tt uti . Id ,ero iandu<lum factum e e conldito; e:r quo te pri111w11 1idi. irnaaincm
tuam e.r adamante purissimo imi precordi i indelebiter affo;j. quam nulla rev Il ei
clie . nullu locu- xcuri et
10
'>.
Co Petra.i a probabilmente nel 1.3-l-0. a \faT o Portonario da Genova.
caro runico h ritorna a lui attraYer o le letter . La co tellazion di topoi mem -
riaJj leP"ati al ritratto interiore i applica comw1em nte anche in conte ti non amom-
i. per e primere la olida intinlit di leO'anti anlicali e familiari, come in una l ttera
a Giovanni Colonna:
Quantum enim locomm imen-alli ab an1i rorum onver aci onc di si un!!imur. tan-
tum ah enti e detrimentum idua commemoratione di culimu. : cuiu si tanta \'is
et. ut mort uperala. defuncto etiam ami co pro \'iventibu celebremus [ ... ). qui I
tam ma
11
num e L . i. ab enta imiliter vi la. lonae po ito ami rorum niltu pro
pr ntibu haheamu
110
?
Lepi tola illu tra I ragioni p r ui la lontananza non ' nemica dell' ami izia. con
echi iceroniani (De amicitia. VII, 23) che ri uoneranno. a propo ito dfl ritratto. nel
109 c.\'el re to deUa leu rami prrgavi di averti ; rmpre in me con animo rnr morc (uso le tur parol r). , ta pur
ccrto che lo sei da gran trmpo: dal primo giorno clic ti conobbi la tua imma,,inr mi ' rima ta :,colpit a 11 c I cuori'
<omr ia un vi\O diamante. indcl bi le: non la canCC' llrr ne un rc mpo. non la strapper nessun 111 0" 0 (Fwn lii.
12. 10 [ trad. U. Dotti]).
110 Di quanto infatti siamo eparati dall a loro compagnia prr la di tnnz11. di tanto canrr lli u111 0 gli vantagai
.con _i l tani ricordo. la cui forza i> tale cli c. vinto il poten della mort e, fa prr; i110 i11 modo cli t
1101 1 pra11ch1 gl i r tmtt come fo ero vivi ( .. . ] Percli r rncravinfo:irci. quindi , oc, vinto allo strsoo modo il potere'
del la la del ricordo .a .riportarci dinnanzi agli oclii l'immagine degli runici lontani ? (Fom li, 6.
3 (trad._ U. _Dotti]). Lep1 molt o vtc111 a a u11 pa o drl De remPdii.s ulriusque forlunae (li . . 12 [5.3)), fa parte di
una bme d1 Lr!' lettere a C10\'anni Colonna (Fam II , 6-8). annunri11f (' in Fa111 Il. 5.
46
De pictura di Lcon Balli ta lbfrti (II. 2. )
111
. e con verr proprie citazioni da ir-
o-ilio: se il po1 cre d I ricordo. e ernplifcato daJJ'irnrnao-ine di Enea colpita nel cuor
di Didone ( hercnt infix.i pcctor vultus/ Vrbaqu .. . ), co forte per l'amore pa
sionale. tani o pi1 lo sar per un affetto nobile rni ura1o come l'amicizia.
1_; immagine dell'amata cende al cuore attra er o gli occhi. che da quel mo-
mento 11on vedono altro ( Yla 'I bel vi o l ggiadro cl1e depinto/ porto n J petto. et
VCO' O'j ove eh io miri [R1f I, vv. 5-6]' <i: [ .. . ] per h"io miri/ mille CO e ruver e
attento edi o./ ol una donna vegO'iO e'] uo bel vi O [i i. e X IL vv. 12-14))
112
.
La pre enza della fi gura clunqu non olo donuna irr i tibilm nte il teatro interior ,
ma produce una proi zione cl 11 embianze amate neO'}j enti naturali che pu e r
formulata anche come ritratto, come di egno:
tal or m' arresto e pur nel primo a so
disegno co la mente il uo bel vi o (R1f ' XIX. vv. 28-29)
Fuggir vorrei: ma gli amoro i rai,
che d et nott e ne la mente tanno.
1isplendon , eh' al quintodecimo anno
m'abbaglian pi'1 che ' l primo !!iomo a ai :
et l' imaaine lor on co parte
che volver non mi po o, ov'io non veggia
o quell a o imil iJ1di acce a luce.
olo d' un lauro tal ek a verdeauia
che ' L mio adver a ri o con mirabil rute
vago fra i rami ovunque vuol m adduce. {ivi. C\'IJ. VY. - -1 i )
L'immagini;- eh ingombra la \ri ta opera amoro a ( an-
tao-a ta). Per que to nella mente (la memoria) la lu e dei rai amati r ta viva nel
tempo e non biadi e come accacfrebbe a un 'effiO'ie dipinta. L' o e iva p r i tenza
del. simulacro si traduc in ' tati di allucinazione e qua i di inco cienza. dolce erro-
H' (ivi , XXIX. v. 50) al quale l' amante i abhandona, p r poi riave i doloro a-
Il1C' ll1C dall illu ione:
[ .. . ] <l ei suo proprio error l'alma ' appaga:
in tante parti t b Ila la vegcri
he, l'error clwa e, altro non h ggio. (R1f , \'Y. 3 -39)
111 Su qursto pas o cfr. 801..zo 1 2008 p. - e per un esempio di 11$0 del lopos in contesto non eroti o. cfr. BE \RI
1967, XVII, vv. 1b-17 e LL\, v. 5.
112 Cl'r. nncli RifCL\' Jll : ovunque l' io guardi t:r va chi bella donna ivi per far empre mai verdi i miei
(ksiri./ Con I g"iadro dolor par ch'ella piri/ alta piet[ . .. )(' '"
47
et YO cantallCI (o pe1rcr mi i non . aagi!)
I i che 1 riel n n poria lontana fanne
chT l" negli occhi. et ,cclcr eco par111r
clonnr et donzelle. et ono abeti et faggi. (iYi . ,L, x,1. 3-8)
el onrtto , .L -\.Xl il poeta rn11a prr luo11hi olitari e rcando l'amata
p n iero. ed ella ali appare ome ninfa o dea ('. 9) o nma donna ' ' irn> ( , ..
l"
113
). in arn ::-a. he mo. tra. n Ira. petto (in ,; ' ta> ). e mpas. io11C' di lui.
Cna ' ituazion eh tr Ya il ' UO innr::io in , \.\ l. H. -1-t. dov . tri un lo in una rnll
riparata (\'al hiu::.a. che qui orri -pond . a li\' Il di frmzion . <i luo11hi ombro i
et fo chi> di CLXXXI). non lr va d nn . ma fontane et a!->. i.I et l'imagirH'
[ ... ]cli quel 11iorno/ che 'l peirier mio faura. ovunque io auardo (n . 12-H).
La menle. avczza a contemplare olo Laura. n n ve I hc lei r vorrrbhe non
,edere nient'altro ( ,\.\'L '" 5-8). cmpn il uo mito eh . faticosam ntc. il
po ta in egu in quello d ile altr donne. e m il ncchio romeo crrca rimmacrine
di Dio n lla \' r ni a (X\'I)
1
H. Le ntinue apparizioni di Laura provocate dal-
la memoria arn r a appannano I tato yj eril enza int rromper la , per
la , ia:re il po lo. nel nno. ad altr pi compl ' e vi ioni. n I(' eccezioni di
. ' X..\.III. L xxm
1
1.
5
' L- LI. i ' ouni del Canzoniere i collo an dopo la mort
d ff amata. con una - lta be ar ripr po. ta n !runico canz nicre ' mat rimonia-
1 del Cinque nto. quello d l napoletano B rardino Rota. "\ Jral ro viruiliano
d 1 primo oano dominano
11
li o hi (quanto anuiata. oim. da qurl di pria!/ Et
P.U: P r h tuo valor perd . I \'cd r quc (o chi anchor non ti i 1011 > [RLf
, XlII. \ 'Y. L-1-t]) nella coppia 'CL- CLI !"annuncio luttuo o. h . horribil
,; fone >. i f rmula nell parole di Laura t " a. \ cll rim in morte la ,i itazio-
ne in omo divien con uetudin pi to a itf'rata ( ovent 1orni > [CCLX, XII.
, .. 1]: torna a con olar> [C L - ' Xlll. " ]: .p o a m torna [ :L :xv."
'.]). hep runi a con.olazion. pur fugucvol ( CL r T \'. \ 1--t): il con-
forto onmco ffirncro rna alle in1maui11i aer iuner le parol e. talvolta. il cres to
(in CCLXXXIll. v. 12. ella parla luce. ior ri plende: doler i11 vi ta et
oave in ,.o [ ' LX, ' IV. ' ' 8]: la ua ,i -1a. ov r col parolr [CC LI.
113 C&.. Trionfi: Triumplws (upidini.t. II. 1. 18-t ( Pi!?r11ullon ron la 'ua donna 1 ha). Pi!!lnalio11f' i rirorduro
1
la fine drl canio P !lrlla rn"rgna '.li a dopo . '<i li a 1 Canarr ( cf r. f /er. \I. :) ) t' .,11hito pri111u d1llr
llC(
1
.
1
de amoro,r. dw furo!ro 0
11
gruo d1 tra nazione lcwrana (e millr eh ... ) e di 'idipp1 (cfr. / ler . .\ \ 1 \\I).
a chiudere la come m 13cX'nirrio. i l morosa fi.5io11e. \.\ \ . 11. 76-88.
1 Qur to uno dci po.,,,ibili _liwlli di di u110 d1i >01wt1i pi comrncnuni cl <'i R1f: p<'r 111111 di.,l'u.,sio11r
r)IU ari1irofond11a lii 1iro11ri-rto cfr 1nrjir1 ] .I ('fr li f("V(' I I .J. s . . I o I , ..
. , . : " .... , 1 " ' , 11. - -. : . r rome eterna 1ri 1a e v11 Pr 10. m pru
1
brama .. uc p111 lrn./ eos 111 donna. il 1oi 1f'd1r. frlke/ fo in q11rs10 ur \ C <'I frnil r Yiwr mi o. La vita
<"lerna dei heatr 'il co111r1111ih11<" ulh fugarrru' (
1
nJI.< t 1 b1 J
< ' ' J, ,.., l'llZIJ Cfl('lllJ, ma I l'!'r, 1 la I IS('OJI() 111111 (' OITl hlHlll( ('llZU
tra la fclk11a scn1.a d1-s1d ri rhr dc11'1a dal!, 1 J) " Il I 11
. ,1 11 ionr r 1 10 1 1111r a 1 1 10 111 pre nza d<ll amata. Prr 1111 ou1111a
lruura d1 que-io >on<'lro 1fr. Bf R ro1_\" 2005. pp. 187- 193.
115 Limmagirre crnd<lr di Laura p11J turbar!' il 11110. 1111111011 tanll> da inurrompt>rlo (R1fL\ \\lii. 11. 1:3- 1-t ).
4
v. 10]). \ el sonetto chr apr la sequrnza CCL X II-CCL \'I id rive una
uioia che. imile a quella d I ri orcio . . i nuln <l I ri ono. rim nto dC'Jlc fattezz
wnto o pirate. drlla loro numerazione appa. ionata delrillu ionr rh colei eh
in ciclo sia ancora in trrra:
Cos co111i11 cio a ritrovar prc-srnti
le !LU' bellrzze a usati ogaiorni.
[ ... ]
:ol un riposo trovo i11 molti affanni.
che. qua11do torni. te rnnosco e ntendo
a !"andar. a la rnre. al\ lto. a' panni . (RtfCCLXX.\11. w. ?-8. 12-H)
'e q1t<lra11ra !>Oa,e de sospiri
dr.i' odo di <'olei dw qui fu mi a
donna. or( in cielo. rt anch r par qui
et 'i' a. e l senta. rt vada. et ami. et . piri.
ritrar (in wrsi ). [ ... ] (i' i. CCLXXXn. \T. 1-5)
Da qu ta agnizi n in rta e pronata dal d rio tra onumf' uno chema che
nel QuattTOC nto e Il I Cinquecento. pe i in r rma i:nt ffOUativa . e I rim r reffet-
to di illu ionr provocato dai ogni e dai ritratti. mo trando com un r dit formal
po a t rasmel trr<' una rrlazionr t mc tic a. Ndla canzone C 'LL . in irco tanzc
,ici nr a qurlle di CCCXI H. i narra un 11110 dalla n u!riatura compie a. che
comprendr un vero f' proprio dial ero: nf'lr ultima tanza prima del e nued . il poeta
addonn ntato . i chi de e Lama ia in arne ed o -sa
110
( on qu ti i ap i bioncli.
et raureo no lo/ - diclo- ch.an or mi triner . t qu i b Ili bi/ eh fur mio ol?>
[' . ]). la donna ri p nel eh ' pur pi1it . an h e le dal apparirali
o i com la veci . c n qu l orpo che 'ii 1iunir alr anima ol cl l la r mrezion
dei corpi ( v . 6:3-6-+)
11
., . Tutti ali altri 'ouni del an:=oniere n ri ,. cati in on tti.
anche sr un c<'rto rrspiro nmTativo on cntito dalJa co truzione di equenz . , ei
onrtti CCL ' ,\'. , \' <' CCLXXXYI Lama a umr il ruol di
11
ui<la piritual dcl po -
la. poichr ora. in cielo. pu v cl rn l'anim.a il cuore di . on t n n olo.
com fa va in vii a. udire par I, f rmar:.1 al,. lto ( . L n .. - ). Quand
il conf ri o del ano ,i n a mancare. ramant pr era la d nna di appa1ir
11
li nuorn-
m nt (Tu eh d ntro mi v di . e 1 mio mal nti./ [ ... ]/ con la tua rnbra acqu la
11 () Cfr. il com111 e1110 ad /oc. di ,'1111tag11w in PnruRt \ I 9%11. p. 13h0.
11 7 Cfr. Ri f CCL\ \'111. Il'. :l-t--t4: O11r. h'ITll r fotto il suo hd \ io.I chi ,,o!ra far dd rit'lo/:1 Jel
fede fra noi;/ J"im i .. ihil .,1111 forma - in p11r111Ji,o./ di sciolta di quel wlo/ che qui kcr nl fior anm onm/
ptr poi/ 1111 "n ltra 1olta. et 111ai pi1 11011 pogliur,i./ quando alma rt lwll11 fnr:-il la.filo pm In. ndnm.
quanto pili , nll'/ ,1111piurnu brll zza du 111or111l1 . \ lit /lime drl Rota la 1i,iom delln moglir 111or11
1
St formula
I I .. ( 'ce11dnr eia 1)"111 r"111n'' il ht'I 'do/ 1mrt'a
ron u11 nfen111111to al rorpo 1' ir. 111 sog110. 1111 ira ?'er np1'. so '
mad 11na. ('al '110 twd1io mt>munu [Ror \ . . L.\ \\I\. 11 . 9- 10)) .
-+9
i mi i lamenti [ . CXL. '
1
12-1-t:]
1
rn), ott nendo una eri e di ''i ioni notturne
(C ,CXLI-CCCXLlll) nelle quali gli con a mia vicinanza fi ica n aata in vita
(et picto a a id in u la ponda./ Con quella man eh tanto d iai I m'a ciuaa Ji
occhi.[ ... ] [ CCXLTI, n '. 8-10] ). 11 poeta. com lm Endimi ne ri tiano. incontra
veramente Laura. on cambio di paro! di lacrim ( cfr. C CL f), olo in una
climen ione doppiam nte altra dalla vita, in oano in morte. Proprio al giovan
amant d Ila Luna il Cariteo intitoler. all'inizio del inquc nto. il uo anzoni re
(Libro de onetti et Can::.one di Charileo intitulato Endnion alla Luna, Napoli. per
Ioanne Antonio d PaYia. 1506).
Diveram nte dal ogno, il ricordo ono ce ia una d:im n ione involontaria. che
pro ma conforto o dolor
119
, ia un a petto int nzionale, di o ciente ri crea, cu-
todia e vagh go'iamento cli tra e e r liquie delr amata. L inc ante t ntativo di
riprodurr il mira olo della pre enza di Laura auida il poeta ui luoahi in ct la vid .
per raccogliere eQ':ni e frammenti. come e il uolo e le rocce pote ero trnttenere
qualco a del uo pa aggio ( o vo ricercando oani contrada/ ov 'io la vidi; [ ... ]
[CCCVI.'"' 9-10]; n' tante rnlte ti vedr gi mai/ ch'i' non m'inchini ari ercar
de forme/ eh 1 bel pie' fece in quel orte e !!:ro [CYIIL vv. 9-11]). Agli occhi
dell amante. pelleQ'rino rabdornant cli immagini, tut1o div nta acro e prczio o per
il fatto cli e ere ntrato in contatto on ramata. e tra i fiori e l'erba fo e rima ta
qualche par-a orma di Laura. gli n avrebbe conforto. com dalla uppo izione che
lo guardo di l i i ia po ato dove ora -i po a il proprio (C V vv. 59-61, 66-76).
ttraver o que ta ricer a. !!llidata dalla memoria e dalPimma.o'inazion . nulla e 'n
perde ( ibid., v. 5) e proprio l'impo ibilita di identifi are pr ci ione i luoahi
on aerati dalla pre enza permette di moltipilcarli all'infinito ( t pi ertezza aver-
ne fora il pegaio> [ibid .. v. 6]). La vi ione di Lama non i rirmova n ila ua unit,
ma on in traccia non perduta. a enza eh pro a di un pa aggio a' e-
nuto ( trov 10: ma uoi anti e tigi/ [ ... ]/ veagio [ ... ][CC VI, vv. 12-1'] ).
Que ta impronta frammentata. di per a in e.on.i orme ( [ ... ] quanti luoah i ua
b Ila copri mai a on:hra. o di gn col piede [ , . 7-8] ). si ricompone,
per ali occhi della ment . ne!J irnpre ion d Irint ro h alda nel cuor .
Gli tup ndi lacerti deir ogaetto amato dun e, in forme illu ori e.
e oniriche fictione.s. el r gi trar .oli affioramenti di una bellez-
rinnova lo chema della descriptio, codiicando quello che
C10 anm Pozzi ha chiamato canone br ve
120
: dalla front . al peti o, alla mano, i
1,; 8 ignifica 'imrna?ine". il confronto con R1f ' UL w. J 08- 109: El io non riuo-
' ando ullo1 no mtorno/ ombra d1 le1. ne pur d suoi pi<'cli orma>.
1
1
9 C8fr. Rif CLVL ." 3 ( tar che di rimembrar mi giova Cl dole>): cxx l, I'. 41 ( dolce llC la memoria) e lii
vv. 5 ( pnma pona per 1cmpo ,en / I J d' 1 '
J I l
, . . ir meno un 1mag111e a< a 1e1amante/ che I atlo doler non mi htia davante/
(e qua o la memona e I cor [)ieno )e Il 18 ( A I . .
. . p f ; " '"mor co nmcmbrar ol 1111 mantene). Sul tema della
mrmona u1 clrarca e r. TORRE 200 .
120 Pozzi 19 . 9 e 1993.
a
-
cont ano i seg11H11Li di un iu ierne p<'r<luto, radUJ1ati in UJla rico truzionc ne e'. a-
rinrncnte fragile di continua. el det lato dC'I Canzolliere le bellezze di Laura i
danno non ol per.fiagmenta. ma per sottrazione e na condimento, cio ome non
viste, rrsc inacce . . ibili allo sguardo dalla lontananza (XX.XVII) e n n dalla mort
(CC 'Cli , . 1-8) , oppure e late da un o tacolo, ad e empi dal velo o dalla mano
( I XXX IJl e LX Il, . 55-57). Pr fetizzando. in . oano. la propria morte. Laura
ammoni c il I oeta a non -perare di ederla mai piu in terra (CCL, v. 1')
121
:
icrnificativo che anche r annuncio di una dimen ione ultraterrena. la ola in ui ia
p
0
11
abile uu nuovo incontro tra l"amant la donna. i formuli con un rme imo
ritorno all a i ta. li vedere agognato. impedito. differito. la modalit fondamentale
dcl rapporto tra l' io e Laura. e il Can:::.oniere. i pu lea.oere an h com la toria del
rapporto tra ramante I" immaaine d il' amala. ia e a imulacro. allu 'inazion
velo
12
z. cl cataloao dell bellezze dominano, per numero cli oc orr nze. ali o chi.
le chiome e il bel vi o. Gli occhi in particolare ono o e i am nte pre enti (l .
XLVll. I XT, C ... ). centrali n lla volta piritualizzante eh coincide con la canzon
L ' ' e con le canti! ne oculorum (L1 I-LXXIII). fonte delr amore (.1 Cill: CY.
. 5) e del can t ( L ' V)
123
Laura la pi b Ila donna cli tutti i tempi, up eri ore
per avvenenza e per vir1 a oani creatura del pa ato. d.el pre .del futuro
12
-+.
Ccccezionalit celeste ( C. vv. 9-11) he ha mo trato m t 1Ta cntta nella ua
na cita paracli iaca e nei uoi effetti bearifici. nella ua non-ripetibilit (CLYITI. \ 'Y.
10-11) e nel uo e er de ianata come ommo cap lavoro d lla Tatura (CLIX. vY.
2--+: CXCI r' W. 3-'i. in riferimento alla mano: e y V. 2: CYTI . VY. 10-11). In
l i Dio ha raccolto il m a)io delle qualit e teriori ed interiori, econdo il topos gi
mcdiolat ino della d nna d paradi . eh la traclizion ombiner a pi ripr -
se con l'aneddoto ili Zewi
12
:>. Laura. che 1 er fermo nacqu in Paracli o (CXXYL
v. 55) un al to et novo miracol apparo in terra ubito ripre o dal cielo (CCCLX,
v. ] ): l'anima uscita clalr alberao del corpo poaliando i cl
bella ve ta de le terr ne membra (VIII. YV. 1-2). qu l v lo h e oaaetto dl
ammirazione per gli occhi della fronte e O' tacolo p:r ali occhi della he .ce1:-
ano la forma vera
1
2
6
Poi h' una imi! bellezza e enza prec denu nza c1cdi.
chi non ha vi to Laura vi ad v ap r che non ali ar mai dato di incontrare una
121
011
,islo iwr rrc Urnzu J' uspr1to di Laura inveccl1iata. eh Pclnirrn immaaina nC'I onetr Xli.
122 , rgnulo il uggerimento di B1:.RTO'% 2008. p. -19. che con id ra rimma<rim di Laura (pi che Laurn
on)
In vrrn d uhragonbta d I Can-:.oniere.
12:) P r le chiom d'r. ad es. R1f \LX.XL\ , \'. 3; LX\"11. 1. O; XC. . '
12
' L , 11' 1 (R f('CL' ' 7-8) ''ht' non si pare1r<ri a lei>. eome a Luerezia, Polncna. ls1h le
-r aurn r suprnorr a< cn11 t' ' " '' =
rd Cfr. ivi . C. XIX, vv . .+'.3-H r CCCLXI, w. I;'\- I-+. .
1
')5 1 r. f'' f C''(' I 'L-1 ( [ .. ] beltatr.I non fu ai 11111 i sr non in que, ta r1!1ll'/ tutto in un "orpo, et c10.ru
- " 1.
11
'" ' ' \'V. - r " : f. D I t 989-1990 e le o.srnaz10111 d1
111i pene). , 111 topos della don no come op ra dell artd1<C d1' 1110_ 1. i,, _..u or.
Hosanna Br1tt1rini 11cl uo 01111nt111 0 n RifL,':X\'11 (l\:111 1nc.1200 ad lor.).
126 Cfr. ad e . quarciato velo (R1fCCCLXll , ' " -+ ).
51
donna paragonabile ( u:.' . 9-10: ..: r, Y. I O). nr di leagcr o a coltare parole
capaci di rend rla in tutto il ' UO fta re.
Oltre che ottratto na co to. nel an.::oniere il corpo di Laura e dunque in-
di ibile' impo ibil da rendere in parole ( ' X: X ... IX. ' '. 6). P r e I ri111ere
rin, uffici nza della poe ia. eh an-iYa fin dentro il oauo ( , ,L ' III, , '. 12-1 +
, ,L:X.XVI, w. 1-6). P trar a impieaa rip tutament . in accezione metaforica. il
I ico della pittura. Que to u o appar con i t nt e icnro, e accoaJ ie un vocabola-
rio pi ampio di quello. pur i!D:ficativo. di Dant :
a voler poi ritrarla
per me non ba to. et par h'io men t mpre. (R1f C, ,\ \'. '" 36-37) 1:17
e quell'aura om de o piri
[ ... ]
ritrar pote i.[ ... ] (ivi. CLX: .X\1. "'" 1. - )
Da poi pi ,. lte riprornto indarno
al ecol che'" rr I' alte beU ze
pinaer cantando. a ci eh rame et preze:
n col mio til e il uo bel 'iso incarno.
Le lodi mai non d'altra, et proprie u ,
che n lei fur come telle in ciclo partr.
pur ardi co ombreaaiar , or una. or due:
ma poi eh 'i' aiuncro a la di,ina parte
eh un chiaro et bre\'e ole al mondo fue.
i\i manca l'ardir. l'1geano et l'arte. (ivi. CCVIII. w. -H)
. n tentativo. vano e rip tufo, ili de crivere Laura in V r i ( pinO'ef cantando) .
\'lene evocato con formule he rimandano co lant mente alla ilimen ionf' (iO'urati a:
gi in Dant wrbo ambivalente. che pu indi ai-e tanto la cn-
m ( cfr. Rif e LX X\ J. V. 5) quanto la re a on altri mrzzi ( fr.
L VU). ma. mcarn? e ombr aO'iar ono termini temi ci della pitl ura ( auta-
n J_Jettivamente una rappr : ntazione al vivo e un abbozzo: la
diu. l 1 arie deriva dalla retorica ant i a e div nta pre 10 canonica
n il elogw art.J ti (Baxandall). "-el onetto 'CCI Amor vu le che il poeta-
arnante dep!Ilaa a chi noi VI.d 1 J } ' ] J
- o e i nura o o c 1e lata ,atu-a 111 t rra, e md e
1
,2
7
'. amagata (in hn.1i1Rc 1 l 996a. p. ;)79) qui e in Rif CLV il topos . emlm1 di( ndf'rf' da Cino. ma f) r
more clw d1pmge rfr. R 12. vv. 21-22.
.2
volte (v. 7) ha ri olto invano a quc (op ra le energie e l facolt cl Irio. i.ng <mo.
1 mpo, penne, carte r nchio tri (v. 8). l po teri , nati troppo tardi per ammirare
Madonna con i propri occhi. non potranno allora cono e re la . ua bellezza nemmeno
per t erba: a chi rifleue ull irripetibilit di Laura) prr l'arte e per Ja natura. non
re ta he o pirar beati gli ocel1j che la vider viva ( v. 14).
Le metafore pittoriche e pia tiche tenaono in ieme il i tema di doppi illu ori n i
quaJi la ficrurn amata si frammenta e riapparr, nel cuore n JJ parole d 1 poeta
128
una ovrappo izion cruciale <' feconda. perch na cita d tramor . della po ia
e !ell a fiaura nel uor tendono a coincider , alr alba della lirica o cidentale
all"origin della forma-canzonier :
Vergognando talor eh.ancor si ta<.:cia.
donna. per me vo tra bellrzza in rima.
ricorr al trmpo d1 i' vi vidi prima.
tal che nulraltra fia mai che mi piac ia.
tro\'O peso non da le mie braccia,
n owa da pulir colla mia lima:
per l"ingegno che 5ua forza extima
ne l'operaon tutto agghiaccia.
Pi Yolte gi per dir le labbra apersi.
poi la voce in mezzo 'l pecto:
ma qual n p ria mai alir tam'alto?
Pi1 voltr incominciai di criver
ma la penna N la man et f'int ellecto
rima er ' rir1ti n I prirnier a, alto. (Rif; X)
Quc ti ver i uni ono in un ne. o ine tricabile ne e it della del dir.
trmpo dcl primo in ontro ( h defin ce p r empre il ntim nt?, l del
<l<'rc e l'oggetto d 1 anto) <'in ufficienza d ila I oc ia. La dell 1mmagm
menlale (> legata alla prima vi 1a e all'innamoramento. e,en.Lo d i JY?
che nel racconto liriro !'' inizio della t ria e i colloca ub1to dopo le ordio r tro-
pettivo. ll riconoscim<'nto del i.mula ro interiore a ompaQTla il d ila po ia
com lamento d' amore e ne ritma rin ante tentatiYo di lodare e di ritrarre.
Le parole. , tando al anzoniere. non po no per far i v.,dere' Lama -
non aiularci a intuire re cczionalit che non anno e pnmer - ma e tat un tcmp
in cui for avr mmo avuto otto ali occhi un'irrnna11in f d led 'lla ua bellezza: tm 1i-
trarre di enuto l tteral . n l di un mano ritt o ' Il tm foglio di peraam na.
I
1 i en o metaforico. lOrne
128 Cfr. 1u1d1r R1f LXVI. v. dcl\ C, in un controverso. t t'Plll 1 e mA o
11
'dipiwi con lu 1111111oria' .
3
1.-+ TI ritratto di Laura
Oltre che nella mente e nell parol , J'irnmacri11e di Laura ' dipinta in cart per
opera di llil arti 1a vero e propri , tori amcnte e i tito e legato a Petrarca da un
Yincolo di ami izia. Il pa acrgio dcl ritra.tt dallo ' 1atuto m taforic di irnulacro
mentale a quello lctt rale di opera d"artc w1111ovazione eh re ter bbc ' icruifica-
tfra, n Ila toria della topica. an h e il pittor non ave - ' C un nome; ancora pi de-
ci iva ri ulta. per. perch a11rib1, I'effiai d Irarnata a un arti ta identificabil .
imone Jlartini ne (128-t-1' H). i t rapporti on il po ta -ono do umcntati.
Cna nella toria po tica delle rappre entazioni dell"ogaetto amato coincid
co con una Yolta n Ila della celebrazione po ti a dcl ritratto e degli artisti.
Per h que to doppio pa aacrio i compie cou P trruca? Prima di tentare unari po-
ta. torniamo ai du onetti h . econdo Va ari, re ero a imone quella fama che
non avrebbe mai potuto ottener on tutte r op re ue m:
Per mirar Polideto a prorn fi o
con
11
li altri h ebber fama di quell'arte
miff anni. non vedrian la minor parte
de la belt che m a,e il or conqui o.
J.la certo i.I mio imon fu in paraci.i o
onde questa gentil donna i parte:
iYi la ,-ide. et la 1itra e in carte
per far fed qua gi del uo bel vi o.
L'opra fu ben di quelle che nel cielo
' i ponno ima!!inar. non qui tTa noi.
ove Je m mbra fanno a I" alma \'CIO.
Corte ia re: n la potea far poi
eh fu di ce o a pro\'a:r caldo et gielo.
et del mortaJ. entiron gli orchi uoi. (Rv/L VII)
Quando giun e a imon ralto ron etto
eh' a mio 110111 gli po e in man lo tilc.
. ave e dato a r opera g nti le
colla figUl'a vo e cd intcll cto.
di o pir molti mi gombrava il p tto,
cl](' ci eh altri pi caro. a m fan vile:
129 Cfr. \A ARI 1966-1 987 [l'ite 1368). 1. p. 192.
per clic n vista ella i mo, Lra humi]('
promet1endomi pa<" Il<' l'a petto.
la poi rh' i. vc11go a ragionar rollci.
benignamente assai par eh ma colte.
e ri spolldcr . avrs e a' detti miei.
Pigmal"ion. quanto lodar ti dei
de l' irnagine tua. se mili voh
nave ti quel ch"i ' ol una vorrei. (ivi. LXXVIII)
Il dittico i pre enta com unit internamente variata, ma bilanciata e chiu a
come un cerchio: la ua coe ion tabilita da elementi formali (mille
130
imon.
opra ecc.) e dall' organizzazion del di cor o, con I' ordio tempora! di LXXVIIl
che torna sul gesto creativo di 'imone lo ri on egna. in prute. al poeta, i pirntore
innamorato di front al ritratto. Al tempo te o. i due fraumenta ono parte di un
in ieme pi ampi , il Can::.oniere. trama di ritratti tentati e e LXXVII in
particolare raccoglie l fiJa <l ila rete laurana che abbiamo attraver ato: il veder in-
ce ant ( mill'anni ) e in iem impo ibile (non vedrian ). la b llezza che ha con-
qui tato il cuore enza rimedio (v. i:), il paradi o come luoao da cui ramata proviene
che ne piega r eccezionalit. r oppo izi ne e l'intreccio tra ci lo e terra: inoltre ci che
il ritratto rappresenta, il bel i O (da intend re in o come ineddoche), ri petta il
taalio de crittivo pi frequente nel Canzoniere (occhi-vi o-chiome) . Il onetto net-
tamente dominato dall' e perienza vi i apre uppo ta dal rappre entare, nell'oppo i-
zione tra un veder paradi iaco, dal quale muoy la po ibilit di ritrarre Laura.
un vedere- ntirc tcrr no J:H. La di tru1za pazial tra I' i,i dove all'arti ta' dato
di ' 'edcr ritrarre e il qua gi della vita umana ' uperata la imone i\lartini.
in un'irnpr -a cono citiYa r atirn e cezionale. Lantite i tra cielo e tena, tra la
visione diretta e quella mediata dai en i, i riflette in qu ila tra imon e
11
li arti ti
ru1Lichi. t'condo la Bettarini , r a' entura oltr mondrum d l pittar dc ritta ai \'V. -8
i piega sernpli ernente come una ersione amplif ata narrativa del
11
i evo
topos nudiolatino per cui la clonJla cru1tata un capolavoro prodotto dalle d1
Dio; per la maggior parti" dei commentat01i antichi e da ta
G lli a Erwin Panof kv la alita dell arti ta al i lo-ipenuaruo fomra mvece m chia-
v platonica. la ua di ima<Ti.Irnr - formru nella mente' o
secoudo la ra immagin ' (Bettmini)
132
- l'immaaine p rfe1ta del modello, hdea di
130 Cfr. /!1fCCCIX, v. 7. dove mille volte co111p11re in riferimento a u11 ttntarirn di ritratto verbal
131 Cfr. BACCIO 1979, pp. 321-:1:1-t.
132 Cfr. anche RifL ' XJJJ , w. 61-62. dovr imaginar ignifiea 'dar un inunacri 11e di: (comr riuru nel
' I d" l d" Plato 1 da pme di Pcrrarca cfr. FE:-- 1.1 2003
di rapre. Pii iare con paro! ); per 11 eonoscrnza 1 a cune opcre 1 ' \
(' Bf,ltTONE 2008, p. H .
55
Laura. Le du pr pctliYe non appai no. di fatl . in ompatibili: i ovrapp ncrono
11
ila m nzi n dcl paradi ono ::.o tenut dal co11fro11to con altri luocrhi d I
an::.oniere. 11 percor:o d lrartista e della ua opera dal cielo alla terra ' mod llat
11
qn llo compiuto da Limra alla na eita, rievocato al v. 6 e in molti altri testi come
11
l pla11cl11' di . L \ YIU. con formulazione molto ,.i ina al v. 8 ( On, t rra - fatto
il uo bel ,i - ./eh ::.olea fard l ci l I et del bl."n di lass fede fra noi: [w. :H-36)).
' o tante nei Rtf' del r to la mhinazion di ciel t rra ( \'Ol e/ m . trar qua uit
quanto lass potea? [ .LL\. "" --! ]), che pu liY ntarc in a tro indi. soluhilr ( l'
,i li in terra mwelici e :-.tumi/ t celesti b llezz al mondo ole [CL\' L ,., . 1-2) : [ ... ]
colei che qui fu mia/ donna. or in cielo. et anchor par qui ia./ rt \iHL <'l et
yada. t ami t piri > [ ; 'L:. ' X\1.' -. '.....--) ). lla conti.unita di quc to mcnimento
e mt uta tutta la conda quartina di XXYll: il vettore dcli' azione e cl I sen o i
diriae prima \'ero l'alto. dalla t rra al ci lo ( fu in I aradi o). quindi dal ci .lo alla
terra ( cond [ ... ] i I arte>) . poi orizz ntalmem n Ila dim n ione iperurania ( ci\i > ).
e in.fin di nuo\"O a , nd r . in terra (equa gi>).
L'i.rnff o di Lama n l mondo pre uppon lo ' t S' pa . acrgio. dalricl a a una
ua mbra o ima crine. eh la creazi n arti ti a. n Ila fatti . pe i il ritra t1 o. rurn va
rip t . Ch i Yoglian o meno ITT.1ire i comrn ntatori eh . ottolin ano la matri-
ce filo ofica d I on tto. r ta indubbio che la n zione del rapp 110 tra opera e
modello q1 rille a n n ' fondata n un imitazi n di tipo naturali tico. l 'Onetto
, \1. eh ' tato pi \'Olt me o u1 relazione e n il dittico
1
:
1
:i. Berton ha propo to di
rintracciar una Y ra e propria pr me a p ulativa fondamentale p r L xYII: la
ricerca della cforma v ra> n i Yolti d Ile altr cl nn (<in altrni>) fiaur rehbc la for-
mazi n di mffui m ntale a partir da una '>Orta di ricordo rombinat rio, olleci-
tato riani,-ato dalla \i. ta di altr b Il zz . un pro e o int li ttual e i11mrn11inati\"O
analo110 a quello p rim ntato da imone t.li. La co..,t ruzione. nella rn nte.
I leone tto di qu lla bellezza inimitabile. r nderel b po ibile la rappre. cntazion
n aata alla pura imitazione dal natural . Pi e min nt mi embra la 1<'11 ura della
Bertolani. h tiene conto della tradizion biblica e pani tica e sottolinea lo 8fatuto di
fictio condi'i. o dal!' opra> di irnone e i1 ieme il . u I 11am n tm.i11t111z1one v1.1-
va up rior all'umano. In i lo il piuorr ha 'i. to la,, ra imma ine di Laura. l'idea
(<forma>) e non rid lo. e ha realjzzato un ritratto imp il)il in terra, dove il
orpo na conde r anima ott 1rnd la vi ta. , ilo tudio d I modello. gli orchi mortali
. ono o tacolati non dal \' lo> lett ral con il qual Laura i pr (cfr. ' X\'lll).
ma dal Yelo metaf rico. la b ila ve ta> indo ata al mom nt della na cita.
Cfr. Ff,112003. pp. 1 .;39_ B1 w101...-1..'1 200:J. pp. 167-18-+. Cm.!. 1 200;'}.
1:3-+ 'i1110111 ( ... ]balza a!!'ilnw111< in Paradi'o prrrh ha portato fino a compim 1110. drn1ro la 111i111t'. i arti tira.
c1url perC'ONJ rlw il poeta rra riuci10 in 1111 lampo ( ... ] a ,intr1izzare in wrra. nclla Jll('JJU'. quando awrn
dall1 1ant fornii' 1rm1w donn s lw la 1era forma d<'lrunic11 Mia donna ( B1.RTO'\f, 2008. p. 62). Pl'r
1111 altra rrc:11111 lrttura dri d111 001w11i l'fr. BAJITl !iCJJff 2007.
:-6
nch a un mp11to meram nl<' quantitativo, apparr vident che prota11oni ta
d I onetto L VII non l'amata. mar arti ta con la ua 01 rra. per la qual<' il ve-
ci re r 11t_ralc 11011 111<'110 di qua11t? I ia p r l'arn r rantato nei Rvf ignifi ativa-
m<'nte, rH li 1ncunal)O)o del anzolllere annotat e illu trato da ntonio Grifo (1470)
il dittico non r ac ompaanat da u11' irnma
11
i11 di Laura o del uo ritratto. ma da una
d ppia raf'Ggurazi n ciel pittore
1
:
1
;;. Quanto al p La. abbraccia p r int ro il r piro
di un '011 tt intro petti o-narrativo t:l, ma. al uo int mo. riman in di part .
ri rrvanclosi il ricono ccnt mi lo pazio della p rifra i be in lohandolo
0
can llandolo in quanto tale. de icrna la donna comr ianora cl I uo cuor (\'. ;. ).
Ben altro ruolo ricopr inv e nel on tto L ' \'Hl. dominato dalJ u r azioni
di p ttatore-amante davanti alr <op ra 11entil > dipinta da 'imon
137
La riOe ion
inguadra I con cguenz dell'operazione rievocata in L Il. con uno arto t rn-
poral<" e ano louic . dal pa alo cl Ila creazione (Quando criunse>) al pr ent
dei o piri. dal \ide> aut ntico d lrintuizion on citirn alla \i. ta> incrannevol
d I ritratto. ll po e ivo mio. eh n l prim on tt ra aff lt110 ament ciaco
al nome dell arti ta
1
:
18
vif'n ri oll alo nella pi ampia f rmulazion d I . 2. a
ttolin ar come l"alta i I irazi n .. ( concett >
1
:
19
). con la m diazione d 1 po ta (<a
mio llOill > ). abbia pint i] pittor a lltrapr nd r l'e e uzi n cl 1 dis !ffiO (culi
po in man lo tilc> ). Il coimolaim nto d Jrio i pu intend r com rYazion
attenta part ipe di un' impre ad ll'arte o com v ra pr pria committ nza, om
n I a od lla miniatura, probahilm nte co va. per il hrcrilio A:mhro ian . L'io tra-
m o dai pronomi (mi > a me>, e- mi. ci. cm. ci.) ' ppo' tO ad caltri> (v.
6) a Piamalion . in un antite i hc ripr nd qu lla tra imon e ali arti ti antichi
(altri [L \11, v. 2]) rafforza il Yincolo r atfro e di id ntit tra il pitt r e il
poeta. Il ra conto cl l clic locro muto o impo ibile tra amante ritratto i int rrompe
nell"ultima t rzina
1
"'
0
eh i rivola dir ttament allo , ultor Pi!!Illali n . n J cui
n me i chiud . ul pian d 1 mit il erclo lirico aperto da Poli I to. L'avY r ari-
va del ' ' 9 con un parali li mo evidente ri p tto alla e onda quartina di L xnt
defin ce i limiti d Ila rappre ntazion . fru trant . in quant muta inanimata.
ri p tto al ri ultato lt nel primo on tto. 'a u a impli ita n l rimpiant h
13f [ ... ] 1\1 cir1waging IH'arded likl'11 es. labrlll'd imo11'. of thr painter him lf (TR.u>r 200 I. p. 99 <' n. l:H).
Cfr. anche \hn11\J 1'\011 1990. pp. '101-102e183. e infra, .' I.o .
136 bo una ratccroria di Ctt ;i\ 2002.
13 . 'fr. B1 K HN :W08. p. 6:3: e ( ... ] fuori d1l C'an:.oniere ai alla la po-sihilit_ di una '>toria (O?nato ). [ ]
!' d ntro il c111zoniere si proponi' conw 1eorico nffubulant . in' n.i cli omaurrro. del proce o di numr-1::
olorirn t' ftnomrnologia (X 1), ptrroroo 1 risnllaii (LXX\'U). effett i (L:X'\rlll ) dell'iter mimetico.
138 c\110 ' imo11: le pcr o11r urni IH' dilrttc dir no tn'. ( ... ] ( E. t 11 oo 1533. CXr).
1:39 Conr!'l10 se ond i pu rendere 1011 '. nhlimr i-pirnzionc' 11111 pir prt>Ci amentc t'orri>pomle Il
,l'dt(I ( Pl.TRAJl( I )<)9(>a, p . .+0-+).
1-+0 U ritrnllo Laurn co11 un b ne1ol e pi cfr. rchabito cli R1f ;xm. '" 75, t' .L:'\.':'\J.
' " 14 ( in viola).
l"immagin non .ia la donna \Wa mbra riY lta alrarle i11 ruant o lai<' pi che
al pittor r ui tra la d lusione ri p tto alra. p tlalirn e allo . talo di grazia della
cr azion arti tica, alte m nt piritualc ma i11capac d infondere toce cd i11tellecto
alle creatur create (B ttarini)HI. B rtone rilt>ni ll\'CC rin oercnza tra reloaio i
imone (e cl I ritratto) e la Yalutazi n cl l rilratt t o. propone di colleuar
il v. 6 al rimpiam [ ... ] prorncato dalla mancanza di recipr cit dialogi a. che
farebb di pr zzarc [al p ta] qu i d . i<l ri m rament -en uali e \isiYi [ ... J eh ali
altri nY c appr zzan > (Berton 2008. p .. O). L due lettur I r . uppongou du
con id razio1 ompl irnm nte dinr del tema: runa \' d n l ritratto la fiuura
p r eccelJenza d Il' illusione n ual . di quant nella Yita ' nmo mute\'ole: !"altra
lo con idera un uperam nto d Ha cupiditas tidencH (ivi. p. 6 ) .. ublimata nel
ielo delle i lee. un pr grc. o cono itirn <lopo la v lta piritualizzaute
da antacrata (R1f L ' X-LXXIII). La ontrad<lizi n na l'ammirazi n I r r opra
di imon e la cl lu i ne p r rin uffi ienza ontolocri a d 1 ritratt i ri oh e Il Ila 1 -
cri a interna d 1 dti o alla luce d ila di tinzi n . propo ta n l inquec nt . na llll
netto plat nico (L ' X\'II) e uno ari tot li o (L ' XYIIJ). fondati u due diwr
nozioni di mimesis. una om ono c nza rir r cluzi n d Irldea. una com imita-
zi n della realt. ri r a di una ornicrlianza Yi ina airillu ione. Inoltr n I rcondo
onetto mbra arrir la memoria di antichi t reotipi ecfra ti i. in I rimo luocro il
topos della man anza d Jla voc com ol dif t1o dell 'iimuagin 1-12.
Lu o del I ic cl lrart . ben radi ato n l t rr no metafori o dri Rerum f'ul-
aarium Fragmenta in rif rimento ai imula ri immacrinari di Laura <' al tentativo
cli de crinrn in par I la bellezza. n l ditti o i rinnorn p r la pr nza d I pittor
e de-ima in m do pr ci o la riproduzion arti lica di Lma embianza umana indi-
'iduale. Il n me la ficrura di imon jlartini ono intr d tti com fulcro li una
compl a mediazi n liri a tra il po ta. l"op<'ra e il m dello. mediazion eh<' tra for-
ma. una i r t rica anti a (fa -unzi n di m taf r figurative per I arlarr della
nttura) m w1 luocro prfrileaiato della rifl ion ull'impo ibilit di rapprc entar .
u to pa agcrio i mpi all"interno di un orO'ani mo ofi ticat (il <litti o). a sua
volta pa11e di una t ria e cli un proa tto unitario. eh compren altn liirurc altre
1 i I ulla 1-0mraddi1iom ira i dur 'oneui rfr anchr Bi::R101 ,, >oo;
11
f-' ') ( [ J 7 - l
1
1 1 1 l
1
. . - " -._ .. . rn u I J "('IO,!( un 1 n rat
o martIDJano. dunq11r 1l ,c"110 lig11ra1irn. dal rigorr drlla 111inw,i rhc poi 1ondurc in\'ecc a"li <''>ili d I ,onrtto ?8 ).
200'.. PP 2.19-222. e IP os rYazioni clw Bernardino Dani rllo dedica a L, :X\ lii. int e,o ronH l'orrrt
rhp tto
3
li rrcr,,11logia1i' i r 'tili-.tici di LXX\ Il: c, \crono'>i il po[rta] d'r,.,cr nel prPcrdtntc 011[1110] (la
11
'.
1111
Donna i11sic1111 r.on la rccellrnza drI Piuor 1011111w1ulando) per a1 vr111 ura pii'1 ullo oo li10, dw 11011
gli 1
1
c
0
11
nwniva .(prr la <111:11ros1111 on[ctto] lii' nniva ad <s.,cn 11. sni pi gonfio). volle in <ftH' '>ltJ prl' '>f' llH' (1 li "(
pur e e a mede ima nral<rra rompo to) emendar i( ... ] {01\111..1..0 J.j.+ 1. c. 621').
1-+2 c\ ei noi '0lll'lli italiani P<rrarrn rlo!!io' I p'tt , 1 " \I [ J
J . . ., a 1 11ra e 1 11110111 art1111 ... in l nn1111 d1 mat1 ahhn,tanza
(
':<'
1
11.ar:1e111.r e ai luo,,111 co1111111i d1ll anwlo!!ia da sica rnm1 <'l'ltat lprlles {'i uprri \pell e)[ ... ] e l'llllus l'il'C'ltfPS
\O li C'lll' \J\ono) ( ... ]: le formule IOfJichr dir in Je<I r '
di, i . cli . , . . ,'r
1 0 1
or,, un po meno W>1mHr d1 q11111110 pm 11011 fossl'ro
nate
un '>1.'rnlo dopo. ma non e 11 ca o d1 rrnum di ri1a,an1c ver auiwdini rriridw ( B\\l'IHl.L
-+ pp .... .
immagini. altri ritraiti ai quali]' Opra di .'itnOrt( re litui e i] rilie\O che. contem-
. l
pora,neamentr, 1H' 1w<vc .
I<.. tr1npo di tornar< alla domanda da rni siamo partiti . pieaarc l'introdu-
zione dcl ri1ra110 dipinto ronH' tema portico ha ta la probabik e. i. trnza tori ca di
una miniatura di Laura. rliP Petrarca avr bbP commi ionalo a ' imonr intorno al
t:336. celebrandolo poi in una coppia di otwtti tH? Qu ta innO\azi nr arebbe
cenamenle im1 n abile nza alcune rnlt materiali e l tterari le11at al nome
di P trarca: innanzitutto la co'no cnza dir tta. ad Avianon . di e p rienz fonda-
mrntali per la del ritratto individuai i.i:; r l'aurnzi ne. tant a i t matica
e di cu.sa quanto indubbia. per le arti figurativeli b. ma anchr i"<'m rgere di una
coscienza 11ma11i stica. e il profondo intere.: p r IC' biografi I immaO'ini <leali
illu tri. Prtrarca r forsr il primo a ri coprirr il gioco di p cclii fra ritratti cicali
uomini illuslri. elogi. hiocr rafi e. opere tori h raccolt e emplari >
1
P. In que ta
direzionr i muornno lr arcromeutazioni r ili convincenti. hr p r ri pondono a
una ola part della domanda. eludend le po. ibili ra!!ioni del ritratt m t ma
lirico. racrioni int ernr all a poe ia e aJla toria d i topoi. 'ertam nt i tr vato1i e i
no tri I oeti d I Durcrn to c no e vano l rie di ritratti non m taf rici. com i miti
di Pi amalione <' di La od ami a e la ,-icenda d Ila tatua di Y eut narrata nel Tristan
et di Thomas. ma. 11 lla poe ia deJI origini. l'allu ion al ritratto n Ila
materialit si in. Nisre qua i empre. p r via di imilitudinc. in un di coro ulrim-
magine int eriore. Una : pinta importante " r o l'e t riorizzazion cl l imulacro
\W o il concretarsi della fiaura in ritratto potrebbe e er leaata alla m diazion
dant ca .. u basi lr ntini an . in particolar al Dant della fila .\'ol'a del Purgato-
rio .. - I capitolo 23 [\XXIV] della lita .\"oca. Dante. p n ando a Beatri . di eana
uno anaelo li rrt ta\olett :
ln q11rllo giorno uel quale si compira l"anno che qu ta doruia ra fatta d li citta-
dini di 'itn etrrna. io mi se<lra in parte nr la qual , ri cordandomi di lri. di canava
uno angelo l'>Opra crrte tarolette: e mcntrr io lo di rgnarn, rol i li orchi e vidi lungo
mc uo111ir a li quali si conwnia di fare onor . E' riguardavano quello che io farea:
[2] e;,( rnndo che me fu dctt poi. clii rano ui alquanto anzi che i m n ac
corgr' c. Quando li vidi. mi lrrni. e ,aiutando loro di:;:.i: < Itri era te t m co. per
1-+:l \ panirr dullu ro1h1u1a1i1uu chr )p i111111a.,i11i ,i dirndnno 1wlrultima pane del Ca11::.011ien'. \luria
Bmolani hu in,ii.tir o ,ulJ u 1<111rnli1I drl prohlt11111 d111'i111mugi 111 nt'lla Ji Pem1m1 ( B1RTOl\\I :WO<J. P
127): ron 1'11pprossi mar,i drlla 'isi n111 !' ddl' ico11a , gli ci cloli ,i fo11110 da pane.
I H 111111 111iniat11ru o. fon.r , 1111 di segno arquarrllalo (COYI J'\I I <>80). rom111 i"io11ato ' crosi111ilrn11111 primn tiri
1:1:36. r in ogni rn'o 11011 pi t1 turcli cl rl J:l.+:l (B<'t1arini. comm11110 ad luc. in l'F.T1t1R 1 200;)).
H.) [ ... J nl1 n 1r-.1i 111011imw imponanti drll'i11cli11n.,[0111 11\ ig110111,1 wr-o un ri1n1110 ricouo,rihilt csitono
{C1 n.1.'\to\O 1973. p. I 0-+ I). Cfr. C1 1 t.L.'\l O\O 2000. p. :H:t
1-+6 C:fr. al111enn B1 .c; 10 19?<>. Co"\n 1 JQ80. I hRoT l<l83. lh r11\l tQ8.+. C1 e.no )QQt. PP 81-88. TRiPP 2001.
J>o,11nrn 200:3. pp. 25-29. Do 1TO :.WO-+. BF.RTOl.l'\I 200.j. pp. 128- 1:!6.
1-i? C1. "' 200:3. p. 10'.i.
perha,a>. [ ] Onde partiti cost oro. ritornai mi a la mi a opera. <' io' del di riruur
figure far endo c'. mi .' enne tu10 di parolr. qua i per
nonilc. e. nwre a lr qualr rrano Ycnu11 a llH':1 d1 s-, 1 all ora
0111
,
110
.
lo quale comincia: Era 1e1111ta [ ... ] "'
8
Tra il di ano la ompo-izion d l netto ' I m eri '(' r i11t . l :\ .. nto degli uomini
on r ,. li. ed ' opraltuno in ri p la a l r no oncrp111 1 ,rr i. nella loro
doppiar dazion . dichiarata mment ata e m Lal H<l. La , crittura. pur
dmant r uzion del di uno ( cfa cc n I ci> ) r gi tra fi ., a di, r am nte la
wnuta di B atri n Ua cm nte> (m m ria) di Dante e i] uo tradur i. aire t rno. in
na i coli a n I primo anniYer ario della morte di B atric e. nella
d inunediatamrnt il ntr ,er::. pi di J Il a d nna ntile.
ntrale una o tituzi n d Jr amata ..,i ri' eia impo . . ihile e rolpr-
rnle: an he Dant non r alizza un ritrat1 di B a tric . r azi 11 di di ... !!Ilare f!!urc
dan!!eli appar . dunqu . fonem nt I !!ata alla e n-. ap ml zz d Ira-.-. rnza di lri
al ri rd (ricordandomi di I i ). ui ran nzi n tute p r rinrn ion drlla
m m . in una parte> che' m1 Ju !! d Ila m m ria-_ da I an d I ri ord d U" ama-
ta a un anno di di tanza daUa ua alita al i lo. ed ' il p ta r .... a compier , il
!! d ffarti-.ta
151
. In Petrar a imer ., un wro e pr pri ritratt . dipinto da w1
re r mirabil che ramant d id r r bb - lo ... miri I arlar . Tanto nd-
1 -. che nel on no L. TII ' d birn la mr PI izi n rra la terra
1 n nrnn . ri ordano - ri , n . e il e J d J am 1 ri i <l n nella loro
_ _ pedi .na. p ro una dif.t r nza tamia! tra J du I -IZI m. m quanto
il nrran di Laura ' un rierano in \ira d rid a di Laura. n n re
- . I ,. rar.n ta la d _,. com .mplar p r p e r alizzarc r I ra1--: ramrelo di
lll\ d1 roato m mon di B acri . la cui anima ' in Para<li . non pi1
m d ,. l df'I c rpo. ff altro canto. ... i !?uarda alla t ria im ma del Can-
=oniere. aff alt zza d l dittic Laura e anc ra ' iYa. ma ha ominriat ad ... um r i
li eh J no propri a I anir dalle ranz ni L\.. -LXXJll.
duz1?ne di un terz el m nt . r art i ta. rra il p ta-amante la rappr -
n d 11 Og!! tto anJato. ro t itui. ce un ambiam nt di rili , .. ma la u-
!! n n mar riale d U tarnl tt > d. nt eh e la on r t zza fi ira d I a to di
iti dalr cl . da O _Roben.i;, ' rrondo il tNo Bari.i ( \ ucmrR1 J 980 (/ ;\)). 111 adonando il ti tolo r In
m arura pmpo,11 da Gorni (AuG111rn1 19<>6 [I \ b]).
Hfl Du .. umi11ria111r111i ronde tina. Il I d. ' . . . . .
In. . l"' .l ZIOIH'.
11
t paro t' 1 Gon11 . n>""llnamentr woa limu 1mnna e es
e ta 11arm11\a , J. p. 193). r
J.;o fr il nus..'lo d1 lellura di Comi. in /"(\'b. p. 2
69
1: 1 Pi appmfo11di11 riJl1 -ior ,
11
mie I I I U
1
. 1- O rapno O ( t' a / 1/a \ om (' uJ llf'ltO LJ'([ /' n11/a ho r:tff( lto in Pf I 2010.
I - tamlo al Pcrp/11111. il ritratto f . . . J' . .
Il; 7iom r ro rr l e . d I li ('()Il( "llllO I ' lpuno prr UC'(' o fOlbOlare il poeta Out'' Ul d ,(I
-ulrimma"in . - a uon a '.'Ollf'ltO L\ \\li. mnrcandorw. ri-prno a L \ nu il l'anllll'rt' di rifle--ionr pura'
o
cU CTJl arr. int<rTotto e ripr o. potrr bb ro rappr utar un an Il non econdario
della alrrra clr<' por1a dalla fi (f ura nr l cuore al ritrat1o di La11ra. na conferma a
po t ri ri \' enr dalla toria quattro-cinqurrrnte Ta d J lopos. dove i verifica una
compie. a rinrg ziazione tra r cpi odi da11tc co lo h ma d finito da Petrar a:
protagoni la ci el iaO' i ultraterreno attribuito a 'imon I o non' r ar-
1i-ta. ma il po ta- pitt re. eh di O' na. e m Dante. in prima p r ona. La parizion
dell" arti 1' ta dall a :crna d l ritratt dcl rrnina una nuova ri convrr ion I I ritrarr >
' U w1 pi ano compi tamrnt m taf rico: 0' 1ticlato dalla pcrf tta ambiva! nza di e ti-
le e di ccart . il p ta abbandona I lavol tte e di eana in v r i. con I paro-
le.
1
cJl'int rprr tazion pittorica dcll'cpi odio dante co propo ta da Dante Gahriel
Ro etti (Dante drawing an Angel 011 lit > nnil'ersary of Bealrice's Death. 18- 3.
Oxford. A hmolean eum). il volto di Dante ' un autoritratto d Jr arti ta. e dun-
que rappr rnt a. letteralmente. il volto di un poeta e di un pittore: ad ac ntuare
il ri pe chi amcnt o n I proprio alt er-e()' . al po to d O'li uomini on rrYoli Ro etti
dipinac du u mini e una donna h ha i tratti d Ila moali e Elizal> th
L pi an trmati co icono!!ra6 o. n lla cena deUa fi'ta .\oca i intrec iano la
Jeag nda di an Luca eh avr bb ritratto la Y r!!ine e il motivo cl lr amante eh
ritra l' amata . . i pcwi alla toria di Ap Il e e Panca pe o al ritratto di le andro
de Medici di Pontormo (1334. Filadclfa. John G. Johnson 'ollecti n. Philadclphia
1u eum of Art ), n I quale il giovan duca rappre entato n li" atto di cli ernare
rinllllaO'i n di una donna. probabilm nt Tadd a :\Ial p1c. alla qual il ritratto
ra d tinato
1
:;.. .
:\la il ruolo di Dante non fu e qui . . \lla ommedia i de, un c ntributo fonda-
menta! p r la toria d lla el brazion po tica <leali arti'ti i.;:; _ Il dibattito ul carat-
ter ultural d Ila pittura (Conti) t tirn niat dai" i dcl Pwgatorio in ui r f-
funera dura ta dr ll a gl ria t rrena e d l primat Lllllfil10 i prim attraver le f!mr
dei mini atori dcri i da Gubbio e Franco Boloane . d i pitt ri Cirnahu Giotto
(Xl). Propri o i ra11ti ' - H d 1la canti ca pi umana, dO\e rart tri nfa onta la
ua uperhi a, gi 11 I inqu nto vengono indi al.i ome la prin ipal font di
razione prr R1:(LX ' Vll-LXXVlll. iovan Batt' ta Gelli, nella ta cl Il u Le::.wm
petrar hesche ( 1:).+7-.+9). dedicata preci am nt ai due netti ul ritratto di Lama.
int fJ r la le terzine dant e:che eh de cri' n uli e mpi di umilt iutauliari nella
153 Cfr. Sl R I bE 1971. I, m1. 38, i 2A. -t2B r li , ta\'Olt' :) I. 2".' e B\Jl.A.\M..r t' \lcL1rc11u' P 89.
154 PPr la lrgaruda drll'!'vn11 "tli , 1a Luca pit1orr, dr. 81ll1'01 \\I 2005. p. 162 r il tommrnlo di Corni i11 I .\'b. ml
I " "r / 15-0 80 , .. \ ' t 1"'- . TE"nRc 1CJ
7
5 l'P 62-65 Lr\cEour..
oc. ul quadro di Po11t or111 0 e r. 1/e ;:i , p. r 1/e .> l . P . .
1981.1. pp. 5. 22L 228-229. ,'Tln:m.K.E 1985, Co;,11\11G\1 199-t. pp. 22222'.>. Ln tN!l d 111111 frmma cui fa
C'Cllll O \'a.,ari r pi1 'i, ihilt 1wllu ropiu del ri1ra110 l"(lll,(' I'\ lita li Li-honn.
1 5 Cfr. Pom11111 2007. pp. 5 .. t' Co,11 t 979. pp. I 63- 16-t. Prr ru1i,rn t fr. _Par \ lii .. " 7 -'.8 _(
operando a r1u1i, t11/ d1'11 l'abi to dr r artl' ha 111 1111 che trrmn) . .\\ lJJ. \, 51 t' \ \ \ . \ , ;3.), fuoglu t' llUU da \ ardu
n Il a /,ezionr ( 1517) d()\ (',.i ('or11 rr wnt n il ,.onr llo mid1da11rioh,10 .\on ha l"ollimo arlislo alrn11 conretto (\ iRcm
19 3. p. 1:327).
roccia com traorclinario intetico elogio cli w1"opcra d'ar1e
1
;;(1. [] 111odcllo cli questi
,. r i. fore ispirati ai pulpiti di ola e Cio,anni Pi ano. influenza tutta la uc e-
fra tradizion e fra ti ca, compre a la po ic u l ri1 ratto. he ne condivide formule
r topoi: la arandczza dell"opera defota dalla ua irrip tibilit. a oluta per l'arte e
perfino per la natura ( [ ... ] che non pur Policleto/ ma la natura l avrebbe corno
[Puru X. ''' 32-33]), feccezionalit onnmana d I ri ultato (qui onumana alla
lettera - in quanto dicina -. altrove per con umata ip rbolc) e la v rita della rappr -
entazione. che induce a r derla dotata di \'ta di parola (dinanzi a noi pareva .
,, race/ quivi intaaliato in un atto oa,e./ eh non embiarn ima ai ne che tace [' .
o .
3. -39]: imato i aria cll di e . Ace.' [v. -0] ) e coinYolge uell"i1lu ione anche
en i di,er i dalla vi ta (n-. 9-60). Il le ico che n ll"ecfra i eo-nala J"iutr1Tento
dell'artefice. la tra ia f i ad l procedimento arti tico. ri pecchia un retroterra me-
taforico intricato ompo ito. che ci ormai familiar . La Veraine imaainata.
io' rappre entata in mmma ine. e porta imprc a la ua ri po ta alrangclo come
in cera i ugaella (v. -5): la raffgmazion cli Maria drn1qu d ignata con
lo te o verbo. imauinar( ). u ato altroYe per indi are la pro luziouc del . imulacro
nella mente
157
revidenza della parola nella muta mat rialit ciel marmo viene
e pre a con W1a imilitudine di norma riferita alla fiaura nel cuor .
Xel canto XII la d crizione deali e empi di uperbia pw1ita figurati ulla parete
oraanizzata; con !!rande preci ione architettonico-acro tica ( hia acci ), dall'anafora
di edea (n '. 2 -36) poi dall"apo trof (O, con ripre e di vf'dea>>) rivolta ad
alcuni dei per onaaai raffiamati ( \\'. 3 --8)
158
e recfra i delle immagini ' ul pavimen-
to ' chiu a da un elogio deir opera: Qual di penn 1 fu mae tro o di tiJe/ che ritrae e
!"ombre tratti ch.ivi/ mirar farieno uno inaef!110 ottile? I Morti li morti e i vivi par -
an vivi:/ non 'id mei di me chi "ide il v ro./ quant"io calcai. fin che chinalo ai vi ("'
6--69)
159
. In que ti ver i i 1icono cono lo til . oYvero lo trwnento pn di egnare,
e il verbo ritrarre eh abbiamo incontrato ri p ttivamente nel econdo f' nel primo
L"? crr. infra .. 1.:- e PoMMllill 200?. pp. 12-13. Per una bibliocrrafia aggiornata purg111orialr ri1wio
a \1:;:-TUR1 e faRNE-rn 200-t. ma rgnalo in parcolare le illuminanti o crvazion.i di R\1101.11\1 200:t pp. 17.1- 198 e
Or. LALDE 200.5. pp. 110-113.
1.j? Que ta amhivalrnza. come to, e i te a11chr in P trarca. ci\rl Dante della ommedia la parola
image/imagolimauine [ .. . ] per lo pi1 riforita alfasprtto di una per ona [ ... ] \la nelle Rime rlantrsthr 11011111a11-
cano r empi di w1 imaginar pit1 qui i1am mc corte e. comr immacrim <l<lla memoria a moro a. Qur 10 11cm toulir
che sia rii Petrarca !"aver fondato 11lri111magine rili ula" cio fortcmcrnc oggertivizzaLa r st1bor lin:1ia
alla fe11omenologia psicologica d. amore. un nu leo lirico-patetico fondamr11tale [ ... ] (B\cc10 1970, pp. 328-
.. La riduzione del ritrailo a uperlicic riflr a, ombra drlla r alt. scmhra da identifi arr proprio nella parola
altr?1e con ir1. i Lenza pc-r indicar quello di{' di Laura ;,i imprime nell'animo drl poeta [ad es. in
R1fL X.Xlii. w. 1.3-14: XCIV. vv. 1-2: CXVI. vv. 13-H] (ivi . p. :332). Quc to po1rebhr rr11drrr corno iu parlr
della preferenza clic la tradizionr succe iva a. egna a cima"ine in rifPri111c1110 al imulacro inlt-riorr .
1:)8 l n ult riorr" p dirnte dci1liro impiPuato per li" inunagini fi11I pavimento ( ... [P111g Xli. 1v.
49-63]).
1:-9 Qui ti 1er i !>OllO dtati ,,,.( <"OIDm!'nto di Dan.iello al ('anzoniere ( 0.\NIEtLO 1.541. c. 158,) a (HOIJO ilo di ll1f
C. '(,Vili. '
62
oJH'.tlo .di Laura; in Petrar a i <lue termini acqui tano per ontorni pi
Jl CUL per I assoc1az1onc on man al V. 2 cli J . nr e per r u o cli ritrane neu a -
cezioue pi tarda<' specifica di rappre ntar una fi,,.ura umana". La dc crizion vera
f' propria d gli altorili vi del canto X ( vv .. 34-93) incorniciata da due notazioni che
logiano l'opera ( v . :32-.3.3 e 94-96) . evocando tre clivcr e alterit risp uo alle po i-
bilit dell'arte teJTena (qui non i trova): l'arte antica n Ila ua mas ima e pre ione
(v. 2). la , atura (v. 33) Dio (v. 9-t). Il Lopos del vo:r: sola deest. il riferimento a Po-
licleto e r ace ntuazionc della componente oltremondana delr op ;a d" aiie 'i ritmvano
puntuaLnente nei due onct:ti pelrarche chi. que te continuit. rafforzate daali in-
confondjhiJi echi cli Pwgatorio XL' . 80-82. i ontrappone lU1 i!mificativo cai1.0 ul
piano dcl genere e dcl tema. Dal po ma acro al canzonier . dalle terzine al on tto, da
torie cli ontenuto e emplar intaaliate nel marmo a un ritratto della donna amata
dipinto in carte: tutto gue to porta da una de c1izione che i offerma uj dettagli
dell 'opera ed evoca narrazioni (e:r:empla di m11ilt e di uperbia) a una rifle ion, lirica
che non de cri ve (se non. di cor 'io. r a pett pi delJa figura dipinta) e racconta
la gene i e gli eff tti dell'opera .. non l'opera in ' o i eh v:i appai . La di tinzione
tra toria e ritsallo, trn w1a cena cli impianto naJTativo la riproduzion ratica
di Wla ::.embianza. implica. per recfra j_ una di tinzi n di modi di tecniche. Que ta
di parit potrebbe dar ra<rione. almeno in paite, della rnai!!inalit de11a componente
dc crittiva nei ver::.i c1uat1 ro-cinquecente cl dedicati al iitratto: il fatto che la pro a
coeva pc o induai con attenzione minuta ull effigi di certi peronaugi uga 1i ce.
conl mporai1 amente, che la rcfrattaiiet della lirica alla de crizione ia eia ricercaie
oprattutto nella natura chiu a e omoloaante del codi p tico po tpetrarche co.
Difformit ignificati,e i ri contrano anche nel rapporto d 1 poeta- pettator
con f imrnagine con il uo ilenzio che embra paifare. Gli o chi di Dant ono
rapiti dalla radicale novit di ci che ,, dono ( [ ... ] e to \. ibile pailare/ nov il a
noi perch qui non i trorn )- mentre qu lii di France o contemplano il ritratto n
un mozione i11t rnamente fru trata nelratte a di una parola eh non aim111 n n
gi 11ng r mai ( be11ignament a ai par che rn a colte,/: ri ponder av a d tti
miei ). Parallelamente) aff artefice divino (Colui che mai non vide co a norn) cor-
ri ponci . in Pel rar a, uu arti ta mnano, in carne d o a: a imon Maitini, pittore
contemporaneo, si ricono un 'e p ri nza creativa traordinaiia, che, attrav ro il
uperam nto dei limiti d I Yeder d l ritran m tiale, gli ha pe1me o di realiz-
zare un.op ra impossibile i11 t rra. Un pa agaio poca! per la toria cleali arti ti
p r la loria del rilrallo ,iene co illuminato dalla oYrnpp izione, n ila m m01ia
petrarche ca dell ecfras.i di Puruatorio X ed Ila 'br v toria dell'art ' dcl canto Xl
(vv. 79-8+ 94-96). prediletla da Longhi. la tr ua ompr enza. in Rtf L/X.\'11-
LX VJll d Ile carte illuminate da Franco B I ane e (Y. 8'...), di quelfartc (v.
80) .in fi1w di ero e d<'lle rime arte: carte: pa.rt (80: 8_: 84), dei topoi cfrastici
d I canto r dello tilc e del ritrarr dcl a11to j 11 d 'orpo, nello spazio int r-
nament contraddj1torio dcl dittico alla p ihilil di elogillT un arri ta del pr ente
63
attrn,er o un patrimonio codificato daJla r torica antica. Que to I ro es o potr dir i
compiuto quando. mutati i paradiomi d ll'ccc llenza, i nomi di Giotto o di Michc-
lanaelo si o tituiranno o i aflancheranno a qu lli d i !rrandi arti ti antichi.
La mediazion dant ca, nei modi di uua nou le11a emulazione, spi ga molto.
ma non tutto. L irw nzione del canz nierc. forma univ r o, fa che al. suo interno
il ritrntto di Laura, ome qual ia, i altro clem nto, abbia trn po lo un ignifi ato in
e in r lazione a tutti ali altri punti nello pazio di 366 fraomenta. Il radicamento
del dittico nella trama di apparizioni. a nze e tracce di Laura ' ribadito dal paral-
i Io che il onetto X X tabili e trn Amor i pi arandi arti ti dell'antichit:
Et ol ad lma imaaine m attegno
he t non Zeui. o Pra itele. o Fidia.
ma mialior ma tro. et di pi alto inaegno. ( vv. 9-11)
L ima!!in che on ola il poeta nella lontananza ha uno tatuto in rto. come
1ivelano le inte1pretazioni diveraenti che ne ono derivate: il fatto che ia tata letta
in come imma!tine interiore e eruita da Amor ( antaaata ), com un
rifenmento al ntratto e eruito da imone (Rico) o ancora ome la Laura reale. in
_ta upremo (Baagio). conf rma la forte continuit po tica tra
u:icarnaz10m e fanta mi di Laura. Que ta eiva di inm1agini parziaJi o in-
pazio e nel potrebbe tTOvare un mblema proprio nel-
dipmta da unon , opera d arte naanno d'amore. Fiaurn doppia e bifronte,
il ha facc . come il dittico che lo ce] bra: una rivolta al tempo e cezio-
nale dell ?ca (pas ato remoto, ingolativo). una al tempo be ' i ripete
m:anabilmente delu o dall 'op ra muta (pre ente, iterati o). L"opera
e_il di una o p nsion d l tempo mortale (di un della m nt in
cielo) e ms1eme un ogaetto e pe "t l t
. non empo umano e un uperamenlo della di per-
wne delle apparenze in un'unit intuita daU'arti ta e tradotta in un ma!!nil o ido-
una nece aria immer ione. con il ritorno in teffa, nel mondo del limite
e dell m uffc1enza. Il ritratto p ' d . dal! d .
. . i uo guru ai a terra ove 1 provano aldo et
gielo o dal cielo dove ni te '
. en e mai nuovo; e cono cenza ppme illu ione lancio
er o l'mtelle "bil il di . '
gi, VIilo e comproIDI 10ne con 1 rrore dell appruenze.
Il vedere e ar1co della t amb" ,
, . , h . e a 1gmta m quanto font di travian1 nto - anzi,
e cilo e il male del poeta-amante (Rvf L Xl , v. 8 per gli occhi h'al mio
ma i pe o gffo v 11 et quell h d d 1
. : a c e uru an o 1 or mi tmacr ) - in ieme
acce o alla condiz10ne dei beati che ' . D 100 Il C' ,
' Vttw et . anzontere e la stona d 11 amo-
160 Per la di tinzione rra occlii terni e occbi in1 , . . f N .r . . .
ocrhi no, rh' un doloro. 0 velo/ contf'ndc lor la di ;a"
e r . 0 CCLXX li. 11 -_1.3 ( [ ... ] al ror traluce:/
voi celar la vo tra luce/ prr m no ol ,, tt . i5-
18
e_ Xl_ ' vv. 5- 1 O. 1r1 particolare vv. 8-1 O ( ma puos 1 a
al De mundo di Ai1ulcio Pctrarra aJ"e o. pDeic ic m
1
<:
110
mt cri/ Wlr formati. et di miuor virtute ). lu un111iostill11
. nnota cus o 1us a i I
I influenza di A '0Slino rfr. e COPl' f'l/J 2o... nimr 0('11 ,, Vl( l'lUr (cfr. BF.RTOJ NI 2005. p. 161 ). Prr
64
re per u1i"immagi1w r la . toria della redenzione da un"iliu ione atlravef'o la pre a
di cosci.enza clH' quanto piace agli occhi brr e oano e au a di prc ato r chr
I ellezza il cli un b ll ezza, la : :era. an-
titesi di ista e visione e Tonf1tt a olo nell 1 tant cono c111vo in cui 1 attrnu J idea.
Lr110 irnile intuizione . i ha davanti aJl a cronica. ritenuta v ra immaaine' di Cri lo
e come tal e contemplata dai rom i al termine di un fatico o pell arinagaio .. 1el o-
nrtto X fil intaarna in altru i si ri fer e alle altr donn ma non i pu e eludere
dir ci ia anche un rinvio al volto dipinto da imone. idolo nel quale la ,.i ta cerca
la forma vera che potr trovare olo dopo la morte
161
Di qui finiamo per tornare,
con un acq11isto di cnso. al punto di partenza, la Vita Xova. La B rtolani ha 1iletto
il cortocircuito tra R1f VI. Paradiso XXXI, vv. 103-108 fi'Lai\'ova 29 [XL] at-
traverso la poi L emi a del
1
1i
2
: ,"e.lo com corpo mortal .. della Veronica
\'elo dal quale la no 'tra VlStone ara liberata olo nella beatitudine eterna; a que ti
aaaiurwerei il velo letterale che pi volte imped c la vi ta cl i cap Ili e deali o chi di
che tanto ha colpilo l"illustratorc d l Petrru a Queriniano
1
0:
1
. Dopo
la morte sru finalnu'nte po ibile contemplare I" icona di Latu-a. non il uo idolo:
quclrintero fugacemente intravi in e ere ol?
tempo e dalla vita. e dopo la re urrez10n dei corp1. quando l anima avra npre o il
uo bel velo l-1.
\!cl criorno in cui Dante diseana figme d'anaeli, B atrice ai una d i b ari.
Quando
0
imone dipinge i n carte. Laura ancora viva, ogg tta al tempo e al di-
venir . E il uo ritratto non ' un"i ona.
1. 5 li ritratto di Laura nei commenti quallro-cinquecentechi e nelle illuslra:::::ioni
del Canzoniere
Ci.a cuna dcll o crvazioni che i primi commentatori del _ri . nano
ritratto di Laura parla la lingua di w10 I azio e di un tempo i. n lna
la cultura dci ingoli inl erpr ti e 1 atte e di una om1nittenza o di w1 pubblico, e
- d 1 X\' I. I C - n ul ,;ianiJcato pr e o di Ionua vera('' 1-l) 161 La d1scuss1onr sulla f11nz1om e sonetto , ne o . . Il .
, . 00" B. 'JOO- C 9005 Zru1'11 'l0Q7 e Rettanm. tommc1110 ac oc 1111ora a1Jrrta (c fr. almeno f'F.WI 2 o), El\TOUl'll - :J. llE ' : . . I t
' / d 11 a b'bl' o e patn t1co mtcnr ono 1om111 rnme in PET1t1nc1 2005). Lr lelhtre pi attente all m l11cnza e mgua.,,gio 1 ic .
1 1
.
1
I' . 1. r
0
_
Il "b"l \ll I di lt luoalu flCITllrC 1c c u et aro U>O t 1"' r
auima <iuclle pit11lla1onizzanti come idea mie rg1 ' e ' a u e a 11 i;> , p ortwio
' d I la ec nd1 1po1r;.1 ma 111 orrm ra o e o p
mn co111< pos ibilr traduzione lei grrro 1 ra, proprnt rrer pei ,'
1
:
1
. L n
0
sa
, . .1 , . altn none la>rml1llnzot1 auramtu ' '
rihadirr d1c I immaui nc Li Laura (' he 1 porta-a manu re1ca lll . . ' f
1
, . , JOOB)
. i. . d .1 ti " .1 tirdo (ombmatono (r 1. >ERTONE - ma un rff1g11 1111'n1t1lc ncostn111a a partire 11 1111a hOJ a 11 t
162 Cfr. 13F.RTOl. \SJ 2005, pp. I?-+ - 18-+ (' Fk ' ZI 2003, pp. 17-.W
16:l Cfr. Cos uTrA i11jia, 1.6. . . .
f b I . I i I' in terra I or che fia dunque a m edrrla Ili
1_6-+ [-) poi .rhr riprr. o il .110. l)('I wlo:/ sr
11
:a.lo e'
'
1
, .
1
,' ( rh'i' tia
11
wder et l'uno t l'al-
<01t>lo? ( nw11fi : Tr111111plius E1er1111a11s, '' 1-+.l- 1 '.. ).
cli'. : .
11
. di un )er<:or
0
di Yirinanza progn sini
lro 1olto ). ul ('Orpo rrlorio>O di Lu11ro romr 11h11no n 1h1le a mtt 1 0 J
nll'Et crno chr 11011 i d senza il drll immarrin cfr. lhRT01-1"1 20 5, P
6
i di qua al_ di l di du an nim nti fo11da111en1ali. cntra111bi Jr11a1i ri
11
me Pi tro B mb
1
();: la tampa aldina dcl r'a11::.011i'ere ( 1.-0 I) <' I p.
0
I Il I
l'oluar_l111f411a ( i.-2:J). 1ra I chio-e puntnt e cortigian d I F'ilrlfo r da11 ioscl' 1c e 6a
ma clitr nel 1- 611>6
11
+t
' ' ' - lutti 1 commenti cinqu crntr chi i rr()'i ' t. I
de i \'O per la toria della rie 'Zion dci 1'-aamr11fa. C;la
l 1 ntr la cquenza d i te ti he arn ora O'O'j O'LJiarno. Paraclocs1l1n I _el
\'a r l q11 ( d' , ' . ' C' ,, , e li I
Pel
.
0
d
1
<\r
1
imm n1rndd tfo dal primo comm nto dcl nuovo -e,.olc>
1
.
1
rarcacurat a e and y Il li (l-)-) '
no. rir nuto >i or:et10 ute . _,) . he ad un liwr o ordin intrr-
b c1 I p emplat ulla cr n lo0'1a e tei11a, rico.,truita Il
a <' I una \'a ta Tn I . . d' . , . . . su a
bioornfi ti a (e n T" . . a\010 I impo taz10nc d1ch1ar tarn '11te
<
11
ne 1ta e costunu del poeta) a cl d li
te o anno drll Prose della l' /u . /' ppro a unqu. a e -,tamp li Ilo
eh affennazione di un e mm.ento. t' te mico oltre
mau1 1co (r 1mpl1c1tam H .
attrawr-o un mod Il I' Il ,
1
r. 1 unico <' retonco)
1
c rnza. r la pr po ta di B ili j
Ync nt . Ja foruma cl Ir cli . . n n. u ta . roncrurnnte
. . 1 . z1 n commentata dal! er tico Yellutello (B Il ') ,
mun n a. 1 a ia ali pa11 il
1
. . d. .
1
. e orn r
con eana alla tracli . 1 i tutti a 1 e ueti pr c d nti f' ucc -, iyjl hll e
e ZJ Il imrn !!ln ndaata d Ir ]' p
t ollarnentotraf 1 lta' Jd I amor ci etrarcarLaura.lnqur-
a ttato petrar 1r e li I J , Il f
tra nclivi ion d l codice e obli d lJ' e
11
cc. ta a a ornrn-canzonicrr.
alm no du e oli la t . d lJ o op ra .e m or()'am mo. i pu in c1frer . per
. na e a no tra po 1a.
I commenti quattr rent chi a Jprutenaonc . . . . ,
tutt poe ia do c ion . J. . . J a una fase m cui la poe. 1a r opral-
. . . 1 nmaton attm pre I .
1
. .
,er 1 arti tJ e ritratti -
110
d' . .
1 1
c mm iano a crlrl rru 111
. . I qu IJ p tl B rnardo u . I
important commento ai Trionfi d di B . icm anc 1e autore di un
protettori fe1rnr i att
11
d e '
1 1
. catol a or
0
d E ti>. ed ' probabil d1 i uoi
. r e a w anc 1e ru t
Lrntr c io tra la fr .
111
az10rn. mai ultunate. ali r.Inr11>'
1
qu ntaz1 n -eu tira di P t . . 1 . . . .
Fraumenta i on rctizza Il . r mica 11rntaz1one-nscriflura dei
, , . ni> a p1 i po tica. Il Ila riprr. a di moti\i in chiav ill-
16.) 'ui COllllllrmi <j1131lro-('inqu<r nt -ihi 111 C - .
BEU.O\I 1992: ul Filrlfo. Br, i 1987. dr. 010\l'>OlTJ 197-+. B\Llht<1 19?-+. 19911
166 Il "omrn nt f
. . . .
0 11
poi mw111pato 1wl 1-+8-+ . . .
r;cr_;, 1nonf: 1_.:;o:J i larnri di Filelfo e dr!lo . 'q11an11firo per le rime(' rJj Bl'mardo llil'ino
'a rmpo. ir1a rd111 nf'l 1-+?J. ' <fU.ir
7
a iro napparnro uniti. iJ1,irnw alJp dtio,r di \utonio
1?: Fil<lfo [eh!' 11011 .,i era '''" il , . .
e Laura. il \ 'plfutel\o
11
dri !Poti) 11v!'111 farnlPggi1110 , 11 1Ja
_,
11
ona 1 U.O.\f 1992. p. 67). '
1
rN m"re '
111
do ume111i t' .,11Jlc implica1.io11i del
168 Ira ,,,. al I
r:
1
ffl. r 111,11ano drrto l<au
1
J,
1
.
" 'to11f1 '>IOllC rlrll' I'
0
r a ,ongia110 ( \ r11ezh 1-3>)
(
\' . I l)f( lflllfllClllO 11lcli110 '>Cetrli1 rii dfr'd 'I e ' . > - i; 1re11o lfll llll1'11zio111 filolrwicu 111 f(.,10
I> . alli110 dr! \Jinturno. c11i lrz' i I a.11umiere in . 01wrti r l'amm11i . inrntnil Cc<,111ldo
11 11 111 11c perduro t t 1
10111
"" t1 11 pr1r1rrl I '
Il' I r . lii Lato rmdemia. molto dr1 . , < I .,,. li. JlfOllllfl('flJI( lfll il (' il 2s ('
l
a r ''.,'
3
"Ome
1
11'11110 da \ ruafro (\ apoli. :
1
1
, '
1
.'
0
,
e il Danif'llo (\ 't1wzi11. 1.)-f I) 1011111110
' 1 r rnnm111.
1
< f>< ro rn:mt1111e una 111111wrazione bt'l>"raJ .
. u 3 Jlt'r I OIWfll !'
169 ull lll('i110 dr. Pot.O\L l'J?-+ (' 19<. ) .
flll 1).3. I 1r 11 '"" SfJllf'(lO I .
11
ritrailo di Cinc1Ta. cfr. infra. 2.8.
66
g crno a r attualizzantr. qursfa altezza. come vrdr mo. la crittura ul rifratto
pratica ormai faniiliare h non pirnarnente codificata. la riproduzione rui tica drl-
la figura umana ispira co111ponimrnti di vena mohilC' e varia. affacciati. ul r
immc rsi in qurlla slessa ila di corte h li ri hiNlc r li procl11ce. li Vrllutcllo. invece.
annota il canzonirre in un rno111rnto po al di drfinizionc e il u c della . ua
lettura ('On oli da I' marginazic)Jlr cJelJ' a I rtto macrolc tualr del ran:::.oniere. molto
mrno imitato nella ua organizzazion i11trrna che nelle rime n l le ico. GiO\an
\ndrca Cc ualdo ( 13. :3 ) non . ol crivr dopo B mbo quando il aen r p etico
d dicato al ritratto definito e matur . ma an he a ontatlo con un ambi ntr. quello
napolrtall . molto attrnto ai contenuti apienziali della po ia: qu t pieua. ad
r. empio. il uo modo di Yilupparc l'interpretazione plat 11ica eh ar approfon-
dita da Giovan Batti ta Crlli . Di cr a la po ' izione di Ludovico Ca telvNro, che.
nrlrall tire le propri annotazioni (Ba ilc"L 1:-82). ha a cli po izi ne. oltrr al lavoro
dei prrdrce ori. tm numrro pili con i t ntc di matrriali fonti. il cli tacco di wia
con apevol zza attardata. qua i po turna.
Gli autori d i prin i1 ali conmt nti quauro-cinqu c nte chi ono e ncordi n Iriden-
t ificar<' come . copo dri son tri L./ \11-L' ' \'Ili I' lo!!io della bellezza di Laura e
d lringrono di
ine elci ritratto. del quale n un mette in dubbio la e m-
mi ion petrar he
. . arebb . econcl il e ualdo. offrire on olazione. nono tan-
tr il I o ta-amante po i da gi l'immagine mterior della cl nna: B n h' 1 Po La
av e dipinta. I i colpita nel uore 1ad nna Laura. nulla di meno per maaai r uo
conforto la re ritrar ll cart da ' imone da iena [ ... ]>
172
. Que ta rum tazion mhra
ri entire della fortu11a d I tema n Ila p ia co11tgiana di primo inqu e nt . dov .
p o il rapporto tra in1ulacro int ri r cl fficri dipinta ' e nfQUfa l roprio n i
trrmini cli w1"altC'ntativa o di una uradatio di efficacia con olatoria (<per maacrior
[ .. . ]conforto)
17
:
1
VellutC'llo.Ge ' ualdo. Ca teh tr tabili conounc il aam ntotra
il onrtt e . ' X e i due ul ritratto di Laura. attrav l"O la po . ibile iclrntificazion dr!
miglior ma tro, autorr d U'immagin h onfmia il po ta nella I ntruianza. n
' imone Mar1ini. ma i primi clu la ciano aperta anche la po ibilit li un rif rimento
ad nor<'-pitt r . pr frrita nza ri rYC dal Danirllo dai m
170 Conunrnda [ ... ] i11,icmr l'Oll la h1' lltz11 di \l [adonna] L[ aura] l"i1irrrg110 tr rune tli mar-tro , i111011 da ' il'nn.
pirlor in qurlla 1t1 hol11111iohi1110, il qunl h111111 ri1ra10 dul 11atunik t'''!'ndo i11 \1 ign . ne lu 1lc<ta do1111n n ru11u111-
plntio111 di F[rnmt.,co] (F11.u.ro t:>O:t c. Hr). C:fr. h\llRO 1:;:3;3. t'. L Xllr.
171 P r 11oti7ia, una dellr pochr dlt' tulli i co111111t'ntatori <'i hio"mfi ,1mbrano e n-idl'rtlrt' 'i11ir11 in qm111-
10 inl!'rnll al I {'>f (), tall'olta 1i('fl(' addotto r Il\ 11110 dr! , 'C'cre/11111 ( rfr. ad ('S. LO"\ I\ '\O , ('' :10r).
172 CEsl \l.OO 1;;3;J c. CXr.
17:3 Cfr. i11fra, s r :H.
17-+ Srhm.tiuno' ;: llll>lo dn Longiano annotu clu simili1 11diuc riu1111111 11tll11 nirn1c. nd i111i1111iom di \'irg[ilii]
inuwine rnpla [: lr11, I\ , I'. 84] (Lo r.f\, o 15:3:.l . c. 4()1'): .'ill'UllO du '01111'
1 11 111ore dli' lit n \li fj., a ;,e111pn l'imagim di la '"a don1111 1wl <' Ort' o.[ ... ] Dlll"_ ( \r"\\rRO l.:i3;3, c. ( \ \ r) t'
Daniello o natura, o \more:(' 11011 nw-,1ro .'i111011e da ."ir1111. rn1m 1oghtrno ulrnm (0\"\IH LO h-11. t'. C).+r).
6.
[ ... ) mirrlion e pi incregno o int 11de11do di . imont' pillon': d<'I cp_ialr
biamo clc110 di ;.opra. iuantunqm' nllri no che il Poe[1a) parli della
di lei che nrl rnore a,ca. ed il ma:,1ro ('hl 1 a, a fatta per \111orr, la qualr opm1on
i pu tollerar . nondimeno prrchr dice Et di pi alto ingegno. a noi piace pi la
prima. [ ... ] ( \hLLTELLO 13r. ('(' .
[ ... ] \ TR : \m r chenel rnorc dipinto_ i!_hel rnho 'erameu-
t tra mac tri il prim crartifcio. rd il nobil1:-"1mo d mg gno. t'Olll(' Il li ('<YllH n 1
. uo Comito Platone.[ ... ) ( l \LDO 1533. c. CL xxYll')
La j m zza n ui wnfra recepito il lcaam tra LXX.VJl-LXX\'ITI e CXX '
' onfennata dalla equenza in ui il \' Hutcllo di 1 one i tre on tti nella ua rico-
truzion p ndobioarafi a i::;: Poi che '[ camin 'iene collo ato ditti o
prima di Per me= "i bo chi (CL ' X\'I). a formare una qu nza 111 Clii il p tere
del ritratto i trorn ubito m alla proYa d Ila I ntananza e delle
olitari allu inazioni dell'amante.
CondiYi a appar anch la l ttura plat nica di L XYIL che nrl G ualdo r nel
Daniello i p i fica. d codificando il ,iaaaio paradi iaco di imone e mr formazio-
n dell'immaain nella mente delrarti ta
\ do\'et intendere. che nel Para<li. o la riLrae -e in cart . ma ne la ment e bila i' i
a,endola mata. poi che fu qua git1 in terra in ca1i e la e: prrocl1r il
ma!ri trrio de ritrano1i dawr benr colla mente il ,. lto raffi urato. (CE l .\LDO
"
1-33_ c. CX1 )
\'ocrliono i Platonici che c mc nella m nt e di eia;, uno artefici' sr111prr prima
ima!!'nata la o a eh 'e!l'li dr. iclrra di fare. co nella divina 111 llLC', rior in Dio, ia la
idra (o \O!l'liam dire imauin ) n n particolare, ma generai<' di riam1na ('osa. [ . .. )
La quale idea dicono e er non al trim 11t i rh un uagell , ol qual 1 utte runa crini
e imprimino: come nella e ra l"unamnc delranello. la qualr tanto pi1 ' perfeua.
quanto pit1 con la omiglianza a quello. ondr ' imprime. ac o ta. Co l" uman
co e tanto pii'1 hanno cU prrfezionr. quanto e pi alle e le I i idei' . CHIO conformi. <'
i a:. imirrliano. Finge adunqu il P [ ta) in questo n [etto] ch"tm certo ' imone da
' i na pittorr [ ... ] nel ritrar o al vivo e naturale imjaliantr 'vf [adonna) L[aura).
in ciclo pr nd e ri.ma!l'ine di lei. eia qu lla idea ch' n<'lla divina mr11tr. e per la
f acr .. <' poi co bella [ ... ] ( D\XIELLO 1 ;- -t I. <'. 62r)
175 :\rl 1ornmrnto del \ 'ell111Pllo agisce opra1111110 il ('riHrio drlla prrtinrnza dei oagrui e dell"unit legli
ar"omenti. 1M quali egli cra 10,1rrtto a r\ir i ptr gli poiianwnti in1rrni [ ... ] (Bi-;uo'<i 1992. p. 66). La sua
opera a c0111Pn1a i rnrio i 11011 filologi e riempi< il '11010 umani tiro. r in.,irmc poi mina. impli<'iiamem cd
p,pli1i1amenH'. ron Il' rdizioni aldine r con Bembo[ ... ] il . ucce o del \'ellu1<llo. rlH rimarr il co111me111atorr
pi1 lr1to in 1u1to il :;oo. dr, e al . 110 opportuni mo. 1d nlla <orr nza - pcr q11ri trmpi - di un proge1to imilr
(i\ i. p. 130).
176 B1lloni olloliiwa lu !'OlllJJOncnlE' filo. ofra nel ("(JJllJlll'lllO drl e . ualdo r il 1aralH' fl' didattko della Ua CopO
,,izio1w (BF.1.1.0\J pp. r 207-208).
68
li rllu!ello forni cr n tizi u Polirlc>to r Pigmalione. rnrntr gli altri comm nti
indugiano rnn particolarr in i t nza ulla vie nda fa.volo a drJlo rultor di Cipro.
Il Gc. ualdo. interpretando il v. 6 di L ' Ylll in una chiave r pinta dai moderni.
i off rrrna u altri sempi di am ri on umati" con immauini. contrapponendo' i
I" n ta cH p ta:
[ . .. ] bramano ali altri amanti ra tutto e com uh imo fine di loro gioirr
di lor do111w la:cirnmr11tr. la qualr gioia alcuni enLirono abbracciati colle imacrini
aniatr: con ri sia che de la \'rnrr(' di Pra itele. opra pi1 b Ila di quante mai ne
furnn al mo11do. prr la qual(' Cnido, isolrtta ov ella ra. dinnne famo i!> ima. inna-
llll aiOWU1C amorosalll('nte C'Oli Jei i trin C. che per C'!mO de rardentr
'>llO dbio 'i la ci la macrhia. Parimrntc il figlio di I i. opra d lo t ,; o cultore bel-
li !> inia. rs. ('ndo fen cm ment amato dal Rhodiano .\lchida. fu da lui dokem nte
abbracciato. che vi rima e il scano cl I caldo amore - qur e adunquc ocrliono aver
gli altri a 1rrado . .\la il p eta [ .. . ] (C1 L\LDO r33. c. CXlr-r)
Filrlfo. con il gu to cortigiano tipic d l uo e nrmento. l di a uno pazio pr -
po itato. al limite della digre ion . a Piumalione alla ua imaain d"avolio>,
rico' tru ndone la toria con ace nti cru<li n uali: la hio a, alquanto ini,'er n-
te. Pu adunqu eia chuno comprend r 1 P trarcha mondarn n poi quando
de imi I materia parlarn> i--. ott:intend un 'int rpr tazion pi nam m roti a d l
Yer o finalr ( n ave. ti quel eh.i ol una" rrei > ). Il Ca t h- tro. pur lud ndo omi
riferimento aJl'appaaarnento e ual I ga nel qu I> com cruclirla parlar >.cri-
tica la Jta di una , imil pr ione. tro1 p equi\'oca ( ( ... ] io non l do qu to
modo di dir , clic i pu aae"olm nt tirar a di on to en >i-s).
' elle not al dittico ad altri te ti , il le ico della pittura vi neri ono ciuto
piegato con deft11izi ni appropriat . h , in i m alradozion d llr formul
ingeano t't arte (Filrlfo) dal natural (Fil lfo) , riv lan . eia parte <leali
inlerpreti. una distirna con ap ,ol zza d lla prati a del ritratto d i primi pa i
della co \'a rill<". ion ull arti fiaurati' (il Depictura di ,\lb rti drl 1-r ).
'on radozi n del fra ario di matrice umani tica eh d fini e le doti naturali
(ingenium) acq11i . ite (ars) d Irarti ta e la pra i dell'imitazione dal" r (dal
naturale) i gi hi della po . ia ul ritratto :ono pi o men fatti
17
'>. la rnrict e
la rie hezza . taranno allora dalla part cl Ile singol itw nzi ni I 11erari , dalla
part d J ritratto tutto immao'inario, al limit enza autor enza oaaett .
177 Fu.r.uo I .')03. ('. Hr (' rrr . ibid.: El alcuni ,fiochi ,fom111du.i farr dd ,o)r tenebrr \llgliono per IUla
Laura s" i11tr11d11 alchuni la p0t,in. ahri 1'1111i11111 C'I altri la' in1 \'I mille ahrt' fnnrtict' rt bizarc l'O>t'>.
178CA
179 La codilinviont di q111-.1e formulr (per rni dr. lh.\.1"\D1LL JQQ.+ e infm. s r pas im) ' ro, forn dir. ad
eoP111pio. pi11gC' \ 'rll111rllo n propoilo di R1f :\\\, u prrft'rirC' l'interprctazio11c di m11>tro comr :imonr \111r-
ti11i perchr di("(' E di pi alto ingegno [ ... J ( \'f'.11.l I li.LO I s2:- , r. 201').
69
ottolinea l'alllbirnlenza di til , ri ordando che e s torrnent o d<' I dipi11t re.
d llo ::.crittore ( .a ' t h--tr 1-82. p. 6-t ). <' che i ar ci , ianifica 110 . cri vcr
t diping r on I ;,t e. o verbo. gmpho (ibid.)
180
. cl e_ttaali at ono le
annotazioni al onetto . , .YIII, in un cont t n I qual l u -o dell e I arol e
<lclrart e r compiutamente rnetaf rie (il ping r antando ). ia una vien il -
lu trata minutam nt : Ca tclvetr , pi aa eh incarnare ignifi ca e ffi aiare con
tutti i uoi colori. qua;,i che ali abbi a po ta la ca rne>. parafra anelo con I mie
rim non celebro l ue lode [incarno>). non o curam ntc e par eh int nda
d 11 lodi d I rpo, clic ndo Vi o (ibid. [con riferim nt a h I vi o)): per om-
breaaiar ualdo int nd di " gnar . non po - ndo dipinaer le ue bell ezze>
e aagiunae h la m tafora tolta da pittori , i quali pincron quando fo rmano
al una fiaura oi u i colori oi u i ornam nti . d ornbr gaiano quando ola-
rncm- la di eanano li ue linc enza i colori e enza i uoi lumi ; tanta
differ nza tra il piu er r ombreaaiare quanta ' tra la\' ra embianza e l'ombra;
[ .. . )> 1s1. . lv. 12 cl li t o on tt . relati\' all'irnp ibilit di rapprc ntar
!"anima di Laura (la di,1na parte>). a t h tr rintraccia un concett o che gli
mbra di aver incontrat negli pi!ITammi ar hi >:
o come i pu clipinu r Phetonte e 1 carr d l olr. ma non lo pl r ndore del
arro. co i pu clipinuere la ua faccia. 111 a non i rag"i d llc u 'irtr. La di,i na
pane non . i pu' clipi.nuere. ma r umana pczialmcnt e e sendo liii ehiaro -ole.
eh' lo plenclore, come di co. non dipingcvole. (C.4- TEL\'ETRO 1. 82-. p. 6'f )
L pi!!ramma in qu tione i pu id ntifi ar n un ornp nim nt l di cato da
L onzio la ti o a un ritratto di abrielio pr f tto di Co tantinopoli ( P -vL
. - ). eh ra tato imitato. pi di w1 colo dop P traTca uno prima d Jla nota
di t lvetr . dair ruclito ferrar lio Calcaanini
18
:i . u ta chi a d pr va
di w1 att aaiamento ana roni tico. eh t nd a pr i ttar alr indietro acquisizioni
tardoquattror nte h inque ent eh ; ' la t -a e n zi n he far scrivere a
Ta o nel cornm nto a un propri t to i pi rato a Rif LX Il, h in quel onetto
P t:rarra m de imo imit Anacr ont n la cultura di en r n l D (C'armina
180 ( .. . ] lo . tilr in qm,10 luo"O [ CC\' 111 ] n <' r al cantar . e al dipirvrrrl'. p1'r<' h i prende 1wr il pl' nnrll o.
rlr"adopra il pi11orr. come pn' ' C f(ltalldo disse: Quando giun<,(' a ," imon r alw ("() lll"l' llO. Ch" mio 11 ()111 (' li (l O'(' ili
man lo -l . F. Dante nel Purgatorio: Qual di prruwl fu mar 1ro. o di -1ile ( ... ) (D1,ir1.1 .o 15-t 1. r. 18 lr)
181 t 11_00 l:i33. c. CCCX \ \ r. fr. h\HKO 15;3;3, r. C:L\ \ \ \r (( ... ]ombreggiar( ... )( a11 rnr 1ra. l11zi o1w
da l"!'ffrtto all'o111bra. onw ,i 1rdc negli uomini r n gli ahri 11 11i111ali. che 1"0111hra di quelli (> quuklw di111 m,1ru-
tionr di ']Uri dw sono. non p1r pl' rfena). DA'<lhtW t :- -11. I' . 181r (ombrr"l-(iar: qu Il o chr diro110 i Pi11ori .
di, cgnarr. r far di l'hiaro. closl'11ro) e 1 rEIH1 no 1582. p. (J4 ( Dipinger i1111 wrfP1tururnte. dw il primo clior-
wiare chiamano i dipintori ombrr" i are rd ai rndo chiamate le lodi cli L( aura J comi sull r. ben cJ ic;,1 0111hrrggiurr.
n>IPndo ig11if1are dw dallr sur rime rrano osrurafl ).
182 Cfr. infra. 2.2.
70
A11acreo11t ea, LV)
1
ll:i. lmpli ita111 ntr. il pofla del pieno Cinqu cent , 11rntatorr in
prima prnma di A11acre nte. attribui cc a P<' trarca la propria c n aprvol ezza d lla
continuit d I cr<' nere <' dci modelli eh ntrambi hanno all e pali .
Accant o ai co111111C'11ti che ill11. trano l'intcro co1pus d li rime petrarche. he. i
registrano int er enti dedi cati peciGcarnentr al dittico. come le p rdut lezioni cli
' iccol Mart elli . pronunciate nel 15-t- daYanti alr \c ademia fior ntina. e il di cor-
o di Giovan Batti . ta Celti opra i due sonPtti che lodano il ritratto di Jladonna
laura
18
"'. TI commC' nto. che Ot-i titui e la ta d Il Le::.ioni petrarchesche (15-t9).
ri. ent e della volont sotte a ali.intero proo-ctto <' . eo-e1 ico d Il Le::;ioni: dim trar
che non solo in Dant e ma anche in Petrarca ., dottrina> oltr h I li til
lin
11
ua. La I ttura dc i du t ti in -erita in un lunao di ror o he muo, dalla d -
fini zio11 e dell a della pittura orne arti cl Irimitazion (ri p ui,arnent con
le paro I e con i colori
18
:;) e eia una loro brevC' tori a ( h cuhnina in Dant
Petrarca per la poesia. in \1i ch laiiaelo per l' art ). p r approdare alla 1"\' ndi azion
dello pes or filo!io fi co dcl ditti ' . L intenzi on > del ditti o manifc ta (e lodar
uno ritralt di Laura>). ma il aper h nti en . di contro. e tato trn curato daali
i11t rpr ti . I r quanto :,, ia molto diffi cile comprcncl re i on t1i enza la e anizion
cJell a (il o:,,ofi a e Pl atoni ca Ari toteli a> (LP. p. _-t 1 ). Lo cop d 1 dittic . ul quale
qua. i tutti i commentatori ncordano. non minimam nt m o in qu . tion .
!" intera argomentazion i e n entra ulla profonda dottrina e la mara' ialio a arte.
che u il poeta 1wl t ere q11c to elogio (in fare que to [ivi, p. 2-t:O]). lnterro-
aancl o i ull a ragione che avrebbe indotto Petrarca a c1frer un eone Ilo. o- non
m lt alto. di lodar uno ritratto d' una donna >
1
110. elli la indi,idua n ll"int nzion
di elogiar r opera di ' imon e prattutto di emulare Puruatorio X:
Del qualr 111 ocl o par a nw che qua i impo trornrc uno pi efficace
r cli maggior \ alorr. \'Olr ncl o cwno' trar ehr tuia pitturn o una cultura pru , i crr-
tamr11t P ' ra. [ ... ) paro I in co fa tt a br 'it tant o e f caci di tanta forza. pr r
lodure un rit rall o di scultura o di pittura, chr io non r do che fu e qua i po si bile
trovare lr pii a pr I osito r le pilr att . \'ole11do adunquc [ .. . ) lodarr ancora il poela
no t_ro 1111 0 ritrati o della sua i\ladonna Laura. fatt da rnaestro non da iena. e
' rggrncl o chr Da111 e aw\'a lodato con tanta brc' ita e tanto artilizi arnrnt i rirraui
delle racrnntate di opra da 11 i [Puru .\.], [ ... ] p r mandar ad ffetto
18:3 111 llT il ,onruo ' il lt''tu 898 P fu purt r di una dtdkalll a 1111 ritrailo di \larfsa d"[,te (dr. iufm . ."
1.- ).
18-i . 1111 1 %9 (lP]. pp. 219-282.
185 per In qual ragio111 sono alcuni , i q11uli hnn110 cl111 u dir la poe ia ' 111111 pittura eh parlu, e la pi1111rn
111111 poc ia m11iola (ivi , p. 229).
186 h i. p. 241. Cfr. '' 1958, p. ?:3, 11 . -18 {i due tiO!Wlli c1wre anal) 1.1' d h) ,l'lli in 1h 'i\lt'emh
11 a11 clabor111i n of 011 111t\ 'i111pl cr ironi r 1t' N ' in dt t' Purgatorio. ( ... ] Celli. in an (lll"ll "t' that rt>-
l'('a(, a k<1 11 s( ri-e of hi,t ori rnl eo111i11ui1, in 1h1 mntt rr of iro11i r wr c. helie1 e, Pt' trurrh had tht ttnd1 hool.. f lht'
l
1
11rgotorio in 111incl when Ir e 11 rolc thc hOnnr h )-
. 1
S\10 Ull modo molto dolfO (' llJOllO \'al'O, {' fol' S(' di llOll 1'.lillOI' \'Ul .r:
e hrlltzza. sr non <li tanta bre' it. dtt quello che a' 'a Dantt'. l, 1 e
di lodarlo con ragioni e mezzi fil .. . ] (l,P. pp.
ll dittico na e r bbe clw1que dal ' nfrout con un m d Il altissi1110. Il I campo
p cifico cl lla I clc di op r fiumati,e. ma in P trarca ar bb. a .. o.ciato a un
non parti larmenle pr ' ti!!io o (non molto alto). la i de d1 un ntraHo fcmrmmlr.
Bi valutar quanto in que to aiudizio ia don1to ali' ottica ciel conunen-
tato; cinquec nt ' CO. per il quale la elebraziOll(' poetica l ritratto C Ormai una
pra i ter
ruanto alla con, iderazion in c1 ra t nula la ritrc tti tfra
come aenerr fiauratirn: un ritratto ' m 110 nobil di un exemplwn o di una :-.cena bi-
p r di pili l"immaain in qu ti 11r non un p r ona(rgio ma
una cl una eh d " la ua fama lo all'am r cl l p eta. Il pa._' acrnio dalle terzine
delle fra i dant ca - ampio ol nne , auardo p rtato ugli al tori li Yi - alla f rma
breYe e chiu a d I 'onetto ul iirratto I tramata non comprom ttr la validit del
collegamento pr po to da lii. eh tr rn nf rma nel qt eh <l i una la limen-
ione terr na umana n lla ' equenza ulmiuant d 1 cisibile parlare (Pwg X, ' " 95)
e nel dittico p trarche. 0
188
. Pa ando dal conte to narrativo a quello lirico i motivi
che in Dant mar ano. in i me ai,. rbi fiaurati\i. pazi fra tiei pili di tesi. i con-
entrano e acqui tano una nuova funzion : acri cono infatti in a enza di de ' crizione
lodano un oau tto radi alm nte di\' r p r natura ignificato. ll .., n o d li" o.p -
razione p trnr hc a. eh i nutr di w1.impli ita fida on Dant . ta for pr pri
nella cli tr formar il 11eneri o 1 gio di un ritratto di cultura o di pittura
nella celebrazi ne di uno ritratto d ila ua Laura. ci ' di inn tare una
rille ione liri a ulrimpo ibilit di rappre entare direttamente al e ntro d Il a lode
del rapporto con r immafilne deU- e ere amato.
. l nu leo cC'n trai cl l uo ra11ionam nt o. Ili o ti n he n 1 netto T, X VII i
loda il ritratto condo la via di Plat n .in /X\'III" e ond la ,ia r la dottrina di
.\ri totil (LP. pp. 2-1:6-2-1:. ). L"opinion cl l m d n 1 qual cl 11clo110 l' a.nim ne
notri corpi (ivi. pp. 253-25-t) fonda il primo . on tto . i riv la indi. prn abil p r
compr nder r eloaio eh p trarca t1ibuta alr arti ta. in qtlanto ci h rend r op ra
di imone da i .na (del qual non ci e memoria alcuna. chf' fu. :i di tar1la fama
189
)
187 e me \'r<lremo (. 1.6). gi nrllr po tille d1l Grifo -tmhra <li ('O"li r l'ru.peuo on,uetudinario del gp11rrr.
188 La bre\it rhe Gelli anno\era tra i meriti dt'lr!'loaio dame; or proLabilmenlt da riftrirt ui Hr,i r,,p)irita
mrnrr 1itati (Pttrg \. \ e X.li. w. 6-1-68). l'i<> ai wr,i pr priamente elogiali\ i. dH' i11('ornifiano I'
cd 1primo110 la writ drlla rappre.entazio1w.
189 LP. p. 2:;:;. Co,1 \asari : E iD\ero qu 1i Mu1t1ti t l'avrmc fatto menzionr in una d(llt .,lit' lt'llt'rt' famigliari.
n I qui mo lihro l'lw ('0111i11ria: \011 sum nescius. 111111110 dato pi fama alla povera \i111 cli lllll(''ll ro .'imonr che 11011
hanno fauo nr fan111110 mai tulle l'op re ue. perd1r rllt110 hanno a venire. quando rllC' ;,i11. 1111110. do\I' gli ritti
di tanruomo \ivcran110111mi rroli (lite 1568, Il. p. 192). Per i riferim nti al ditlil'o in n'lnri" in \ 'archi cfr.
infra. :t 1 t rnp. i . pa.uim.
72
_uperiOJ'(' a artisti antichi C la prC'lJliarit drll ' r 'jJC'f'if'nza COn() Tiliva eh
I ha re a. ' ('I uomo. COITI(' tuttr [(' co. r. ha due(' rri . riclC'a che r nella
m ntc d1 Oro <' I s. <re eh ha quarmiI ( uno ritratto e una ima"ine c1 11
' 1 1 qu o.
qua I I puo (ti'(' lilla Ombra [i\. f> 25 >]). (' ('il proprio n C'ia. tttla fiuura (> ili
bello dcl r:ident chi ritra le co r dalle propie. lr fa mpr piu
che non fa d11 le ntraC' dall ritratte [i' i. p. 2.)7]. l pera di , 'im nr ' eccezionale
proprio l crd1r <'
1
rli non ha Yi to Laura olo in t rra. ma anch nrlla mC'ntr di Dio.
rha ritratta. in (_ " i f;ce neUa rn<'ntc qurlla imagin e qurl imnlac-ro tanto bello
e tn:110 dr eh
ha di poi mes o r dipinto in cruie [i,,i. p. 2;)8]). p r
te tunomare qua
11
0-rn fra noi :. qurulto la hC'llezza eh ha nella , ua id a ' ia up rior
a quella eh ha nrl uo c01vo in terra
1
'>0.
. :c?ndo CC' lii. 1!el LXXYHl I' a. p Ilo mat rial d mina u qu Ilo a tratto
e mttut1vo crntralC' 111 LXX\ II. per h n Jla prima quartina Petrarca racco11li n JJa
11
e11rrazi ne e nC'I faciml:'nt di qne ta co-.a a11ificiale. io <li que to ritratto. tutte
I a user_ i principi che .\ri tote_le pone n Ila aenerazion d 11 co <' nalurali (LP.
p. 2?0): l alto concetto ( cau a foial ) mo. 'im n ( cau a aO' nte) a ritrruTe Lau-
ra. _cio _a introc_lu!Te la la ffiair Mia a11ificial in qu i:-Jla tm la n Ila quale
e ali la rr Ira. :t. c10 nelJa malena. di acciandone quella prica::.ione che ,,i era della
ffigie del VOito SUO (ivi. p. 271 ). lJ porta , duole eh il pittor l10ll rabbia r a
anche 'irn. come fa1rno i] ielo e ali altri aaC'nti qi1ando intT ducono J forme nella
mat ria. ma CJlH :-,ta po . bilit e5clu a dalla cli I r nza tra form naturali forme
artifi iali: q111llo di dar il moto e m niem a oroi ere ' un p1frlecrio che la
natura si ' risrrvata p r la propria di fronte aJ liwllo raaaiunto daU-art (iYi.
p. 27-t). Voce e intelletto . ar bb ro paro] elt con d ttrina dal poeta
per indiearC' la vita - al posto <lellr I i genericb moto. ru1ima o nlir - in quruJto
proprie cieli' uomo. r uni o in cui i ritrovano in irme (i\i. pp. 27.)-'..... 8).
Le due let1 un' cli C lli mettono r accrnto 111 ritratt om operazi ne com
prodotto del r arte 1111 :;11 onoscit irn d Jr umano (L. x \'fl ). in id.iato.
nella ua realizzazion prati a. da imalicahili limiti naturaJi (L \\\ IJI). che Perrar a
inda
11
h r hhe attraver. o lo p tam nlo louico . ul qual il 'econdo on tto i onda:
<' primer n Ila cr azione di un 011g tto artificial i prin ipi eh preiirdon alla g -
11 erazion del li:' cose naturali. e si r:cludono i I ree denti. in luhbiamente aagu niti.
di ualcl <' trn a11enzion cos spiccata per la dimen ion peculati va del
.190 Crlli ricordu 111 pn"ihilr obi :tion lt>11ata al fa1to rlH' i platonici intendono d1t in Dio ci 'ono ,o)ameace le
de lit' tNil111t111r. non cegl"imlidcl11i pnrt iculnri >. t' fo riferimento ai \ tr.i c[n qual partr del cirl.
111 rrn I t'\t111pio. 011dr \ atura tol,t>/ (p1t'l lwl \ i,o ltg!!iadro, in ch'ella \ O),t'/ 1110,Jntr q1111 tri1 qu::uno
po1PM (/l1fCLI \ . \\'. l-1). i111t>rpreia1i t'Olllt' t' in Dio mm son lr idee panit'olari di O"lli r<NI. da dow
pn:-.r la 1111111ra l't'. 1111piu drlla b<lleua di Lauru?'. li nodo\ iem sriolto attrawr,o u11"arno111t'111a1ionc dl!' erdi
fa ri-,alire 111 Cr>naldu (cii qunlr il primo clw io 11hhi11 Jnl\llto l110 11 qui. l'h mi pain d1t"abbia illlt' o nlq11111;lo
<1ues10 omtto): il pittorr in cielo dde l'ideo ddla nu111rn 11111111111 in 1111i11r,uh... c)u pi1 lwlla 6rrura umana
P.O ih!lr: i11 lt'l'ra, \t'dt11do L1111ra. la pi bella L'l't'a1urn 11n1111111 r tlunqur In pi1 oimilr11 quella <'h<' awrn 1i;10. ,i
rwordo drll'idrn t In ri1ru-s1 (LP. p. 260).
.3
ditti ' O riman un epi odio i olalo, in un panorama compi iYament e <li trat1o dalla
crona a e affezionato a du dari di fondo: il ritratto di Laura ha funzion con ola-
toria e i ' On tti che lo ricruardano ono tati ritti per lodare la bellezza della donna
e il talento cl I pittore. i eh non pax in di cu ione la de tinazione privata e
amoro a dcli opera dipinta da imone e la doppia componente encomia ti a ci
te ti. che alcrn interpreti, fino a ocrai (da ultimo Berton ) han no pullo fino all idea
di LJ ' Yll-LXX:Vlll come onetti ' di corrispond nza in terza per ona ,concenti-ali
ulrinterlo utore arti ta pi che ulfoag tto del canto. Al cont rario. in Petrarca l'in-
dubbio omaguio al pittore ontrobilan iato da un forti imo a petto intro pettivo
non comuni ativo, ri vo ativo e non interlocutorio: il riferimento a wia realt
preci a re ta imprigionato nella pietra lavorata d ila liri a, dalla quale continua a
tra parire, non m no plendido e toricamente vi o. Il ri ono cimento dell' a petto
o titut:iYo e intimo del tema trova ri ontro nella po ia arn ro a che i compon
trn Quattrocento e Cinquecento, ma la dimen ione dell elogio ri ultata. nei fatti ,
dominame, e tanto pi ignifcat:ivo , per que to. che i commentatori la recepiscano
enza e itazioni. qua i natura/iter: olidamente agganciato alla fortuna di un crenere
pittorico. il onetto u1 ritratto diventa oprattutto una macchina celebrativa.
e corredare un te to di immagini ignifi ca ncce ariamente interpretarlo e in-
fluenzarn la lettura. importante v rilicare e ome miniatori e incisori abbiano
illu trato i no iTi due onetti. Del re to. la toria delJ illu trazioni al Canzoniere si
ovrappon in parte alle vicende editoriali dei uoi ommenti. Un dato i impone: n
a margine di LXXVII-LXXVIII, n a riO'ore. in alcun altro luogo del te to i trova
alcuna raftuurazione del ritratto dj Laura dipinto da imone Martini I'll. cade in-
vece he i f a un tipo iconografico di Laura, e, a po teriori , i ten le a farlo ri al ir
a quella mitica immagine. al ritrano ori ainale. In altri termini . cer1 amen te si rappre-
enta Laura (in ouni ca o non in corri pondenza del dittico), ma non il uo ri1rat1o.
Limmagine di Petrarca i fi a torican1ente ulla bas di documentj preco i
192
non
co quella di Laura. ulla qual i miniatori quattrocente chi fan tasticano libera-
mente. In as enza di atte tazioni anti he del uo volto ( e i e eludono il pre unto
ritratto pre ente negjj affre chi del porti co di otre-Dam -de -Dome ad vignon
e quello ricono ciuto da Gelli a ari nelJ a cappella degli , 'pagnoli 1 anta Maxia
"Io ella
19
:i), l' iconografia ul gata di Laura i tabili ce attravcr o una celta rap-
191 ulle po hr ecc!"1.ioni. eue-otto cntesche, mi offem1er all a fine d I capitolo.
192 Limmauine di Petrarca stabili ta a Padova nelr ul timo quarto dcl XJV ecolo.
193 Per raifre codi. ''.1.n e il drago. ciac . arcbbe stato accompagnato da 11 1111 quartina in latino cfr. TMPP
2001. tav. 74. L.a nouza. e segui ta da Bernardo Bmabo (cfr. ivi. p. 104) [e p r Ci m:vra rie" Bene i cfr. Rif C LI X,
w. 7-8) e m un.ann?12zaone al nruo LXX lii in un manoscritl o con ervato a , ' 1. Loui ( t. Loui niv rsil y,
Xli Library. rn . Ullman 23. f. 42r. segnalato and ar da W1LKl.N 19.51. pp. 223-224). P r il prc unto
di po da Pietrn Bembo, tratto da una anta largh rita avignonese, cfr. TRAPP 2001, p. 105.
Per I 1cl cmi1icaza o1w dt Laura nella Capprll a d gli pagnoli cfr. LP, pp. 255-256 e flilp 1550., Il . p. 195.
74
prc r 1rtativa che i afferma piutto to tardi ., in incisioni d l . econdo quarto del XVI
secolo. ' 0110 gli <Hn1j nei quali pi int ense sono, in Provenza. le ricerche di ve ti!ria
. J I . h d. L 1'J.i l b ,
0
' tonr 1c gcnea og1c e 1 aura , a ur prc unta tom a ara nirovata .intorno al
1 3.3, ma sono anche gli anni del ommento di Ale andro ellut llo (1. 2 ), che
i apre cou una cartina della Provenza. come in un ideale toria e g ografia dei
luoghi petrarcli e chi, e e mpagina la quenza testuale delraldina in nome di un
prn ipio ronologiro e narrativo. Il tempo dcJJa vita i o titui cc al tempo della
poe ia, il tempo deJJa rrouaca al tempo meta torico e univer al del Canzoniere. i
trova un.immagine nel momento in ui pi la i cer a, quando la e rtezza di un volto
documentato diYcnta pi affa cinante d Ua po ibilit di invent:arn tliniti. ' elle
edizioni a tampa si diffonde co i la pratica di adornare il fronte pizio o la pagina di
aperi ura cl Il rime con inci ioni h raffi.amano Petrarca e Laura; la donna ritrat-
ta, come ar poi per ccoli. con i capelli raccolti in una cuffia ricamata. che cende
ulla fronte con una fa. eia in forma di cuore, e con una coUana eh aira una o pi
olte intorno al collo nudo' %
Nonostante il Petrarca v llutelliano e la ere cente diffu ione dei ritratti inci-
i atte tino un intere e per i dati materiali e per le embianze dei due amanti, il
Cinque ent o, for e incoraggiato dall caratteri tiche di uniformit tipiche del libro
tampa1o. non int rrompe il sil enzio illu trativo tl' effiaie dipinta da imone
ni, ignorata gi nei mano critti. La mancata v:i ualizzazione della perduta immaaine
attribuita al pittore i piega innanzitutto all'int mo di una pi u n rale tendenza
degli illu natori quattro-cinquec nte chi del Can::mziere: non accom-
pagna in maniera continua d ten iva il te to, ma i limita a mar rune 1 -oglie
fondamentali rincipit delle rime in vita e d Il rime in morte
1
%. Con una o tanzial
corri pond nza, I apparato illu trntivo dei Trionfi eana, a tutta paaina. r inizio di
eia cu11 1rionfo. i tratta di can i01 e -enziali, d'in iem , eh non i addentrru10 in
un confronto ravvicinato on il t to., ora elu o ora contraddetto dalrimma!rin .
iamo lonlani dal c11or del problema d 1 rapporto tra liri a e ritratto. Tra l immaui-
nj e pr dalla poe ia, quali po ibile o pi facile illu trruc? Quelle eh hanno ca-
ratteri netti e precisi e offrono dettagli concreti da fs are e tradurre vi ivamente. La
bellezza di Lama ovw1que nei Fraomenla, ma de cri tta in mi ura molto limitata
mai con tratti individualizzanti e dLmque vi ualizzabili in tm efficrie particolrue e
ri ono cibil c. e poi i hi cdiamo h o a ra raffaurato nel rit ratto di imone (un
volto, un busto una fig ura intera?) gli indizi si diradano ulteriormente: eauendo
19-+ ' ullr ri cerche del rit rnl Lo di Laura r fr. 'llAJ'r 200 I, pp. 102-1 11.
195 For e con rif .rim('nlo a R1fCXC\ll. v. 7.
l 96 lT11 a nella rnarrrriora11za dci manoscri tti ill ustrati del Can::oniere, tutti italiani (comprrsi trn la finl' tiri X\' il
eo d . I . . I
XVI sec. ), ri uliano mini a1i solo sull a pri ma pagi na delle rime in \ita e ovr si aprono e nme 111 mone. oppur ' u
frontrspi zio: in alt ri rasi il la,oro dr l miniatore i limita alle orni i di quc. tc cRrlt' o alle iniziali. Fino alla met del
' V t colo i mano. rritt i sono ooprattutto veneti e lombardi, poi tosca ni c. ndl'ul wno quarto del colo, pado,ani e
11apolrtani . fa il primo 11 to forcmino. redatto prima dr! 138:i (cfr. ' ltAPP 2001. pp. 66-82).
un principio di \'ero imiglianza pr ml nd alla lettera i so11ct ti. d hbia1110 imma-
crinare eh r fficrie mo tra' e il b l "i ' di Laura. come 01tolinca il Gc ualdo.
fi
1
di,iduand n l \ olto J'ocrcr tto d llc rappr ntazione che ci i a pelta dai ritrat-
ti ti(ilmacri t riod ritrattorida, rl n llam
contemp non po iamo tra urarc rarnbiguit di rultus. che . ignifica 'ia volto he
a p tto. n' escluder la p ibilita cl Ila -in dd he. intra,i, ta da Ca ' tch tro n I
bel Yi. o> li Rt:f C YTII (dove par eh [il p ta) intenda> il e rpo. contrai po lo
alr anima - n n )
1911
.
Le.trcma p ,ert dcl materiai da rappr ' ntare - i porlti dati d rritlivi for-
niti dall rime - i combina poi con una difficolt interna. statutaria, drlrimmao-ine
poeti a ad er rappr ntata. eh -pi era. ad -empio. perchr contino pili raf-
figurazioni di Laura nelle illu trazi ni d i Trionfi che in qu Ile del Can:::oniere. per
quanto. a lfr Ilo d l te to. la ituazionc , ia attament rov
1
'
1
Q. I inuuamrn
liriche rnbran "offrire pi dell imrnauini narrati\ quando 'rncrono -onop t
affin \itahil 1 Lteralizzazion - r du tion to literalne > (Trapp) - implicata
daffillu trazi n wo. difficile definir i t nnini di qu ta . una forzatu-
ra qua i Lma violazione che appare piu vident nelle -ue co11 rguenze che nella
ua origine: ad empio nell'eff tto traniante provo ato dalla ,isualizzazione ica-
tica di m tafor pre e alla lettera. daali car1 i tra il te to l"immagine. In un
ca o rillu tratore corpo a ci che il l tl r ' abituato a p re pire com involucro
trnspar nte. a n 'id rare io' non in ' ( on tutto il u Ha11ra11t impre\i to
co f1 i nte di con r t zza). ma com tra lato. come inc n. i tente Jicrura di altro:
nell'altro a . rimma
11
ine fa,. r qual o a eh nel 1 . to non c. o vice,ersa. Il
m agrio liri molto pi di quello 11arrativ e ag!!redito dall"illu trazione. che n
impov ri 'Ce la I oli ernia e ne mplifica le cillazioni. Tutto que. to. come ndremo.
ha una on1sopa11 vi nte n Lle <liffi olt dimo tra te dalla por 'ia nrl comunicare
cont nuti vi ibili. a front della vi\'acit 1on ui la pro a (> in grado di accouliere
que
11
li t i cont nuti. L emblema la m tafora. pi in crenrral il li1wua11crio delle
figure. ono l \e predilett . tant p r la I o ia che p r rillu trazionr. p r fua!rirr
a.que la incomuni abilit: vi di ftwa chr div ntano vi di un po sihil incontro.
un di onv ru nza. p r quanto obliqua I r caria. P r que to le
metamorf1ch o metaforid1 di Laura. in viri t'1 di una para do, al co11-
cr.etezza. 1 pre tano ad ere vi ualizzate molto pi d l 110 a petto puro e rmplice.
D altro <auto. he co a in grado di interromp re la co11tinuit del di coro liric
19? CE! 11Loo 1:>:n. r. '.\r.
198 C-1. rwr.rno 1:)82. p. 6i.
199 \I p111110 rltr romr llOla BfRTOI ,, ?OO- 1 11 . I . r rfi .
. . . -
1
" - >- "1 1 11 1r111on 1 r1 Tnon 1 .ono cm.tntti ad a"ai11nrrcr1 cl1111en11 non
pr ,1nu n11 11r1 La di I a Il 11 I 7 rfi "'" " I '
.
11
: ,.iur uc '
1
w.traz10111 e c1 mm 1 <' cl1111q11c marnrion >,1'111plin11unte peri' 11.
prr 1 oro a'pl'lto nurra11w1 (1Jl'r quamo Il. ) .. '":-
a cgorno. f1110 .,tafi p111,,peo.o corrcdnti clt i11111111rr1111 .
200 Cfr. Twr 2001, pp. 66-67. '"
76
con addC'nsat1H'11ti di vi ivit? Proprio la metafora. che, com<' i rif rimrnti al mito
auli aneddoti. introduce un a petto . paziale in u11 r gime t mporalr e in taura una
o pen. ionr cristallizzante
201
.
In qur. to quadr . runica' ra ree zion r rappre. entata dall.in unabolo qu ri-
niano G \' X\'. ul qual torner mo. . olo parzialm nte. dalle vi!m tt d Ila tarda
edizione Zatta ( 17S6 ):!O:!. :\ gli altri due ca i noti i illu trazioni il l crame
tra i t ti e le immagini . icrnifi ati\amentc. di tipo mbl matic m tal m t-
te fuori crioco il problema della vi . ualizzazione dir tta
20
:i. L metafor i oncetti
ono fonte di emblemi (in uu mano cTitto d I VI e . con rvato a Baltimora
201
)
r di imprrsc. drllc quali i rimarca on pr ci i ne il 1 cram e I te to (i n una copia
cieli aldina 151-+ ora a hat worthw:;). Alcuni ca i inquecent chi di anzonieri il-
lu trati. e mr la Dlie (1.- +) di c've e La f'ginia di Er ol Ta o (1.-93)
funzionano ccond mcc ani mi imi li.
econdo le ricerchr di Trapp. nei m n critti Laura rappr entata in '. om
incamazion 11011 caratt rizzata della b llczza. oppur econd una cl 11 metamor-
fo i che . uhi '<'e nel Can::.oniere. o ancora nel\' atto di compi r un azione vocata
in uno o pili te ti. e on<lo e n l terzo ca.so la vi ualizzazione ' facilitata ii-
pettivam nt<' dal fi ar i di Laura in immauin (Laura ome lauro, com Dafne.
ecc.) o in metafora (Laura-fort zza) e dalla pre enza di una comp n nt nan-atfra
(Lama che porcrr al poeta la corona dallor ulla riva della orcra):!
00
. I miniatori
emhran dar corpo nza nopp difficolt ali tr formazioni di Laura. proprio
la canzone dellr Yi:ioni" (Rtf ' CXXllI) praticam nt runica illu trata an h
fuori Alcuni illu trntori pr ndono ul . eiio un trav .-timcnt mitolo!!ico-
:201 <:rr. Hos1.'<11t11.1<J98.
:202 :olo parzial11H'ntr , 0 10 un cerio n11111rro di tt,ti ' dallt> t' allt inci ioni
la1 ora110 pi1 art i,1 i. 1111cht' ,t ropt'ntzio11e co111plt"i"111u111r conct'rtata nrntata dal! d1ton.
20:3 Come Hdn1110 (t'ap. -t ). le ,tt,, ,j di fu!!a. pur i111butTa1e dalla direzione opp ta. 'ono penor.-c dalla
por,in ndfan'O'.tllrt' 1'1ptril'nza figurativa.
20-t Baltimorr. \Xulttr, \rt \1
11
, eum. nh. \X i-:'O. dO\r ;J:) per la magirinr pane rrattt' dal ( a11::.011iere. al
cum da Q, idio t' dai , 'almi. ,nno 1ra,formate in tmhl!'mi (' la \PP :WO I. p. 88. nota I 00: rfr. lORRE 2008 e 200<J).
'.W:> l: tdiziont ;. l'flrmlnta. mi di 17:! piteolr rnflinmi-,ime inunagini. 1<>_6 rifrrile ai .in Yita.
attrihuitr 11 \'i11cr11zo Hai111011di. im11mgi111 collegata al tt,10 da una ng:i ro"a.
1
11 1crhe il
rnrri,pondrnt!' usou111t' un ruolo ;, imile a quello di un 1110110 prr un' impresa (rfr .. 200 I. P
11
U1 100
e .hc ]<)85.
11
. :tlo). il e:bo di un rnro <1111zo11il'rl' ill11otrnto tl1 l1nd1t troh11tlond.1t
o \'111('zia. 1280 ru. ). in1ens,
1
uite pcrchf le iJ11111al(it1i nti 11111rgi11i infrriori oom1. ltg.11te 11! lt''tll da piccoli
I
. I ( I I i I' l I r- '11111 1998 (t'I> '0 31) nuuurdu un te;,t Ili cui
< 1 nc uamo nt 1<,1111p10 e r1 punt1111 : l'"<'lllfllO 11por111 o ' 11 \ .1 -- '' " .
Fokl111to di \lnriglia lamrma lr offerrnzr 1111i-11tt cltl"li 11cd1i. eht' ,etlono e piangono (\ ) . P1erpont
Library. nh. 819. f. ;)(>r ).
206 Con
1
imi,o rifrri11111110 alrinco1 naJ:ion tapitolin11: tli ,wdt lauro tuta ghirlanda col,1./ !:
1
qunl co lr ur
1 I I (l' ((' \I\ 10'3105) ln un m111osnitt11 lo111h11rdo dd H-tO
ma111 mtorno 111torno a r 1111r L mp1 n,o -.r 11: " ' . .
Il I ' li ' 1111 are 111dw \mon rlll' ,rn"lu1 la fnrc1a.
ca. 111 c1uesta M't'll!I. rnpprc,rntata a prnnu p11cr11111 t t t ' . < ... _
1i ihilinentt ro11fitta 1111 petto di Fnu1ces('O (Bihliottrn \p<htoltru \atJt'ana. Ili' Burh. lut . .39i.l. f. 1. ). Per uhn
raffignrazioni 1hlla scc1111 d!'ll'incoronazionr t'fr. Tn 1PP 200 I. PP 7:2- 6.
207 , ullr ill11strazio11i drllu l't\llZ ne prsr111i 111'1 ( 1368) di Jan drr \oot cfr . \11Tu 200<>.
all gori o. dandoali forma 'i ibil . <l e empi . a met tra emblema r narrazion
(e dunqu a I rocevia di un doppio p t nziaJ vi i, ) i o I loca qua11 to mo t rru10
mia dozzina di mano critti di ambiente fior ntino. che i a1 rono con l'in auimcnto
di Laura-Dafne da part di P tra.rea- \pollo e con la h'a formazion cl Ila prima in
laur :!08: al di l del ci rato omacrgio a Lorenzo d ledici. qu ti front . pizi. a tutta
pacrina o m n . nd n ano in mrni a immacrin la trama allecrc rica e metamorfica
d lrint ro offrendo un on tu : ace o d"in ieme al testo. nel :ecrno
dell"all g ria della tra:.ficrurazi n . ella miniatura d"apertura di 1111 quattrocen-
t co mano .ritto napoletano delle rime lo eh ma i raddoppia nella compre enza.
in, rtita. cl Ha c ppia mitolocrica (Dafn e .\poll ) e di quella I tterale. 'i:itata da
Cupido (P trar a Laura)2Q.
front di un cr neral n.10to i n grafi o ul ritratto dipinto da ' imon
po ediamo innum r Y li immacrini di col i eh 'i ra rappre ntata. Degno di n ta
'. p r. il fatto eh la raffi!!mazion di Laura ' qua i empre accompa(Tnata da quel-
la di Petrarca. trrurne. non ecc zioni. alrinizi d lle rime in morte. dow e
n rappre enta il b I corpo di te e enzc vita'.!
10
. L'int rdi1 nd nza tra i due ritratti.
eh i pu l crcr r anche come ubalternit di quello di Laura. ha anche una ragio-
ne torica. I r h tra Quattro e i11qu nto un'iconografia d'invrnzi ne acq11i ta
r clibilit daira iazion on il 1itratto documentato del p ta. La e n u tudin
di que-to abbinamento. p o nella f rma d i du bu ti riYolti r uno wr o raltro
(di profilo di t:r quarti). det rminer alcun on cruenz ull lte drgli i.ne ori
italiani ri prtto. ad mpio. ai fran i
211
. \ macrcri r racrione allora non d ,. tu-
pi.re che n uno t nti di rappre emar il ritratto di I aura dipinto da ' imonr. \ cli
dizioni a tampa cl Ile rim compar dapprima il olo ritratto di P trarca (\' nezia.
ol Zoppin . 1 36: V nezia. Brutolom o Z ppino. 1.-38). co1 11 ancora sul fron-
te pizio d I Petrarca lione e (Jcan de Ti urnr1'. 1 -5)
212
: a partirr dal fronte pizio
de Il Petrarchisla di .
1
iccolo Fran o (\'en zia. Giolito. 1539). i incontra an he wia
ua iconocrrafia all'anlica
21
:
3
L' ffi!!i di Laura comincia arl affiancar. i a qu lla d l
po la in erli illu trativ che tabili n . arafi am nt . un e Il 11am nto tra i du .
e ondo una connotazi ne ora olenn ora amoro a. T ritrai ti appai no ad mpi
raffigmati ulr urna che nterrebb Jr n ri d i dur innamorati (Ven zia, Giolito.
208 ' fr. TR.ur pp .. 6 8: La mctamorro;i att1111ta o in OrMJ raffigurata, ad c;,1 111pio. i11 1111 111&. fiorrnti110
drl 1-+60 c-a. (B1bl101rca Apo 1ohra Vaticana. 111 Chigi L. I\' 1 H. f. 10).
209 Bil1liotr a \po., tolira \'a1icanu. 111 . Ottob. lat. 2998. r. 2. PPr una riproduzion rfr. 'Tt \l'I' 2001. 1av. ;;a. p. 83.
i'i;,l?' 11.); 111i11i11tura aggiunta a una copia drlraldina 1501. Pariui. Bibliothrqur \u1io1111lt. Rr,,. clr;,
.,_ \rlin .2 H2. Ptr Laura morta pianta la Pr1rarca ;,1t-sso cfr. ivi. ta\'\ . 118. 120, 121 (nrlrultirno ra'l(J
la fanrmlla 1 rarf1g11n11a ul (oprrchio dcl arrofa,.o).
211 Cfr. infm. : :3.6.-+ e \1 2007.
2 Il fro1111,pizio 1110 ira il ritra110 drl olo Petrarca. di profilo, in 1111 1ondo. eo11 il olito rapptH'eio. la orona
d alloro la -rri11a FR \\CE. 'CO PETR.\H(C ].
21:3 Cfr .. \ Ioni l\lllt 196-t, 11. e D1 i'ERRA\ 1995. n. 4.5.
78
1543-4-t: 154 7). at t cstando la drvozio1w prr lr rrliqui petrarchr.-ch chr . i e prime
anche in Llll ade poto, '011 ello sopra le sarre reneri del Pelmrcha e di M. Laura: il
te to (f_,a11ra, eh 'un , olfu Ira le Donne in terra ) a ompagna l'immacrin n tre po-
izione dc' I VPll11tello. notoriamr11te votata al culto di memori e tracce rnat riali21-t.
,\ltr ve i lue hu ti affrontati wn
11
ono incorni iati. in i me. in un uor . come ul
fr nte pizio drll'edizione Lyon. Jea11 d Tourne . . 1. -i. 1.-:-Q'.!
1
:;: ul ruorc- ornice i
libra w1 picrnlo Cupido nelr atto di ca11liar una fr e ia. rh vi. ibil pi in b o.
ulla traiettoria drl tir . alraltezza dei due v lti
21
".
L impaginazione delle crrigi di Petrarca Laura ri ent in mi ura ere e ntc
dell"a. fi unzionC' d<'lla loro vi nda a toria e mplru . toria di un amor nobil e
one to che ha prodotto Lmo til. che mai non ebbe cruale. donando ad ntrambi
fama immortalr. Proprio co r citano i ' r i cin laud d J P trar a di
Laura eh p . o corr dano l'inci ion . ul fr nt pizio del Petrarca n il com-
mento d I C :iualdo n lredizion \ ' n zia. Dom ni o iO'lio. r i du ritratti
on hiu. i in o,ali eparati . ma le critte in e1ite n lle ri p tti, ornici ( IAI . "OA'
\ OL I AITRO DA TE HE .L OL DE ,LI O 'Hl TY h - cT , ERA IL COR
A ME CLI OCCI Jl RJYOL I) e n i cartigli ovra tanti invitano a una lettura unita-
ria clellr dur i111ma11ini. intrecciar n I mito di un amor imparecruiabil : L\I
T DOLCE Fl L T Dl CORl AR E.
1.6 li libro i1111amoralo e il co1po del :e1pente
I due ruoli del e mrnentator e cl lrillu tratore oincidono. e zionalment . nella f-
crura di li ton io Grifo. al quale i deYe r a1 parato e eretico e icono11ra fico he COITeda
!"incunabolo qucriniano C V X . Que to gcr tto tanto tra :rdinario quanto i olato
fu realizzato in ambi nte milane e, uegli a1111i novanta d 1 Qu< ttro nto. V neziano o
padovano. il Crifo frcqu nt la orte di l odoYico il necrli te i anni in cui 'i ra
attivo il I eta fiorentino B rnardo B Llinci ni . fu runico di L lio , mico e in
corri ' ponci nza poetica n Ca par Yi nti e con il Tebald
ue Li nomi om-
21i ll u!.to compan a partirr dalrrdi1io111 t:>-+7 dtI ro111 11w1110 wll111rlliano td riporu110 nrll'rdizionr Zattu
( PHRAJl ' \ I ?:>o (ZJ, p. XX\\' ). Di\rr,a r rinci , ione dl'll'urnn 1wlrt>dizione \'entzia, Dl'11ehi110. 1586: .i due.
l>OllO nei rarli!(li ootto;,tnn1i (' l' im111agin(' r ;,rguit!I dnll'C'pitnf!io 111trib11ilo a I(' d1 ver I
in lode cli Pl'lrarca r di l.nnra (rrr. Co1.1,\Rll.f: t' \hm\ :200-+, La\. 27. p. 76). \ ell tchz1one h?n e ?el
1558 (Houillr). dovr ril'vora il n1i1ico ri1ron11111nto d!'lla tcunhn di Laura da pari<' drl poeta \lnuncc
(rac onto 1dito fin dal 15-+5). r pn'M'lll(' nn doppio rilrullO <li Petrarca e Latu-a. a 'C011lpag1111to da 111111 quarllllll
di vrroi in loro lode.
215 Per due riproduzioni
1
fr. ri;,1)(1t iv11111cnH' Cou \R!l .f. t' \hm\ 200-i. ta,. -t9. p. 119t1t\PP 2001. P 11'.l.
216 Cfr. 1111che 11 idizioui Lv n. Cuillaumc Rouillr, 1;;;;0 1 1:>.>L d ' e i ritratti -on cirro11dati d11 un rnorr ('011
Cupido<' Fama.
117 P1r una riprodu1io111 t' fr. Cou.AlllLE e \ 200-t. Hl\ . -+ I. p. 99.
218 Ptr lo ra111bio di
0
om11i con Ga piu-o \ 'i conti e per In 1111nziont da parie di efr. FR1 '.O
1990, pp. -+6-+7 , .. pC'r il canzonicrr del Grifo i1i, pp. -t lH.
pren lono alcuni e ponenti di primo piano della tagione poetica cori igiana lornbar-
da e ferrar . molti cl i quali. e m 'cdremo. ri' ono ,. r::.i , 111 rii rallo. L'<' emplare
qu riniano della princeps di Rime e Tt-ionfi (Yen zia. Yindelino de la pira. H 70) '
d dicat a una alma forse da id ntificare n B alrice d"fa.te. giovane
spo a dcl La tC ' lll"U delle po tille dovC'tle prwcderc re ccuzi one dclrapparato
illu tratirn. r alizzat e n un oc hio al romanzo d'an entura uno alla favola
cortigiana ,an ,a). mo,.,tra lUla c rta omp t<.'nza filologica. pur ri ul-
tando in un omm 1H eh<.' molto 1r,c al bin mio Fil lfo- 'quarzafi o e ancor pi
al! hi ::ie lel co iddetto ,\ntonio da Tempo-:!
20
. Protaaoni. ta indiscu o d1 I ciclo di
ilhnrazioni il libro. a dalla fr ccia <'dal erpmte. che fiaura il p eta
in balia d Jr amore e della tentazione
221
: con p che ezioni. Prtrarca attraY r a il
mr:;oniere in que ta ,. t cifrata ed mblemati a
222
. Laura im ce rappr entata
ra in arne e o a, abbialiata alla paanola. erondo la moda dell'epoca, ora per
mezzo cl J lauro e cl Il meta.morfo i autorizzat dal t to. Pit eh la mute\'01 zza
d lle u mbianz . appar nt ment indefinite e irnpr ndibi1i
2
:?:l. mi colpi con le
leaITT eh mbrano preiedere al frazionamento ic n grafico del uo e rpo: la lta
in merito a quale e quanta I art ne ,; n rappr entata no11 ha a che wd r con il
taalio cl l ritratto di imon . ma on il problema I lla pre enza fibica di
Laura c ome vi" n po. lo nel an=.oniere. In particolare. nrlle rin1e in morte il
rifo riduc ckasticam nt il campo d lla raffi!Turazione. mo-.trando olo la tr ta e il
219 L'cpi.,tola drdicatoria. don -i )rage Come pia<JUf ala ubli111it \o;rra dw io lini--e rhmnilr lurnro rhr rra
gi prin<'ipiato in papiro a ,,uo nonw r come in altro rnllwne non lo \Olc\i. lodando prr grntia dr opinion pitt 10,IO
tal pirtura dc mia deLile mano ,he de omi altra. i ,dita in FR" o 1990. pp. Q0-9 I.
220 Prr il rapporto con qu >ti rommrnti cfr. i' i, pp. ?6-8-t.
221 Cfr. \llRtL'\t C.\'\O\A 1990. pp. l-18 e 16:).
221 omc ''"''rzioni \lum_,, c,,01 \ 1990 (p. 172) '-<'!mala: f. ? r. in ('urrispond1nza di e far udomi d" uom 1 i10
lauro \er<le (RtfX.'\Ul. 1. :39. prima rena nlatirn alla rru1zonr d1ll1 metamorfo,i'): f. ] il'. dow. rwl ,onno.
J rance-co '.oma "2!r. prr di Na,-i prrhirr 1111 una twhbin (R1:fL\\ I.\. 8). dO\l' i
'." 111 al111conr o. m 1111 par-;aggio rlw rirchrggia qurllo 11of'Olo nrl testo: f. :ne. do1r.
con ti libro 111 mano. e colpito dalla frl'f'cia clw ,cona dagli 01'd1i di Laura ( Et f't'rto 011 ..J1c 1oi dirl'.,lf' all ora:/
( ... lo .,trai onde \m?r 1il dw mora [Rtf LXXX\'11. H . <J . 11}): f. -f:31'. clolt' r pre ..o al lardo. Jll'r il
madn"alc I (ron fed h ali at.nliir11rn1ionr d1ll11 l'altura nri prr,.,i c)p)Ja frt'!'a rirn ): a f. 9c il frrno dd-
.d1 La.ura. _che fama ti p1w1a ( ( ... ] Indro/ d I b<l lunw leggiadro [R1f CC\'11. \ "Y. 8-9)) in preda al
dtgtun.o
1
"'rrn. 'tene tllu trato con un Petrarca dlt' <h.,rna la nw,cchtO dietro un "ruppo di alhrrL dr11agli
11
""ntJ nf'l f. 81r. il 1iaggio di RtfCCIX: f. 12-+r. pl'r R1fCCCLIX. 111 mrlt1qur.,1c11011 >0110 I!' 11nirhr
1
fr. ad e: f. 8. r: Prtrarca appan rirnlto a UllH 11na t"ompagnia di donrn (co tu11tota il Crifo
11.t dt R1f CCX '\11 ): f. 1101'. pl'r U1f CCC,\l: f. 11 alla finr;.1ra. rwllu 111nzone drJIP 1"i-,ioni (H1 f
CC f. 12.k alla fi11r 1ra. 1wr /i1fCCCLlll : f. 128r. n lra110 di ,ouoporrr \morr al ui11dizio drlla Giuotizia
RifCCCL.\ ): f. 131r. im1<rhia10. ,Javarni a uno >jW<Tlrio. pl'r Rif CCCLXI : f. 1:3-tt'. in prrahirro da1a111i alla
0
2.2::3 _' ugli 3'>)lf'lti rii co111 i11uitt e di corrr11zu ,hr contra tano 1"11pparcn1r 1u'>uali1 dr i tratti drlln don11u cfr.
.200i. r.hr spiega lt' illu lrnzioni del Grifo alla luce di Ull
0
Htlenl!1 lrlluru drll'i1111ro f"Ol]JllS; r rorrr ll o !'
<'OrNdtran ti rapporto Ira illu. trazioni I' 11-.1i dal p1111to di 1 i,11:1 paradi"matko. !"Olllr in. iem di luorrhi chr
I .'11.'."''rat'.'r'. pn'_ rnti. 11111 il punto di 1i. ur i pub far 1al1n ,olo pc-r rordinc Qu -
rrruano. 1 ht 1 drH r,,o d.11110 tro. 1 talrnlta compnnde nmr "'"trai 11ga111i.
80
volto drlla do1rna:.!:H. co11 una ola<' fiignifi ativa ecc ziorn. in corri p ndenza d Ila
canzonr CCCLI '. dm< la donna 'i:iita il I octa in 011110 (f. 12-+r: ili. 2F:.!:;: la e11a
fedeli alt to fino ai df'ltaali - Laura pon i drl letto in u la ponda manca> (\.
3) e 1111 ramo cel cli palma/ et u11 di lauro trae d 1 uo hrl no (vv . . -8) - e prr-
se11ta i du<' protaao11ifili nrll"atteggiamcnto di due' interlocutori , che intcra11i s ono e
si protendono hmo vC'rso l'altra:.!:u. Proprio la visibilit apparrnt mente tanaibile di
Laura e l"ogg<'llo drll" ultima domanda che Francr co. incredul in i me
fj lurio:io. lr pone (,'on questi i capri biondi. et r aUl"O 11ocJo/ - di h'io - eh' ancor
mi fit ringe. et quei belli occhi/ eh fur mio I? [ ... ] [ibid .. vv. int rrocrata
a propo. ito della realt del proprio a peno pre ente. Laura ammoni ce il po ta a n n
far i incrannare com ciocchi. per h lei pirito icrnudo. I ' dato apparirali
in que!.ta fonna . olo prr trarlo <f affanni. \nrhe e la modalit adottata p r la raf-
figurazione in morte (-. alla lrttera senza corpo, i11 que t oano Laura pu dunque
apparire. ab ncficio drll'amante. rive lita di quel velo eh in r alt ha la ciato in
trrra:.!r. ' Ile uree iw ,; ioni in . ano. eh corri pondono a CCCXLI. C XLIII.
CCL\'! (ri p ttivament a ff. 12:-1'. 125c-1-6r. 126r). la pre fi ica
dell'amala non vi< rH' problematizzata in m do o pii ito. nell r lative illu-
. trazioni la fiaura intera nu0\a111cnt o tituita dalla ola te ta. che punta da un
ottile !.trato di cielo. Con e trema e r nza. p r la canz ne : 'LXIY
228
il rifo e
gita una ra1 pre entazione eh ri e a e prirn r I e n CTlJ nz p amino della
bellezza di LaLtra pur omettendone il corpo: il crpen1e che i era a ten1ar ancora il
libro irma111orato ha il volto e le chiome dell ' amata (f. 1:32r: ill. 3). in un.immagin
che ci rip rta. on un alto di cinqu ecoli. alla Laura-fa a oncethial di Bare l'.
22-f In <"orrio.pondenza drllr 1 i,ioni ' dd p<k' ta. ad per ll1f CCC\X .. \ \ (C \ \\". 12 lr). dow_gl! ,Ptm' cli
1rd1n Luurn ira le animr heatr. e ibid. pt> r il ,ucce"i'o Otlt'llO CC '.\.\\\I ( fom1:1rnt a mtntr. a11z1 1 e drntro
( ... J }: 11r-11 que te appari.rioni. lgw-au in rirlo. il libro ' rh olto. aprrto. ron il 't'rprntello 11. .. \
dilla ctmtda. rhe la co l'i!'nza poi pt>rcrpit't' rome un a1noin1rnnno. ril'om un modulo d1e. nrt te,IJ 'u ' !!1ll ,11
ri1ru11i . .,i co111hinrr rnn l"itlHrrogazimw ( cSon que,ti ... . rfr. infra.: 3.3): cd1"i" grido: -D/" ben de a: andtor
- in 1i111 -/ r ' 11 don Jr dwggio ,na dokl' fo\!lla (CC .\\\\I. n. 7-8. ror,il"O mio).
22'.i Fa ec(eziour anrlw 111 n1111011r dt'lll' l''-ioui (ff. 113c- l Ht), nl'lla <1unl1 ptr a rigore Laura non rnppl1.'>l't1-
tt1lll i11 q11anto tale. mn nt'll1 .,m '11rrr,,i11 mrmmorfo i.
226 La rnrhUJl'''ol1zza di qtll''l!t inH'rn1imH' ' ronfermata dalla nlatin1 po-tilla. 't' la qual( ndla raiu.om
rautorr cdkhinra )1 propo;.tt 1 rr,po;.tl' rin IHh<on fra loro>. r. <' ronlmno. dal.In ,celta adotta.la per
il sogno di H1:( XX \lii , dw acc11111111 pi11111"10 lo stato di inrn,ri111za dc) clorn11r11H'. Bt W\I 2000 ha
cl"indipcrHltnza (di qur;ta L1111ra) cl111ln f'Ollh' tllplazion [ ... ) d1Jl"io liriro, ,,ulJa drl
tra l'io t Lnuru ril'Oll(hC'iUIO du Bi'oEJ 197.) (p. :36) 11), di RifCCCLl\: Dtc Br1lt11tu11g .dtrorrTl'XlC.. h1:i
a).,o darin. Laura nun rinnurl "t'"<'thtiincllil'h wird. - da" i.,1, urul zum amll'nt. ,ie de, D1dmr, \ erhaltni..
zu ihr [ ... ) diul1wi,,rl1 d11Nl'll111 .
22? Per 1111 nitro ,,ogno in mortl' cfr. f. 1221 (p1r R1f CC.\ LII ), do' e -,i vrd.r Lnura a bu,to. ron lt
mn11i wrso il por ta, qui rapprt'M'llllllO ('llllll' un libro 11JH'rlo. >tt unu paor11111 dtl quale :,1 Hdt' ti . 110 'olto
pi1111gen1r .
228 \rlJ'ordinr .,eguito dalla princeps, )a t"tlllZOll<' r p ta tra i) >OIWltO \ .1 .. ln \tr!!nl'. e?n:r
1111\tlti11111 rirnduta nel pNTlllO in iut 101111,,to ormni cl min1110 dalle 1erN0111 'prrrtuolr cbe m1111111uo la ez101 e
fin11l drl Cmr:.oniere.
81
P rfno nel conte to cli qu ta in olita O"(' ll <'l'O it illu tratirn, chr nrl . uo a petto
I tt ral pr mia Laura pi eh P trarca. n n r ta traccia del ritratto lipinto da
imonc. I on tti XX\ ll-LXXYIIl on im cc ac mpagnati da du immagini drl
pitt re. che cmbra int rl qlr con il libr . da dur obri p :tille:
l no ' imon hawa r tratta madonna Laura e per' fa rauc1or tal emetto. Et <la
sapere eh qu to imon ha,N1 retratta madonna Laura una' olta h <lapoi
rnl:.e ritrarla e mai non poteo farla eh te ;,e bene: e per f ere rauctor que to o-
netto. xcusanclo el pictor. come apar. ( \" .\T. f. 3.-,., margine dr;.lro)
eaue la menza dila pi tura. ma muda ubiecto. ( ibid.)
Il rifo mbra 11 n aper eh unon ne oli O'a in manirra m<:>c-
ani a la ompo izi n d l onett alr uzi n I l ritratt dicr rnolt p co dcl
- condo t to. a munat al prim dalla e ent 11za. ma di tint 11 I O'O"etto:!:!'l. La
na cita cl I dirti o \i n pi O'ata in hiav r ali tira. dando unlterprctazionr olida-
mente t rr na d Ila aduta d I pittor . int a omc mplic irripetibilit di un O'C ' to
cr atirn. Grifo riporta tutto a una mi ma c mune e quotidiana. re tando ai fatti: la
cir o tanza del ritratto 1iu cito b n una ,olta ola e !'in lulgcnza con a al pitt re
-embrano u cit dal r p rtorio della p ia oeva Ye110'0110 riferit con una familia-
rit riYelatri . . ()'li anni in ui l"incun ol vi n illu trat . il confront tra poeti
piuon m ont t orri!rian fa !ri pai1 di una on uetudin c n olidata. qui brn
p r epibile n i toni di una medi t conficl nzial alla quale . mbrai1 i:1 irat tanto
la prima po tilla quanto l due raffirurazioni d I pittor . ritratto mC' tm !ri.ullare
di cort (Mariani 'anova). al lnit della caricatura (ill. 1) . . ella <'Ila di rappre-
entare im n non Lawa contano div r i fattori: il rapporto q11antitati,o tra i du
tabi]jto dal on tto L VII. la predi lczion dcl Crif o p r la raffigurazione dei lc-
tinatari. v rio pr unii. cl i t ti petrar h bi2
30
_ ma prattulto lo status del po ta
OftO'allO. eh lo indu ad a ociar raiO' m Ili d 1 on tto alla pr pria perimza
dir t1a del rapport tra poeti e pittori. li n m dcli" arti ta. eh riporta u un cartiO' lio
( I\10. >).lo e lpi e piLt delrasp t1 fu0'11 nte d Ila donna: il ritratto ' per lui un
00'0' tto noto. h i richi cl . i dona i ri vr. he i approva o i rifiuta. h i pu
far ridipin
11
er pi pi volt . La
1
nt11ra menta) del ritratto tra i lo' tC'rra ai uoi
or hi di nta all ra una cmplice qu tionc di e llenza non pi raggiunta, di una
quela di ritratti in uffi ienti dopo uno ri11. ito. e di on cgu nza i ne inlerpretata
ome pr t to p r un mani rato ompliment alr arr o arti ta. Pi in grnC'ralr la
?)9 P r d I . I
-- er uso tcmum c. un IO nelle d1das ali1 roen\ rfr. \1 co" 1 1-+93. (3 1 ). c. B2r: cli pre. rnu rl
lf <-0netto fumo far1i ad q11P. 10 uliircto ( ... ).
230 IO ' al il cri1ldmo Ami('o di P trarl'a ptr i d tinatari toriri dci tr ti 111 11 an hr in altri 1'11 i: ad
''f'ffifllO a f 9G (' C . d 1 'Cl ' Il ( h .. '
. . Jr. ,no ' 1. '>0111 Il? . , e: 1 oggi 1 mtrrprru.1 come dialogo ira Laura e 111111 donna anzi ana
a pro!>O"ll? \'atore dd.l Olll',,lll C ) C'OlllC eff(llivanwnrc indirizzato ca una donna di tempo. I' rnffigura liii
volat1I< (. 1 dirl'libr una l'll'ogna) ncll ano di rerapitarc la mi. iva r la donna chi la a cogli( 11 mani np1rt<'.
82
lcllura drl Crifo ri se111c drl roinvolgimPnlo di arti ti e porti nellP oC'ra i ni politiche e
f e to e della corte C'd , ispirala dalla condivi. ionr qu tidiana di e perirnz mondane
creative. La forzC' ca non poteva non offrirCTli rnat ria n Ila qualr imrn rO'rrr
la ua copia ci el Canzoniere: 0110 ()'li anni in cui L onardo dipinO'c la Dama deLL'Er-
mellino. cantata dal Bellincioni. coll abora alralle lim nt d Ila Fe ta del paradi o.
probabilrnrnt di s<'gna un co t11m' da ()'io tra o da parata p r il 1ifo t o:?:
31
L
con onanzr dell'incunabolo con la ritratti tica co ,a. tr tta tra i tanz r ali tich . e
idealizzanli. sono C' \'identi. ad csem1 io ncll rompar e delh\mico". pr o in forma
di busto di profilo:i:t!_ Il ci rcolo tra pitturar poe ia ' !ri attivo: il poeta omaO'O'ia rar-
ti ta eh lo ha ritratto. !'arti ta ritra il poeta eh l'ha cantato. cd entrambi ann di
giocare ' li una eri di strategi comuni. prattutto metaforiche.
Il corredo illu tratiYo alle lit dal Grif compr nd ene rie b di d tta11li2-i
3
.
ma aneh cripti hr \i gn tte al limit del rebus. e nelle ue paO'in un r !!i. tro ifrato
ed emblematico , i m cola o tantC'mrnte alla raffi
11
urazione diretta r ali tica. La
lta iconogra fica pili radicale e diffu a n<:>l i lo - il po ta-amant in forma di
libro' con attributi fortemente allu iYi (la fr ia. il erp nt ) - titui e di p r '
una pre a di posizione molto n tta, qua i una dichiarazion di int nti. A ben YCde-
re. dunque, anche un illustrat r prodiO'O e l qua e com il rifo non ri e a na-
, condrre la propria prrdil ezione I rr I inv nzioni metaforiche. Pale m nt dott
dalla loro compon 111 ira t ica e dalla po ibilit di m tt rl in c na arO'utam nte.
tn e gran parte d IJe sue ili u trazioni pr p1io a part' dalla traduzi n l rt -
ral dei tra-lati in imrna11ini. I metaforici chioYi di R1fXL\' (,. 9). che, onfitti
n<:>I uore di Latu-a_ vi a\Tebb ro Cli todilo pi dm Yolrn nte rimma!!ll del po ta,
prendono con istcnza mat riale a f. 19c. con tmin,enzi ne ,1, iva effica che i
prolunga. non completamente gin tificata dal te to n lrillu trazione rclatfra a , .\1
{i doloro. i ch iodi eh trafiggon il libr mbrano o tradmT i wl nosi ' t echi
he feri 'Co no il orpo d Jramant ). \naloO'am ntc. a f. . c. in e rri pond nza di R1f
L X \'I. 1111a gragnuola di fr cc e e eia una fin tra va a lpir il libr , pr n-
el ndo alla letrera i primi lu ,crsi cl I n tto (Io avr mpre in odi la f ne trai
ond mor m a,ent' gi mille , trai i>)- e a f. . Br ire. d O'lli faci > di R1f .\'.
doli alf amante in quanto vcnO'ono da Laura
2
:H_ dinnlano_ con oluzion pie i -
la<' con tu1 swplus di ma1eriali1, una fiacc la_ una fr ccia una p< da diretti ,er o
i] lil)rO e av olti in un cartiO'lio e n la ritta D LCl.
2JI me>. rr ,\ntu11io Cri \'en 1ia11 rhonpano d' \111 onio \!aria (la noia di Leonardo (Londra..; h Lihrnry.
c:od. J\rwulrl f. 2:>0r) 'li legg in \hRI \\I e \\O\\ I lJQO. P 15 . ). Cfr. anrhe G \ffT\ I l}'.)C), p .. 1. I er Leo
11
ar<lo
e Bdli11doni rfr. infra. * 2.:3.
232 ' fr. BR011, 198:3. ' ugli C\entuali rapporti l 'Oli In ri1raui,tka dd ttmpo. ad e,empio ron il di Beni rin
d'Est di Cinn Cri 1 foro Homan o con la Pala a Brera cfr. \hRll.\I \O\\ 19lJO. P I . t
233 Perfino Laura nudu. 11 f. 91 prr R1f.\ ,\lll , n . l:l0- 1;)5 t' a r. -1,. prr CX.\ \'I.
2
" C 11 (' d f I 1 p 0 c1 111' ooni uecid1nl( che ,;,n la nu1<lon11u
.,4 omc hian,c1 lu n, .omemorun o ra :.l' lltt' < r:.111101 t ,.
Laura lui lo togli!' in huo1111 pnrl<', fo il prrsm1 0011c110 comr npur (1bul. ).
83
Appar qua:1 111 vitabil allora. eh la fanta ia dC'I rifo , ia colpila dai Cl"i
pi'1 decritti\'i di Rt:( ,C _, xv. he. riC'\'O and . dopo la morte di Laura. il tem
1
o
d lrumarnoramento ( n . 9-1-). i off nnan 1tlla b Ila pregione dC'I . uo orp
(le arni. i capelli. la bo ca. alj o hi):
\luri eran dalabastTo. e 1 tetto d. r>.
cra,orio w,rio. et fen ' tre di zaffiro.
ond 1 prim opiro
1111 rrmn al COr. C't giugn r (' xt r lllO:
ind i mrs:oi d.\mor armati u::icir
<li e di fo o. ond'io di I ro.
coronati d-.tlloro.
pur com r fu . ripensando tr mo.
O- un bel diamante quadro. et mai non
,.i i wclra nel mezzo un eggio altero
O\e. sola .. edea la bella donna:
dinanzi. una olonna
cri tallina. t iY. no-o orni pen ero
criu . et for trnlucea chiarament
che mi fea lieto. et o pirar OYente. (R1fCCC, X\'.'"- 16-:30)
Il pa aaaio alrillu trazione (f. 11.- r: ili. -t ). in oraaaiato dalla m dalit int ra-
m nte metafori a c n ui ' condotta la pr . ntazi n d 1 corpo. a nera una ca a on
du fine tr riquadrat di azzurro. alle quali i affacciano du auerrirri in mmatura:
tmo di lor o ca una fre eia infu cata (di a tte) in direzion del lihr -mnante.
n l quale ono onfitt tr fr ce. mentr raltr ha in mano una fiac ola (di fo o);
a f. 11:-v compaiono la colonna e il e gaio. u I quale ' fi a t o i I lauro. Ila te a
i pirazion ri onducibile la tend nza a r iftcar tealralm ntr i conflitti int riori
e ad a e ondarr l p r. onificazioni n i loro a p tti pi con r ti: a f. 12-tr I' aut or
chiede aiuto ad Am r p r cantar di Laura (Rtf ' 'LIV) a f. 12 r lo fa citar<'
anti alla aiu tizia (Rtf ' 'CLX): a f. 6-ic il dialoao fra anima e cuor li Rif 'L
fi!mfato . ull du paCTine del libro ap rto (e n un lto un cuor trafitto). mentr lo
guardo e trrno r for r indifferente di Laura e di more ' prr so dal I du pie :ole
t te c_he i affa ciao in alto a ini tra (" - Ila n n. ma e lui eh crJi aovcrna [ v.
7) ). Di que te forz' a. tratte rhe div nt ano prr, onaO"ai ' pi na la poc ia cort igiana'.!:J\
ma lr loro potenzialit i iv . nella t ria drllc ill11 trazioni al Ca11zoniere. saranno
111 e a fruuo olo molto pili tardi.
I rami drlredizionr Zatta (1T6)
lo di tipo alJ aorico. mo trando virt
fruttano di I r fercnza 1111 pr cdimen-
cntim nti 11 Ila forma prr:onifi ata di
Bo\Clt\ 'I 1986 (p. -+9) e \h11'1F.R\I 2003. <'h ha c\idr11zin10 il rm1prro di rcrlf
11><Ma1 ,h[no\ "Il'> il c111 "trn(l'rn cli - aera ar. p .. [ J r 1 I I J
. . ' r } n ><'11t,tZ1onc . . . \1enc '" 1ce1nr-111r a co11111< crc con n l<'n< rnza
clcI BOJarclo a O!()!!'lll\'arc e teatr11liuan gli &Iati d'animo (di pcr 1ipica dcll'ambic-nlc cnrn1rio11alc) (p. 105).
8-t
figure umane. talvolta ntraddistintr da attributi, chC' i muovono in i me al
poeta C' a Lauru. AnchC' que to apparato illu trativo. orn quello d I Grifo. non
i atti ur alla 'vi 11alizzazion pura e . emplir . includ mio qua i i ternati a-
mentc uno i;carto di en. o. un di pilt iconi o aaaiunto dalla . crlta all aorira:1:3u.
enza contar<' il .a lottiero ana roni mo di molt yian tte. pr pri in que ta
dizione. tutta,ia. che i reai tra una tardiva vi to a riapparizi n d l ritrat-
to di Laura. L innum r voli raffiaurazioni eh lo riauardan n n i r 11aono
ulrintento cli riprodurre l effigir dipinta da 'imon . ma u qu Ilo di e plicitare
iconograficu nu11t c l"irmnagine di Laura z quanto imma(fin . in quanto ritratto.
oggetto Yi ivo clir occupa un po lo nello pazio e provo a r azioni n I po ta-
amaut r rngli altri pcr ' onaaui. Il ritrall n n UO'ual nelle vari o orrenz .
che lo mo. trano chiu. o in una ornic ora r ttangolar ora ovai . r n n compare
in corri. po11dr11za d i sonetti LXX\'lI-L\..XYIU. L ditor non ha bi o11no di
illu trare il di11irn pro1 rio p r h pu' offrire ai uoi lettori una trouraille pi
prezio a, la riproduzion del vero ritratto di Laura. il o idd tt rilieYo Pe-
ruzzi i:i: : ri11Ci),iOIH' clir lo raffigura camp aaia in una po izione cli pr tiaio .. in
apertura drl !->C'condo tomo. d ' orrcclata da una lettera in ui il proprietario
dcl pre unto rrperto -;pi ga che r pera di ' imon ra in r alt un larnro di cul-
Lib rato da ogni urgenza r fer nziale. nelle in i i ni il ritratto dfr nta
un e p cli 11 tC' \i i vo alla d li p r onificazioni. on I 1uali interagi ce
in un ronl to allegorico. La . ua prima apparizione i colloca in una tipica -i-
tuazionc di \ ' a<d1 aaiamen1o mcm rial . i pirata a Rtf :
Il P<'trarrn in ima wrde ed amena campagna. che tenendo in mano il ritratto di
Laura. piange nel riguardai" il . as.' o u cli cui era olita edrrsi. in \'icinanza I I
quulr un i u11 palagio con due una,. r'o \lezz d e !"ultra wr o,
ll!' : e alquanto lungi da que to 'edesi tma praderia "paziosa. Opera del wnor
Harto/0111111eo Cril'elari. (Z. pp. L \\.\'lii -LX. x:)
236 Pu t,,tn i1111re"a111t nrrnrr lr i11tt'nzio11i 1ltll'l'cliton' 11t'lla prefazi n '. dow. trn i mrri1i ct,1ri1hrci
rlw abbrlli-rono rrdiliOm'. tgli r\ rndica ('()Il orgoglio "li 111111.'llliri ritrarti tiri p trarrn. \liul0t.lllll Laura t'
C11,t hc-tro: td 1tltn, i 1111111c'ro' i mmi lnrnruti dn dili"t' llti i111i,ori. co quali ahbiam 11011 '111111 rug1onr pen,,ato
di rii mpim (sir] i 111t't''"1rj \ 1101 i di p11md1i fogli : t' rht 1,prinw1.1ti . ono _riclta ,'mto
quali si 1ron1110 roll oc111i . 10111t JHIWioi 11ppie110 10110M't'rt' dalla d1duaraz10nc rhl' si t' pnn1ts a (Z. P X\ ).
Ln Dirl1i 11 r11:rio1u cl!' . rn111i rn111111uti in q1u. .,10 pri1110 101110 si 1rova alle pp. Per focili.rnIT
rintcllirrcnzu dr tlltlllt'l'O'i l'Ulll insrrit i 111'1111 pnst'lllt' li Ostra rdizione. 'OlllC't'(' h 11llt1>t\ I ad lilli\ quukh llZIOlll'
o 111oralt tiri P11rnnn. nd co111p1111i11111110. dO\t' gnuno de rami -ar
J1N't"1 ario ,om111i11is1rnn 111 ('llri 1
0
0 lrggiton 111 scg1111111 Dirhinrazione, col 1101111 in,itmt de loro dihrn1t
1
m
1
sori (iii. p. L \\\'lii ).
2:n ' ul rilic\!l P('runi 'i ,offrnna TR.\PP :WOl. pp. 1- l :H.
238 Ptruzzi p11rla di un marmo molto raro da me ritrornto nt'lln mia 'a,a. in cui rolpito il riuano dr!
110
P
J 1 I I d <' 1ml111i in dm\ da imom \lemnu
trar<"a, e d1 \111clo1111 u Luurn, fn110 111 rn1nmo a 10 un 1r170 e 1 irm< 10. argo u '. . .
t
I Il " I ' I "t 11' 111n ft<"11 s11b \nno Donum \I( CC.\Lllll.
cu torr e111,1-, rn1111 n
1
1
1
1un-,cc < 11 1,rn1.J011t' e 1e \ 1 r: 1111011 11 .:i 1 > ' .
I I
f 1 p 1 I ' 1rt1 , tome di"i nt'll \ ffadcnua della
o erre o chr p<r n1rn110 appunto 1 r11arC'a qui' 11 u, ,
Crusca( .. . ] [Z. 11 ].
L'illustrazione (Z. p. 222) cYoca una lit udine m , ta ra111111cmorante e d
f nna oncreta. n I ritratto che P tra rea tiene i11 mano. alla prr. cnza interior
e-pr a ai n-. U-13 ( 1 Yolto. et le parole che mi tanno/ altarnrnte conftt
in mezzo 1 e r > ) . Lo LC ' pa acrcrio lalrimrnacrine mentale al quadro I iccra
la \'icrn tta che ac ompagna Rtf .. LXXXIY:!:iQ e Rt:( ,LXXYI (Z. p. :38 ). <lo\'e.
econd la Di hiarazi m". Tl Petrarca in e mpacrnia d ,\morr. eh ali pr :-.enta il
ritrntto di \f[ad nna) Laura, pa a intr pidamentr la O"ran ,' elva cr \rd('n11a. Ope-
ra del iu. Jacopo Leonardis (i ,i. p. LXXIX): il ritratto 'aie li accompagna
il po ta e ali perm t1e di attranr are enza paura bo bi in ho pit i rt selvagO'i
non altro h la co tante vi ione interi r dc I ramata (cli i ' I ' 11raJ i occhi. et
Yeder co parm Id nn L donz lle. l on abeti t facrgi [vv. 7-8)). \nche in
riferim nt a R1f 'XIII (Z. p. 2-i8) rin i ion d forma atti,a ali virt pro<licrio-e
del ritrntto. tali mano eh onforta ramante O']i rid e racrcrio: Il P trarca ,-icn
orpre o \iacrgiando da un orribil t mp ral ace mpagnato da balrni e da f ulmi-
ni: ma ali a i tito dal coracrcrio h l rianima, mo trand crli il ritratlo di Laura.
pro-ecrue enza purno att rrir i rincomin iat uo Yiacrgio. Opera del ig. Jacopo
Leonardis (Z. p. L 'XIX)
2
-1. L compar deireffiO"ie i infitt cono nell rime in
mort . do,e a di,- nta ocr(1 tto di meditazione:!"'
1
e accu a da cacrliarr provo a-
toriam nt contro la .\1ort
2
"'
2
.
Per trovare w1.immacrine del ritratt di Laura a ociata ai . 11 tti che lo e I bra-
no bi ocrna p ttar il XL ecolo. quand . in una di pen a drir Jizi n 1890 d Il
Rime ed ll"Afi'ica (Roma. Peri.no. 1890. di p n. a 1 :!-1:1) incontriamo Laura in pirdi.
:239 c,\.morr. cbr tenendo legato il Pl'trarca. rovr. ci il ritratto di Laura. aeci 11011 fia da lui 'rrhllo (Z. p. ++).
\nche qui rrffigi traduct 111aterialme111r quella rlw nel te" I() r u11'apparizionr fugare. rontrrnplaia 1wlri111111a-
ginazione: la ,; nrna rnmplr irnmrnt i pirata al ' ; del onrtlo ( c mor rhr 111 legato et I irnrni in cron'>)
e mo tra 11 p(J('la le!rnto C"On le mani dietro la chirna. e \morr dir con la de tra tirm i ca1 i della corda r ron la
ra ha appena rO\ riato a t rra il ritrauo. che <"i appare ron1r il retro di una IUH>la.
A ere ecoli di di tanza. ' mlira <JUa"i di ttre alla 1ra,rrizione di una lirica 11Hralr come certi
'oneui di Paridr CPreara - in ..e na. ad r tmpio. l'amante. il ritrano. \more r \Ione (Quando r1a111or mi troro
afl/itto tanto [CERt. AR\ :WOi. !\)): poirh olo rimmaginc rlw il poeta porta al collo lo proucrge dalla \lor!(' .
rcndenclogli sopponabil ra .. rnza drlramata. quando la perde imolomarianw111r Mila pohr. 11011 gli rNa dw
un modo per alla mrcltlc arciera. \a. conder,i tra le ali di \more.
:2i l cli Petrarca allo srri 11oio, rh on att nzio111 rimira il ritratto di Laura, apJJ"'" in una ta11za oruata di
q1ri emlilrmi e pri11w11ti la Poi ia e la di lui gat111 a ba ><ma un piedihtall (Z. p. I [R1f CCL\\ 11 )): cli
P!'trarca a>-.iso \irino alla che piange addolora. 1r1111H1o n llr mani il ritratto di Laura (ivi. p. 1:38
' 'X\ llllJ:. cli Prtrarca mirando rf'ffigi di Laura rinfarria al proprio lntclleuo di 111J11 a\er pr vcdma
la dr ler mon<> (l\'I. p. !il [RtfCCC, XX)). La cdichiarazionP d rami rnnt nuti in cpw. lo -,rcoudo 1 mo r
allf' pp. xiij-xi\.
2-+:2 Il rhe rn<.tra alla \lonr il ritrailo di Laura. rimprocciandola d'a,er di!itnr11a un'op ra b Ila (Z.
p. i2 (R1fCCLX.\ \111)): cli Petrarca. circomlato dalla \ti seria. dal Pianto. dalla Tri,11zz1.1. dal Dolor<-. e claLrAn-
dw \lort1 come cagione di tulli i uoi mali. per aver u ci'a Laura. il cui Ritrauo I mo>tra (h'i.
p. l ;>i [Rtf CCCXXXII)); Il Pmarc-a a i lito dal C ru 1gio. i piratogli dalrr rmpio di Laura. il di ui ritrat1
1110 tra alla \forte. provo<'andola a pri,arlo delln vita (hi, p. 193 [RifCCCLVll )).
2i3 LimmaginP riprodoua i11 lEo 2003. p. 101.
86
imm rsa 11rlla Irti ura di un piccolo libro. r all a ua de tra. in won<lo piano. 'imone
1artini intento a ritrarla, srcluto u una panca <li pi tra: ali pall del pitt re. un
p trarca dai tratti molto dantr chi conten1pla rapito la donna in cam e a. \'o-
no tantc la frdrlt qua i pedante delrillustrazion . i veri celti p r ac ompacrnarla
(R1fL, XVII. v,. 7-10) ri pc chiano una l zion anomala. hr ott linra la natura
cele tialc drll' opra ma cmplifca il viaacri ultraterr no d lf arti. ta. La <li po izio-
n delle figure ci irnprdi.ee di veder il ritratt di Laura, che il pittor ti ne rivolt
v r o <li &r: siamo ammr si ad a .. i terr alla na cita <l lrimmacrin , ma. ancora una
volta. 11011 possiamo guardarla con i 110 t ri occhi.
8.
C:\PTTOLO 'E O DO
L.EREDJTA Ql \: R 'E\TE CA
2.1 Dopo Petrarrn
\el Can=orziere. il dittico formato <lai onetti L \ \ U e I \\\'Ili ce I" m r-
grnza & corsiva pi I tlcne drl trma delrimmauin di Laura pre nte e a ente.
il luouo <lei te to in cui il I roblema d l ritratt i plicita in un incontro di p e ia
e pinura .. ullo :-. fondo di una fitta r te di rimandi r orri pond nze. La lradizione
che ne di.Tende ha l caratteri tiche di u11 v ro proprio ttoaener . eh i affenna
preco mente nrlr li' po tico. Ricono iuta re\ idenza di que ta f rtuna. re ta da
stabilir quanta partr ,.i abbia una cowa1 ' 'ole memoria po tica di Rtf I XXHI-
L ' VUI e quanta inwcc la emplice forza di attrazione del tema.:'\ l uattrocento
I trateuie irnitativ adottate da chi crivc ,. r i ul ritratto indi ano Uil oma2aio
intenzionale ma profondament infedele. al dittico. Il onertim nto dci modi
<leali int nti di Lllt m cJ Ilo pur dichiarato va di pari pa o on rindifferenza per i
M1oi rill i macrote. tuali : cltia iato ulla propria funzion prati a r fer nziale. il
. <metto ul ritratto i tramuta in un modulo infinitament rip tibil . monaci i lata
dallo fondo del! rac lt ' P a alr tern . nel ritual mondano. Qu ta tend nza
i lega in parte a ra ui ni di ordin torico ociale, in part alla pra i ai aratteri
della poc ia cort i1Tiana.
Limp rtanza dapprima r nt p i in ludi! il d l ritrano f!mratirn t nd
a oincid re con l'affrnuazion di i tanz d'oc a ion di pot re. le0 ate al uo
ruolo nella vita drll corti
1
: i m ltiplican I atte, tazioni del rnlor ri on sciuto
ac
1
li arti ti in parti lar d !l'importanza attribuita al ritratto in tutte I manifc-
. lazioni dell ' autorit e nrlla m moria t ri a di rn, ate e dina ti . p , o 'On ali
te i comntittenti dci ritratti a in aricar i po ti al loro IYiz10 da loro proteui
di lebrar i pittori , I 01 r I dam i ' iun ri eh , .j , on raffiumati: i Y r i
hr ne dC'ri ru10 :ono pr d tti in , rie, improni azioni da on umar app na e rn-
po t p o dal vivo e . n ra ' mpaunamento d I liuto. \Ll1eati alle ritualit
1 .\ellt' cor1i il ritrailo hu u1111 f11m:io111 irnportami' ima [ ... ] Di pri,iltgi a_,,ui d1e a Fin.'nzt r1.1r1i,111
pot god rt' 111lla eco11d1111wt d!'I Qunt1rofe111n rwllt rorti. e 'Pt><'iulrnente al rhino. Ferrara. t' \lilnno
(C1sTE1 1973. PP 1 o.>0- 1 o;; ).
89
dell'encomi e delrocca-ione, qu ti t ti ffimeri raccolgon e i11 ieme ol lit rano
la traccia pelrarch ca. annullandola in un I ulo di rime e . intugmi com nziona-
li. \eali te i anni, rappo110 del di:.C r:.O UllUllli ' li O uJle arti (' l'influ nza della
po -ia n olatina detcrrninan tma orta di sec ndo ( d po qu li pet rarchc o) allo
di na cita d 1 a nere. riportato ali u fornw tardoanti he. ,li pi<rramrni compo-
' ti da ali umani ti contribui cono a Ii ar una rie di fortunate formul (d ta
o
manu . inaenium et ac ). m ntr . n ali ultimi le nni del . ecolo, la ri coperta
d lla Planudea ff re rnod Ili p r , in latino e in Yolgar . le opere cl'a11 e i
loro artefi i patr ni
2
. La diTezioue imh c ata dalla crittura sul rii ral to i spi ga
anche aJla lu e d W voluzion omple " i' a !ella poe ia c ntemporanea. in ui lo
traordinario ucc p tumo d I 011=.oniere i realizza un tan-
ziale traclim nto ( antaaata):
[La lirica] ar proprio lo trunwnro len rario nel quale nwglio i ricon -,ce e .,j
la ri,i.lt cortigiana. \ on una lirica pr ()'rarnma1 iramrnl c pr1rarrhi-
ta. ma nei fatti fonemente petrarrhragiantc. I a ricerca di Pr trarcu di una parola
poetica
11
anciata dal contingrnte e per" 10 dalla 1oria per
ribaltar i neirimpul o de i, i,o da10 a una poe ia immcr!'la 1otalmc111r nel contin-
gente r nel o ial
3
.
La r alt. il m n lo. la Y:ita ( d lla ort ). la inaolarita d i momrnti e dei lu ahi
tornano a r !amar i pro1 ri diritti. e riacc dono allo pazi d Ila po ia pr prio
attraYer il mod li che da quell pazio li a\ern I aneliti- un linguagcrio eletto n 1
quaJ trndurr filtrare 1utto il po tabil . 111 1ue ti anni mobili. di drfinizione. come
i concilia un dice he teJ1de ad annullare I diff r nze con un nH' aaaio vario e
pluraJe. aderent aU. e pe1ienza, I otenzialment ine auribile. dci in<Toli e cl i gruppi
oriali? Lc p dirnt eh I rm tt questa mediazione, me vedremo, r la elida calia,
la rubri a in pro a. t n-a di mezzo tra la liri a<> la crona a. oali a ulla qual id po-
ita. nei uoi dati nziali. la realt d1f' n n ntra n Ila poe. ia. In 1u . to e nt to
e in anni in ui il Can::.oniere i mm r dai mm nti. il libr cli rime tenei
a perd re la propria funzione ,ien riprop to. mai. dai porti he non , ono in
ontatto on l orti". Il p trarchi mo attribuir alla forma- anzonicr un rilif'vo ,e-
coodario. ma. ome ha o . r ato Malinv rni. opportw10 ri 110, cw, alorizzarc
anche forrn rudinwntali. appro imativr cli oraanizzazione int ma. r li lin uerlc.
con 1 loro p cificit. dal!' a p tto indiffrrenziato dell illo<Ti- oll t t >re '.
:! U r. s11pm . .' 1.1.
:'} .'amaaata. imrodu7iont 11 1996a. pp. '\Cll- \C\ .
4 u quc,to t1111a. fondanw11talc .'"nc1n 199:3. pp. 11 -:io.
. ) Cfr. 1998. p. 700. doH i ChtiPnr. 11 raforw. l'utilit di 1111a nozio11r 111<'110 ri idu <li canzo11it>rr prr
''udiarf' la IHNrn pot!.iH d!'I X\' 'Nolo.
90
lclJ'acrogl ipn i I ri I ratto. il la bi I ron1anzo delle occa. ioni cori igianr valorizza lr
componenti narratiw C'd cnc mia tich dPl t ma. a di capito d "li eC'hi trutturali
m tapo tiri. La nwditazion ulroprra d'art ' o tituita da un Joaio pili diretto o
dai frammenti di un raC'conto lirico iu rni il ritratt oprattullo oaactto d l dr ide-
rio. aiutante o 111 diatorr. 11 mod 11 del dittico p trarche co (.' 1.-t) circola in formf'
parziali. che :i co1Hrntrano di ,. lta in \'Olta u . inaoli m ti,-i (tra i pi fortunati.
rillu ione del ritratto qua i-vivo. il confront con i urandi arti ti d !l'antichit. la
fuuzio1w consolat oria cJ Jl'imma
11
ine) o li combinano. nello te o t to o in una e-
rie continua. Contemporaneam nte. alla compo tczza dell'archetipo fa eauito una
notevolr rnoltiplicazionr di ituazioni enunciati\'C. Il onetto ul ritratto pu orari-
\'Olg r i atr arti la. alla donna. a un altro p ta. ad Amore aJla atura p r onifi-
ata. In icm al numero cl i po ihili dc. tinatari int mi. r c quello cl lle \'O i che
prendon la parola n I te to
0
: attrav 1" la pra i della crittura in per ona di.
e plicitata o m n dalla elida calia. il I o ta intr duce a parlar figur r aJi o imma-
ainarie (un altro a111ant . h pu e r il ianore. ma anche p r onagQ'i femminili
e oggctti)
7
. Il ritratto continua ad e ere I' aCT tto della rille ion olitaria d l poeta.
ma pili pc so diventa I o ca ione di un incontro cli un dialoao. re,, nto imorno al
qual<> 'i raduua un aruppo di ,. i. in uno , nario poeti h ri pe hia. ul piano
della finzione. il ruolo delle inmrnaini n Ila \ita d Ile corti. L'u di omp IT te ti
ll p r. ona cli o in n m di (pro) i pon aali antipodi d lrunit ( d Ila o-
ria) d Jrio 11 I an::::.oniere. per quant i f ncli. parado aLn nt . uffa unto che
d'amor<>. anch u om1ru 10n . i ri' lo alla mani radi P trarca. u ta ten-
d nza particolarizzante e prim I ia nze d ila c mmitt nza i nutr d I rapporto
con oggetti <' occa ioni concrete (doni, \'ia<Tai, ri correnze) dcll'allaraam nto terna-
ti o tipico d<'lla po ia cortigiana. h giun ad ac oglier rnoti'i pr pri d 11' l aia.
Nel momento in :ui la r alt chiede ai p ti di parlar del pre ent - celebrand lo in
modi ra olenni , ora arauti e aa lanti - la p ia ri copr l pr pri p tenzialita di
ade, i n e temporan a ai fatti a ali oaactti. eh in idono. da Jlarull a J.Iontal ,
con I u compon nti l aiach ed piaranuuati he8. u ti aen ri pi d ali altri.
non imp rta se an h n ila r alt , lo nella fnzi nel tteraria. incarnano la par-
t cipazion materiai ' d ila po ia alla vita deali uomini: ono icrizi ni. bialietti di
6 l'n poo,ihil(' modo di clu-,,ificarc i ca i di cl3ild"edid11 proprio jc n11rhdtm. wem dn' Ct'did11 in den :'.lund
grlegt wird (l\.n,,7 1981. p. 2:3.-) .
. Ri prtto alla .mmocinatio. linra di pen itro per, ,1i111zionr che cl ri,a 1d i comur'.l' in e
n11rrati,i. ma i ampiarn me irnpiecratn andrr in po;,in (ud r,rmpio nella dr la d1da.'eaba LII
prr ona di 111hili n una di,,,rinziom' f11m:io11al1 piI d1t t't'torirn: rfr. Grt Yf\ 20?.) .1? I: 8. nota Q \La fo:mula
p(r ona cli - pu ,icr11ilirurl' ,in ( I) a 1101111\ in 1 tn di. [ ... ]. 'in '>Olio lr d1 . d1 [ ... J
[\ I
t'> f . / ' . . (I )., (' J>lkitl.' da llCI COdll'l llltl'OdU
r11w ci ;in 1111 mn11d1110J In orn111ln lii p1r.w11a < 1 'H Il\ 11t'11mta a qu (\ 1111 '
rono i sonet1 i di ('OrTi '>pondcnzn -,1Tit1i ;.u rommi,sionl' [ .. . ) ) .
8 \rlla nostra 1radizio11(' il so11< 1i o credila gran parft dl'llt f1111Lioni e dei l'arnutri d1'lrrpignunmu. Cfr. \lt r--;r
A !.1111996.
C) l
a mpaomun nto (come o-li Xenia crli . lpophorela). lettere e didascalie. e adt>
e s che a,. lte una rnbri a pi o meno C'ite a ci informi ulle circo:tanze. reali
0
fittizie. in ui un ritratto tato eguit e ..,ui materiali di rni ' ' mpost . oltre h
' tilla omrnitt nza eh ha ri hi t il son tt . . \la quanti d i no tri t ti furono wra-
mente r apitati n i relativi ritratti? Quanti fur no l ai darnnti ai prot ttori h li
a,- YaJl ri le ti? Limpo ibilit di risp ml r on ' i m zza a qu t d mand . che
hanno a eh far con la 't ria mat rial dci t ti con i m di della loro tra mi ' iOIH\
non ci enta daJla nere it di formulari . >: IJo lC' o proces o di ritorno alla realt
nel qual e i m tiYaJlo. tro\'ano ra i n an h i diw1"i ruoli a. unti dalla domrn.
daJr arti ta e dal , i o-no re: la donna cantata non ' pi una (o quasi) e i I pittore diven-
ta il protaa nista a oluto di un ncomio o. al contrario. i 1idure a pura e pe ..,
0
anonima fw1zi n rispett al committ m la omagaiar . Il p ta tesso , i ne ac olto
tra i oaa tti d ani di e ere ritratti. r ff ttiva produzione <li immacrini I i lettrrati
la-eia impront dur rnli n i loro Yer i.
\'ei mponim nti he in Yaria mi ura di e ndon dal dittico p trarche o mol-
to facile ricono cere. a un primo liwUo. le tra e di lllleredit condiYi a. ma la con-
tinuit apparent reata dallo trato dei mat riali le irali e dalla ario-lia dell rime.
a uno guardo pi att nto. i riYela illu oriaQ. Il fatto eh intaITTni e I>. . ico coinYolti
n ri c1itture d l t ma o iano attinti a luoahi cl i R1f div rsi da LX ' \'II-
da w1 lato conf rma il rili ,.od I ritratt (in n o ampi ) 1wl an::.oniere.
d.all altro uaa .rie la rn dia d lla prati a cli ria emblaaaio draJj imitat ri quattro-
mqu. C llt a que ta con tatazion aaaiuna I'affidal)i]it olo parziale del
r_epenm. nto d1 t r petrarch h com crit ri I r tabilir> filiazioni po ti h .
l cl I n u1 ritratto tra uattr Cinquecent api are ben pi ricca r
. naul:ic.ata d Ila t na d Ue imitazioni cli un ar hetipo
10
: t ria ineludibile e in i me
rn uffici nt come v dr mo. e non div nta anch toria di voci. di de tinatari. di
luoghi e di tempi ( . talYolta. di immagini).
2.2 Comini illustri, medaglie e genealogie
.ome ha critto P mmi r. i ver i ul dipinto di imon .Martini hann un arattere
di rn. int!ma [ ... ) del guair on sprovvi ti i te ti d I Quattro nto. eh
appruono 11 11 arnb1to delle corti deU.ltalia d l ord [ ... )e aneli a lfrbino eh pr -
9 :\l'I pctrarrhi,1110 l'w,1ir110 f>i con rvali o' . d"I 1
li I . . ' r. pn \I
1
li nirnl!'. propno qurllo le"Ulo ulla tra,111.... 1011 <11 ,rhem1
' nmr paro f"mna. d1 fonuuJ e lr sere le ,ic-ali. Cfr. GOR\f J 993. pp. 183-19{
10 1111 impo"ibiJit. f>l"f molta J>OC i d J e; . d" t d
m . . . . a e . _inqw 1 1011 an ulla pr rnza di tr''"n' pNrar hr che un
mmento \I ranu ntr 1111!1 -<mo t1ltrne11uu 111 C'Otrl<' 11 rlher,i Franco Torna \ d f"l ('fc 200 I
.hRIBO 200:3). Condhido ro11 entrambi l .. d .. ' . . . . .. 'I'. n n . 0'11. ' .. .
. . . .
1
ea 'he 1111 rllrntrl(nro da,vrro ,wrn.firal1\o ai 1wrrnrcl11su. allln 111 1111
ti mtono po Ileo appartntcm<"ntc omoae 1
1
. .
1
. nro e per que,10 1rn.11 1oso. dovrrbb tr11('r conio d1 111olt ,. mpon nu
non
11
tull<'
1
nprrrono ll'rnatJ<"O e le cdir'hiaruzio11i trorich( ('foMA 1 2001, p. I 02. notn 67). '
92
, ntano un caraltrrr <'11comia tico decisa111 ntc rnarcato. ia nei confronti dcl
1
ittore
ia veco il modrllo>
11
Lo er azio11r cogli una fa atura det rmi11antr. p rch' nrl
ditti pctrarrlw. e . nono tante la doppia pr rnza del nome d I pittorr. l'elo!!io
d I , ingoio art i sta rimanda a un di cor. > pi in liretta e e mplr o. he coimola
il p eta. r il modello I dato '> r 0
11
aetto d Jr amor e della por. ia. r Laura. non un
.oagetto d finito da una r lazion di pot r o da lll1a conting nza trin ca
1
2. Il
frne e lebrativo clie prr icd alla na -cita di molti te ti quattroc nt chi dedicati al
ritratto imponr a qur. to chema modifichr rii vanti, come l'introduzione di dati o -
ca ionali che la di ciplina el ttiva <lei Cw1zoniere avrebbe etromr J"evidentr
predilezionr per il confronto con gli antichi. I onetti riferiti ad arti ti id ntifi.cabili.
' 'ero imilmrnt<' eone piti nel cont to di fr 1uentazi ni e pere reali. a imilano o-
prattutto qua11to a P trarca arriva,a dalranti o i luoahi ornuni d l conternpora-
n o di r o dc gli umani ti ulle arti. influ nzat dalle onc zioni e dal latino d lla
tradizione rrtorica i :i : i aratteri formulari r fortemente e difi ati d I loro ontributo.
drterminantr r pr ticrio o. pcna)j2zan la con r ta de crizione d li p re d'arte. a
fa ore di trilli comr la orniaHanza al limit dell illu ione. il confronto tra Xatura
e rte e Ira ali arti ' ti moderni ali antichi. l"irnpo ibilit di o t n r la ,; -ione di
modelli eccellenti. un acrificio che non . ar enza on cru nz .
La poesia che ccl Ira il ritratto i aff rma c airin ana di con olidati tere-
otipi. che di p<' r , ' irriaidi cono indirizzano la d -crizion in canali pr \' dibili.
limitandonr le po ibilit. anch il volaar embra tr Yar nella propria Q"O\i-
nezza i1111 erf!'tta la capacit di ad rir aire p rienza Yi iva come. dopo Bembo.
accadr molto rararn nt . Baxandall ha mo trato om il ,olaar li Angelo Galli.
poeta grrtario di F derico da ntefeltro a Urbin . ia in arado cli e prim r
carati riti h(' drlla I ittma di Pi an Ilo incvitabilment pr lue alla lingua di
coloro h negli ,' te si muti. la elogian in lati.no H. Intorn alla fiama d l pittore
medagli ta attivo a Y rona, YlantoYa F rrara i raccoali un crran numero di
componim nti dencomio. opera di umani ti h ara,itano i11tom alla figura di
uarino da \ 'ere na. a ua rnlta autore di' r i in onore di Pi:...anello
15
\Jolti di qu -
. ti carmi . lehrativi riguardru10 propri) ritratti. 1ito r trozzi. alliern di
I I PO\l\111-,JI JI -+7.
12 ' ul fatto d11 1H'I p<I rard1b1110 1'1111ieir della do1111a <nntata .io l'cecezio1w e 11011 la nonnu dr. Goll\J 1989.
13 Cfr. 200:l, p. 18.
H B\: 19%, pp. :3-t-:35.
15 \ cl <'1tr111r 'i mihi par 1010 wP11i11mfa11cliq11e fmlta (C:oRDU.LIUI 19%, diw._ IO): prob'.lhilmentt'
intorno al 1-+2 o 111 J 4:l8 Jlt'r ri1wraziarc il pittore I er 1111 'an Gerolamo adorante il n:to u1 croce. og!!I pl'rduto.
Guarino trascuru il 'Cl""t'lto raffirrurato i11 , e .i co1m11tra ,ul ,mr<' "O di Pi,11111'1!0 11rl far -cmbmrc reali la
rapprr:.e11razio11t' I. flJ9-+. p. :..00). ,181a lu tra.li'
artribuiMt a Pi,1111dlo (e[ ... J Prud Il'. grn\ j, atque 1110th11i-./ \11111ifir11 pro1.mi-. ulitm,, Rlllll'
1
" [' ' _-_
28)) e I< inizinli dPllr h('fft \'i11r oul rerso <leUe 111eduglie die ritraggono I artista (rfr. 11111. "'.l. 8? l:
\rgan r criunto n ddinir(' f(' lll('clagli e di Pba11rllo Jll'(' li , perfetti ('Olll(lOllirnenti !mini. epi"nllllllll d1 pochi wr I
e rii "<fili hi la fo11urn (cir. in P11utu 1990, p. 12 ).
3
Guarino e prot tlo <la Leon llo. poi da Bor o e da Frcole l d'Es1e. Pi a-
nello per la aenero a int nzione di Jf ai ari o. per h nel ritratto (oggi I cnlu to) la
' ua fama opraYYiYcr. mentr il napoletano P rccllio (Giovannantonio de Pan-
dani), egr tal'io di Alfon o Id" agona, inYita ad ammirare( pi e['" 15] ) le
immaaini di L onello d. t di Filippo Maria Yis onti. al eauito delle quali. tra
mill altre mirabili fiaure dipinte o in i e da Pi. anello (alter Ape Il es [ v. 21 J ).
ricorda la propria effaie :
t opere i11 i!!ni no t:ro {fingere n1ltu
Quod cupi , haud par\'a e t gratia hahenda tibi.
i longo aliter mca non exibit in anno
l altem vi,et munere fama tuo
10
.
A pice quam nitide Leonelli principi ora
Finxit. et angLg ri lamina ,era Duci :
\lille alia fuu.it rnira no\itate .
Qua i.nter vivet Porceli.i effi!!ie
1
.
Due dotti poeti cli corte enhano in cena per celebrare i ritrat1 i d i ianori
airombra dei quali vivono e criYono. ma non mancano cli evo are. in po izion
rile ata. I onore eh l'arti ta ha re o alle loro t e embianz . iamo davanti a
ritratti cli per onaagi ma chili; illu tri per lignaaaio e rango ocialc per il pre tiaio
acquisito con il loro apere: ono effigi in cui qu ti uomini creano e trovano una
. anziane imbolicament f:fica e della pr pria autorit politica e del proprio status
mtellettuaJe, un ace o alret mit, e pre o dal fondam ntalf' rbo della vita
al futuro ( viv t ). In un cann ri alente agli anni f rrare i cli Ba inio da Parma,
mai tro de poitria al ervizio di Leon llo tra il 1446 e il 1449. vediamo filare
in due chiere ignori e letterati accomunati dalla ventura di erf' tati ritrai ti da
Pi an_ello: la ra egna comprende i gi citati Leonell d'E te Filippo Maria Vi-
conh. numero. i condottieri (duce ) ed umani . ti ( [ ... J vate , no tro qui tcmpore
ducunt/ e ula. quo vivo. mira tabella facit r i chiud con da F ltre.
ma tro cli Ba inio a Mantova:
16 D"altra part : poiC'h de>idcri 1:affigurar il mio mhiante C'On un.op<'ra in.sig11c, ti dr10 essere non po('O rico-
110 e la '.
111
a fama non dureri! a lungo altrimrnti. almeno 1ivr grnzie al tuo dono (I rad. rnia). Questi vrn,i
(Ad Pisanwn praestant1ss1m111n [CoRDELUER 1995. doc. -+8], 11. 31-:3-+) sono prr,r111i n li' a I dilla Stro=ii
poPtae pater etfi!tus \"c1lf'zia 1) 13 fl e 25 I I I al f' I
. . ma <e cornpon11nr11to es1,1c anc w un tra on un fllll 1
diwr,o. attestata da un manosnitto di ModPna (cfr ConO I I llR 19::. r 11 ') I . . d 11 . d 1 / ' , . 1
d f :/J. . ., . prrrn1 ur 1 m cg 1 1ro ira e 1
lrozz1 pa re urono inviali a Lronello nel 1-+43.
17 Guarda <1uamo acc11ratan1c11le nf"tri' 'I lt I I J li
, , . .... e Ile.o 1 vo. o <.r pnnnpe ,ronc o. r I a pr110 aulcn11ro d I dura ongu1grro
111
.:nct.i!lo. allrr f1gu11 cff1g10 111 morJo .m1rab1ll' e ingoiare" Tra q11l'ste vi1'r1 il ri1rr11to di Porcellio (1rad.
nua). ca
11
nr valeR romanus 111 laudPm Pisani pirtoris (C:o11Dt:LLfl.H 1995, dcw. 64] . w. 1.1- 18)
PorC'el110 [>Otrt'bbr nferirsi alla 11111lagl'a l I .. 1 I Il I
. . 1 .<e e Jrallva < 1 o pcr r 11ozzc con Mana cl Aragona (cfr.
\lou"o e \ArAH 1991 [Le Muse]. p. 11.3). Per lr ml'dagli di Lconrllo cfr. ll1u. 1930. 1111. 24. 26-32 e 21.
94
Victorinc pater. Ho111ane glori'a li1wua.
PI ingenio fu quoque vivu cris.
Idem habitus. cadcm ora viro: tumqur ili cwram
Cesaricm et ranam nwvcrat arte coma111:
Et gravitas eadrm ultu . caput illud: et illwn
Ore suo ncdm, 111it1 erc pos e onum.
Et me. discipulm, fucram qui illi11 . imago
Terruil audace admonuitque animo :
Et s!upui dr111rns. et te quoquc vivere. magne
\'ictorinc. putan . . gaudia maana tuli
111
:
ln un omaggio drttato da raaioni per onali. affetti\'e. il poeta i rfrolge diretta-
mente al sogaetto rapprc cnta1o e il topos della vitalit d lhmmaaine (vivere) i
mc cola con quello dei poteri motivi del ritratto. che embra ul punto di parlar
r infonde timore e rf'vcreuza nelr allievo- p ttatore, come la "tatua di Ale andro
.\lagno terrorizzava il generai Ca andro
19
. Gli effetti morali dell'efficri ono am-
plificati dalla menzioni" del r epi!!ramma che la accom1 a!mava. illu trando le virt
dcl socrgctto:
Et lcai ingenui:, r latum epigramma tabclli .
Dignaq11r tam pri co carmina culta viro:
lstu111 non domuit auri scclera1a cupido,
J\on mctus. aut animi cura nephanda dolu .
' 'iros docuit sacras tra tare camena
En aliw ocratrs! , 'olu et i te fuit >
20
.
n si mil e e empio di t matizzazionc della poe-ia ul ritratto all'interno d Ila
po ia te a prf'rorc ma non i olato. Gli omagcri tributati a Pi fil Jlo nei ver i
18 Padrr \littoriuo, ro11111110 per gloria t lingua (cio pcrC' li ha acquioito fama grazie alru o prrfcuo del la1ino] ,
a11d1r 111ns1<'rai1ivo grnzie all ' ingl'gno cli Pisa nt'llo. ( '(')ritratto) ruomo pos. ied gli stc i modi, lo 'lt' asprt-
to: e poi ad art qurgli (Pisa11cllo) a1c1a riprodouo la capigliatura e la cloma bian a: (nel ritrat!.o I uon!o)
h1t la stt'S'la gravit dPI l'Olto. quel fomm.o rapo. e r rcdrrcsti d1c co11 la ua hoc a po emettere YO e. L 1mmagmc
p111cn1 mr ('he ero slHIO 110 discepolo r 1rn1mon "li 1111i111i t1111crari: rimasi altonito come w10 :c!occo e cr,edendo
dw t111rhr lu fos i vii o. "nlnd<' \'it i orino. nr prny11i u1111 arnudc 11ioia ( trud. mia. dal canuc Bas111111, ad PI, I.\ L .Il
pil'tore111 i11ge11io.111111 et opt11w11 [Cono11..ur.R I 9%. 61 ]. ). qua stab'.lirr >C i r!trntti
!'YO<'uti da si1111n di1 inti o mC'daglir (rfr. i1i. pp. 1:{:)-1:37). m1111<I rnso s1 d".''('
pern,arc a 1111 ' efficrir dipi111a accompag11u111 d11 un <'pign11111m1 (efr. i1 i. p. J;l?). rhe forsr mflu111zo qut'llo
io1111to da Fcdcrlco da frli ro prr il '"o rido di uomini illublri urlio di l ' rbino (.\1.IBL\.'<I G\.'<01'1 I 98 J.
pp. 202-20.)); a noi re ta olu la nwdnglia (cfr. CoR1m 1.1FR 19%. p. 176).
19 Cfr. P1. 1ln<:o 1987, pp. 208-209 e At.BtnT1 1960-1973. voi. lii ((Ot pictum] Il, 2 ). pp. H -i5.
20 E I<' i l'!pigran111111 inciso btilla d lirata tavoletta, elt'.ganti dt'gni .di _di rnle n
lo ('ClllCJllisl 111 ccllrrnlll hnu11a dell'oro, 11011 la patml o l mg1.1n110. t'SC't'l'llhilr dell A
110111iui i11sr"11 l'inti111i1 1 con le sucre 11rn e: ceco un altro o Tatl'! ,\11rhc fu muco (uad. nua, dal r111110
carme Rosit;ius ad PJ,'J'. L\'D/ pictorem inf{e11ios11m et optimum [CoR1m.1.1ER 19%. do . 61]. w. -i5-30) .
<leO"li uma11i:,ti YenO"ono ricordati. ad t>. ernpio. nel canne 111 la11de111 Pisani Pictoris di
L on31do Dati. non datai ma f ce comi Oi>LO nel 1 quan lo il porta Pra a Roma
pre o il ar linal iac mo rini e !'ani la ra imp gnalo 11ell"e. ccuzione d gli
affre chi di an i 'anni in Laterano:
Int er pictore no tri tawere portat'
PJ '. \\O palmam qui omnia ad ungurm
7'.aluram ingrnio et mira exrquawrit arte.
. rratorum quamquarn . enteutia e l.
meo tamen herebam pane qur probabam
l lorum iudicium. , ed Clllll. proh luppit r! ip..,um
. r h roa video declucere ,j, o-.
\"i, o. alip de,,. nun 11 nus omne frrarum.
Torpidu" o tnpeo. PI . .\: :t 1 [ ad . ydera laudo.
Di r i fa L etiam ut Promothea 'ineat
21
.
.\'ono tant la fiducia ripo' ta n I aiudizio d i poeti('' 1). che potrebbero e ere
Guarino ' trozzi. ma an he Ba inio r Porcrllio:!
2
. Dati non pu na condere il pro-
prio -1up r damnli alrabilit mim tira di Pi anello. che auaglia la natura ripro-
ducendo con traordinaria verit ali uomini altri eri \'\' nli ( qu<' (ultimo un
wro e pr prio leit-mot neali logi del m <laali -ta verone e).
Il t to di ,\na lo Galli (ca. 139;- -11:59) citat da Ba\:31ldall apparti n a lma
oppia di n lli h 1 airurn l'arti ta no c mpre i nella sezio11C' pil rompo. ita
d Ila raccolta d l poeta urbinate. il : r nd libro. eh onti ne an h i 1<'. ti di c rTi-
pondenza21. P r il primo romponimf'nto (28-t ). la rubri a n I mano crilto F r cita
al Pi an llo da me er Anaelo p r part del maanifico tlaviano deali
illaldini>. menlr n l mru10 -critto \' i leaa cP r part d 1 rnaanifi o (imor )
tavian al Pi anello pi tor . H-t2>. ttaviano ra fiulio cl l trim pr t ttor d 1
GalJi a Crbino. B rnardino deuli :baldini. u ua richie ta fur no mpo ti an h<'
i ucce . ivi on tti 286 e 28 . che dowYano accompaunare du doni una e rva un
caYallo. d . tinali a France co forza. clu a di Milano. Dunque abhiarn< a h fare
ron veri critti u commi ione e for rnat rialmrnt inviati dal fHH'la arti. ta, da
parte di un ianor al q11al lo lega 3110 inroli di rviz10 di protezione:
21 In laudem Pisani [ oaoF.LLIER 199-. dor. 66 ): c l ra i pi li ori. i 110,,1ri porti a '""11aro110 la palma a Pi.,n
nello. d1e rafficrura111ICJ O/.!lli rc>-a alla perfnione (riprod11!'r11rlo og11i 10:.a con a>.,ol111U pn!'i,io11e) ll\'('\'ll a11agliaw
la \atura ron tall'1110 1 ane niirahil . A.ndw r il wrd1110 1lri po<ti r -.arro,anto. tutlavin ri11111111,o arwornto al mio
arbitrio< approrn\O .,nlo i.n parti il loro i11dizio.. \la q11a11rlo. pn Gi<>,c. I() vedo rilrnrn co1111 ,i.,..i i nosrri rroi .
i ranilli. rnm1 \ho OltJli arner risto .,tnrdito 1wr lo tupore. lodo Pi.,arl<'llo fiuo agli IL<;tri.
le<rto d1rh al punto rlw prn,ino Prometro (tmd. 111ia ).
22 \('I ,,cco11do li111011tro Ira il poeta f' l"arlihta rlcJ\nbbc CSSl'r<' rollocalo in 1111'or1"11sio11r pir tt1rd11 (cfr. ivi.
p. 1-+9).
2:1Cll,LI1987. 28<+-285.
96
' I' Cimahb cum Giotto et um C<11tilr.
eh 'a pinger 1m rr l"IJOnorala mano.
rt chi dr l'arte fornai pi:t . oprano
torna;,;.rr hogg et ere ces rr lo . tilr.
farcbbr rl nome lor pur ba!isO cl \ ilr
cl glorioso et dolce mio Pi ano.
tanto pi[1 grato cl suo til deretano
quanto t pi1 dc l'i11Ycrno 1111 doler aprile .
.\rte. a<r et desegno.
man ra. pro. pectirn cl naturale
gli ha dato <l celo per mirahil dono.
Lr . uoe figure son proprie t tal
cli 'a panr \ ivr ol gli manca cl ono:
prr de lrrna fama lui :,ol degno. (-8-+)
Il -on etto affida J'affermazion della urancl zza del pittor a un ap 1tura ipote-
tica, che impiega il lopos del up rrun nlo d l t mpo. molto comw1e n ali eloITT. di
arti ti. per tabilir un confronto dir tt tra mae tTi di epoche cli, r : 1ui il paraao-
n p r' n n tra un pa ato r mot m1l1 e il pr nt . ma tra la rina cita delJa
pittura foaai ( . l-i: )2-1 : e torna ro 'imabue, Giotto G ntile da Fabriano,
onrero i du apri pi. la d lla nuova pittura (Baxandal l) uno dei mae tri di Pi an lh
e e fo . ro ancora pi arandi. comunqu P.i an Ho li orpa cr bbe. Le terzine i
po tan -u a p<'lli pi -pe ilci d Ila ua art , qua -i pieaa ndon lo til > ( ,._ . ).
an he la lode dC'll<' uc fi ure ' volta condo il olito mot i"o d ll"illu i n cl ila
vita. della omialianza alla quale manca ol il no, pr eme 311 he nei carmi la-
tini. Qu ta truttura bipartita i rifiett n lla di tribuzione dell formule. 1 qurullo
alla lebrazione pili t r otipata d li qumiin orri p nd il le i om nzional
d .Ile rime p r ritratt (mano, e tile> ). menlr la prima terzina o pita C'lementi
pili te nici nuovi: in parti olare me ura. aer maniera appartengono alla
t rminoloaia quattrocenl ca relativa alla danza: Co, 1 alli, il p ta di rte, ru1-
dava a imilando le figure dipint di Pi anello, il piltor di cort , trru11il ' P ifi hc
qualit i iv d Ila nt mporru1 a lanza cli corte
2
.;. primo libro dcli rime il
2-1 e, p '>>O, ptr ma1r11if(1u una per ona o unn l'!hll, , i1nr ii.- erit che t'':'ll ha \'Olore di tum le al?"<'
p<r onr o cm.e com.i mili , ienr adoptrnra. in tnl rni.o. unn partil'olare forma di p:m1cro.ne. potr:.nmo defmrr
d('I oprava11zame1110': virne cio affrrmntn. di fron11 nd 1';t'mpi famo>i lrhi d11l pa1rnno1110 111.:.u-
! rriori1, anzi runi!'itI della persona o C'O>ll chl' i v11ol1 lodart'. ( ... )Lo eh Lllll dd 'oprarnnzmmn(O 'mllllll>Ct'
rl pa 1110 a tutto fnvorr drl pnst>11I<'; lo testimonit1no, fni l'nhro, lt formule taceat ... e .... ron.cetr
bnst Si r \ ilup1 ato 1111 llllO\'O ' 11011 solo il ll'rUpo Hlll iro r deltJlO di rlo<rio: tlllC'he I lllt'rltl der 111od1r111 t' d I
<011tcn1porn11ri d1vono cssrn 11ppnzzt1t i' ( .trnrrr I QQ:.l, pp. e 186 ).
2S H1N1NOALL 199-1. p. ;3!) ,. nota 11 p. 34.
ballo ' meato 111 rif rimento alla grazia alla le
11
giadria d Ila donna amata da
Federico da (31. ' " 3:- ). Ri sp tto al primo s nrll . ' he co titui ce un
elo11i d Jrarli la in 11 n rale. il ondo i concmtra -ulle ue abilit ritratti tirhe. e
C"
il le11amc tra i du tr ti' e plicitato dalla - ronda rubrica. Prr s pra dieta cauion
(F) e Pro e<o>ckm (Y):
. hi voi del mondo mai non e::-.$er prirn
\'egna a r trar dr! naturale
al mio Pi ano. qual retra l"hom tal
che tu dirai: c.\011 . anze pur ,irn,
pcrrh"el l'appar \irnce et
O mirabil pictor. he 1anto mie
ch'a la na1ura tu qua i quale
cum J"arte et um rincrc!!llO ex.cc \'O.
Credo te manca olo. ad es rr lri.
eh Ila a uoi nati d la rnce e 1 s n .
tu a clepinc fa.i parlar tacendo.
B n p ri te agli amanti wr cr i i omei.
far a eia cun de la ua amata w1 dono
rt ::. tarian emprc eco non dormrnd . (285)
La prima quartina e prime. in forma di invito, la promes a di rtrrni1 a cui pu
a pi.rare chi affida le prop1i ernliianz all"arle di Pi an 11 . la rronda i rivol11e
direttamente al pittore. viluppando il motivo accennato in 28-t. ai \ '. 12-13, che
pro gue nella prima t rzina: l'art J"in11egno lo rendono qua i ugual alla natura.
non fo. eh lei d la v ce e 1 no. mrntr 1 f!!lire del pitt re, eh mbrano
'ive dotate e.li n ibilit. parlano ta ndo:!
6
. La formula cdrl natural d iu11a
il ritratto dal vrro. m ntre racco tamrnto di ars inueniwn. con lr . ur varianti.
o
fi a in ditt lo
11
ia diventa qua i obhli11at in cont ti di eJouio
27
. Con li evr slitta-
mento. 11rll' ultima tPrzina i affacria la po .ibil e funzion dcl ritrai lo come osi il ut o
erofi co: tanto l'rt rnizzazione c.lclla propria immagine. una forma di immort.ali1 (v.
1 ). guant la 011solazione che ali arnanti po . on trarre e.lai ritrall i d J] runat ( w.
12-H) derivano infatti dalla omiglianza. qualit principr cklr art li Pi an Il o.
Ri p<'tto al primo onNIO. l" enunciazionf' r pi 1110. a. animata daJrapp llo iniziale.
26 (Jr. \\ooo. - 1987.
2? Gi i11 Ciovanni \ 'illani chr di Ciot10 al nat11rul1' ignili<a crl al vero, dn 1111 111od11l o r!'al(' o. 1111rlll'.
C'o11fonrn111<1111 allr di11u11-.icmi rcali clrl !i1orJc.llo raffig11rntn o da raffigurare oppure cco11 11110 riprod11:r,io11I' mi -
nuz1oh1t. ns;,ol11t11111rntc frd1l1 drlla n1il 111 (G/J/J). Prr lc l'llrianti drlla nippiu ars rt ingt11i11111 cfr. B\:11'IDAIJ,
I rn-.. fl
98
dalla semwcinatio dello pettatorp (\\ . 4-0) - sp . o introdotta pC'r e prim re mf'-
raviglia tupore -. infine al pittore. la mancanza della \ O e
non acrompagnala da qu Ila cl lri11trll llo il riferim nLo a Pimialione diventa
un"allu ion(' '(' :.11alme11te plicila. C'Olll (' i11 Fil lfo. rautrntico la. cito petrarche CO
. i riduce all'agaetti o po e ivo mio. clir da RtfL ' yn pa. a alla tradizione
come egno dcl rapporto. ora fortf' ora con rnzionale. tra il porta e r arti ta .
Solo llll a llllO prima d Il a tesura di q U(' ti onetti. nel 14-t 1. r ahi li t ritratti ti ca
tanto maa11ificata dal Calli non era ba tata a Pi anell o pn riu cire ,incitore n lla
11ara che a Fl'rrara lo contrappo a Jacopo Bellini p r un ritratto di L nello dEte.
in i reo tanze rie relate da Lli e d ali Aleotti e da .\n11elo Drcrmbri . nel De politia
literariaw:
ti nuper Pi.:.anum \'enl'lumyue. op timo. a 'i no tri pi ctore . in mei vultu
varie di ;,ensi:M. c11111 altrr macilcmiam caudori mco \'ehemcntiorem
aclie erit , alter pallidior m tamcn. li cct non graci liorem. rnltum rfflnucrcr. Yixque
prrcibus rnei reconciliato
2
'>.
tru1do ali paro! eh il dialo110 crli auribui. e. Leonello dunque non apprezz
veram nt n : uno dei due ritratti. cli,rr am nte dal padr '\ic l. he decret la
\'lloria di Ja opo Bellini. lJ ritratto del piltor '" neto ' di diffieil identificazion .
mentre quello di Pi anello probahil111rnt la taYola ora a Brr11a1110 ( c ademia
Carrara [i li. 5]), for eri ordata on commozione da w1 altro umani ta della cerchia
guarininana, Lod<nico Ca rbon :io.
Negli tes ' i anni in cui uarino wivr che la 11rande art con cd una rita
enza fine Principibu [ ... ] ma11nan imi >:
11
quei principi mo tra no un effetti,o
piccato irlt r p r la tra mi i 11 cl Ila propria embianza . . \ F rrara i te tma
28 C:fr. B1..\."011.1 1%3. pp. :H-i -:H'.) r t99.). p. il t' "n.L,lOIO 19"7:3. p. 10-lCJ. Pt>r i imi di dei.:li
,\lro1ti cfr. :vl'f.1.11 1892, pp. :'i-6: Quando il Pi-1111. fra lt famo.,e impre e.I <argo11a111 ro111ender con natura./
e rn111er1ir l"i1111t"i111 i11 picturn.I del uumu illw,lrl' Lionrl \l arrhese./ Gi con,uma10111ea il 't' \IO me' .I p r dart'
propriu forma u 1'11 fi!(nni :/ all or for1nm1 bdtguosa dw fura/ l'umanr glorie cum diwrM' 011f1,t./ ' 1rin5r dl{' d'.1
degna P sula rivo/><' 111oi.sc il Brlin. bummo pi('torr./ novello Fidia al nostro 7itro 111011do:/ .hl' I 1 sua 1t111 eff1 u1e
ftze vi111./ a la M'llttnzn clrl paterno amore./ onde lui primo. N poi il Pis1111 >1'1011 do.
Du lllBHIO \'I. 68. 7 (p. -+ 2 ). Bicordtlll' (' 0111(' il Pisano(' il i 111i gli.ori piuori llOslra et.
po o lt111po fn uhhi11110 di,1ord1110 uel rapprrsruturr il 111io.1oho. \l':'.'lrr I.uno ha 11
11
!(111.1!10 '.' Il a della
mia rnrn11gio11r u11u mngnzza pi inten-a. l"ahrn mi hu raff1.. urnto p111 ma non pm 1s1le. a .remo 1 <Ollll
ri eoncili111i alle 111i1 ,olll'riluzioni (uad. C. Badiui. i11 /,1 \/use. eu1.. p. 16).
30 Cfr. Le 1/11$1'. pp. 7:>- . b. 11. ++ e CoHDlLLllR I()!);), do<'. 78: [ ... ] Plemun ,1 pi1turi-.
signis. 111hulb. imnginilw,. \unquam illa111 L('1111t'lli 1hpkio quum \..r11 011itr- nuh'. mm
ud oculo 1e11ian1. ila illim, humani--inuh gr.,111 ., i111itu111r [ ... ] ( [ .. . ) li mio l' p11110. d1 ra-
tue. tavole1te i111nw,,ini. \ 011 c' volw rhr io "1111rdi il ri1n1tto di Leondlo ro1g111to 1l,1 \1110111t1 Pi-ano
s1 11zu dw Il' salgnno agli or('hi, i111i1 n i suoi "l''li [ ... ] [1rad. mia]).
:11 Pri11('ipil111s 1 it11111 divina ex arti: pen11111111/ 11111g11:111111is trib11e11s [ ... ] ( cC011ferr11do, . 1111' artt
dil'ina. l'il11 i111111ortal r ai pri11 ipi 11111g111111i111i [trud. 111ia]); sn110 i,.,. 19-20 del citato rnrn1t d1 Cu:1rmc1 m 011on
di Pi smwllo (Co1um 11111 JC)I)!) , do('. 10).
99
consolidata tradizion di raffio-urazioni d i clu hi. otrnuta dall'u . altrettanto
tabile. di cel brar que te La enealogia dei przpi d'Este, e e-
!luita tra il H.- e il 1-. 9. compr nd 16C) ritratti della ca ata. da \lb rt ,\zzo.
primo Yi ario di F rrara (109- ) a Ere l I e (amio-lia. di ,po ti in gruppi di nove e
collocati n1ro medaglioni. u tmo fond dorato per i duchi e le ron. orti:l
3
_ ono
ritrntti a colori bu ti per la mao-gior parte di profilo. influenzati da modelli anti hi
e, com 1 meda(Tlie di Pian llo. o pe. i tra i I irazione r alistica e idealizzazione
la ica . ricol'. Leon Ilo e Boro cf E te i att nn ro alru o di fi ar la propria
memoria n un uni o ritratto. - mpr ripr dotto. m ntr Ere lr I f ce r alizzar
immao-ini anch m lto di,er e. eh ri p echi a ro le ue 'arie et:
1
"': per una di
que te - un ritratt . probabilm n1 po tu mo. dipinto da Do. :-, o :,i na.
Pinacot ca E t n ) - r erudito elio al aITT1ini ri cri e un. pi o-ram ma della Pla-
nudea. aff rmando che i poteri d Irart i fermano alle qualita e. t riori: Yirtutem
t mor non poti exprirnere:
35
. La particolare predilezione c!ella corte ferrare e
per le meda(Tli . il ruolo centrale di qu ti oo-(Tetti nella toria d Ila ritratti tica.
i 1 o-ano infatti all'id a che reffi(Ti del orpo dev'e ere a ompa(Tnata da un ri-
tratto delr anima: condo rin. !lllam nto di uarino da Y rona. le immao-ini non
accompao-nate da un commento critto rimano-ono mut
uc t modello icon -
o-rafico e eone ttual a(Ti ce Yi to am nt in molti ritratti o 'i in uno dei piu ce-
lebri dittici d I uattro nto. quello in cui Piero della Fran ca (H10/20-H92)
raffio-ura F d ri o da Iontef ltro la on rt Batti ta forza ( ircnz . Cffizir
17
d bol o-iu tamente onte tata f. la po ibilita di riferir a quc (opera un
carm attribuito al carmelitano iovanni A11 lr a Ferabo , che oagiorn a rbino
intorno al 1-65 o v r o il 14 -:
Imago eiu dem principi a Petro Burg n. i
pi ta alloquitur ip um principrm
G11xit magna oler haud arte Tima11t
qui capit aut fai o palmitr Z U;\b aw .
Parrha iu tabula. Euphranor non marmorr culp. it,
32 CORIUDl\I 1998. p. 22.
:33 :\( r;,istc un fac-.vimilP ( 1996). dr. Le Jf!lse. pp. -+9-38.
:3.+ ui ritraili di Em1le I cfr. \h'\C\ 1989.
;35 cExprimit in rabula Pha'thontem Apell1"./ -cd lu11111 et radio 11011 r\primrrc./ .'ic tua. mi pri11-
c P . Do;,;,1i- forte exprimit ora./ virtut<m rt mor<;, 11011 potb <xpri.mere ( ci\prllr cli Coo ra1 pr<s nta Fetontr i11
un quadro. ma non rapre,111tar la luce e i raggi. Co,. o mio prinripr. prr 11 v,crllura Doso rappr rn111 il
tuo a. pcllo: 11011 JJll'.J 111tar il ,aJorr e i cchtumi> (trn<I. mia]). Prr 1111 1or11mrnto al te. LO. che cito da
l IL,10\ 19.3.1. p. 179. nm 10 a Botzo\I 2008. pp. 15-+-1 :J6.
36 Cfr. CoRJtADl'lr 1998. p. :.14. ro11 riferimr11to all'rpistolario di Guarino.
::1_
7
dataziorw dci du' dipinti molto di,111 sa, rollcwata da alcuni intorno al 1472, da altri al H7-+. dopo cht'
hdcrrro a\r\a 11vu10 du ."i,to I\' il titolo di dura (rfr. 801..zo\12008. pp. 151 - 1;):3).
100
rghotrlr.., g<'mma. t'I i11 patrra.
11rc PnL\iteli- ippi vel rleti
rarlat u. qur [ ' ]copae pltidiarhaqu<' manu.
\ ::.1 nrrYo mihi dat rum rarnibu os a.
das anirnam. Princt'p . tu detatr 1 ua:
'ivo igitur. loquor et eio per nw possr moviri:
gloria Rrgis prae tat rt artifici :
18
.
Il te to aagiu1w una voce l ruliar al dial o- po tico ul riLratto. r up rando
uno eh ma enun iativo delrepigramrnatica antica - il ritratto parlante - per ap-
plicarlo in liii COlltC:,tO llC mia tCO. 'om Ottolinea la dida calia l"effi!lie te -
a che i rivolge al io-nor eh rapprc enta. e lebrando r arti ta attraver o il topos
del!" ( 'berbietung (Curtiu ): il opravaHZamento degli antichi da parte d i mod rni
qui interpretato in modo divcr amente che in Calli. e contrappone una
hmga . chiera di pittori, cultori in marmo in bronzo d li antichit al moderno
Petru . I nomi deo-li ani ti ono accompagnati dai materiali propri dell r lative
arti ai quali Piero ri-,pond on r fficacia delle o a. della carne dei neni che d
alla figura. ltre a un corpo traordinariam nte naturale". il uo ritratto ha tm"ani-
ma evocata. sul piano della fllZione. comr d no del princip alla ua imma!line (v.
8r'l_ e e. ihita. sul pian r al . dalla CO truzione del dipinto: ondo UH chema di
a ccndenza numismatica. rall goria il m tto ul cerso (Federico ul carro trionfa]
della Fama) completano con le qualit interiori la rappre ntazio11 del o(T(Tet1o
identificato ul recto"'
0
do,e il solenne profilo dcl du a n di l'animus regali e al
contemp n la l'occhio p rduto. Alla fine del ecolo. nel mano, crit1o raY nnat
he contiene la n-r-ion latina cl I De pictura di A.lberti (Bibliot ca .la" en e. H6).
ac anto al pa o rclativ ad Antio- no T \I n ftalmo dipinto da \ p il "''il frat car-
38 dtI rnecbi1110 principe (duca) dipinta da Pi<'ro_di B rgo (di .'an .'ep.olrro) la .parola
te!>hO pri1wipr. \ on 111i Jiibe con grande arte l'abile o Zrusi. eh i11gu11m1 gh m'.rlh co11_ u11 f11no trai 10
di viti'. Non mi clipinst' su una ta\ola, 11011 mi s('olpt Eufranorc nd 1111trmo, 11011. 111 '.111
\lent1w1 i11 u11u pattra [Po11 -l ., I %61radm1 11wtal pl1111 ]. I' non sono d1 Prnss11elr. dr tl1
Polide10. r 11011 so110 dalla mano di .'copn o di Fidi11. Piero m_i d 11cn 1. t'llrlll' t' ?'su. t' tu. P,nm:1pe.
con la 111a 1wturt1 di\ inamidai Lmima: d111111m \ irn. porlo l' so eh potenm 111uowr con le nur fof"'le: ro 1 eccelle
la gloria clil n (' quclla d ll'ortista {trad. min). 1111,10 r trasmrs o da u:lla ca \ atic:ma
(\'at. Cod. l" rh. l.111. 1193, f. I H ). dir rn1rogli1 oru1ioni t' t'iumi 11comra,nc1 111 on re d1
39 Per il rrworniasti o dr! principi o del n romr unici po .. ibiJi pitrori di 't: ,u--i ('.rr. ::WO:t p.
176 e un (' mnponiniinto del Cabine/ di ,1org1, dt ,'nrdrr') (1<>-+6) dedica10 li u11 ntrnttn dr L111g1 \lii (c11 oln\
1991. \' li ).
40 \ 111' 11wd11glie ctl1r i11 cription acHd m, 11 11111u1> of idrnt il ration on thr olm'N' umi 1l11born1io11 on the r"l'H'r
C (Co11R \Dl'\I 1998, p. 2-+) .
4: 1 1wll1i. /\ntigoni imuginc111 ea ta11111111 pnrt< v11l111s pingrbat qua on1li 'itium 11011 -
gli untiqui I i111n1ugin<' d' A11tigo110 d11 q111lln pnrt!' tiri l'i so on- 11on t'rfl n111111' n1111'nto o_-duo
ra. 11 , -+0, pp. 70-71 ). Cfr. \Il\\\\', 90 . .'111 mano.,critto ri111rnt't'll anrht' la mano p111 nnuca dell u111ani-H1
LoclO\'('O C11rho111.
101
melitano d erudito Balli-.ta PanC't1i annota propri< un rifl'rimrnto ai moderni ritrat-
ti di Fc clerico. curiosamcnt foc<'rtdo il nomr del .\lant<'gna rnent re la sua nw111oria
'1:-.n a mbra andar a Piero i:!.
ederiro da \lontcfeltro conce e un grand onorC' alla con. orlc Battista ,'forza
a . eunandole. nrl dittico. la po izionC' n rmalm ntr ri erYata al!' uomo. ma anch in
altre e rti il ritratto la ua c kbrazion po tica coim olcre\'ano le spose dri duchi
e alt rr nobil I rm dC'lla I r CC'rchia. Per kbrarc I n zz di Ercol I con El 110-
ra cl'.\rauona (3 luglio 1-t. 3) . . 'perandio da r alizz una medaglia eh, li
m tra tmo li fr ntr all'altrai:l_ e-i. te w1a medacrlia di \!fon I eh ha . ul cerso
il ritratto d Ila ec nda mouli Lucrezia Borgia. ancora in ocra. ionC' delle nozze (2
ebbrai i.-02)H. I ritrntti di France co f rza e Bianca .\laria \'i conti ggi a Bn -
ra (H:. 0-1-t80) n r alizzati in un formai . preci ament -t9x3L e . cond una
lf' ni a h doYe\'a e r tipica d i ritratti imiati in ie111 all epi tole-t:;. u due
medacrlic in I ronzo corr lat ( 1-tS0-:-1 e 1-t; (il i. 6ab . ab]). opera di Matteo cl
Pa-ti. ono ffigiati , i!!i m nd Pand lfo ta e I tta d ali Atti. le cui iniziali
.....
for i intr c ian nel Tempio albertiano a Rirnini;
0
. Quanto i legge ul retto dC'lla
medaglia di l otta (D. I - tta .\rimin n i>) corri ponde alla di itura pr ut r nrll
elida cali d Ile epi tol eh I i attribui cono o l i indirizzruto n J liber fsoll eus
di da Pa.rmai
7
: J tr nta pi t l latin . divi in tr libri. che ompongono
r per tta. adattano il mocl li ,;cliano a una n bil finzione a piu mci. in cui i
alternan ieri mondo. J otta il po ta t o. h n a cocrli e I conficl nze ne e -
I bra e , prona !l'ottava lett rad I p1imo libro Ba inio imita I otta a 11011
fari ritrarr in ambra o in bronzo. p rch le lodi di e la ua I o ia IC'
garantirann fama imperitura (' ., 13-16):
-+2 Cfr. f,e .l/use,cat. p. 169.
4;3 'r11za ronl>lio. con i.,rrizio11r aJre, rgo cOP\'' PER.\.\DEI r una thla di rhrrubino tra qurllt dt'i 11111
'PD i. rfr. Boccot.\Rt 1987. n. 56. p. 82.
H di autore anonimo. prr cui rfr. Toornr e 2000. I. 11. :360 t 1987. n. 76. p. 102. Il
modello reclo-rerso era tato adottato auri)[' per Ercole I e l:lt"onora d' \ra.,01111 da
11
11 >cono ciuro (130<.co
I \RI 1987. cat. 11 . 60. p. 8:j).
-t.) I/use. cat.. p. 9 .
-+6 I f0\(,ri <l Ile due mcdaglie lllthtra110 ri ,,pclliHllllCllle il 1a.,1rllo rii Himini (' retrfant1. principalt l'lllhll'ma dti
\ lalau.,ra. ' fr. Le I/use. cat.. n. 24. pp. 1Q(J. I07 r n. 25. pp. I 08- I 09.
-+7 In 111111 dci w,ti delrJ (rhr C'ito dalred. I erri [B,. l'IO 192:>]) il 'il!"orr inna111orat i rivol t ad \morr
,u,,o ?). '.'rnndo 1111 nrchr,1ruzio1w 1wrin11111uta in anni di JIOl'o dal Trbaldro r dal Cu,io. in
tnuumlu pmpno per 11ldirarC' un ritratto ftmmi nilt (rfr. * 2.:3). \hrow Bihi nio d ,cwr allr mu'>r 1wll n ra<,a di
Cin\a1111i (i_' i . ran!1i11a I ''.ria. ,\lii ) t' alla mua Clio. qua .. i 11rta111l'11tt criirlla dipinta prr lo 111<liolo di
l,11ml'llo 11 E H' (m. Cam1111a lana, \\ I Basinii Pan11rnsi cpi toln ud di, 11111 Lro1ll'llurn .
0
11 nnrn1 ); Clio dt-
rriu:i ai\\. 9-12_r ai\\. Prima di fuggirr 11tll"aria 1Jc.lla notti'. la 11111'>11 imit a Bahinio a .,Hglian,i.
'.ant11n I( .1"'.'' d1 l.Ronrllo. <' d111 rl11 11011 lo la,1w: e \anquc rgo q11am pingi i11.,,i1 blllll cnndiclu Clio./ Cli o
11
ntlu
1
.n. lart1"11m1: 1tn11 _''. nuw1n./ Dulds amil'c. gcnm,, \ ultus culo q1w nilrnlt!.: / I lane fadr111 in tabuli ,,
1
P'a111 mli-,,e mt'_lllf'11to 10 d1t [Leo111llo] onliJ1 di dipingm so110 la candida Clio. la pi1 uPUa tra Il.' Pitridi:
amwo: le mu lwll1 "11aiwe. il ,ofto <gli orchi l1111 111i: ril'orrlati dw qur'to .,l<',>O \ i.,o ha oorri.,o !llll'lll'
1111 d1p111t1 [\'\. I 1.J-118. trncl . mia]).
102
Quid iurnt in liquido' ulttt . dtdut'rn <lr<'tro
Vinwiqtw oc11lo1:1 prorrwrr in arre tuo ?
\uper c11i111 'idi . imilr in ima.gin 'ultu .
Quo 111ira prittcrps fP('rrat arte tuo ..
'\cJde animalll. potrrant aeqttare prr omnia wros:
'font um humana rst
'.\re tamen argu<'ii111. gra ti . sim11: hrro
Laudil t fa111ar <'Oli ular usque lltae:
\ anquc tua111 quarn um prohat t colit iJl e ficrurant.
ludi tiu111 tan1u111 iam probat ille uum.
\ 011 ta11w11 haec mon , animttm\ e loquetur imago
' fantaqur erit facie dotibus orba . ui .
\ 'i\it amari,, Diclo. uprrest Lunctia famar.
Fama \ igrt Thomyris . . cd 1 a men a< re earC't.
, 'ed 'igil lti 'at um labor et ua plendicla lau
\ etrrnum faci('!l nonHn itt orhe uum
48
.
Lr parole e. ron duC' v ltr ,incitrici da quc to onfr nto: l'int ri ma, com p r
Calcwnini. r , ta ..,aldamenl e fuori dal d minio I Jr art . la fatic d i po ti pu
c11. todire la fama attrav r o i oli anche in a enza di imrnacrini. La c I brazi n
co-trui e la mrmoria e, com n l ditti o di Piero. la Fama trionfa uJ Tempo.
2.3 Pol1fo11ia cortio-iana
l na parte . della poe ia quat1roc n1e ca compo ta in per na di>.
atlraver o qu ta finzione da 'o a p 1--011acrgi cl lla ort . a protett ri d amici del
poeta. Il far,. r:ii alri111pr0\ i. ta> un impecrno ri hi to e patro inato dai ignori.
un rito ocialc clie . pe. o incontra altre pratiche c rtigiane. e m la mu i a. il ballo
e la ron urtu<linr di far. i ritrarr <la cri i arti ti l ali o piti cl Ila orte. ome abbia-
mo visto. i sonetti di ng lo ,alli in onor di Pi:ianell ono critti all'ombra di nn
protet torr (01 ta\'iano d gli l lmldini) i Jlocano tra t ti di :ienizi n piti per
acco111pacr11are omagai 1 cn concreti (una crrnt e un caYall . eh nei ri petti"i onetti
I r ndono la par la). AJlo iltl'!i!->O po ta i drw una lunghi . ima ri li cornponirn nti
. ritti in I r ona li Fedrrico da \lontefcltr . 1T dati di rubrichr eh ci inf rrna-
-+8 h i. lsollr11s. I. 8. \ 1. 17-3:! (e \ l'Osa 't'n rapprt', l'nture il tuo mito i11 limpida umhrn. r mostra.11' i tuoi Ol'dti
i11 hronzo 'i\ UC't' ? \ on molto 11111po fa ho 'i sto so111iglianu J1 un 'innnaaim il tuo \Olto. rht il ,ignore [ ' igi-111011
do) mtva riprodolLO ron arlt' 111irnhil1'. \ ggi ungendod l'anima. UH('hbt potuto 1gu11i;(lian in tut10 quello 'tm:
luntu Ira O-iato rompirre una mano 11111111111. E tlll lll\ ia non aHei da ridin. st quaklw n1lonho [ J 111nlto
rirn1Hhl'ClllP si rura''!' srmpre drllt tnl lodi e d!'lln tua fama. lnfutti quanto appn1111 l' \l'lll'ra la ruu hmrn. tunto
opprt'n:U il proprio giudizio. E lllllR\'ill qnc la i111m11ginr 11011 t'>primerI i ('08lUllli (' ranimo. e llllll fi'Unl rns
hellu ,11r(1 prirn tlt' llc >tll' d ti. (Di fnm11 J \in Di don!' innamora tu. di fama 'OJlfll\\ \ 1 Lmn'1ia, grn1i( alla fama
ro111i1111u a ,htn 'lmiri. eppun 11011 ;.uno ,mir ritratte i11 bronzo. e 1wn ptls,11110 coman sullu . olem futiea
rlci po(ti (' ul lorn magnifico elogio. rlw nmlc t'lt'l'nn il lorn 11on1t nrl mo11do (tnul. mia)).
no ommariament 1111 circotanze per le quali i \'<.Ti fur m per l ni
ne mli dalla morosa (Per uno drapeo-ello donato [ 1.)] . per uno clrapegello
:.pili< (2. ]. p r un p nachio (62]. per un bigli Il con il nom dC'lramata
cripto d ua mano. una pr rn s::ia dam r ubit infranta dalla n tizia dr! pro-
imo matrimonio di I i [. 8]). p r oo-g tti che la donna ha l nuto o in I salo (come
la bianca bend lla che ne ornava la treccia (6-t]) o per .ituazio11i ncll quali il
duca ha p cuto o- cl r cl Ila ua vi ta (la mes, a (99]). ri t ti pr ncle la par la lo
. Le o Federico. in quant amant al qual il p eta pr ta il e clic e il mc tier : pii'1
rararn nt la dorma di turno (16. ). L'u o di ed re la poesia ad altr 'oci nou ou1-
rnlo-e ol chi non a far ver-i e d id ra conrnnqu fame sfocJ'l'rio, ma anche chi li
ompone in prima per ona. coU ghi e ami i po ti. ondo uua pra .i eh int n ilica
al tmi a p tti d Ua I o ia di orri I ond nza. ,\cl empi il Calli du s n tti
in nome di iu to de onti (2. 8. 2. 9). h o-li ri pond (279a): la rrlativa rubrica
molto dettao-liata n I ri vo ar I irco tanz della ompo izion (Per una ofovene
boloo-n . . -el 1-38 di ma!!io in F rara e endo l la mie f ci l'infrascript onett
im p r ona di m er iu to da Yalmonton cubiculaii inam rato d trna giovine
bolorn la quale in qu lli d e ra partita et andata in ,iJla [ ... ] ).
. "ei b n pi note,oli Ritlzimi di a paro \'i c nti. olo di rad le rubriche idcntili-
ano in m doprec oi 01ru1littenti
50
ladi tinzion tral"i el altrevoci clatapiut-
toto dal ntra to na il torm nt enza tregua d Il' innamorat inf li 1, o-ioi d i
giornni amanti dei quali rievo al vicende. Ari lo ratico. con io-liere du al poeta,
a paro a ua volta protettor di altri poeti e di arti ti, qu ta condizi n privile
o-iata aiuta a pieuar la I r enza molto limitata. nella ua prima rac olta, di nomi e
fatti cl Ua corte forz
realt b n pi en ibili nei anz ni ri dedi ati a B atri
cl.E t alla Jlpote Bian a Jlaria forza. che e mpr ndon an h te ti 5CTitti "P r
mi ion cl 1 \lor
52
. Le !!io tr il lu o dell dame 0110 l o a ioni di qu , ta
poe ia. che i i pira ao-li pi odi ao-li oug tti !lP tra facili aro-uz e divrrtimenti
(p r un du Ilo [-t. ]: p r uno o-io\' ne he. in qu Ho pon to h li amba al ri davano
-t9 Le ruhrirhr 0110 trasmc'''" clai due codici che con nano 11 rim e sono wro'>imilmrntr da ricorHlurrc alla
\Olom drtrautorc. La numerazione che adotto' qu11la cli G\111 1987.
Lr drl \"i >C .nti ai onrui. delle quali rautorc d raJTiOlll' rwlla dedica dl'i Rithimi (\filano.
_H93 (\1 o:m _H9.'l)) a \1rcolo da ono a \"Oh!' , ere r proprir glo' e ad Hln111i rl<'i trrmini
comr ha cn1to B ngrani. cui i dcvc !"edizione ri1ic-a dei canzonil'ri prr Bratrire d' Ehi<' e Biancu
Mana forza (BoNGR.A,"J 1986. pp. 68-73). .
:J1 \ ri_Rithi111i 11011 ri ono :ifrrimcmi agli _'for1:a. n 'mmrno nella d1dica a da Corrrggio: s1co11clo hso,1-
co 199.) (p. J lfUP ta poe,111 non. ra funzionali allr e igrnze di qul'lla corte. pi1 prroc upata dtllu rir truziorw
del pa.<"1110 _r del('":.' dd proprio pottrr: infa1ti al .\I ro ( drdiC'ata l'edizion< a stampa dd
Paulo P Darm r1111a1111. do,e h,101111 nrorrr uUa g111calogia (I. \li. , v. 46-5 ).
;j2 \'t c.ovn_ 1979, CVII. CL \Ili- LX lii. Lu propc11sio11 narrutiva, chl' i propria della pcwsiu t11rdo-q11at-
t nxint_ 'ca /(<'nl're: ( .) pn.,rnte nella prinrn rarcolta. [ ... ) au111111t n I r1111zoni1rr per Bra1 rin i11 r1wio1w
ridi: d"pr-r-ri11w cort1:na11a rl 1 tenti. da coru;idPrare un necc ;,ario adattru111nto cli C11,,p11ro ali" ambien1r (At BO\ICO
199;). p. 8-J: rfr. B<l\GR..\.\l 198:1. pp. -+0--t1 ).
104
la i110 g11a ducale al 11 (ostro) ill (u tri si)mo '( icmorr) . . r inarnor d"una donna dc li
Ve.conti) (CLX Ili]: per un ventaglio [ Il-XVII]: Per un hala . o cli r avrva una
dama ad una or rhia. Gng ndo ia una ferita cL\rnore [, Xli ]). una por ia talvolta
debole ma ncc b ariamrnt a
11
il . in "rado di accettar tempi e m di di rompo. izionc
in o-ran partr mod< llati sulle igC'nzr d Ila di corte: chi rrive rirn r pronto a
irnprowi.'are. r in::ii<'ltl<' a rivrdrrc i propri rr.'i quando non rie cono 11raditi alla
committrnza. ' tanclo alle mbrich . r attuale l<' to XLVI dr! canz nierr I r Beatric
fu inucgno amenl rifiutato da (' l i che r av va richie t . in quamo \i prcnd la pa-
rola una clonna o-elo. a-":
1
. non un uomo lpito dallo te o rntimemo. c me la dama
dc idcra a; il successivo capitolo L li arehbc la con e!!l1ent ri criltura:
\wndo una c1rta gala11tr madonna mandatomi uno che ponato per motto
dal re F<cleriro. re di \apoli. il qual '"r"o dire: amor me inrend< r ueloia mr
. truggc>. <' 1110. lrando H\<'r chr facc:;:,c qualche co a !>Opra il predirlo
\ er:,o. fu facto il precedentr rnpitulo: e prr..,entalo a la p(rcfa)ta madonna. Ila fin e
. eorozar-.i rnl 111e o. dirt'ndo rhe ali U\ "'a rom . o me clice-. clw rlla il , olern in
per.,ona cr uno omo rhr !.i lamrnta!:l i d"amore e di grlo. ia. non di donna. Il me "o
tornato p<'rd1r lo remuta si. in sua pr rnzia pre i il calamo e a la impr \"i ta feri
altro rhc <icquila qui :,otto'"
1
.
Il canzoniere di \iccol da ' rreo-o-io. condotti ro p ta di ,,al r . ' molto pi
araro di <lati materiali . anche c 1ualche I m nt util i I u recuperar laJla cor-
ri pondcnza con i di J.1anto\a. Il 2-t f hbraio 1. O:"" i l criYe a [ ab ila
d'E te a propo ito di un gruppo li onetti che ha comp t cli r nt . i pirato dal
ra di un o-im ru1e morto in bracci alr amata:
[ ... )A li pa giorni io hebbi da Roma 11n :,onetto composto opra qu lamarcria
rii e. e11Clo uno giove111' Romano in brac io a la . ua inamorata b llis. ima. ranima
ali -.piro<>. P<r la qual rnsa par ndomi il ca ...o di qual he mrmoria degno. persua:-o
anchora eia chi mi mand il predic10 om'tto. mi tfi..,po. i anrhora io romponerr
qualche ro-.a: r1 etL facto quattro li mando p r ... ati:.fat.:tione . ua a la Ex. Y.
\ l primo parla il aiovr11c morto. nrl condo la lonna ud \more: 11 1 pw la
do1111a ad ptio gio' cne defunrlo, e nel quarto la urna dm - epulto [ ...
La l tt<'ra pi aa l' <ca ione di com po izion acuum ia i cambi di Y mc i m
atto nella rquenza. Li pirazione elci te ti ' e nrreta in -i m gi l t1 raria, p rch '
.)3 ' <mulo In rcl111in1 ruhrira. ( ap(itulo} c/"1111a iuamorata che i lamenta (/"amorr. !'di rrelosia.
.ii \'1. C0\11 1979 rubrirn u .\L\ Il .
% Lt 110-lh.\IHI 189:3. pp. 2!i8-2.i9. P!'r tre oOll!'tli rhr sPmbnrno orri,pLmdtn i11 pnr1r 11 q1ulli qui dr 1rit 1i
rimi o allt' oo,l"n azioni di \nto11i11 11,,uni Bl'm 111111 i dw. nrlh nota llologirn dtlla ,ua l'tl. (CoRnF .CIO 1969. p.
:i-+7), ritit1w di allribuirli 111 Com"""io t li i11,1ri,re tru lt' 1':\lrmngami (. "\\ -\\\'li ): nd primo pnrlu \mon.-. nel
1'11m1111tc. nel trm> il :i!'pokro.
dichiaratam nte olkcitata dalla lrttura di un altr 'Orwtt o <' clall"in i ' t nza di 11n
altr p ta. In ne " 11110 dei quattro trsti parla il po ta in :ens< tr lto. 111 ntre ulla
c na ucc dono i dm protaaonLti della ,-icrncla. Am rr < l' urna. condo 1111 uso
che la lirica ha ui a. -.imiJato dall'epitaffio"''. 1,'abhand n dell'io cl I po ta-amantr
a farnrl' di altri qui JrO'uihile nel uo a. petto total1111'11te finizio e lctt rario.
come alternanza che i111roducr 1ariatio e lrammatizzazion' nel piccolo ciclo. uc. 10
pr e limcnt . I r'. non ' affatto priYo di lrO'ami con la scrittura in p f 'Olla cli
om catraoria funzi nal . n co 1i1 ui cc anzi una:. rta di doppio intern , tm tributo
indip ndrm artifici della p e ia alla propria funzion ciaJc <' alla propria
dimen i net atralizzant e dial gaia, cl l tu11o maguioritaria ri pett alla ua anima
oau ttiva lirica.
C't'
Lu:. e rtiaian di e mporrr wr i a n m di t rzi pu intrec iar i e n la pra ... . i
di all tir ra c lte leuat a fe te. tic rrenze e lutti. Ql la pluralita non pi o non
lo I tteraria. implica carni i 011 reti e relazioni ociali: r uu coro ffirn ro rhr si
riuni e per un cant d tinato a . opraniwr nel tempo. l ' 11 p ta. in uenerr inca-
ricata da un ommitt nt . rirnlu ai e ll o-hi li invita a c1frer u un t ma daLO.
cel brand tm p r nagaio. wia ire tanza o un op rad' art . La pluralit ogg ttiYa
delle \'O i cl' autore pu ombinar i con una polifonia interna ai ingoli contributi .
eh attribui le paro] a persone di Yolta in v lta tliver . mrt1endo in na fram-
menti di dial !!hi fittizi. e1 1-9.3 il medie tunani ta di ola mbr !!io Lronr
ollecit numero i po ti f rrar i l mbardi a e l brare in v r i un bu t marmorro
dell'amata Bean-icr d colpito dal corna co Tomrna o alliern di
france. e Laurana . .'\ IJa ua Recita/io de nobilitale la cultura ' consid rata upc-
rior alla pittma. con un ri ono rim nto rh i I aa alla predii zion m ridi nalc
per il marrn ai contatti del L 011e n la e rchia d l Ponta11 dcl ' annazaro.
on la Y n zia d JJ'l e di Tullio T..;adozionf' d<'I mar-
mo orne materiai p r il ritratto n n la ola . e lta di campo rompiu1a d I nolano.
i11 quanto proprio la po ia n protrae e n r nd m nnm ntaJe. in n raziano.
l'interJZi nr rei bratirn. om erfrc TPbald o. attrawr:. il Beatriciwn one ha
T lto di ar ompaanarc la tatua n lr parol . memor dci p rduti mornunenli d I-
l' antichit. elci quali re luno olo roviu<' o ricordi 111a i mitiri:
B n fu Li a corto arompa.,nar il ,er o
al marmo in cui I ua don11a C'xpr pira.
ch O!mi mortai lavoro il 1c111po tira
al fin. ur e. cr li \'aJ li>giadro i> t r o.
.")6 L"e11i1arfiu 1111 I i1>ico ca o di to1111io111111n 1t1 1 1 ' I 1 I I
. . . 1 i 11111111 n r,1uo puo par arr. ro11w 111 1111<111arnm111111 1 /\ l'>ih!llH ro
111 mon1'.d
1
/\Jbicra dPgli \lbizzi , dow 110111apinmo . porla la do111111 o il ,110 busw"(cfr. 1,,., li\ 1970). P1r
11 rapporto Ira <p1fifamma ('(I <'pitaflio nel Q11a1tro1111to C'fr. \h " , item J 99o.
57 Co111R1T\ 198 . p. 5?2.
106
&
Dr Ciov(' Oly111pio il :-,irnrr larhro p<'r:-,o
<' f'l lcrcul dc Lisippo. nr pi mira
Hlrocli la . tatua dc rol11i rlt<' gira
rol rarro illu tra11do r uniwr o:
ma lw11d1r rotti sian. ba ldi<'
tronlll . i i11 rartr. tanto la
p contra il tt'mpo irwordo che va
Comr han dal riclo i roqii cli> natura
l'alma. cu:-," da gli porti i,a nti
quri dr 11wtal. cli marmo l' dr pi t 11ra i11.
La storia ha dimo:t rato fondate le preoccupazioni cl l committenl . dato eh molti
dei trst i ('i sono aiu11ti. 1111.'lllr<' !"op ra d'art alla quale Oli dC'dicati vcro:-,imiJmenl
perduta. a meno chC' 11011 ia da identificar on un bu-to lei L U\T erroneam nte at-
trihuito al Laurana''>. Quanto ci re ta. -,par o. delJ'incompiu10 Beatriciwn. compr nd
\'Cr::.i latini e vol()'ari di Ant nio Trhaldco, Ere le , trozzi. Timol o B ndrcl i, iornnni
Biffi. Lancino Cnrzio e altfil
0
. e comlJina t rcotipi deJla I o . ia d'amor , in omagaio
a un . og()'etto femminile e alla pa-. ion di Ambroaio per B atri . con un f rte affla1
celrbratirn e autoe lebra\'O. Il contribut probabilment pil'r inter . ant quell
del Trhald<'o \'Olgarr. 'he ha or()'anizzato i tt pezzi onlluiti n Ila tufua/a d Jl u
rime in unarchitrttura molto compie a. T a rqu nza di :on tti (223-229) i apr
dando la parola alla htatua (Che auardi e pensi." lo son di spiri o prira) -j hiude .con
un tributo della por. ia aJla propria e, pacit di pr , rrrnre la memmia d Il p r eh
il tempo
I ,'irnp , ibilit di animarr il bwto. che- pure emlra \i\'o. rap-
pr cnta la nota clo111i11a111 della serie d' ntrale anche n i contributi di altri po ti.
come il Bendedei. chr l->Criv di una b miglianza che fa dubitar tra il mod llo e la
copia (Per a la dimand<L onesta). accu a rimidia di . atura. h imp cli
il dono cicli' anima alla . tatua ( Q1La1Ldo io le miri ben, Lu sei pur q1Lella)<"
2
. L'in' rto
cppurr irnmp rnbilr conlnr tra vita r non-vita tra carne e rnarmo. '- efliracementr
calato nrlla stellazione 111 taforica della J i<'lra . che ri hiama miti di r azion r
di immortalit (Pigmalione. Drucali n Pirra). m ntrr la tu liata alternanza d Il
vo i dei dr tinatari interni (il I u to. L onc. il po ta. lo '>pruatore ree.) d conne-
tezza al ritratto c I I rato. mcli nclolo al rntro di un dialogo.
:)8 'l.BIl Ili o I 989- 1 <><>2. Il/ 1.
S<> Prr il bti-IO dtI l.011' n rfr. D\\11''11.i 2000. p. % e rnn. I i'.>- Ht).
<>O Pt' r 1111 !'lt1uo pro\\'i:mrio mu ntc11rnlo dt'i 11,,ti (di l::rrol1 .'l!'OZYi, Gion11111i Biffi. Lrncino Cul'lio ec -.) rindo
ad J\r;o: 11 J 998 1 \J.HO\JIO I<>% (p. 91 ). 11111 rfr. 1111rhe C1 101111 I <l89.
ul Prr 11111m11111 nlo dc11aglia1o ad alc1111i 1t,1i d1ll11 rri1'. rimando alle mii' m111 in Bouoi-r pp. i;:--to?.
P r il Bmdt'd i l'fr. C:1. ro1.111 I <>8%.
10.
-
n perazionc anal ga a quella del Tcbaldco compiuta. qualche den nnio
dopo. dal mediocr rimator bologne- Girolamo asio. clic. in qualita di perto
c1arle e mm . fu uomo fi fiducia e n 1tl 11tc di I abella La ua Con-
L
;;;ao-a ( I:)_=- ) ha tra 1 -ne prin ipali f nli di propri un hu lo e lpito.
che ritrae .anlla nzao-a. fiulia di Giovanni. fratello d<'I march e France co li
'
l'o ca, ione non J ot rn erto fuggir alrautorc di una raccolta come la Cronica.
attenti:. ima all"attualit mondana:
[ ... ] il no,o Phidia lfonso cultore. ritratta la di"1 rffgie de la Con-
te sa ignora Camilla. ficrliuola a la felirr rrcordationr di' lo lllu triss[i1110] '[ignor]
Gioanpir1 ro onzaga [ ... ] \I n di, o mol11 liate ali r interwnuto lo
W1 o .\lolza. quale con .,ua Immana. anci di,ina por..,ia. ha fatto r:- en pi1 eu'rl.,a
la s uh ura. t conwnc' olmcnte (come dire floratio) Pict01ibu. al qut Poctis. qui-
dlibet audrndi empcr fuit acqua pote;,ta:; [,1rs po('/ica.' "9- 10]. Il perch mosso
io a11chora da rara heltad . da ecc Lo . cultorr. rt da 1> profondo porla. cri, si
il pre.ent [ ... ]():
1
La hrazion d lla tatua. op ra di un Alfon o eh improbabile potrr
identifi are on AJfon o Lombardi. produc nov on tti leO'ati da un -j trma di
pa aO'<ri di rnce ' ontato ed t riore. eh pri\il aia la ronY nzional divi i ne
d i compiti tra paro] marmi r il topos d Ila r ipro it d lla fama chr 1 arti i
con donoM. An h in qu t a o la erie. po ta in p izion di rilie\'O. alrinizio
della raccolta. i apr ricreando la ituazion in cui lo p t tatore-lct tore incontra
il ritratto (O tu he miri in qu t bianc a o/ la ffiO'j di amiJla ( ... ] [ w.
1-2)) e i hiud ul I n i.ero d l futuro (Chi di marmo l'edr questo bel colto). La
dispositio alternata ott linea la collaborazion la parit tra i due arti 1i (lo cul-
tore lf 11 o e il po ta France co M lza). ai quali la Fama ordina ln1aO'lia
e rri' ro eh tal ultura/ a compaguata de irnrnortal crittura (w. 6-7)
non a\Ta fin e non ron il mondo t o. ltre al t ma d lla crittura eh a icura
reternit. alt1i moti\i ono condi,i i con il t bald o (la fr cria eh olpi il mar-
mo credrndolo carn . il p n i r dei po teri he si troveranno davanti alla b ll czza
tram.andata dal marmo cc.). ma tutto cio chr 11 i onrtti per il Beatricium rra
raw1vat dalla comi l it dri rimandi dalla man irura d 1r w11ani ta amico
d! Raffaello e di Brmbo. olori . c i p rdc n i " r i malclc tri di 1111 mercante
d artr pi utto lo in li nr al er ili 1110.
A qu tr impr e. a comunale dall'idea di co truirc tm rn01mm nto di parol .
, ? t. nrndo la delle immaaini in nome cli una pi icura immortalit. va1rno a. -
unilat ' anche pm tard rac olte lcbrative (Templi. RimP in onore) e funrbri (come
6:3 C1. 10 1527 [Con.:aga 1:)2;)). c. 6.),.,
6i h i. rr". 6 7 ma cfr. D1111" 11..1 H0\11 \O 1998. pp. :387-:392.
108
la raccolta i11111ort<' di J\lbicra clr11li Albizzi voluta da ' igi mondo della, tufa. 14?:3).
illogi per oper craite (i C'oi)cuza. 1. 2-t). p I' ritratti. om . fuori
d'Italia. il proflu io di rim prr !"effigi clclr umani ta Eti nn Pa quier (In lephani
Pasclwsii imagine111 si11P mani bus. 1 :-8-i )1>:;. La con ape\olrzza della racc lta polifo-
nica come ar hitrttura di parole rafforzala. nclrc perienza con reta, dalla djffu a
prassi cli 1 ttare pigrafi da incidere u la:trc e piedi talli. di comporr pigrammi
p r accompaunar opere a arte. di i1wentar motti per mcdaO'lie e ritratti. Del poeta
lombardo Lancino Curzio r r pigraf critta in alce al ritratto di Cri toforo LonO' -
ni di JlClrea olario (t-05, Londra. ational Callery)b
11
, di Tito Y pa iano trozzi
il vrrso riportato sul recto drlla m daO'lia delf umani 1a LodoYico 'arbon . op ra
di p randio(l.,. Lucr zia Borgia hie e a Bembo un motto p runa m daalia
68
co
I abella trEt a '\iccol da Corn O'crio: entrambe le opcrr ono !riunte fino a noi. ma
la cconcla identificata con piu i ur zza in una m daglia di Gian Cri toforo Roma-
no. eh<' mo tra . ul recto rcfricrir della march a. ul iwso una :fiO'ura allcO'orica con
la . critta o: BE.r\ ' . IO RE.\'Tll ERG . uno d i tr motti UO'O'eriti da ..\'i ol
in una 1 ttera d l l-i98h<l.
\ ono tant innumcreYoli 1 , timonianz ome que t . la fida p r la opraniv n-
za nrl trmpo ha indubbiam nt premiato le parol . pur tanto inferiori. n lla maO'O'ior
partr d<'i ca i. all opere h I bravano. 'o poe .
la
lunahi ima dida ali.a di un \lsibile che. p r noi. non pm tal . ln rp10'rafe cu t -
dj il nom e riprt r eloaio. con o tinazion . attravcr o O'li anni i e oli. an h ai
piedi di una comic<' vuota:
F errnaYa il pi eia cw1 di que ti segni
pra due hrlle imagini pi e.
hc con la borea ap rta fa ean ' rrni
che ' I cauto e r armonia lor dilettasse:
e qurlr atto io cli on. par che crni
che l'opra r >otudio lor h1tto
le belle donne rhe ugli omeri ha11110.
e fo scr quri di rn' in "cmhianza bta11110.
();) Pl'r 11hn rorroll!' di qu<',JO tipo cfr. :3.5.
66 t 1111-.dll'dH d!'I dipi111o in BnOll\ 198?. cai. 21. pp. H:3- IH, 0111 cfr.1111d1e \i. rr 102- lOi.
67 Ur. Poi L\RD l 98i- l 985.1. pp. 20 l-2(J:l . n. %.
'I 1" '3 B lC)tr'
68 1,11 ll'tHrn con cui il (>(ll'IO ri pondt 111111 richieota. !mipo11endo i! F.1/ <llltnllllll. I' ,a
> ul
1
I
199:J, I. p. H6. 1tt1' 1ttn quella d Ila dul'ht,,a oi pno ltggere ndl t'd1z10111 del carttgp:to - -.
pp. 121 - 122. l.u 111td11"lia 1li Lucnzin po1r bht' es t'l'l' qu<'llll thr ha sul 1Y'f/O ti 'uo profilo. _ul l'(rsO un rnp11lc
br11d1110. ('fr. Too.:1111' 2000, I. n. :362. lii. Ja\. 8:3 r lfo< <0L1n1 I CJ87. 11. ?8. PP lOi-10.).
69 (
r 1 R l8'"' 2r.1 ""> ... < ' l'ot)f.Rt1'\""'"'H >ooo Il n 2018.lll.tav.3931RoccoL1n11<)87,11.
' r. , l llO (' f.N trn "" PP o}ol-- ... U' - . I r
o2. p. 85. Ln ficrnrn sul tlllft donna uliua rhe tienr unn 1 ergo cou cui uu:1urn un. ot rpen1,t: 'opra. a tr't'.1 '. 1
lti si wdl' il del sa11ittario orntontato dn una :;tclln. li 1110110 alludt'rt'hht' ta all11 rno111i-tc11La dell a1tton s11
ullu protr1ion; che la offri11111 lt111ru1i e artisli.
109
I inf rr"iori in mano
aYcan lunghl' et critturc.
OYC farcan ron molta lauclr piano
i nomi cl I pi dcgnl' figure:
e mo. t nn ano aucor poco lontano
i propri loro in note non
Mir Hinaldo a lume di cloppieri
I donne ad una ad una i arnllieri
70
.
L' pis djo e fr ' tic -aen alogico della fontana dei po<'ti (Orlando }1rioso. "LTI.
. 8-96) meh in e na con a uta intei yj irn il rapporlo tra funzione architettonica
d lla p eia (an ra il monumento <li par I ) pra ::ii celfhrativa realr. tra 01111e11i
par l in ci e u mon t parap tti. u pie li talli :-u l'O\ -.ci. I po ti ono i I ila 1 ri
h s tenaono rnat rialm 11t l ouo tatuc tl figura int ra delle donne celfbrat e
al e nlcmpo ono lavo d lr p ra d'a11e, in quanto conferi cono. alle damf e a. e
1 i. un 'identit. il nom critto u] arti ali eh tenaono in mano. ,' enza nome 11011
i d n mio. om embra rie rdarci. con la ua in quiY cabil e\id nza male-
rial . la on uenidin tipo!!rafca dell maiu col nell stamp cinquec nte eh . La
finzion ario t ca d orpo. pia ticamente. al rappor1o di dipendenza encomia tic1
tra i I o ti le ara11di dame cl Ila orte. e I r ma alcuni protaaoni ti . celebri e
o- uri. di una grand taaione po tica e ritratti tica: tra gli altri. Antonio Tebald o.
Ere l trozzi. Pi tro B mbo. Ja opo adolet . Bai la ar Ca tialione. il \f uzzarelli.
C !io Calcagnini. .i ol da 'orr ggio e Timoteo B nde(ki. rimatori r umani ti raf-
com dediti alla cel I razion di grandi prr onalit f nm1inili chr on . tal
patron di e peri nzr arti'tichc e zionali. La pa. i ne di I ab ila cJ'E. t (OF :LII.
8-) per i ritratti ( p r la p ia) la acrompam' p r tu Ila la ,ita. dalrimmaainr
che la mo tra an ora infant nel mano critto della Genea/orria della msa d'Este.
ali m claa]je. aJ bu to di Cia11 'ri. toforo R mano "'
1
. alla tarda ffiui tizianesca di
Yi nna. T l i.-08. in ,.i ita a Ferrara. la marche a e] cri' a11imatamrntf' il ritrailo
he_J aY ,.a dipinto Lorenzo Co. ta. de.tando la uriosit cl i prc enti al punto che . i
der1 ,un COrrier . a 1antorn p r prc>nd re il quadro
72
. fl UO inlrre SC' per
qur la 11rnnagrn te timoniato an h da rum le tt ra dcl 29 ai
1
wn cl Ilo tf'. o anno
a Gian Ja op? nella qual J abella c-hi d dur \ 'Cr i in lod d I pillor . da
m t1er n li ultuno quadro eh vi ha facto il Co ta del rctraclo no tr "':i . In agostc.
70 19CJ; (0/l \;l,JJ. 81-82. Rinaldo giunge nrl palazzo del \lautornno (dN-ritto allr oll!l\t' ?3-77).
a'rohna la uowlla del na1>po f' rwl r
e I f' Ulllllllra Una IOlltaJIU Olla"Onalr Oflllllll dr 111ag111ficlw -.1111 IH'.
'
0
lnhto potrchhi rifrrir'i uu 'oni110 rhe .\ntonio Tcbaldco ri1olgl' 11110 ,,cuhore (Trn 11 or.o 1989- 1 Q<n.
2 I d()(unwmi nla1iii 1
1
CJUNO rii ratto i.0110 riportati in \'1.cuo (' Jfo10 '.W01 . pp. 123-1:.16. CHI. 11. 55 <' nir . 188-189.
7
1
:J ( ... ]( rnrrrs imo far
111
t11rc11rll'ultimo 1111adro rlie vi li11 fal'to il Co ta d1I rc1mc10 nostro u11 IJC'J di tico u 11111
<e,1111 \11;1101Ho1o '>OO l H,,rt 1 I 111
. I li
1
. I -
1
"
0
P
1
"
11
/! 10 'a JI' a '<'n\'e mwora al Calaudra. farendo rifcn111c11to
a ( ( f llf('rf' (a rrwu rc 111 <1w11ro dcI rPt" Il (Il '/) I' I . e . . . . .
< 1,1 (J no,1ro )/(. : ' ('( rnco .1111111110. ll''lCll'l('rl' d11 e 11zaga, il 26
110
in assenza della 1110<
1
lir, Frane co Conzaga (\ ib il quadro in of'ca io1H' di una vi:ita
d<'I duca d'Urbi110 a .Mantova. r l'anno <guentr il ritrallo uli fu i11 iato in i mr a
qu Ilo del la fialia El onora a \ <nrzia. dovr era priaionirro. L identificaziou di qur-
sto ritratlo on qu llo di llarnpton Courl (Ritrailo di dama con carrnolino) ' moli
<li .T11 :a. ma tra lr raaioni di roloro h la o tcn1.1ono ('e- la vicinanza d<I quadro alla
J onanlf'sca Dama dell'Emelli110. il ritratl di 'ecilia Call rani h I ab ila av rn
rhie!ilo ron tanta in i tenza veni . mandalo a .\lant \a.
L cor1i di Iilan . va r Ferrara .-i rambiarnno ali arf ti om i po ti.
hasli p nsar a iccol da Correggio. al Ti bal<leo o aU.Aquilan . Al primo. che Ario-
lo evoca in corrispondenza di Beatrice d'E t (OF ' LII. 92). i ianori di .\Iantova
courniis ionarono anrh itw nzioni pi 'Ciole. ('Ome m1 di onrtti per un liuto.
strnmc nto pr dii tto da 1 abella. o una di!!na fictione da p rtar n la cola.na o ber ta
mm qualche bello motto per il 111ad1e e Frane co
7
": al p ta. pratic di cirnile fan-
ta ic, viene hiesta una invrnlio11e clic ia diaJLa cum el motto. Invenzione
cfanlasia ono ali t . i tennilli impi aati. nelle I ttere di I ab Ila. p r far rif rirn 1110
a i111p compo. itiYi di b n altro r piro. come l'icleazi nr di un on tt p r un nuo-
'ql1a<lro
7
;; . La marche a commi ion al nobil umani ta Paride r ara r in, n-
zionr I er due dipinti d I uo studiolo. affidati ri pettivam nte a Peruaino a Lorenz
Co ta. Il t to r lativo aJ primo quadro. il e mbattim nt <li La ci,ia 'a tit. il
. lo ron:-erYato. nel contratto tipulato tra P rucin France e \falat ta. agent di
1. alwlla a Fir nz ( quoddam opus La ri,ir et Pudicitie cum quamphuiJ l et multi
aliis ornamenti[ 19 annaio 1;0:1]); in e o i ddirwue un fondamento principal
(il nucle della 1 tta tra Pallade e .\more. Diana e Yen r ) da ali ornam 'nti. le fiaur
lrsce11 di nt rnocheillutrmano on empilabattatrlia1primopiano:[ ... ],
Pallad<' \'OI par r quc idem re m \nlo \.rn r , hav ndoli p zat l tra.le d. r
et l'arco d' mg nlo I o t tto li piedi. tenend lo on l'una mano per il v l h il ci co
porta inanti li och, e n raltra alzm1do ra. ta. tia po ta in modo li f tirlo. [ ... ]
7
<>.
Que ta d rrizion cli .\mor :-e nfitto ' molto 'icina ad alcune I r?.."e d I_ .er ai:a
po<' I a. ad e. mpio la e tina eh' I . criw la lolla tra, more 01:tLma :
com<' nei fa1ti non c vera oluzione di conti11ui1a tra la nch1 ta di un mv 1iz1 n
alta e mplc a e il capriccio di una fa nlasia privala. tanto che ali t , o r eta
11g1,,,10 lu iuforma che cl.o ili. S. (il rnord11"t' Fn111t'tro] 11tr riam?. qu ti nw a ton lo rttrato d \ . '.: d1
porl10 i11a111i io g a\ Cl'H fut1i pontf(' lo telaru . .'uhiw lo pnruu. dOlc d1c pmrqur ad O;!nuno (fb1d.).
7-t Ci10 da una lettera tiri uwrrht t del I.) ago'to HCJI. riportata i11 l.t110 t' llt\11.tt 18Q:J. '\\I. fl 230.
5 Cfr. \ t RllL\ E.'- 1971 . p. 23. no111 -t'.". mu a11rhr :WOb. pp. 169- 1 <lO.
76 11 t tu pu Jrogrrc in \\ll'Rf.l .L 2006. pp. 110111 b. lr di q11Na l- 1.r1'.h-
hli"o il rin l'io al prt TO l'udicitie. dOI e si d!'scri1 r I auanu a_ Laurn t' lu 11tto11a <.11-
Qu 1raJizione. ri spr11u111. 11d !'se111pio. dn Lu :a ('Iho1!fo d1 tas/1/.11. l't1 ..
Gall1n). rH 11 cguita d11 Ctri,arn. for-c i,pir11to dai rmd1nuh Lchrcs l P
11
1
rappo1"10 trn il c:ido pittnrirn dl'llo tudiolo ('il Libro de naturu di' a111orr 1hll Lq111eoh1 efr. \1u 1 _QOo. fl 1--t.
7. C11n 11t\ 200-t. L\ \\I\'.
111
il march e Frane sro ommi ion u11 'i111pre a rif rila al pr prio amor per l abella
Bo chetti
78
. ;\ell'ambit d i lavori per lo studiolo, una ncr ta opera di rnc<liazionc
fu chie ta anrh a B mbo. che nrl 1 03 rie'" n l'incari o di comporrr lUl 'inv nzioue
eh oddi fa tanto l abella quru1t i \'arn1i Bellini. molt meno pr pen o cicali
altri arti ti a pi aar i alle impo izioni cl Ila mcu h a
7
'1. Proprio l ah Ila i ria ( ara-
dualmentr i .., opr ) di tro la dorma recrzionale raffi!!urata n i Ritraili cli Tri in .
che nr offron un ritratto n' di m talli. n' di marmi. n' di ol ri [ ... ]. ma fatt di
pru- I . r di ent nti dal :\lu d ttatc>. in con apcvole e orcrocrli hil comp tizi nr con
1 arti fiamati\' : mffi!!ie imi ibilc" eppur a tutto tondo. pili cornr lcta di qual. im,i
dipinto. per h'. ul modello delrcloai rpiclittico, comprendr] doti <'htcriori cd int -
riori della mar h a e le attribui. e alcun d li qualit alle quali t<'n va di piso.
reffiaie di Lah Ha' af"fidata oprattutto ali medaalfo ai ritratti dipinti, I'im-
ma!!ine di B atri c1 te. p a <li Ludo,ieo il \loro ( OF :LIL Q1-92). leaata in
prin10 lu a a un b Ili imo bu to. OJ ra di Gian ii toforo R mano (Pariai. Lourn.
H90- l9. ) for e elebrato in,. 1--i dal I' o ur i rnnni Pincaro
81
. i; p rienza dC'lla
du he a com patr na delle letter alla c rt forze ca fu brew e inrrrta. interrotta da
una mort pr matma. Le f te miJru1e i per rin ediamenlo del dura i>Ono ri ordat 111
una fa.mo. a paaina cl Ila Tlta di erafino 1quilano cli Yincenzo Calmcta:
Era la corte oa de omini in qual l-e rnglia \'irt et rrcizio copio a. e tutto dr
mu ici po ti. da li quali. !tra lr altrr e rnp :.izioni. mai non mr. r rhe da
loro o aloaa com dia o traardia o altr norn penarulo o rrprr rntazion non e
a p 11a . Leaaevrui ordinatam nt a tempo conwnient ralta Comedia dcl pocca
ndaar p r w10 Antonio Grifo. mo in quella faculta prc n era pirrola
r las azione de animo a Ludo\ ico ' forza. quando. a., oluto da I< grandi occupazi ni
d I .'tato. poteva entirl a. Ornavan qurlla c rt tre generosi cavallirri. li quali. oltra
la porti a facuJtate. di molte altre \'irt erano in ianiti : \icol da Correggio.
ro \ 'e conte. Antoanetto da Campo Fr ao o: e altri a ai. tra li quali era an or io. che
di e retario con quella inclita \ irtuo. i.-. ima doru1a il luorn ot1<n11rw1. [ ... )
81
Anch fatt ah' l !!iu te ri rw avanzat <la Albonico (ad e rmpio . 11 lr effettivo
ruolo d 1 'almeta pr o B atri )M. r indubbio rii i fili d lla no. tra toria i intrc -
La in rui il C(reoara illu lra rimpr a dw lia idealo ;. il docum mo \ ' lii drlr 11ppr11rlicr Il in Cuu Slfl I
_QO-t . p. -90.
?9 ttl molo ili Brmbo. ull<'otalo dall1 lruer 209. 219. 2:n r 225 d Ircpi>tolario (Bt imo 1987- 1993. 1). si of
ferma \ tu.1 2006. pp. 109-110.
80 \ d . raffinit con 11 \hhr. la prudenza e la liberalit. dw J-.ahrlla 1ole1a dominanti
anelli' 11rll 111111111g1111 dr '<'affidata allo st11diolo (\ 111 1 2006. p. 125).
81 i u ienno iii riguardo i in \cosn 1998. p.
82 C11. \IEH 19:>9. p .. I.
83 hno:-.1<0 19%. JHts,fn.
11 2
ciano S<' lllprr pili fittamente. ,' ulJa . cena della corte ecJiarno cornparire r qui ]ano
' lra111botti sta 1 iinprovvi atore. il Grifo, clic vrro irnilment proprio a B atrice dedi-
ca il uo i ncu 11abolo ili u trat . il Corre11crio r il Vi COJJt i. chr n i uoi canzonieri non
a stampa crlchra B atrire Bianca 1aria .'forza. .\1ilano dalla 't cana ono giunti
Leonardo da Vinci r il Belli11cio11i . porta di dubbio m rito ma di icur opportuni m
mondano. im iso all'ari t crati c b n pit talentuo o \'i. conti. I e rimi' dei du . <li-
tr nrl H 3 p r I<' rur di Frane e lanzi . ono immer n Il occa i ni cl ila cortr.
pur srnza 1111 grandr roinvolgirn nto d I 'vloro
8
". r ono rritt a lr tto contatto con
ali artist i. \'i conti r ara11dr amico r prot ttore di Bramant . h \ ' lentieri udiva e
b r
diceva in proviilo i11 . u la lira (Va. ari) e del quale. orn p ta. i di hiara allievo >:
B Jlinrioni e lrhra l'orafo 'arado . o ( :ri toforo Foppa) r Leonar<loll<'. che realizza
il di cgno 1wr la . ilografia che ad rna il rront pizi d ll Il rime e appronta ali
apparat i . crnici della Festa del Paradiso (1-t90). u libr tto cl Il t o Bcllin ioni.
in onorr <lell<' nozze di L abl'lla (r .\racrona con Gian Galeazzo forza. Il onetto rh il
pota to. rano dedica al ritratto di rilia ali rani (1-t.3-r36). tradizionalm nt
identificato con la Dama dell'Ermellino (J..+8:- -1-86). adotta il m cl llo cl 1 dial ao.
in que t rn o tra il poeta e la \'alura. r ne fa il pr te to p r loaiar la donna il
J\loro. committente d l ritratto , uo ian re:
- Di rh te adiri. a chi imidi a hai . natura?
- \I \ 'inri eh ha ritrato una tua tella.
Crcilia -. lwli ima hoagi ' qutlla
che a uoi ht>gli orhi cl ol par umbra oscura.
- l:l10nor tuo. e htn con -.ua pictura
la fa che par che a1:>colti l't non faYClla.
Pensa. quanto . ar pili \\'a et bella
pi 1 a te fia aJoria in ogni t futura.
Ringratiar d1rnqu Ludcl\ ico or pi
el l'ing ano et la man di Leonardo.
che a po teri di lei \o gli on far part .
8-t Il ducn 1'1'11 probuhilmrnte pi1 rri-ibil( ,1 carmi (' OllH' qu Ili di .io1anni Biffi. 11> iti lo olt> anno 'onora
111 r111t l'll('OllllhI iri ( cfr. LBO\l f.0 199.) ).
J ,. 1: I I \ " 11 ( \ .E CE L99) Jl 1 :!) ui )J('ni di Ga1>11ro f1"
8!) hw,t Rrnnwntl' nh11a1 a 111 una rasa u1 prop11r ,1 l t 1,c 1 1 : . . . . ,
l\U.l I 198?
1
rfr. \ 'Ec< b 199.'). p. 20. I sonelli di Bramante ono tra,1m,,1 dal Ili>. P1u:1g1.
tionalr. l111lil'n 1 :>-t:3. C' l'. ?Or-. -tr. antologia poetirn fomla111c111nle per la alla '.11quegli 11
11111
(Brllincioni 1HTOll('. Paolo d11 Tae<TiO. 11lrono dd .arreno. Lancino CurLiO. rmnn,ro lanzi t' ullll qualr
fr. t 9<>5. pp. 8'..!-8:3.
1
chr Ltonardo <' Brarmmt, nbhia110 l'Ollnhornto 11011. olo Ili. anrn '.\ la-
. I : 11 Il 1 eut(l 111 r, di ror1r e 'lwttacoh tearrnh.
na d llr .rnz1t'. ma onrhe 111 proget11 nr ia1w,tu 1 t' ne a e' 1111
1
" ' .
86 BEl.l.l\('10'\I ( -t9:l. e '(onerto] prn il re1raclo dr \ ludonn quel r:('(' .. -tro l:t'?nardt'. U\ che '.('
d
. / 1 J f ?) '(<>rinito] 1' 11 lintt' di 1111111ro ho1111111 ftuno:-1 11mnu 'otJO .1 I umbr,1 el loro 1 t
a 111. r1e11 1111ti t ft u11. 11a 111'f1. : e, ,
1110 trando q11rst11 matinu Cnrndo,;,o <>ioic lrg1111 (S be1111011 lero <ti ramo la 1111t11m).
11:3
Chi lei Ycclri. cos brn d1( i>ia tllrdo
\Wlerln \'i\'a, dir: Basti a noi
co111prrndcr or qud eh. natura rt artr
87
.
fl onetto n l ciuale .\ircol da .orreagio loaia Leonardo n 11 si riferi r a
1111
dipinto identificabi le ma all'a traila impos ibilit li un ritratto. ptello cli una don
11
1
tra r linaria per bellezza grazia:
Zeu. i. Percotile o \pelle
che arnto aw., e a ritrar que ta in cari<.
do, nclo in lei mirar eia una parte
la arazia che puoi mi'\ta con qu lte.
corno a cruardar cl olr o contar
la , .j ta in lui ria mancata e l'ari .
p n:h natura a rocchio non ompartr
potenzir in qu I che namra e'\cell .
Cus. LEO\,\RDO mi . . e il tuo CO"nomr
Yi 011 guir. eh O!rni altro \'I\ I r exc di.
op1ili il \iso e incomincia a le cbiomr.
perch e a 1111 tratto ue bellezze wdi.
tu el ritratto rrai. non lri. ch omc
d'occhio mortai non ,. che mi <ncli
11
8.
L'ipotetica e nfiua deuli t i arti ti antichi darnnti al compito cli rappre en-
1.are qu La ' ricondotta all'impo ibilit di o rvare il modello. di o lcncrn la
\'i ta. ancora prima eh di imitar} . . 'on ' ri,alit n rarto di \'i i n tra antichi
e mod rni I er hr I' ccrll nza cl Ila natura (il uo ap la,oro) arnrnlla l ouardo
cl IJ'arti tacla uat cnica. uperandolefa oltdrU'o chiomortal .Jfortiric rdipc-
1.rarchc hi (ritrar [ ... ] in cart : LEO RDO rnio: O<Thio mortai ) biadi cono
dietr il ornplim 11to all a dama e I' omacrgi ali' arti ta. nrl qual il O'ioco on ma tiro
( Y[ 'J ). i combina con una finzi ne rh nrl 'inqurcr11to di" nter . empr pi
con u 'la: I apo. troC al pittor co11t mporaneo. n lla forma di un con i11lio o di un
ammonim nto da part del pota (w. 9-1-+). Lronardo r ca11tat da molti altri porli
(Piallino Piatti. Ta on ... ). tra i quali il famiucrato Ca. io. eh c.ledir v r i andrc
al principale allirvo dt>I
17
rand to cano. il B ltraffio. lodat da Lancino Curzio <' da
87 BLLLl\CIO'I 1493 ('(' \fr\ iir P'r I' 111af ' 1c , ,,. q e . cl ' Il ,. \ . , . d e . . cl Il
. . . . . . . ' ' ' , I li '. IO SOIWllo r I qur o ( I I('('() o a ;(JIT('"!-(IO f'llll<lll o a r
mw o.,,rna71on1 m Bo1.10" 2008. pp. 186-192. "'
88 CoRm.c;ro 1969 189.
11-i
Jarcello Filo senosc'. Cornr nel ca o del Bcllincioni. la cor1c. ia drl rimatore tro\a una
O'itanziosa controparte in u11'irnrnauin . e pi[1 pr ci amcnte in una erir cli ritratti: il
Boltraffio raffigura a pi riprr e il Ca io. in chiaw ora C'riptica ed rmblematica. ora
pitt naturali \cl a o drl ritratto Dr,on hirr. ' pale e l'influrnza d l modrllo
doppio di originl' 111u11i matica, in quanto 1i1d recto i vcdr reffiO'ic idralizzata drl
porta con le iniziali C[asius] B[o11onien i]. r . ul l'erso un tC' chio ron la <Titta cl\-
IC\E JERO\ \'\11/ C,\ ' lh. con prohahilr allu. ione al doppio caratter drlla
ro11im. raccolta chr rnmprrnd 'iia p ic d"amor ia rpitaffi .. "on importa tabilir
il trtra tiro m I qualr il rimatore boloO'n r loofa il pili re ia tato , e-ritto prima
o dopo l'esccuzio11(' di uno cki ritratti: il dato ianificativo atte tal da que ti ami i
che il pr tiaio cleO'li arti ti <' d I ritrauo ' ormai tahilito. com pr so i iunori
co prr. o i po ti. Cli criuori non olo ' i fanno ritran- in medaulie in ta,ole. ma
intui cono le potrnzialit dcll'aulorapprcsentazione ulla OO'lia delfop ra. il valore
' memorabile' cli un doppio ritratto ompos10 cli effiair r parol (e rpo e anima). i
ignificati h i posson affidar a un inci ion<> u frome pizio.
Tomiam ancora una rnlta alla fontana d 1 Furioo. per illuminare la tatua cli
Elisah tta Gonzaga (OFXLll. 86). dalla qualr i irradia una r te dir lazioni a1ii ti-
chr <' lellcrarie hrn pit ampia di quella tracciata da ,\rio to con i nomi di adol to
e di Bembo. lrhino la e rhortt> di Guidobal<l da f ltro anima una Yi,a i -
ima e ne, rirvocata da Ca tiglione nel orfeaiano: la duche a a patr cinare I
Colle1to11ee in mortr di 'erafino quilano. che era tato uo o pite e protetto. a I i
ono tkdicate lr rimr di Panfilo a o r la forma del canzonier li
Bembo. il pro imetro di io,arrni .\1uzzar lii (L'amorosa apra) 1u 11 . olo pro-
uettato. del almrta. Pr prio l paain del orteaiano ci mo tnmo. per o dir dal
com p t \'H 11a cere un t to d' ca. ione . . el nono apitol d l
Bcrnard ccolti. eletto n nico Ar tino. propon un ioco 11el quale
17
llllll chca CIO
clw CTPde cht> hi qu IJa l ttera . che la iITT1ora Durhe- a porta in front .ma
Emilia r plica chr lui olo. per e me on e ama li.,ahetta. pu t ntar qu
impre -a:
[ ... ] Unico. avendo tareiulo alquanto ed p'.tr che :-e, i11
ultimo di .sr un .., 11 tto la materia prcd na. dt.'dnarando c10 chr
qu lln lctt<'ra , : che eia molti fu stimato fotto ma. pc1:
e culto pi[1 h 11011 pan e eh la bn'' ita del tempo. penso pur cht
f OS. !' p<'llbUlO <li.
89 11 I ( I' '>0()0 1 fr 111chr \ 111 \1'1 1 ()C)C) r :.01ua11u110 Pl-D R,o, oro,,.,,, 0110 M'"llH 11{1 (a ' IORIO - pp. - 11111 ( . '
90 ' ( 't ' fl J 98'3 JoOHIO '>000 pp .fQ .f(J tht hll :.OllO(illl'!llO ('Olllt' nt'Jla !ll\'Olil di JJal>WOrth
. ,
1
n L'U\
11
e r. IM
1
' . - ' . ,
11
. :. l: S ()' ., > di \lo 111 , i1 n<' isolato il primo
ti Casm <' 1ioela d a111on ,. pmtn d1 11101w , 111ene 11< < '' 1,101111 1, nn ...1 <
11 1 1 f "o 1 o h fr11Tin che <11111 ruon' ha prn1rnto a'llt'lto: cnlln 111a110 inl1l111n ..otto la g111 1 Hl a 1m 1carr 1 111u1r .1 1ist n 1 "'
(i d. p. +I ).
91 C1-,r1 .LIQ'\f 1981 , I. 9.
I IS
li oueuo improni, ato dalrL lui ul aioiello a forma di in do at o dalla du-
che a i pu for e riconocer in uno dei te 1i rintracciati da Uberto Moua, che
ha conte tato. con buoni araomemi. la tradizi nal id ntificazionc <l I aioi llo qui
vocato con quello \"i ibil n I ritrano d Ila du h a altribuilo a L"Ac-
colti, co110 itore d Il a Planudea e pionier dell pigramrna in volgare autor di
irumrnerevoli componimenti u -1atue di oag tto mitologico, oh.re ' h <li un onelto
u tUl ritratto colpit . dove il buMo parla e i] motirn della dm zza d Ila donna i
intrec ia con quell della tatua priva di 'ita:
Io che on culpta in marmo umido ba o.
dal pil'to in fnor on imil alla YiYa:
acqua da me. da lei pianto dcrirn.
lei dura e fr dda. io duro e freddo a o:
io orrni ,;iatore tupido la o.
lei ogni errn uo di en o p1fra.
lei candida pi che ro a e riva
et io col andor mio la neYe pa o:
lei d'ogni amator uo frauda el disio
et io. eh mo tro e5er virn. confondo
bi cerca indarno el concubito mio.
Qual Lei ridendo 1nia durezza a condo,
qual lei mirn ciascun con volto pio,
ma e chiami qual lei non tiri pondo
9
:i .
Il componimento i regge u paralleli mi e antit . i tra tatua (io) e modello r al
(lei). riuniti nel paraaone e pii ito deirultima terzina ( on anafora di Qual lei). che
as o ia il busto e la donna neJr asp tto b n olo ma anch n l ilenzio. Il carattere dd
te to. dominato daJr e rcizio inge!!no o pi che dalr elogio d I ogaetto, non fa uppor-
re una composizione in morte (tanto pi che al . 2 i clic viva) ma se si potes e di-
mo trar che come o tiene Damianaki. il bu to al qual i rifer e ' commemorati o
e fu auito dopo la morte d ila duch a Batti ta forza. n ti ulterebb rafforzato il
rapporto con la tradizione d li" pitaff.o al vianda:nte
94
. Ila ba dcl bu to la rritta
DIV B PTIST . FORTIA VRB(ini) RG [Re<Tnatrix) eh la id ntifica e la celebra.
92 200-t. u <JUC ti onr11i r. ul ritra110 degli CHi.zi 1orncr al :u. Prr lr rim dc!rA<-colli cfr. L\ 'lALh
1993 (' \h:s JXJ ACCHJ 1996.
9:3 1515. c. Kk4r.
9-t 1998 (pp. 386-:rn?) rirJorta il lesto con la cOrJJa J)ucl1r a di Urbino .ul1Jita e 11 1"'<'-
. I r ,. too
nscc r lf' opc:a in qucstion bia ria id ntifirarc con un liu to postumo di Battista .'for.m . . colpilo la fni11cc;,co
Laurana (per 11 busto. con rnato al Bargello. ffr. OA.\llAXAKJ 2000. pp. s:- -60. taw. 82-86).
116
Perch non e ' encomio s HZa nome, abhiarno detto. Cosa p n are all ora dell ul-
tima statua, eh 11 Ila fontana ario tes a oc upa la nir hia tra Lucrezia Borgia e
Beatc d'E t ? ' d Ua tatua C'he. ola. la o ti ne? Di tutto 1 re to rano i nomi
uhi;/ ol qu ti duo rarteficc ava occuhi (OFXLil. 9:>, 7-8). Lin onfondjbile
n ra gonna e il vestire schirtt.o identificano lessandra Bcnucci, la donna amata
da riosto, che ritrae e tes o. con reticenza altrettanto tra. parente, ome ardito e
rozzo inaegno ai uoi pi di. La collocazion d lrunica tatua privata in que to
mornun nto alla b Il zza e alla p ia iguificativa p rch. cbiud ndo fottagono.
le couC'cd un po to donore. Lanonimato in ui la ciata i addice p rf tta:mente
al suo statuto di dorma della po ia: non n una donna nobile op lente n una
dea. la donna amata. 'ella tradizione liri a il ritratto !'a enza-pr enza d ll' oa-
getto cl amor on temi profondament legati: per que to la domanda ul ritratto
e ui modi in ui la po ia ne parla non rie ce a liberar i (e non dei e liberar i) da
w1 altro interroaativo, che riauarda l amata le , ue rappr . entazioni e parizioni.
Finora abbiamo vi to epiarammi. carmi e onetti che lodano i ritratti dei irnmi e
delle loro pose. occa ionalmente lu. ingat di qualch com nzionale aalanteria.
quando e in que rione il iitratto dclr amata. co a crivono i poeti? Com interpreta-
no l' anonimato eh il a nere lirico pre cri.ve o in cui riflui ce attraver o le fonnu]e di
un codice condivi 0
95
- anonimato che il nzio u un uome ma anche in onsi tenza
cli un oggetto. tutto interno alla poe ia? que to dato limita la nostra po -ibilit di
ricondurre i te ti a immagini preci e, dov po siamo ancora rintracciare con icurez-
za la memoria degli oggetti? Co a r sta in poe ia, di quell e eh Micha 1 Camille ha
chiamato love r lic
96
?
2.4 Occasioni della poesia d'amore
me a fare on the window 1 re.
waiting as eYer, mute the wbile.
mv love topa hrlow in the qua re!
Hobcrt Browning. The talue and the Busi
ella poesia d' arnorr (in o in per ona di) il ritrano al d:lle pi vari.
a ociazioni di motivi. pi o m no aro-uti en ual i. perim ntate m umumer Yo lt
9
- I) I 1 I i ( ' )) 11..1") d1 Dn11te e di P\tran;a (cfr ,Jl.\TI 200:?. pp. -t23-
. ,, opo (' .111vc11z10111 11u 1v1c na 1zzmll1 <' 111s1\'ll1C e <'"
1
1 :
1 1
.
1
,cn9) r I I li 11 l' tenclt1110 n scomparire dalle n1c('O te mc Il'
...:1 e s1111 1c11tnre All<1stni1on1 ie, 111011 111<'. e ai 11 t.
(dr. Go11N1 198%).
Il I .. t l 1or10 tra fomrc k11u11i11ili. anonimato t'
96 c\\JJJ.l .f. 1998. Per Il' qui nntc, e JO pnrll('O Ili( pr1 L ra1 I
rh!' 11011 so110 11!- ritratti n alkgorit\ efr. infra. 3.6.-t.
117
c. cr 1z1 I otici lflmC'ri legati a 'ommissioni cortigiane o all"r il romarl7o di una
passi nC' prirnta. 1 -ci tC' ti rirondu ibili al rn dcll di H1:f LXXYJII. i poC'ti illumi-
rnmo un altro ,cr ant dC'lla ,ita del ritratto. in cui la ua natura di rappre C'nta-
zione onta olo in quanto 11 pcn11C'tte la funzione emotiva cd erotica. irr guanto lo
I on in una r !azione aff ttirn r fisica e m un :ogg t10. Qu sta di, r a C'splorazio-
nC' dell po il ilit I l tema i compir :ulla scorta di coli di !ragerrdc aneddoti
di cui far t :;oro oprattutto la tra<Uzic n romanze. ca'l
7
. li ritratto pu 'O'tituire
un v ro e propri oaa tto d'amor . p r quanto prowisorio <' leuato a uno po ta-
m nto: mma incapace <li comunicar mozioni. l'imrnaain inn ca la rict rea
d lroricrinale o con cna u e tC' a i11 quanto ' imulacro a cui non corri ' ponde
una realt \".\" lll r attenzion fct ici tic, deff UlllHlll eh IH' desid 'ra I' animazio-
11 <>s. Pi rnmuncmente pero r effigie ' I r aria e mpensazionc per L1ss nza di
lma reatura amata. eh i allontana o dalla qualr ci si d n all ntanar ': il ritratto
dfr nta allora un ocra tto o titutiYo. ul qual i po .. ono trasferir" temporanra-
ment i entimenti nati al contatto e n roricrin< le. \ Ila pro pettirn del de iclPrio
1 Ila mancanza. tra re .ere in carn e a il ritratto :.on po " ibili pa. acrgi
interrn di e o timzioni 1ipetut u e i,e. daJrimma!!inazion (nel ocrno o nel-
la fanta ticheria ad ' hi ap rti. n Ila fi azione volontaria dell'immagine nrlla
rn nte) a] ritrall al mod lloQQ.
La richi ta r:imio dcl ritratt ono tra i motivi pi f 011u11ati pr . so i po ti
cortiaiani. eh e pandono anch il ruolo d l imulacro interiore. plorau<l artifi-
cio interazioni lll taforiche. fl ritratto r ri ('\'UtO COlll p O'JlO damor in pcrata
on e ion . o cl nato e me dopi io del p ta-amante e imolto nrl rapporto con
ramata. Ri pet1 aJr ampio r pe1iorio me so a frutto dai narratori in prosa. la p e. ia
pri\il gia 1111 igu mun rodi ituazi ni molt odificatr. he per natura aderi rono
al modo liric : . olitu<linc. idolatria. azioni parole prodott dalla lontananza. dal
ricordo e dalfal>hand n alle \'i ioni int riori. Lallocuzion al rinatto drammatizza
rin omro tra rio l'imma!!inc. ciocrli ndo nrl pr n1 e d 1 t to la :i t uazionr ri<'vo-
cata ria Petrarca in Quando giunse a imon l'alto concetto. L enario pi <'On. 11 to
p r il confronto tra amante C' ritratto ' un luog hi11. o ind fmito. in rni J"io sta
. olo <li fronte all'idolo lo ven ra me in un tempi : la predii zion per la carn ra
<J7 cr ... aJmeno BLTmJ 1992.
98 _n111raJ1. rOl111' 11t'i colpo di fuJi11i11<' direuo. 111a 11011 r'i scwnJiio. cl:amare u11a piUuru r i)
(lC uno dr1 mali. \on 1 1111 rorri,pcmdcnza. rri\'f' Giorn11 Franct''"'' Londuno nrlla /Jianea ( 16:3.). rit. in Pu>t 1-
'. \ r \lO 199?. p. 72). Il mito di in . rarionw di innamornnwnto prr wia M'i111Jia11za invcnrnla.
I' tra 1 p1u fonuna11 andw in po '>ia. ma '>Oprallutto in rifrrimcnto a inunagini 1rat11 da oggrui vtri.
\rl (''t'lllpio in una '''.'flll'll7:3 df'gli !mori (onte I:)? 1) di Gionrn Baui .. ta Pigna raman1t dnppri11111 I agheggia
I amata a--111_11: rwl 1w11,11ro r 111 oog110 (Prcq 1991. C\ li-Cl) ma in rg11i10. fru 1ra10 dullu nulurn rffinwru di
qur,,ta upp'.mzume. "il<' i_I r.itratto dipiuw. a sua 1ol1a inadeguato (ivi . 'li-Cl\' [L'ajjligersi per cedc'tc
la
111
01 d1p111t11 fro1am s11m1gluw=c1 ]) . \"ondo il prore '-O i11ver. o. rwl Prinripe llennafmdito ( J 6.)3) rli
I rrautf'. Palla\irmo. Orgill1 I" pri1111' imagini drl MIO futuro i,po o clc-rivano dalle li11g1w. rio/. dnllr porol1
(p
1
11111ll1 della fa111a): 111 un $tcondo 1110111!'11LO 111' 111olr il ri1ratto r infine brn111a l' originai.
118
r pri11te fisicarnente il ripiegarnrnto clrl perr irro. la monomania dcl d i<lcrio. rlla
\'ita del ritratto . . tatica e na co. ta. cri i tC'rni . ono im 'C'f' crrnrriche di . tanzr da at-
traver:,arc (nel pa saggio dalramata alramanLe. e virr cr-a) o t atri naturali dove
proi zio11i irrnnauinari . o titui cono tanto la pr<' cnza quanto reffiaic mat riale.
J1 ilrnzio:,o colloquio ron rimmagirw d comi lenza pazialr alla condizion
lirica I r e cccllrnza. lo tato d ll ' io in a. enza drll' ogcr tto <f amor . la cui \i ta.
dopo la prima,<' fatalr vi. ione. non . i d pitr . uon com e\ ntualit uegata o com
miracolosa eone<' . ionr d Ila orte . .'ccondo una luncra tradizi n . ali cruanli drcrli
amanti incontrar:,i in hie a. da un banco all'altro ( P r cl prcfaL illu tri -
im '(ignore) a la me . a irn pecto la ua amoro a la 1ual 1 r cey' poi ad
trn orto roo: Per una donna che clic ndo orazioni in chie a cont mplava uno :uo
ama11 te
101
) o complice mtcqua:,antiera. davanti alla quale la donna e ita. p rch'
,orrehbe rYitarC' ramante l virino(' in iernc pr nder racqua b ne<l tta
102
: o per
strada. in particolare quando la donna . i mo trn ul balcone o alla fine tra (lo no
ancora dr mirar \'ago/ r antiqua rt de iata mia fin tra/ h 1 cruardo mi altr ve
non ra/ n curn altro vrder r animo appaao./ quando nza quC'lla bella
imacro/ la \egaio facta olincra et ihe tra./ ( ... )
10
:
1
). ll profilo della fin tra p o
. i comr la cornic di un quadr
10
'. lando ra<Tion a \'irt r t i hita e
al rrcent 'eba. tiano lei Piomh ndo R ne niio;;: ' un'apertura u un luocro
uiacc ibilr (la ca. a di lei ). ntro la quale la donna-1itratto appar e compar . e n
mi"impr Hdibilit do lor a per gli o chi che \'Orrrbber aziar i cl Ila -ua pr rnza
(Fin . tra crratio.,a [ ... )/Quanta doalia. \'l.'O'!!io io. h ra tu hai.I rhC' dentr a te n n
ia mad nua \-i la. Hl()): I r co11tem1 larla a piacim nto. il poeta i far bb ' lentieri
inratC'rrare alla grata della fine tra ( 1 fo i ferra tuoi. fin tra me ni
piedi. ma l fo . t' trco/ madonna e m Jr rt i rnm o./ pr !!i m mes tu to
in Sila lrnla IO'')_ purch r alllal.a tl011 j riti ras (' pili di tr l pare1 l he }a !la COll-
100 e \I.I.I ICJ8?. 99. E C.fr. i1 i. 166: c.'ta11rlo rl 111in ill (u,Lri,,imo) (ignor ) l'(ederi1 ) a In llH''-a 'routro a la -un
llJ()ftl'll lll )a [c.,ta cJj \iro) ('J poi la I idi' a la rmr,(nl> ( \ ).
101 \1,(0\1'1 197<l. \ .
102 cli im' rutt' et 't'!Jll!'lllt' ,0
11
1110 fumo farti ad qut,to ,11hie110. E"rudo uno :;ownr in una 1:hit''a appn-.o
1 I I I 1 1z11 o volrrnt' pi"liar 1>01 dir 'l' ae1on-1'
ad uno Uidio d1 aqua ..a11rrn. w111u n11111ta ,ua ,pcun< o n < uhJU1m1 tN r i:: . . .
de
l "i11w111' 1 il1 11 1 1 l"1q111 '!' rit1t11m 1er"orr110-a ul111w1110. et poi dw 'tetre 1111poro111 for-
1
01,t' ahruu<li i
,.. ' ' ' ' ' ,.. - 1 cn (n 3>] B-> )
pa-,,i. Il "iOl!' nr parla in q11r,1i dui 'orntti u lt>i ml'ntn 1111l'!le ,u,1>t,11 (\1,rn,T1 i -. - c. _r
lo
) (' Jf)U >5 I ' cr I ... ) ...t "' /.() (c P11 u11a linc,lrn krata clo11' 1>0l!!!i31'81'1111101\MI tld
> ,\llJ O - . \I . -v . .J. tllll lt lii.- TJ V
1mfa111 .' (iunorc) (F)). .
' I 11 . 11 .1 ( frs1111mlb).ndts.rt.18n19r.
10-+ Con1c tait' 111 f1111:-.1rn t r, pprr.,tntala anc u 111 mcu111110 tHjlllrlllll llO e . ; . r- ( I
Il
,. I 1 ' l 1 ' 11 cl<1 auri on \ en w1. I.> I;> ra. Lont m.
O Ili' lll(' ISIOll!' su) rro111<''fllZIO l t')! J , /1'(1111 IO/I tolllp0.1 .,1110/ (1!11! I I '
Bri1i,Ji Libra0. C:. 37.1.7). riprorlo110 in 1 ()88-. p. -+.>. . , .
rn:i rifcri,111 nll11 111rn.1rn , '1baslia110 del Piombo (Ho111n. Palano \'cuezia. 8 febbralLl-18 r11 ig io
2008). il cui 11llt,tinll'11lo i ,t1110 < ural<l da L11r11 Houcoui .
10b C11..1.1 1987, 70, 11. t. :'i-(1 .
107 hi. 7-+. n . 1-4.
dono. oltre le quali -i tro\'a il h1oao pi di oani altro vi tat ambt : la camera
dell'amata, eh a ua ' 'olta pu djy ntar la meta dcl ritratto.
La pectiarit dcl ritratto tra ali arredi' del petrarclti mo' data dal uo movi-
mento al maraine tra lo pazio e elusivo della donna e lo , pazio dell'io amante, al
centro di uno cambio c01rola1orio fondato uJla O' titnzione. Diver ame11t dagli
oaaetti tabilm ute collocati intorno alla donna. il ritratlo prc' upponc uno spo ta-
m nto e volae una funzi n in molti ca i parallela a quella della lettera o dei doni
(un fior . un velo. un ch-appo, un oag tto on ol ri da in1crpr tare. un bialietto.
un pi colo libro di Yer i)
108
I pi tardo pece/zio d'amore (15-1-7 ) di Bartolomeo
Gottifredi la matura oppina in eana alla aiovane .\1ad<lal ena com ri ponderc al
orteaaiamento. inYitandola. tra r aluo. a mo trar i alla fine tra con una l ttcra
(la quale fin ai di l gaere. e parte lo auarderai. dandogli a cono cer p r que to , e-
ano che tu ai legger qu te lettere a mano. che I l l1erc ue ti aricno care
109
)
e ad apprendere il irnificato imbolico dei colori, per non commettere errori n Ila
complicata chermaalia dei favori amoro i
11 0
:
OPPL\A: OITTii color ha il uo icrnifirato: il \'erde speranza. il ucro fermrzza e
dolore. il giallo di perazione. il rancio contento. il bianco purit e fede. razzurro
gelo ia. il leonato noia e fa tidio. il cancriante in rabilita e legg rezza. il bigio
traYaglio. e co gli altri di mano in mano. Per bi ognrr che tu gl"intrnda. ed
a propo ito gli . appi ri pondere. E. poich dri fa, ori parliamo. io voglio, per pi
egno damore. che tu porli la impre a sua. la quale troverai nei colori drl primo
favore ch'egli ti mander. e. e ibile ar. in loco ch.t>gli la pos a ,rdrrr ed
acrli altri non dia da o pettare. potra lo fare appi cando que!>IO pendaglio. che
hai in fondo alla collana. cou un chiappettino di qurl f'Olore. <lov ora appr o
con eta rancia
111
.
ono modi di una comunicazion cifrata, eh tra i uoi crrni a1movera la poe-
ia. e. naturahnente: il ritratto, che p r non condjvide con n uno cli que ti orrgetti
di cambio (tranne che. in parte. con lo pecchi o). lo tatuto di rappr entazionc.
di doppio immedia1-o di una Putbianza: neff irnmagine la prc cnza da iicordar o
ri vo ar non ' m diata imbolicamente (come ac ade ad f' empio per un gioiello
contra eo-nato cla cer1i colori o att1ibuti
112
). ma dir ttamente 1iprodotta. li LPt-
108 Parolr si-riLte o oggclli con1101ati veicolar10 in modi diver&i figur ru,sen1 i o con e mono. per mrdiazione. di a('-
rrdcrr alla Ila donna. Ricordo arwhe il aro alla Pliadr. per cui ramante de idt>ra trru,formar;i
in liii ogge110 <Ire e V1tu10 alla dorma. Prr il rapporto tra lon1a11anza e condizione lirica cfr. PnETE 2001.
109 pecchio d'amore. Dialogo di Messer BartolomPo Colli/redi nel quale alle "io11oni s '1sPgtW 111a111orani
(15H) (ComFRw1191:2. p. 269] .
110 h-i. pp, 268-27-t.
111 hi. p. 270_
112 Cfr. ad e. R'l' 881. clic Ja parte di 1111 gruppo di clwrzi tassiani ul 11<>111r di Co tanzn ' forza. duci)(' sa di
' ora (879-88:2): Col bd diamantr uo lrgato in oro/ clrr \olle dir <os1ci/ clra spiali amlwdur gli affetti mi!' i? I
120
terP Amorose (1587) di Lui ai Pa 4ualigo il ritratto una drllc prime preoccupazioni
lei dur amanti e i ge ti che lo riguardano vengono letti come prove cr amor o cU
noncuranza:
[ ... ] \'oi non vi iete drgnato di tener al ritratto quei cordoni ch'io \"i mi i ( .. . ] Avt>va
dclii crato di (Tivcr alcun(' lettere u la cordella. ma perch voi, duhit.ando for e
d1'io non ve lo rende i. mi de te tanta fretta. non ebbi tempo di c1iverle: ( ... ]11 3
( ... duol infinitamente rh'abbiate in pf'n i\:l'O eh.io non mj ia degnato di tener
al ritratto quei cordoni chC' voi vi mette te. come a me poco [ ... ]Onde e ben
io tol i via il cordone bian o da e o ritratto. non fu perclo lo riputas e indegno di
tal luogo, ma perch venendo da voi mi parv pi com nevole il tenerlo appre o di
me che il lasciarlo nel luocro dov'egli era. Tol ilo adunqu e per goderlo pi compi-
tamente me lo legai al braccio. La ciai la cordeUa bicria dove la mette te. e le cii i
opra quelle lettere, che pm avete ,edute. [ ... ]
1
H
La casi ' tic a dei comportamenti amoro i doppiament o pe a trar alt e let-
teratura. in quanto da un lato ricorre pe o, nei fatti. alla poe ia come tTumento
di conf e ione e di eduzione, dalr altro un 01izzonte di e perienza con il quale il
codice poetico i confronta o tantemente. a imilandone le con u tudini. In altri
termini. ituazioni reali nelle quali la poe ia ha una funzione pratica diventano e
tcs e oggetto di poe. ia. Que to accade in modo e plicito e dichiarato nel ca o dei
te ti in per ona di pe o commi ionati per commemorare epi odi di una priva-
ta vi nda d'amore'
15
Let1erariam nte pi m diata ma non meno vi to a 1 eco di
que te pratich nei capitoli in t rza rima, che. u1 modello delle epi tole ele11iache
rievocano m ccani mi e cenari 'dall'interno'. grazi alla loro natura di lettere. e i
po ono co tituire come frammenti di una toria (come in certi pro imeni quattro-
cente chi
110
) e ome monoloahi di per onag!!i (i peni alla traordinm"ia fortWia,
11 i poeti cortigiani della crittura in p r OI\a di figur f mminili). ln que to
nuo risprcchiamcnto tra realt e poe' ia non improbabile int rccttare la memona
di esperienze vi ivc materiali t timonianz che ri ono viv e parlanti proprio
e accettiamo di non ottrarle al conte t ibrido e qual appartengo-
no nel quale olo i picuano.
L'uno tan10 siudurn/ ('he non rnolr altm imao/ e par di sua hrltl contento e pago:/ l'alrro c1alato Am r pr
de figura:/ <'O qu I fido Amor rh'twni altro anmza/ adorna la cosuinza./ e nel tenero perto/ forma non cangrn
ra111uroso flffctlo.
11 B1SQI ILICO 1587' p. 18.
114 lvi , pp. 19-20.
115 Cfr. Ho, s1 1980, che clf'n('n il ritratto Ira i topoi du' rientrano nrllr funzioni na1Tativt' riluto-egemonin-
nazioni >.
116 Cfr. Mussi 1 11r:c111 198().
Ll
'... .. - li ritratto dell'amala
\'enio la fine d I canne in cui celebra il talent di Pi anello ritratti ' ta. Ba inio ac en-
na alla ua abilit nel raffirurare le grazie dell fanciulle e <.lichiara che, -e il pittore
rappr nt r la ua amala Cyris. per ricompen arlo canter o lo di lui (Quid . i
feci ' e niY a mihi forma./ Qualia dona tibi. Yir memorande. dare111? I [ ... ]/
Te canerem olum ...
117
). e molti l o ti cantano la pa -ione per un ' immaaine pura-
mente ipot tica. ancora conlnata nel dominio del de idcrio e delr att a. per alcUJ1i
il ritratto dell amata w1 oao-etto ai oncr to e 'Onlurbante. Il rapporto con que ta
pre enza artificiale e tanaibile pe , o molto fi ico. impHca una relazionr falla di
onfe ' ioni. di paro! lacrime ma anche di ba i. pericolo am nte porta sul rorifinc
delr p rienza erotica. dove l peranze di un appaaamento piamalionico i infran-
aono e il ritratto, letteralmente. prende fuo o. Co- in un carme in cui
rivolae alla tarnla nella qual dipinta l'amata (Ad tabellam):
Pan'a. ed nimiwn tabeUa felix.
Quae vultus domi.nae refer cupito
Et nunquam milii dura. acerba nunquam.
Fronte ne cio quid nui erena:
1t le conspicio liben et ora
Amoribu aucta Gratii quc
Agno ro. ut aeoula meae pueUae.
Ut caro libet in I urri ocello .
Quo dari cuper t ibi Dione!
( ... ]
.\t vo interea. lahella cara.
An e t cur eao pr . a non rr twgo
Et centmn fero ba iatione-r
ed qui tam ubiru. r fuJ il i!mi ?
Quae te fax. bona. corripit. tabelJa?
co incendia dura. no. ro 1lan1111as.
Qua de pectorc conrnmo ac I uanti:
.\tea i thaer. mea culpa: ego celestu .
Qui te dum trmer o 11Ji . fatigo
Et iuncto iuvat ore cornmorari.
aevo pcctori haU1u p ru . i
11
8.
11? co,a t'. da_rei. doni: uorn.o memorando. 'r mi rilrar,si la b!'llrzza di C) ri ? ( ... ) C1.111lrr<'i >Olo lr ...
(Brmniu.tad PI 11 \ M p1clorem UWf'lllOsurnf'l optimum [ 'oRDEl.LllJl 199.5. doe. 61) . , ._ 7:3-7-t. 77. trnd. mia) .
118 ma .trao;di11a;iamcntr fortuuata. che riproduci il d1 irlen.ito volto di mador11m 1 11011 sei
mai lfl '>e1h1lnlc nei n11c1 confronti. rna1 dura. 11011 o a 1osa fai cenno con la tua fro111r s1rr11a: co111r ti o. >1rrvo,
allC'gro._ r rirn1.10 co .il di mille Amori e CraziP! Com!' brllo cont1111plarr lr pir1ol1 gua11cr
drlla mia 1 1101 can oc<"h1. li<' Dionr p<'r drsidcrrrrlibr iu do110 ( .. . frat1a11to. rarr l11blira. prrchr
prrnwndo\'t 11011 "' uggo e no11 rice\o ermo baci? Ma quale incPndio >favill l!lnlo improwi,,o? Qunlr fuoco ti
awolg(. rara tavol etta? Cono TO il terribile wrndio. eono e-o le fiamme. rlll' cmcuo dal pctlo i11f11orato: 111ia.
122
Agli occhi drll'amant . la Imola piccola ma fortunata perchr riproduce il vol-
to de idera1o ed emi rr benevola: gli permette di ricono cere. con trepidazione.
l'aspetto rlw gli r caro. Il pa aggio dal ingolare al plurale. dal tu del ritratto al
quale il poeta offr violr e ro ( vv. 10-11) al voi delle labbra ( v. 19) inne ca la
volta epigrammatica finale. quando l"impul o di pretenderne cento baci provoca
il fulmineo incendio della tavola. I ver i cJj Marullo ono la fonte di uno trambott
delr quilano, lie ar poi imitato da B rardino Rota:
PrC' awrmi el mito tuo ernpre celato
la tua figura in rartC' ebbi dq>inta
s na111ral. eh.ognuno arria ti111ato
ambe due \frc. o runa e r altra fu11a.
quando arro. lo per ba aria cl fiato.
vedila t ucla a lor de fiamma rinta.
chr 1 mio foco r acce e e pit1 me incende.
ch tua tanta lwlt i;e te a offende
119
.
Il ritratto dc Jr amata raltro ri p tto a una vi ion neaata. una fitnrra in-
tenzionalmrnte cercata (ebbi depin ta ). nella quale 1itrovare il volto [ ... ] empre
celato. ln virtu di una ornialianza p rfetta. he compaaina e annulla la distinzione
tra immagine viva e immagin finta. la diff renza tra le due arebb dcl tutto inin-
Ou nt per l'amante "manio o di baci. e non fo e eh . quando m"icina trnppo le
labbra alla do1ma ritrat1a. il uo re piro appa ionato (il aevo pectoris halitu di
Marullo) finisce per bruciarla. L'apparente colloquio con l"irnmagin non olo non
procura un vero appauament cn ual , ma ' di fatto. un fru trant e maniacale
oliloquio. come un arguto pittor ml rari ordaT all'ami o po la:
Omn plagae au:.;jlium prto cruentae,
rl pie I a loquor ipse cum tabella:
' 'ivil Lucia qua wuusla bdla.
11al ura artis opu llO\' llll1 tuent .
D11n1 cultum et r pulo rler11 iuvcrnac
crin , fron1 111. or11los genus. labella,
ori nrquitia . 111anum. fabella
qua ' ' i11clu fcror hcu ! dolo utc.
Quid (ul pone adrral) q11n. i a11dicnti
inquil Roltrapb.iu i can dicato
e-orde ha e fcr : minu hoc lic l ci nti.
proprio n1ia qurstn rolpa; io srrllcrato, che mentre ii affatico scon i<leratamrntl' di baci e ff-. indnaiare co.n I?
mia bocca uniln alla tua. ti ho bruciata con il ('rudclt soffio drl mio petlv (\I \Rl LLO 19 I. Epwra111111ato11 ltbn,
Ili. XXXI,"" 1-9. 19-29. trad. mia).
119 AQIJJLANO 130.
123
rti add re po"e delicato
non t \'itam operi: errro ' Cnlienli
haec dic-hi que aninuun Deac plicnto
120
.
N 'lrepiararnma De se et Bollraphio Lancino Curzio immagina cbe il Bol-
trnffio lo orprenda alle pall memre ' a orto n Il a con1emplazio11 del ritratto
delramata ontrapponga alla ua dcyozione (di ato/ corde) un franco e di-
v rtito richiamo alla realt: poich' que ' t ciocchezz non i add ono a un uomo
colto e -acro-io. farebbe meglio a d di are le uc attenzioni e le u paro) ( haec)
alla donna real , enza hi dere al ritrailo quello h non pu dare. Per amore
de] !!io o deJla provocazione. J" arti ta te o nega a Irarte ogni po ibil i I di dare
vita all opera. La fr quenza on cui n i ver i del Cmzio compare una certa Lucia
ha indotto a identificar la tabella c n il bollraffie 'CO Ritratto di
dama della ollezion Thy en (,\Iadrid [ill. 8)). della fine del V colo: la donna
che vi raffigurata ti ne tra le dita un a ticella che orreao-e un occhio. atlributo
deiromonima anta.
e il canto d"amor pu e ere compo to in perona di , anch i ritratti di cui
parla po ono raffi!!urare dom1e diver e dair amata del poeta. In que to pa ago-io. i
moti.\i e i modi della relazione tra ramante e rimmagine non cambiano o
mente. olo trnn itano da una rnce all'altra. e ne ii ultano interpretati. per co dire.
econda. I Rithimi di Ca paro i conti comprendono una vera e propria erie
u ntratto. dove te ti ompo ti per occa ioni diver e e fore per diver i cornmi11 e11ti
vengono radunati in virt del loro tema comune
121
. Il gruppo aperto da due onetti
probabilm nte l o-ati al dono di un ogo-etto reale, econdo quauto recita la relativa
rubrica ( Que to e il equente onetto furono compo 1j in norn d. un zentil ianore
al qual la inamorata ua havea mandato di Jont an pae:;e una tavoletta dove cp a era
molto mae trevolmente ritracta al natwale )
122
. I el primo parla l'a110nimo aenti-
luomo rivolto al la donna:
120 Mentre cc_rcavo o]Jiern a una ferita anguinante 1 parlavo da olo con una taYolrtta ditiinta in rni vive la
vaga. bella. L1w1a (la 11 1twa e endo il o d Il b'J d. ) "d 1
. . : ' , o P a m11 a 1 <'opera arte : mrntr cons1 rravo ucconc1atura,
la grazia della u1oven1u j C3f)Clli la f 1 I . I . Jabl . . . . .
. romr. g 1 ore 11, r guancr. 1 iruzz1, lr mali zia e In. 1 1\ir della bocca. la
mano. la ua favella cucendo ingann d - L: . ' '
1 a cui ono. wwnr. a1'YllllO trascmato: ePere! - 1111 dio'r herzando ti
Boltraffo - come e culi mi 1r e alle pali di ' ' I
. . r e JO 11 opporti q1wst co e con ammo devoto? \ on e e 1to a
uno rhe sa L anr 11011 ha ti potr e d. d I J Q
, . r 1 are 11ta a uu optra eggiar ra. 11ts1e co,e dille. du11q1u. a chi nte: e piega
: e .. PI de!la 111a Dea (CuRz101521 , r. 108 [1rad. D. in FioRJo 2000. p. 103]). 'ome ha piegato
omeo. opera di qurSto notevole poeta non i pu ric-ondum alr r;,pcri nza roni<>iana, 1iercl i' nc11li Epiuram-
mata e nelle . 1lcae le jJOcb oc-casion t b li C: .n "
(
. _ 1 t0rncoc r sono 11nm r r 11c a rn1;1a d1. le. a dci tcs11 e d!'1 1101111 '\;1ttad1rn
ALBo.\ic;o 199:) p 90) Ancora Alhonico (' ,. 83 89 01 ) I 1 I
1
. . ." . m, PP ' '/ ia olio 111ca10 11 prc en:t.11 dominante della poc ia
m atmo n i maggiori e minori J>Octi della f 1 . I d 11 I 1
Gw
0
V- . . . ' .
1
ano s o_rzc ca, e 180 a111e11to <' rspcnenza d1 mnalore n1 vogare r 1
par tSconu. vero asiro d1 quc ta stagione pocl1(a oh re chr mecenate e amico di porti e ari i ti.
nl rilievo strutturafo d Ile sequenze trmatithc ncllc raccolte q11altroc1nte che cfr. Ro 1 1980 e L11.1 fl 'ERNi
122 Vi CO:-.TI 1-+9:3. d daratio11r al son. [99]. r. D3v. ma rfr. V1sco\'1 1996, ad lornm.
124
l'alma ov . ('1 viva viva.
per 111a11 c1 A111or culpila in un diamanlr.
col ri111en1brar dc le tur luce a11cte
da lr cpial solr ogni mio brn deriva;
e pasco i ber1si in contrmplar la diYa
effigie picla drl tuo brl embiante.
la qual tanto poco f. dal verdi ta11te
quanto r de voce e d"intcll ecto priva.
Tall1or mi as al e un dubio in m zo al cor
e r opra fu cebtc o pm de humano.
eh.Amor Gdcl da poi fuora l'exclu e,
dicendo che 1 tuo acro alto splendore
agionto al bon volere in ba sa mano
d' huomo lerreu bella crratia infuse
12
:
3
_
JI ricordo petrarche CO del \'. 8 non chiama in cau a re perienza di imone .Yfar-
tini. poi h il dubbio in merit all'orioine divina o umana del ritrntto topico e.
viene risolto da Amore con la sempli ce on tatazion che la bellezza delfoo-uetto, pur
tunar10. tal e in dello plendore del modello (vv. 12-14). Il po ta-amante nutre
l'anima con il rimembrar (v. 3). i en i con il contemplar (v. 5). l due op ra-
zioni i realizzano altra\'Cr o due imulacri, uno colpito da Amore ( culpita ). uno
clii into da mar10 terrena ( picta ), econdo la pi omune c rri pondenza tra arti
funzioni : alla cultura i a ciar10 la memoria e la tahilit di un entim nto. alla pit-
lttra l'illu ione della vita r drlla pr
Il parallelismo tra i due fenommL ri or-
cio e i ion . accentuato dalla collocazione in ap rtura d 11 du qurutine. m utr il
prc ente li con uet udine ( \'utri co. pa -co) i ontrappone al pa ato (a al e)
dcl dubbio che viene chiarito da Amore nel econdo onetto (Amor, chifece il natural
desegno)
12
. cl dialouo con l'amante eh me o in c na in forma diretta. e ondo
una modalit adottata, a Milano e neali te i anni, dal B llincioni, mor ribadi cc
che l'art e dimo trata n lropera di terrena man viene cto d Il a dmIDa
([ ... ]il quale/ lodar non critmo- linaua Immana al ' cgno [vv. 7-8)) i di hirua
on fitto da tanla b llczza. La cri 'poi movirnen1ata dal pa ao-gio dalla pittura all a
:cultura (dalla tavola al amm ) e da l ritratto f nuni.nile al ritratto maschile ( o-
n tto fa to in per 011a d'tm giovcne che la ua mede ma cffio-ie havea facta ulpir in
12J \'1sCONTI 1-193, (99), C. 1):11.
12-1 La str " tl di s1i111io11c sur proposta ad rs1mpio da \1i1toria olo1111a: onde ,l'effigie ua 1irn .e
srnlia ess<' r clc' ne l"nlm 1. al ('Ui valorr/ sempre s"i111hini, e la dipi11111 fon/ c,ser dt ognor 111 wder n110 pi enU.
(CoLOi\NA 1997. Ri1111 s11irit110/i disperse, XXX\'lll. v1. 5-8).
12S \ 1. CONTI [ 100], e. 031'. Dialogo sreonclo la rrlativa clidascnlia.
12
camaino ), dal succes ivo ritorno a una figura di I01111a ( In p<'rsona d' uno ainantr
che havca la cfficrie le la amata ' Cttlpta in camaino ). in un s meli o che presenta forti
continuit con il primo:
Brn chr t"habbia " ulpiw in que, ta pi r tra
cun puntr dr diamami in tal larnr
chr dia e Prasirel pcrdon rhonore.
e ria cun de::.i al panrngon :-i aretra.
pur e I pit1 nobil nal dc ;;ua pharetra.
rnn la . ua propria mano il 111io
t'ha rulpta cos Yi\'a entro il mio core
rhe da . o il wr pit1 n n imp tra.
Luno per dare a ali orbi mei ri toro.
quai per fooar il duo) che r alma mc
tante onde eh 'io mi faccio e moro:
l'altro ' p r refriucrio de mia m ntc.
che fora . nza te. qual -ola adoro,
com chi morte ha mprc a pre -rntr
120
.
Il onfronto tra rin-atto materiai e ritratto interior prima m o in ombra
dalla qu lione ri ha da .\mor . div nta ora il nucl o d l componimento r lo
anraYer a dal I rimo ver o alr uhim . d terminando una trut tura fatta di di\'i io-
ni nette e r cr lari
127
. lrimrnacrin culpita dalrarti ta in cammeo i affianca
quella ulpta da Amor nel cuore clclrarnant . econdo uno scl1r111a alternato
che i tra m tt dall quartine all tcrzin : il ritratto vero e proprio e il imulacro
interi01 ccupano lo te o pazio. in un quiJibrio accentuai dai paralleli mi (' '.
1-i opera dell'art i. ta: vv. 5-8 oprra di Amor : w. 9-11 funzionr drl carnm o: vY.
12-li funzioue d Ila ultura nrl cu r ). ,\li, llo di disposi/io. l"ordin guito
nel on Uo (99] \' ne roy ciato. antcp nmdo l'oricrine e la ollocazion d Il dur
immacrini alla duplic natwa cl 1 conforto eh pro n Ha r uolocria int ma
al tempo liric . il ritratto mat riale. in oli tam nte. mbra pr c dc rr colpi-
to da ,\m re. al qual i attribui la omiglianza tupefac 11l prima r oca!a prr
tavola dipinta. J\ono 1ant la mo . a iniziale, relati izza11te (Ben c.lw ... p11r ).
11 parallelo i rnantien :i onclud i11 I arit. prrch' tra lr due irnmacrini pa a
126 hi. [102]. r. fJ.+r.
12_? 11
11
m?drigale di C:cs:m Rinaldi , dw mita: Pi11or u1 d1c dcI l'inuwo finta.I 11011 -.ai
rh altn 1wl ('Or 11w I ha I "ore I I 1 1 !\ I "" 1 '
. . ' , ' r per e 1 g J <i-tn 111 1mprc. '" mor 11c pr110:/ q1wl .. Jw d1p111rr1 tu e arlr e
llltlUra./ <1111'1 rh io 11orto n1I n11c1 \1no fi / . . ,. I . I ., . . "" 1
. . . ,, . r 1!ura. ''oprr an11110 o J1r110. coprr o a m1 p1ttor r hl 1011wn11 per urli'
I rwr .\mor 1l 1or ( 11111111 (Gnregg1ame11to poetiro 1611. (' . 111').
126
oprallutto una di tinzionr di funzioni: il cammeo e il ritratto interiore, entrambi
s olpiti , off'ro110 ri spcttivame11tr conforto a<Yli ocrhi e allievo all a ment . eh orri-
pondono ai , c11si e ali' alma di (99] r:.!
11
PiI prr. il imulacro interiore trionfa. an-iva a por i come modello
ideale per l'arti t'i la te so. Cn onclto drl TC'baldco int rprNa fJllC'. ta up riorit nel
egno della COllWllZionale prot . ta C'Olllro I" audacia e Ja , toltezza dr Jr arti ta. che ha
ercato di rappre cntarc colei che n' i pili crrandi pittori (che. prtrarche carncnte,
intc er s bC'll r arte) n la ' te. ' l \a tura . aprel hero ricrearr:
Qual fu il pi ctor temnario e
rl1r ritrar \OI 1 la tua forma in cartr(
Chr Zeu i e \pcl. rhe intc. 1 r s br n l"artr
e chr hanno il pregio a tutti altri t lto.
imitar non . apriru1 del tuo bel rnlt0
col di,, gno pur la minor partr:
<'011fidaria tli novo forte
r \at ura. hr nch po"'a molto.
,' che non dar fatica a la pictura:
s<i un , ol. non ti far una --11lla.
non ha in ca1ia il suo honor la 1 ua f!!ura .
, ' ol o il cor mi o scia farl a romr hrlla.
dw s<' di fu or pot "e pr r ' cntura
I I
. . I (' I" ' LI I J-1<)
mostrar a. oc r -.n ognun gnc ar: e , 1 e qur a.> - .
li invito a non fari ritrarre. che il poeta tra forma in un ompli-
mento alla destinataria (' '. 9-11 ). i rove eia, con forte contra'tO. ne-l ' UC w
r cup<'ro della .,ola rappr entaziou adeguata ( olo il cor mio): al cuore. \.tt -
rio o contro r arir r la 'a tura. i ri' ndica la fa olt lu i' a di r nd r a pi n
Cfr. ad ,.,. /IT ):);) (Re11d1 la cC1[!J/l <' p1rd1. urf'lulola imprera nel core. le'. .ma
l'inut"i11c , o,tra/ i11111 r dipingr \more./ 1wrchr J" opra chi111'io d' altro pittore?/ Ben mm pt>n 1em/_ mirar la
forrnn i111 crn11./ lilli 11011 fon\ d11 rnrrhio ILllCJUH In M"\' rnu./ Dunqu . p1-h- dcl \l'ro./ I ahhu1 nlllll'fl fi11111 11 St'll o./
perd1.ill rimiri i11 \'Oi 11Hntrr ,.j pe1N). li (c' 'to i J!l'l'rl'd1110 Ja un altro madrigale (HT I.)'. Prega la s11<1
rlt e. st' 11011 gli 11wl dare il suo core, "li dia almeno la .ma ima[!ine. courlrult rlre g/1 clo11ar l 1111a t'.
render /"altm ): .sa .,deg11o, oi prr ndrtr/ eh ' il rnr, u,1 ro, i r hirda./ I 1mag111 nhlrn n11 s1. \la d11
fia dw l' a1111niri,/ 1'11111i l' f' 11 mo, tri ,ago./ M' non -.1gm' il mio cor la ,.o,1rn imugor/ Du11q111 rl cor m1 rendei .I
che, 1wr1"h in 1111 rr,piri./ non fia mc111 0,1ro in tutli i 'lilli dc,iri .
I T1 u 11 ow I CJ 8CJ - I 99:!. JI/ I. 91 r .. rr. ii i. 18-:'. :!:>.>. r lii/I , +Hl. 1\'. 1-8 l' \1011ol1lla 111io. 'e br11 nt':.wurgo.
1ai/ fuugendo d1 ritrar miu do11n11 in rnr11./ pllrr111lo 11 lt' rhe mal far po,,,.a 1'111w/ qul'I c:hr. non F P'. In nnturn
rnai./ \011nc11.,
11
r, 1hr "'
11
qill'I , l'!!llO andmi./ 11g!{iO ,opra i pitwr" prisri 1 ,ahurtr./ \ r hui-1110 nrn.
i11 quulrhe purte./ d11; in ccN a11r rnluto a"ni ) . Cfr. 1111rhe H1/C( ('\ . ' 1 1111 ,0111110 d'. \ ircolo cl.a
Co1Tcggio (Conru.c.c.10 J 96CJ. 2:J8, 1,. 1 :J. J-t ). ,' 11lla don1111 roml' r11p1>lu10ro mirarohi-o. rhl' "'.'ppnrc 1J ,uo artrh-
1r oarl'hhe i11 di l'ipc'll'l'I' rimandi 11111 Ohsrn a1io11i di Df. I. \l DE 1CJ8CJ-l
1
>
1
lO. PI' 11 -12-t.
117
le embianze della donna. al punto che e l'immagine interi or . i pot ss veder
affe terno, eia uno ricono cercbbe in es a l'amata. Il grido degli pctiatori e-prime
w10 tupor oinYolaent , eh di e la perfezione della omi.alianza. proprio come
le parol del po ta-amant che interrompe il pittore all a fine dell'ode anacreontica
dedicata al ritrntt.o dell'amata
130
.
Cn di Ale andro forza, ignore di Pe aro e corri -pondente e amico del
GaJJi. attiva un coll aarnento immediato, quasi identitario. tra ra1te divina d Il a
natlU'a cr atice e la co tante pre enza interiore del irnulacro amato (ogni hor ):
Phidia o-i mai n Praxitele a prova
colp con arte in mam10 tal figura
qual fabricata in iel ol da natura
in raJma mia riposta ogni hor i trova
131
ignificativarn nte r encomio attinge al repertorio del riuatto anche in a enza
del ritratto te o, e reco di Petrar a ravviva. di lontano. un empi i e elogio: iJ recu-
pero dello tilema a prova in combinazione con due nomi di arti ti antichi d tta
re ordio di un componimento che celebra le virt della donna e de. crive la condizio-
ne del poeta marnorato. i d una po ibile conci uazione tra I a pirazioni mimeti-
che deff arte e la lucidit irnpareagiabile cl ila vi ion interiore, nel pa agaio che fa
del cuore dell amante un alleato del pennello, identificando l'irnmagin cu todita nel
petto o nella mente come il modello ideale al quale l'arti ta dovrnbbe attener i: [ ... ]
ni1 opu e t aila tibi imagine: pectu I Hoc aperi: in cord e t pukhrior illa meo,
crive Angeriano rivolto aff arti ta che vorrebbe ritrane r a petto di C lia
1
:
32
. Con
toni da Antologia Greca. la te a nozione i ripete, pi ardita nelfepigramma XXX,
do e colpi cono la nudit del oggetto e l'identit perfetta e irrazional di tabula e
anima, quella te a confu ione tra e terno interno he troveremo nel Rota:
piciens pictam in tabuJa e Caelia. '- oller
Pictor uhi nudam me modo vidi I?"' ait.
Inquam ego. "non oudam vidit te pictor. amaoris
Hic anima: hoc anima vivit amanlis opu l 33_
130 CarminaAnacreontea 198-t, 16. Per il collegamento tra l'imman'ine in carte e quella prodoita d11I c11orr si
deve supporre la mediazione di Rvf CXXX.. vv. 9-11. rna no11 si pu R1{CCCXX VI. v. 7 (eh ' i "rido:
-Elfbcndes a[ ... ]).
131 FORH 1973, i-1, vv.1-4.
132 [ ... ] non hai alcun bi ogno di un'a11ra immagine: apri que 10 petto: nrl niio cuore lei pi bella ( NCERIA-
w. 199.J. LVI, vv. 11 -12 [trad. mia. ulla base di qucllaingle edi . \Vii on]).
1_33_ la im?:agine dipinta (guarda11do i ritratta) u una tavolella, Celia di. sr "Quan lo rm1i
I pittore_ nu lia uuda? . lo replirai. "Il piuore non ti ha vi ta mula . Qui e l' anima del tuo amani r:
quest op ra vive nell amma dcl tuo amante .. (ivi. X X).
128
Il a rappr entazionc diretta, dal naturale, . i o titui ce quell a mediata dal
imulacro, che, nel Ci uquecento. t nder a concidere con l'idea. on il concetto13-1 .
pos ibile e 1endere ariare lo cherna di que ta oppo izione intrnclucendo un
terzo ele.mento, come fa lo ste so Visconli nel onetto TU dei Canzonieri per Beatrice
d'Este e per Bianca Maria lforza:
Il Cel. Cupido e un depenlorc a prova
mostrarn ogni lor forza d' arte e ingegno
circa e tei: il Cel gion e ogni ecrno
in farla. che virtute e belt piova;
ved mio l' opra Amor excel a e nova.
per far del Celo uno acto non men deo-no.
mc la cbiu n J cor, non in de cgno.
ma viva e grande come il ver e trova.
li depintorc una altra volta virn
l'ha farla in quc to legno, ma d'ardore
a urnmo studio il guardo acce-o priva.
ch ' f' ella inccnde l'umido mio core
qual tanto pianto par che circum criva.
che faria il legno e ' ha s p o urnore
135
?
L'incipit annuncia i tre rivali che hanno gareg!riato per ritrarr il modello, e i-
bendo. petrarchescamente a pro a, tutta la loro abilit acquisita (arte) e il loro
talento naturale (ingegno), doti h li mettono uJJo te o piano in quanto ' arti ti' :
il Cielo, npido e un pittore, di po ti nello te o ordine con equcnziale e cronoloITT.co
poi eguit.o nel presentar le ri peltive op razioni. Il Cielo nel fo1mar ]a donna con-
11iun ogni co tellazione che emana virt e bellezza (cio le conce e un ci lo natal
e lremamente favorevole); Amore non olendo e er da m no. la colloc nel cuore
del poeta-amru1te, a grandezza natlll'ale e non in de egno (v. 8
136
): la pre i azione
in neaativo avvicina il irnula ro aJla natura (viva e grande come il ver) e con-
temporanea mente accelltua il di tacco ri pet1o all"immaaine altrettanto \'iva (v.
9). rea li zzata daJ depintor u tavola. U verbo riJerito al pittar de iana tm ge to
autenticamente plastico cr ativo (l'ha fatta). a fronte cli lm'azion combinatoria
134 Cfr. i11fra. 4. I.
t:l5 V1. co TI 1979, lii. L' ult imo canzonieri' per Bianca (orza altro non - che una e ri11tcT-
za111rn (ALDON1co 199.5, p. 86) di quello per B atrke, scompara. alla qu11lt' ri serva mo!ta G.\RGA"O
1988 (p. 201) gnaln 1 re onet t i, ri pettivamente di Gregorio ilvestrc. ,u1ierre _de Diego I lur111do dt
leudozu, in cui all a do1111 1 in carne e o sa alrimmagine i11terior si aggiunge il ntratto, mteso all a lettera.
136 Cfr. GtAC:oMo JM LENT1r;1 1979, XXII, vv. 1--+ ( cOr romc pote , grnn donna ntrare/ per g!i mri da' s
piccioli 01w? I e uri mi o ('Ore come pote rhr nentr' so la porto l onque r Yone?) e R1j X ,J\
129
( gion )e di un m vimcnt (chiuse), e il d ittico (in q11e ' t le11110) riporta la
o truzion po ti a Il' erg tt eh ec 11do la di da' aua. ne ('O titui '(' ro ca i li
( ln pie tam tabellam ). Eppure I r prio l'azione del pitt r f rni T il pr t to p r un
nu vo allontanamrnto dal n r t . in nome ella pointe incrcgn a: la ' ua celta di
att nuar . n l ritratto. l'intcn it d Ilo cruarcl intenzi nale cd ace rta. p rd1
ahrim nti il 1 gn a iutto a\Tebb pr ' fu m a cad al cuor cl !ramante.
he pur ' pr t t1 dal I iant . ungo lma atena di ernulazi ni. 1'01 ra divina (la
donna in arne a). la ficrura nel cu r la ta\ola dipinta corri p ndon ai nodi
f ndamentali della r t i oni a <li Laura dcl ritrarre mc t ma poeti o. ma in quc-
to quadr olpi e un a nza ' icrnifi ativa: la ricrida tripartizi ne embra tenere in
di part il p ta. eh compa.r ol in quant arnant . upporto clell'imauine vittima
delfi.nccncli c1am re. L'io- m -p ta qui n n i o erva daU.int rno dcl rchio liri-
o. in qu I ruol e ntral o ac e ori o ( ri pctt air art e al pr hl ma di ritrarr ) che la
d pi ' t lar la elida alia 1iwlano i.nv e dalf t mo. in rappmio alle oc a ioni.
. \.lr I po to. il p ta nd oru ulio arn me in gara in un n tto del Tebaldro.
h 1 introdu come t rzo lem nt . al po to d l ielo:
Qual Zeu i. pell , o qual pictor piu d gno.
b n ritrart mai d un huom faura (
Qual Pra itel mai fin in petra dura
imaaine pi:1 '" ra col !ILIO ina ano?
om ,\m r dentro al p tO il hel cli !!Ilo
m"impr de co t i. he in s pultura
pin. :\!orte crudele. a rl a dura.
;, I I r mon. trar ua forza e non per drgno.
n I cor pi chr mai \'va la r n rrvo:
n, peri indi Fortuna mia aciarla,
in che non torna in polv oani mio nrrv .
E in lr carthe mi po . o ritrarla.
,.i, r anch r pili ha f enic e cerv .
n' long t mpo mai potr di . f aria rn:.
Di front alla mori della donna. fop ra d'art ' olo un'i1 olf' i o una pielra di
paragone. m ntrr l"imma
11
inr n l petto i imp ne ome una pr nza vi a r il ritratt
,. rbal omc w1 a pirazion ali' t niit: in a nza cl I pittor m d rno la inu11 -
tiia truttural tra arti ti anti hi (" '. 1-i) io-poeta ( . 1 - H ) int rn alla tabi-
lit cl I di uno impr o da rnor (vv. 5-11) ace ntua lari alit tra inm1a11i11e
1:37 lf.H \I.DI.O 1989-1992. 111/'.<!. :):)6.
130
e parola. e l'ornagaio che la poesia lrihula a e te. a. Il ritrarre i11 rart he ( . 12)
pirnarnentr as unto per de ianare la rappr cntazione in vrr i ( ome :ottolinea il
p c. ivo mie e. p r oppo izione. l'u. o lPtlerale dello tr . o \Prbo al'-). m ntre
Zeui:.i. Aprllr r Pra :itele rimandano a Rif C X. contr. to di ambiuuit tra imma!ri-
ne intcrior e ritratto. L 11fa i po ta . 11lla con unzi n fi ica (\\'. 11. H ) dalla quale
il ritratto int ri r qu Ilo -critto no immuni funzi nale al ric:ono im nto di un
p terr pit1 alto alla crittura: come abbiamo \'i top r il Bealriciwn. il tf'mpo corrode
e di stnwge anche il olido marmo, e la pietra te a pu prrndrrr la parola p r af-
fermare la propria in uff ienza ... 'econdo il uu to di Anaeriano, eh carica e tend i
topoi fino al limit e di rottura, la por ia pi dur \' OI cl Ila cultura. ma verament
imperituro . lo il fuo od Ila pa . ion :
Qui gelida ub rupe fui lapi . ora wnu. ta
\une rrf ero et rnltu-. cJi,a pur Ila. tuo .
cultori drbr ... ed drh plurima rnti .
l lic polit. ili canit. quocl ranit. illud habr .
L t nosti . lapid rn trrrt hora f 1wacior Euro.
At brnr quod ranitur. non H'r<'I hora fuaax.
I lir muta silex. al carmin ntlaor et or
\ '( rlia loquor. toto ernor in orhr nit n .
'\on ad it cantu;,. remanrbit 'ita ralorque
ero \ati \irn calore lui
1
;
18
.
Che e :a M1cc d a parlar cl I ritratto non e la pi tra lata, la ma la don-
na che yj raffi aura ta ( Cn ca ' O particolare di crittura in p r na li > ' qu ll
in cui. ul mod Ilo dell Heroides a pr nd r la parola ' un ouu tt f mminil
com a cade in un I uon numcr di capitoli quattrocente 'chi, dominati da nti-
ment i di a lo ia di di perazi ne r
1
>_ (Tn onrtlo cli Antonio] bald . dando"
a infeli e. ci immette in una a.rna finzi n pi t lare eh mota
intorno a un ritratto:
redra me amas i , h r l timor rombai lo.
dir SI' wr fn r Amor pict r p rf etto.
t \1ra I' ff<ri mia formata in t o to.
n' e rcar ti avrr altro ritratto.
1:38 cfo. dH' Mlii ;.Ulla una pietra ai piedi cli tuta nipe. ora rapprc,tnt o le ll11' br!lr labbra e il ruo_,. lto. i11a
rauciullu. Dt\ i (''>'iCI'(' urata (o sri debi1riet'
0
) allo" uhorr. lll!l . oprnllutlo al pot' t.a: l. tUIO lan1rn (la ptl'lra). I 11ltn!
<ama (li 1111 lodi ). CiCiht l'Hll ln li appartir111 . Co11tt' 'lii. il ttmpo, pi1 \t'l()(e ddl btn> dell E>t ]. eon
" I "t1a Qui ono muw 1111'1m rnn ono celebrata m
fil f>lC\nl . lllll lt on fu""l'\'Oh llOll po1tt'rilllOO \"Ili \lllll fllll lt'll 'l n o . .
\tr,i e parlo 1011 111htllTH.1 ,i.:;ta plende11t1 in 1.11110 il mondo. \1tclll' , l'lll 1 la la \l!a e la
culdu pas.,iom dtI pot'lll, r ..ar ,jrn In (lll>>IOIW ti ! tuo poeta ( \\GfRl\\I. JC}Q,). CL\ \.\111).
1:39 , u qurolo sollO"l'llrre dt' l rapiiolo in trrlll rimu. frrqurnlat tra gli nitri du \irrol Ja Correggio. T baldro.
\i.Tonti , ngtlo Culli, rimio n Lo:- 111 1989"\'ru111
ch'io ami te comprende e a nt10:
('he ('ssrndo il \'Olto mio pit 11 di diffPllo.
awr p r honor mio <l \Tei ri petto
che non nr imularhro tratto:
r pur io me tr mando. r a nw a
imil. h temo re tar ::.emprr pri' a
de r alma mia. che l '('O'Uir non
h'. rom a te queta pictura ari\ a.
il pirt mio. r d ndo eh.io sia a.
mr morta la ar. lei far ,.i, a
1
t0.
:\elle r ar le d lla donna la di parit tra un amor ol I re. unto ( v. 1)
uno ri, ndi ato m real (v. - ) i . prime n I ontra to tra clu I rov . di e<rno
oppo t : ra nza delrunma!ri.ne formata> da Amor dal petto d !ramante. a-. n-
za d d tta dalla ri hi ta del riuatto. e il a nero o imio d lr ffaie dipinta. L' una
atte ta lo caro oinYolaimento entim ntal delruomo. raltra una dedizione I ron-
ta a up rar ani r tic nza. X l di am ro o. poeti o e romanze co. il 10110 del
ritratto rnle quanto una dichiarazione d'am r e ianifira una re a incondizionata.
che i f nda ulrid ntit tra copia e mod li u1 yaJor imi li della o tituzio-
ne (io me t mando>). In iem al di onor di far riprodurr u11 rnlto che cono ce
imperf t1. . la donna affronta an h il ri hi di perdere ranima. eh . ingannata da
una mialianza perf tta (w. 9-10). i tra fciira nelr:immaaine. Il m tivo ripre o
in un on tto cli inc rta attribuzionr ( Yon dubitar, mia dea, l''e sirnra
1
"'
1
) . nel quale
ramant aiu tifi a la propria ri bi la d l ritratt dipint Il un.ip te i e attament
peculare a qu Ila t muta dalla d nna; anch e n n av va bi oano di una pittura>
div rada quella h i uoi o chi. i truiti da Amore . . anno formar<' continuamente
i' m o in arta a far ritrar la( ... ) fi!!ura di lei. n Ila p ranza dir ruperare la
propria anima attirandola on r rffiaj : [ ... ] . io ho rimaain di ro tei./ forza chr 1
pirto mi talor ritorni./. e non per\' dr nw. p r ,. der I i> (ibid. , n. L-14).
L animazi 11e d I ritratto eh PiITTnalion aY Ya ottenuto n I pr ahirreH
2
qui
i produ ili ll1 do f rtuito e attra\ r:o un t t rtU!nO. fru ttand r attrazione e r-
1 -tO Tmwrn 1989 1992. ll/1. 199.
Hl <\QUll'\O 189-t .. '011elli dubbi. XX lll .
H:l .\!'I ll'>lo rhr d1iud la l'itala rrir ul ritratto nei Rithimi. Ca paro \'is10111i i11via 1111 cammeo a 1111 amico
r gli ron. di rntar i a Vrrwre. co111r Pignrnlione. ptr ,ederlo ani11111to: cPuotr' io ,, mandarri 'iva
,._va/ la brl!a dw I tuo core ha morto./ ro1111 in un "ll>O pallidetto e mor10/ 1i mando rnlpta la un effi.,i1
dl\_a.I rlw 1 m11 prn,<r mancho amrna ri\lJ liarirn cli toi. nr 11Hn UD\'<' por10./ clu; tra ali amici il duolo
et 1l 1111prr r deriva./ \1u prrgha pur upido 1 la dca \'r1wn/ romr caldo 1
dc,010/ I ,a,.,o rnu1tra durezza .et 11e1wrP./ o poi rhe 11uo se1Yir li cr noto/ fari pic1rn,t I ue , 011lie tenere./
facpnrJo11 gorlrr l1H1 dolr< voto (\i. cmm 1-+'J::l. c. D-t1. e '011r10 mru1da10 ro11 11110 ritracto i11 ca111ui 110
clo11ato ari 1111 zenlil , ignorc ).
1:32
citata dall 'asp<'l lo soJ11igliante sull 'anima i11namorata. che 11011 lo di tinau<' clalf ori-
ginalr. Lo tr . o cff tto pu e sere ind tto <la altr ma11ifc. lazio11i. pi fi irhe. drlla
fcnorne11olo1ria <'rotica. me lr la Timi <' i I al ore d lr anianlr ( o in un on tto drl
Tebald 0"':
1
) o. pil'1 ing mo ament . dai o:piri. non ne arianwnt amoro:i. della
d nna in carne o.
, ' e la imagirw vo tra a 11Ji occhi piacque
a lor d1t" oprra fu , ol d' 1111 pirtorr.
'istoli agi unto natural \'igorr.
111agior dr,,io cli lei "edrr mi nacqur.
Fu qur .. to. quando a vui for i cli-.piacqur
n d1ryi in vc,,re Yarie al suo colon>.
ehr 1 cor mand' un u pir tutto di odore
t' piolwr 11li orchi dole-i r limpidr acque.
, ' pir>gli il fiato un non . rio rhr di ,fro.
como \mor ,oJ e. :,opra la nawra.
chr a COO'llOc r tanto alto io 11011 arivo.
Lr larrimr abrllir puoi la pictura
tal rhr. io fo ,,i di l i pri\ o.
I
. . . . I+!
< 1 'u1 ;.,t('ssa ,, er prn a' rer paura .
\ cl detta! qua. i mai p r pirn di un rimatore npre, dibile a uto om
-iccol da Corr agio. po siamo i 111 ra \'Cder a I m no du Y r i ni li un eYento :.o-
prannat ura lr' clic oimolae il ritratto dell 'amata: il natural ,iaorc eh l'epi di
ri vo ato ai , . 5-1..., ha dato aff imaain ha inten i.fica lo, nel p e1a. il d ideiio di
,cd rla (v. i ). nl punt h ora n tcrn la p1frazion quanto qu Ila d ila clonna1t:;.
Che co a ha tra:.formato !"op ra d'art in un :.tituto perf tto dcli" riginal . I aando
il de tin d l poe1a-a111antr a un ffair di1 inta? li O' piro il piant d Ila d nna. in
I-t:l 1989 1992. Il/ I. '..!:n. \l a rfr. anrlw C0Rn1.cc10 1 %9. 108: ' d'un .olo rhio gi qu Ile ,,arelle./
pre,.11111dolo tra lor. godetlll In lur<'.I e una ,o( 'im. rol frat I. .I_ el 'i narra di I.or Hre 110\ perch a
le nwmbru lcgindrrllt r i;,nrllr./ rbe 1 pktor con htlln arti: a qucst ulnw che 1'.11
eondnrr./ dure. 1 fargli \l'htir rame. o ,.a e pelleU lo gli ho spmllo gia 11111lc o(h(Hl'I/ pl'r c!nrgh ' 1111: '('l\l
che tn ' I sciai./ dir 1uu,i nl ror gli im. liti martiri./ Pig111al"nn fu hrl frlirt ii-sui.I 11111 m In 1m11n111 >UU (lt1 non st'
adiri)/ ;, imi I lwllenr non gli 'i<ldi mai .
lii Conn1 ..cc10 I%(). 6:2.
H5 Il llal ura.I \i non' r 1111rhr in lUI aluo -on 'llU d1l Corr ucrio (i \ i. 286 ). dl'dinuo al mo1 i\ o dt'lla donna-pietra
(' ('0 I rttilO li llllll inrt'rtt'ZZ3 tra (a ,ua Jllltllrtl di illllllll'1llt' O ll (' >el'C \H'llll': c\on 'ia pi ehi >l'Wpi-ca.
pinga o ,crinv' u
111111
t forme n dfru1e aneora:/ ropri pur. Fidia. \pollo e \pelle, Flora./ d1 moderna opra
dc fama i priH1./ Q11c-,,ta ( 11 110 donna sculprn i11 pirtra 'irn/ d1c.m11ural di_fuoru:/ lal :-e
ancor \'rnnr adora./ dir questa pi b Ila e 111t11 (11,rivn./ Par rh ella !!llard1 l' pur 11111 "h oerh'. ha_,_,:( par< ht '!
mon1epur1icu frrmo il prdrJ par che nspiri r odtH'!llU aura ptni./ ma \ ' !lll\l ( 1111111 qutI d11 111 111 ,. wd1./ dw
pir1ra ' 'i\O 1 fil dt omini assi,/ n in pil'lrn n1do io mui tro,ar mrreed1.
1: 3
carne e a o ritratta (com 11gcrrrirebbe il' L ). nel 111omc11to in cui che i vi ta
dipinta (a l .;uo e lor ) in vr te \'arie. ci .. probahilmc 11tt\ con un abito di colore
0
f agia di\' rida quel! indo ato o e lto per l"irnmaainr. \'mhra cli a:si tcr alla
I at tica della ituazion mc a ili cena da Tito r pasia110 ' trozzi in liii
cann rirnlt al pittor o m' ura. cl ,. i raccontano i capricci di una ciocca or-
tiaiana incerta ull"abbialiam nto 11 il quale far i ritrarrr. oltre che ulla taai ne
mialiore per ambi ntare il dipinto:
Ecce nO\ I Tclcue con:>umitur arnia curi .
\'ultquc tua pinui. .o mc p(' ritc. ma11u.
e' i(iccl in Jonao \Il CX al
Et darum ar uia nomcn ab an ' fcrat.
cd. dum con ultat qliac c mmoda rebu
Tempora. quo habim incJuaL anmh abit.
\'er rn do laudatur. modo di itur aptior a ta:.
:\une placet autmnnu nuncquc r robat ur hycm :
:\une cupit xr mis pingi velata capillo.
ultibui:.. et nuda nun lib te coma:
Dumqu cliem et vario aJtcrnat in pta I aratu
Qu cJ cupit in longas prorrahit u qu mora .
Quid tibi ,; ? quid tulta para ? a11 forte \'ereri .
\e I \tas populo nota .it ?
Tal . totque tibi cum . int in rporc m ndae.
Forma pi torem qua ri hab re tua ?
Quod i ura no,ac t tanuit imagini t i
pcctari a era po teritate upi .
Edita qua populu d tr mono carmina lcait.
llla ltlo mor ffigi mqur t nrnt:
llla tihi potcrunt pallor m afferrc I aenti.
i lrnrr impuro fuait ab ore pudor.
o an et a1ie m a. lonaum t ran mi . a p r a \'lllll .
Itera" nturo temporr Thai ri-,H
6
.
J.t6 c[110 che Elena. inqui ta. logorai a da nuo' i affanni. r \'li le es er!' dipi111a dulia tua nr uno. abi li Co. m.
\atural111r111r per '>praHiwrr. nobile. u lungo. per oll<rwrr un nome illm,lrP d11 1111 .unr inco111p<1nihilt'. \1a
mcmre 'i in11 1Toga u qualr tagione ia opportuna p r 1111.inrprcoa co .u-aorclinaria ,. '" quali \'t'sli drhhn imlos-
'are. ranno'" ne va. Ora 'irnr lodata la prirnavrra, ora ;,i dil'r pi acla11a 1'1stal <'. ora va ben!' l'au1un110. ora i
plaude alrill\rrno. Ora d idrra e'sere dipi111a 1011 i raprlli Vl'lati . acconciali 1011 ornarnr111i l'1>terni. <'ora I<' pial'r
clu la rhi<Jma sia 1oprr1a. E 11w111rc. in ua. ahrma i giorni r i di,er:,i prcp11rali\ i. protrar in lturglH' a ll r'>l' ci
dw '11011' . Ch< ro'a rnoi per te? prr 10,a fai pr<'parath i. !-C'iot-ca? per ca o lt'rni rii!' lu 1uu in o tanza ; i11 troppo
nota alla grm ? !'lill!'nr tali ianti siano i difrui cl I tuo corpo. d idni H\rr<' udi. po.,izionr un piLtorr prr la
tua .'e .ti l'ansia di qur w nnovo rilrauo. 1 r de i Ieri rs;,<n a111111irata dalla lontana p<hll' rit.
l'.11bhl1C'a1J clu la grm legtre ade . ., o ul 1uo riguardo co11 rrnno i 111oi modi e lu tua effi gie r po1run110
farti rmpalbdm 111rntrc l1ggi . . I' mai il cl1li<'ato ro>. orr fugp;1 eia 1111 voh intpndirn. For r. dita atlnl\"PNJ llll
,.,.o grazie alla mia anc. "arai una rruo\a Taicl1 pc>r il 1empo a venire (. 1d pirlore, in , "11101z1 131 ;j,
c. r (11ia C'fr. andw Pu10 .\ r ' PA1t11ow 1979, pp. 53-34. dt>i quali adouo In lllllllf'/! natura], trad. mia).
13-t
Con 1111 rove. ciamento atirico dcl 111otivo he abbiamo visl i11 Basinio da Par-
ma la do1111a <' invitata a non aff annarHi per affidare la propria m moria a un ritrat-
to, prrch ' il porta ne ru todi ra C'lernamcnte la fama: i uoi " r i r. pl'imeranno. in
modo in quirncabile e p r r t rnit. quei more equivoci che. fac udo i litrarre.
lei vorr I be na nd r e far climenticarr ai p t ri. Le par )C' inchiodano il moclello
alla ua ,. ri t, r n n r denzionr in una bella immao-in .
2.6 Idolatria
li ritra11o r 11n so. tituto. ma proprio per questo anche un idol ' llll O'CJ lto di ado-
razione in en o pi no. I ad vozion all.inmrnainc dell'amata r un culto privato. hc
ha i1 uo I uo
11
0 na1malc e id al nel cuor d lr amant . pu pincrcr i ohr la mort
( qu to quel man ueto chiaro vi o/ che doppo m01i ador rai an hora> li
7
) . L
ur e rimonir si compi non ila camera>. an he e mcrit r bber un tempio. come
abbiamo visto in un CJ ij)'ramma dcli' 1110/00-ia Greca. puntualm nt ripre o da n-
aeriano ( Eriacr hui tatuam et templum a difi are d e batJ blata aperet pr
Iov ut una p1we ' H
8
). ;"\ I rito r uraenza del feti cio rende d I tutt e ondaria
l'cv ntual im1 rfezion d l ritratto:
I ropra aclorar. ia come ,lr:
ebrn r a Lui di unii . non 111 n
l"i111a11inc de Dio da nui . i rolcHQ.
Cos i chiude un onetto he il baldeo rivol.ae al di anator . e imaaliatore
Ciro I amo .\1ondclla. hiedendo un ritratt d ila donna. p r h' non pra\T\'e alla
ua a :enza ('ai h nza i1 u lum io Ycnao m no [,. Q]): il ri ultato n n
ar perfetto. alm n rimmagiu prirn r una Yera piet> (pi t d l ritratto I
dell'art i t a [ ' " 11 ] ). . ara ad rata, co1m111que ia. com ani n n rimacin d
Dio. Il rappor10 qua i deYozionale tra ramam - p ttat r il ritran ' qui rifor-
mulato n una note,ole conuni ti n cu e di i. n lla quale for ao-i ce il fama ma
d Ha forma vera> di
Jdolatria dai 1oni ' Cop rtam nt bla ' f mi' qu Ila
profc sata. on d I ol fu1al apologia, i11 un on tt di Panfil
I-+7 \'1bCO'\TI 1-tCl:l. [ 1 ;)9] .r. F2r. " . I ;3. H. 1; idol111rin ( 1111 1rm? ril'orrer.ne mi llithimi. cfr. t's. (I:;)]. (_16b). t'
" pra1111tto [ -t ]. dmr rrli idoli drgli 1u11j hi (anin111li . 1Nri t'd !',seri nalt_irah) >Ono a 11110 1dol '" t'lll1
ou luct' 'illlt('/ r qui' I q11111l' io pregando -r111pre udoro ( n. 3-6 ). ull altare dd q1111lt 11 p0t' lll hn offt'rlO "'Ptrto.
in"e"no t' '>rn. i (, . 1 O) f' ha bru into il proprio 1uon prr 'il'tima (' 11 ).
H8 c.'urcbbc 01a1u l'tHl\l'llP111r eri"erle mia '>l!llllll t' t' dilil'arle un tempio. al po,10 di Giow. lei ri t'
l'offrr111 dtlle preghi1n ( \, .F. Rll'\L"' 1993. L\ \ 'IL" S-b).
1'19 'l 111w1.o 1llll9-1992. Il Il I, -t-t6. " 1 I-! .
1.-0 Cfr. 1. -t .
erro d I rnllo 1110 dw u1r inam ra
radorno. crlorio"o e bel cli;.l'gno.
non per mo"trar clo . iu del t amor drguo
l' tcmp rar la fiamma che m ac ra.
ma perchr crrca ogm111 dcl dio che adora
hawr qlialrhe reliquia e qualche egno.
e b nch' 'l'lr sia. metallo o 1 !!no.
con umma rc,er mia e f' l"honora.
.\.lrra r liquia anela n n ' lio io.
lu i el mio imula ro la mia di' a
(p rdonarne colui che in :i 1 Dio).
Queta ara cao-gion chr morto YYa:
pensa quant crebbe I piacer mio
e haver poi la toa i.mao-en \iva
151
.
Il p ta re pina . p r . I raaioni all quali qua. i tutti o-]j amanti n orrono
per
11
iu ti ar la ri hie ta d 1 rilratto: l"int nzi n di m tra re la propria fedelt
il bi o,gn di trOYar nforto. Il ntim nto h lo muO\' a d iderar il cdi eano>
eh raffio-ura il rnlto amato unile a qu ilo h pm11e 1 r denti a e rcare reliquie
e trac cl I loro Dio. idoli (= immaaini) signa be e i venerano per quanto :iano
fatti di materiali pov ri (vetro. rn tallo o I 11no). Que ti ogg tti 11 n hanno valore
in ,. ma in virt d I leuam imbolico con ci che rappr ntano. he li rende
in timabili a
11
li o hi dei f d li. a tati di un ntatto \ ' J 1vo fi i e n il divin .
La profe ione di f d dei -1 O afferma l'uni it dcl proprio imulacro>. un
rapporto lusivo eh i ri pecchia nella tr tta contiruil dei pronomi di prima
onda per ona inaolar (io.I tu>) nella rima quiv a \1va>:visa> (n-. L.
1-t): in a i trinaono l"amant (morto h \'iw 11razi alrimma!!n I Il' amata) e
l'immaain inanimata he. e pr n<l e vita. dar I b pi 11randr gioia a chi la ado-
ra. B n pi ordinaria perfino un po' grott ca r la rimonia mattutina dr. critta in
uno trarnb tto di Leonardo Giu. tinian. eh riempi di I aldanza popolar ca ITf' ti
olenni orue qu ili cli Lane lot priaioniero di
1;; 1
r t" dipinta in . una cari iz Ua
com r f11-,1i una anela d Dio:
quand 111i I \'O la 11rntiua bella
in o-enochiou mi buto ron dr. io.
(adoro. I oi diro: d1iara t Ila.
quando farai contento lo e-or mio?
1'1"6 .,- L' 1 \I 1
w.o
7
::>. I'< l/.lllll<' a 111\Wnt ,. ba,a u;to dci Sol/e/li e ( 'apituli. Brc<ia. \fi.,ima. 1:500.
136
B5otr poi rl l>t riugo rnn clolcrza.
po iamipartoe,ornc11alam
,\ u malin. quant Lanccloz fu lcYez r1 il ot le fenrstrr. ouvrrt par drvrr;. 1 jardi11
et il vini ('Il la chamhrr pai111e, i vit l"p11age dr a cla111r. i ranr:linr et la alue rt
vait prr" ct l'ambrac1 cI la baisr !'li la houchr .. i e dC'li11 ru ,,ez plu qu'il ne fei 1 e
11
mtlc aut re famr for., cn .,a dame.( ... ] [LX\ '\\'Ili l] Quant il Noit 1 , z chascun
matin . .,i wnoit a cha. <'LllllH' fi"ure qui t''>toit poi111r 1'11 lru dr la roine. ,,i le hai-.oit
e;. ieux et e., hourhc;. au.,i tom ,,e re f11;.t . a dame la roinr: ,,i plouroit et r dcmantoit
t rop durru1111t. Et q11a11t il a\'C1i1 grant piC'cr drnwmr rt plaint a mc.,chranrr. i
revenoit a., 111agr., rt Il' . hai;.oit et lor la o-reincrnor honor qur il pooit et ain i
r confortoit par lui et re e loil la rho r qui pl11::. li avcnoit i:;:i_
J :ossrssionc amorosa che qui si fa pre11hiera profana trova , o una ri pond nza
interion n<'lla presenza della cfiaura nel cuor . Com abbiamo to in a paro Yi-
co111i . il ritratto dipinto o colpito t il imula T interior ono cl tinati ri pettimment
a11li occhi d l corpo r a
11
li occhi delranima. p r i quali rnlgono ftmzioni diwr pa-
rali l . L i11t razione mrtaforica tra le due imma!rini '-iluppata n i te ti i riflette anch
nclJa costruzione e 11 ll'u o di 0
17
actti reali. aioi Jli. rn lao-li ritrattini. a loro rnlta
C\'Ocati in ,. r i. La po . ia non cl cifre que te r alt. ma e 11li in e 11li a,,p tti che -
in grado di r prim r . framm nti r f nom ni h p o coin idono con quanto. neali
oagetti. d< ri,a dalla familiarit con la po ia te" a. i fonua co ' una :..orta di doppia
corrent<'. i11 cui i due codici .i incontrano quand e dove parlano la te a li.nana. o al-
m no una lingua imil . quella <l Ile m tafore. uesto pr s. o si chiru ce oprattutto
quant cli . poniamo di d umenti che ci r e no il te ut di relazi ni. I -onali e
di committenza. che il c di e llli.co t nd a lider . Le te timo1al1Z pi utili al riguar-
do :ono lettere e <lidasealic. h r "i'itrano la on r ta n goziazion trar alt imen-
..
zionr. tra le occa ioni e la l ro na-,crizionr lirica. In una l 11 ra li Pi tr \.r tino a D n
Dieao I Turtado de ambasciatore <li Carl Y a Yennia. non I appr ndiamo
l'origine di un onetto. ma al)biamo acce o al rnore <li que t meccani mo circolare:
Chi dubita. se 'ignon. cJp la bizzarria dc i \O tri andnri. con id ri il onctto che
mi a\'ete fatto omp rrr 'opra il ritratto drl qualr mo:-.lrate olamenre lo im glio
152 C1t 11'11\ l:) t:)?.<-.2r (18). \i,1. l. 2.:l. 718arrnlgoglii11Lenentipropo.,tidnL0<'l'hiin 11sT1\I\\ 191:1.
p. 25 (\\lii ).
1:-3 cli mattino "<'"Uentt' . quando Lanrrlot -,i ulz. apr lr li1tl''t1e rh danmo ,uJ ginrdino 1 \l'llllt' ndla rauwru
dipinta, 1idt il della sua signora. i i11rhi11 d1nanti a lri e la salut: 'i 11niri11. l'ahhrafl'io e la hari
sull a hoc<'n, I' 1w 1bbe un piacrre maggion di qndlo rhe 1wrrhbe a1uto ron q1111bi11,i nitra Jonnn dw non_fo, e la
sua 11111ttla . [ ... ] 11tte le n1attin<\ app<'ntl ulz11to, si rl'rava davanti a ogni li"11r1 l'he rappre entava la t'g111a. e le
harian1 IH'd1i l' ulla borea COlll(' st [rn,,,l'rll la 'ua signorn: r pi11ng11 U. addolonl\'ll forll'tll('!ll('. F,
dopo cht a'11ngo si era addolorato e anni pinnto sulle uc .,,rnturr. ton1111111!11llt' inuna!!iui. ll' ha1!:1va _1 1:'-11d1n1
loro l'onorr pi1 "rtmd rhr potern. r tro\'11\ 11 in qm to un !!ran 1onforto per st': 1d t'rn la dH' pm
11
h p1an1 !I
(L{//1crlot I \', L. ' :\\\I, 2:3 r L\\ \\Ili. 1 (trad. th1 Bi RGIO 200 I. pp. -+.)3 e -+:17)).
13
di seta. che Io ricopre a guisa di reliquia. Ma perch on erto che i mi i ver i non
t ngono in tanto di buono quanto in lei mo tra di natune la D nna eh . enza
averla inanzi . ,-i ha ras mplaLa il Vcccllio, ne chicggo perdono al fantastico del ug-
aetto impo tomi. Intanto eccoveali n I modo he io ho apulo fur\'cgli. Di Vi11 zia.
LI .X\'. d. go to. i\1.D. xxx.11
FurtiYamrnte Tiziano e ,\more.
pr i a rrara i p nneUi e le quadrella.
duo e empi han fatto d. una D nna bella
aerati al aureo ignore.
Ond eali altier di di,in favore.
per eguir otal Dea come ua tella,
con ceremonie apartenenti a quella.
l'uno in camera tien. J'aJno nel ore.
mentre quella cffaie e que ta imago
dena:o a copre e fuor cela ad altrui.
e in ci eh pi de ia. meno appar yago.
\'anta il ecreto che a conde in lui:
eh', ognun del fo o uo pr aao,
ardendo poi non a verun di cui
1
4
.
La compo izione 'al buio alla quale il poeta co tretlo dal gu to bizzarro d I
conimittent . rinnova l'e ecuzione del ritratto a distanza' compiuta dal pittore. li
onetto non olo accetta que te condizioni di crittura - del resto assolutamente co-
muni per le rim d. occa ione come per i ritrntti - ma viluppa un'invenzione che . e
ne fa cari o e ne trae i pi.razione, interprela11do pienam nte l1e t.ro o ogg<'lto impo-
to dalf amba ciatore-poeta. TI onetto co truito u una doppia eri e di immagini,
che discendono dalla coppia e ordiale formata da Tiziano e da Amore: i due artisti
hanno gareggiato. con i ri p t1ivi trumenti (penn lli frecce) nel ri trarr ramante
del Mendoza, realizzando du effigi. cu todite nella camera nel cuore; ntrambc i
ottragaono alla vi ta al1rui runa na co. ta dal!' invoalio di eta' r altra dal p tto
cbiu o deWamante. La carnera il luogo nel quale i l f dele cl amore officia l ce-
rimonie 1i ervat al doppio idolo, ma anche il luogo in cui .. tori amente. i ritratti
privati veniva110 tenuti, in cu todie di peUe, di toffa o di legno
155
li dato di realt
diventa la guida per plorarc., in poe ia: rambiauo ro esciar. i d Jl 'o tentazione in
na condimento, del egreto in e ibjzione, che impedis e di identifi are il vero oggetto
della pas ione di di 1ri ar i tra de iderio real e indifferenza appar nt .
154 AnmNo 1997-2002 [LA], 11. 441. Cfr. Po11Mrnn 2003, Anoui:s 2003, K 1uJSE 2006.
155 Cfr. Oi:tBf.RC 1990 e 2008. pp. 17 4-1 7.
138
La t.es a cHnarni a di rivcl.aziouc occultamento ispira una non meno . ofisticata
invcnzion . o pc a tra materialit claborazion fanta tica) tra concr tezza dell'og-
getto e rarefazione tiri.ca, nella didascalia che accompa"na un sonetto di Ga paro
Vi conti:
sendo nel tempo dcl earneval un e rto rrio ene a la pre nlia de alcune damij)'ell
tra lr qual f'ra la amata sua., et e. endo pre11ato da e e rbe gli dice e qual era
la ua inarnorata, e so dis ' t' che per alcun modo non li nomjnaria mai quel nome
qual e'. o era indf'!mO dc nominare. ma quando pur ali piace ' e al.iela
.mos1:raria rei meta in camaino. Et dati.o orcline a que to, tornato da loro li port w10
<'amaino che a caso hav a omprato. dove era una te ta non cono ciuta. et mo-tran-
dola a tutte srparatamente poco in di co to dar altre, quando fu ad quella qual era
l'unico cor uo, v !se il giovan il camaino. dove era uno piccolo pechio nel qual
e a attentamente mirando idde e t et erubuit dolcemeote. Trovando i il pre-
dicto giovane da l ad alquanto tempo olo in camera et guardando quello pecbio
fa que"to ' onetto parlando al predicto pechjo
156
.
Lo carto tra l'argomento di que ta pro a narrativa, qua i un pi colo racconto e
il contenuto del onetto non potrebbe e ere pi ianifi.cativo:
pechio nel qual la mia diva mirando
conobbe la agion che 1 cor mi opprime
rt vide il dal.ce sguardo che me imprime
la voglia dove oguior mi truCTO amando
pechio che discopri te alh ra quando
rni f'u men duro l'idol mio sublime
Cl111 n0\'8 arautia ramoro e lime
che l' alma mi con uman d iando,
per che non retene ti in te la effigie
che ola sol . plendenle a gli. och.i mci
o de le I u e , ue qual 'he vestigi ?
he col pen er c hor iace i:n mille omei
et se r.itrova in le pili hns e tiq-ie
beati i mo i11 cel 01i 1 ro, rei I:> .
H on tto rivolto allo p cchio. non ' lato cii.tto in quel carnevale ma da l
ad alquanto tempo, nella solitudine cl lla camera, e rispetto alla ricchezza di
dettagli cl ila elida, calia, bilanciato ull' aIgutia eh ha mediato la di hiara-
zionc d'amore: la silenzio a si.bi7.i.one di una sembianza generica e fuorviante, in
un ogaetto che i rove ia e diventa decifrabil parlante' per la ola int r , ata,
156 !SCONTI 149:3, (9:l], c. D2r.
157 l bid.
139
:-ahaguardan I il ecrr t ul uo n m . li tempo d Ila cornpo izione b 11 distinlo
da qu Ilo dell' pi dio ri '" cato. a ribadir eh la lirica. anch d'ocra, ione. non
1110
he e:- r a po. tcri ri. meditati\'a I i cli narratirn 1.:;s. Il arnm o- pcc hio descritto
dal \'i conti fw1ziona rcondo 1111 principio molto imi le a quello clic agisce in una
medaglia della fin del\.\' olo. attribuita aff in i ore Lyippu (ili. 9)
1
:;
9
: il profilo
ul recto ' qu Ilo delramante. che pr nuncia l'in\'ito o la d dica DI L\ fL BEL
rJ O - E QrI IL TYO, ERY tlRA, il volto h puo rill ttcr-- i ulla :up rficic
le\icrata del rero qu Il tlelramata: re ortazio11c a cruarclar ha in il ricono ci-
111 mo di mi"e p ri nza !oppia e (di l/c qui ) r della di omocrcncit tra
una qualit (b llczza) e una ontlizi ne ( u lditanza e f delta). ln as nzad 1 ritrat-
to. la .:- rnbianza delramata pu e --er erncata nello p c hio. ocrcretto amhicruo "
t"ti . ""'I \
maCTico, al qual i attribui ce la facolt di tratten ri' l'imrnacrine cli chi vi si riflette.
T ll'Espinette amoureuse di I an Froi art l"amant vi ne , orpr dati" irnpr . ion
f ur I le ma dame et d a ficrm
1
b0. eh cr]i appar n Ilo p cchio n I quale la donna
i guarciata durante i tre anni della loro pa- ion . In un capit lo di Siccol <la Cor-
r crgio. lo p culo tutto ci eh r amant . part ndo. ha la ciato all'innamorala:
cli front alla ua uperfi i muta. n lla quale rifl ttt' e t a ma pecula l'amato.
I i i trattiene p r w1 tempo lun(Thi . imo. fino alla ideram nto (Tu mi la 'eia ti al
tuo partir un p ulo./ dinanti al qual t tanto eh io m a id ero./ e m ,. l ndo. te
trovar li p ulo
101
). d tino ar ri ervato alla protaCTOni ta di un madri-
cral di Diomede Borgh i. he n Ilo pec hio ritrova olui eh ama:
[ .. _.J il Bor
11
he i. in p:r ona di bella e gentil 'irn ragionando con uno
ch10. nel qual rra - 1 fattamrnte acconcio 1111 ritratto di Cin-alierr. amato
fonemcnt da lri. eh ella non po1rrn a niun panito enza wdere il
d tto
non fo per r arO'om nto. aremmo 01winti di tro,arci in un conte to
d 1 tutto .. fittizio. lett rario (qu<'llo del plat nico ri1ipecc11iarnento tra CT]i amanti).
m ntr l 111\"enz1011 poeti a i fonda pr prio u una caratteri tica d 11'0CT11ct lo, uno
pc che contirn u11 ritratto. fn e o la donna v dr. trs a e ramato, con u
1
10
nto eh riguarda i og11et1i (compr enza e/o id ntit) e in i me la loro
m .erta cuore !,npporto e terno. uando i pr hia. la donna incontra
I 11nmau111c delluomo amato. 11on la propria. p r la reciproca m tamorfo i hc i
1:)8 ulle rornp nrnti 11arra1he rwlla liri a q11attrorentl'M"a cfr. \f \R(ll\\D 1998.
1>59 Londra. Britibh \fu><' um. Cfr. I liu, J 98-+. n. 796. l'I> 206-20 : ''r.111 R 1> l ')1 w' 11 n1t1\ ')()00 1> 99
I H TF..KI R 2009. , . . - . " . - . . '
HiO F1101.. 1111 1963. n. 2629-2630: dr. Rm1tlf>Alfl 1979. p. 18:-.
Hi I CoK11tcc10 1969, %5. vv. 19-2 1.
lb2 BoHGm 1 1:-85. p. 77: il rel111i10 111adrigalr (C'aro p<'gno rf"amon) ,; Jr"gr ;
1
i.
11
p. -+7.
1-0
'compiut a quando more li lcg (<1:1"un di noi ratto i cangi JJC l"altro [. 12)) .
Qu ta yrr ioue tardar galante di 1111 motivo profond d Ila filo ofia d. amore n a
bpiecrarr il prodiuio. che 11011 altro che una trascrizione po tica ingerno a dell"og-
grao ste. so. Ritratti in1ili , che sfruttavano effotti e amhirruit cl Ila vi ion . ono
atte tati da invrnlari narrazioni. La p<'ccbi ra-ritratto cantata dal Bor(The i rea-
lizza quella comi rc -enza decrli amanti in un rifl o tanto arr O'fiata da Ana lo Galli:
cO h. che fo 'io l'immaain ua nel pccchio./ beato me i fo i l facto ombra./
cha icrn pur cc ba iart'mo ocr11e ora.
11
'
1
. Qu ta condizi n vuotata e fanta ma-
lica i ad clic al corpo innamorato. eh di per un ombra. ni i vana mei tu
umbra "cl aura./ 'orporilrn par 1 wnhra ,. I aura mei ' . dice ncre1iano
al proprio ritratto
10
"'.
2.7 L'ombra dell'amante
\ el Quattr cento molt rim per ritratto ri11uardan r fficric del po ta, il cui e p tto
ha pr ::ilo r onor cli ere inunortalat da
11
li arti ti. autori neolatini la di-
mrn io11 celebrativa piccata. mentre in rnlcrar embra dominar r autoritratto
deJrarnante inf lic . eh con la pr pria immagin concli,i<l la dannazion di una
mortc-in-\ita: corza nza cuor e . c11za anima. i tra Tina in una o pen ion
doloro 'a e intrnninabile. , elle fortunati%ime rim di rafmo .\quilano. improY-
,.i atorc ammirato e coni<' o dall corti. il rinatto d ,ita a una br Y qu nza
continua, i11t ramente dedicata alrimma11ine del poeta e non a quella della donna
1
0.".
Li pirnzion offerta da una prcunta fftgie dipinta dal Pinturi hio. ma intorno
a quebto pr t to r alternanza dei de tinatari int rni o trui e w1 pi color manzo.
fatto di lonta11a11za. de idcrio. crudelt. Il primo onct1o -i 1ivolcr al pittor . cu-
. andolo per l"impcrfezion del ritratto. eh non api ar 111icrliantc emplic ment
perch quando fu e euuito il mo l'Ilo n n ra:
Cniro Bt'rnardin. l'opra r nr<>ra.
ben che alcun dira h 1 non (> rl 111io
ma 11011 curar. ch' io I ho .,cwato e dr to
chr far nou i p tea quel rlir 11011 era
ron dir che 111ai tu mi vt'de ti in ci ra.
prr h dal d eh altn 111'aper;.t' el p 'CO
16'.3 C11 u 1987. 130. " 12-H.
1( \
l f J l , ( 111 .omhrn o un f11nl1b111a mtto cil a rui il
H e 011 '('I altro dw 111111 \'111111 0111 )fil O liii lllllU>lllll ( t 1111 COI fl I. I
n1io corpo,; riduc(' (A c:F.RIA rs 1CJ%, XX \ \' I, 1 . 1 l- 12).
165 AQlll . \\O 200S. 1:5- 18 fprinceps Ro11111. Be,icken. 1:502]. -.01wi1i rin ho commtntato in Boi.to'
1
2008. PP
119-127.
1-+ I
perd rarclir. la forza e l'intrll cto
la form:L cl cor. la ymagi11 mia ,crn.
E . olo apres o I i :.on facto una ombra
che in un puncto di 1 aro e nulla torno
qualche I mio hel sol e ingombra.
E a te par e di ,edcrmi uu uiorno
mia . rorza fu. non i . che og111m adombra.
eh' .\.m r la ticn ol r r mi o ura, corno
1
bh.
Tant l'amant eh il ritratt no o pe i u Lm 'in omplet zza. u w1 st< lo inc r-
t na animazione inerzia. h altra\ r a an be il ' e ndo onetlo dove rapparcnte
clifett dell'immarui (la mancanza dell'anima) div nta il uo privilcaio. perch le
ri pannia off r nze e la pr di pon a rie nre la Y:ita dalla I nna cui ' de tinata:
O rinacto dal ver. tu i pur di,o.
ch in poter d mado1rna ou!!i ne 'ai:
non t doler d I pirto chr non hai.
ch a mezzo del tuo gno io non arri,o.
lo on pur. come tu. d. anima pri\'O
e pato e ento. ond quel tu non fai:
ma per la effi.uic equal chi crm mai
qual un de doi chiamar !>e po a
Pi pre to tu. ch avendo lei d io.
come f !!i di m . eh canti o parli.
ui cllla el tien darratti el pirto mio:
cb. come I 'a i pini. anrh pu darli .
onde !ucto I 111io ardor eh non o io
potrai tu olo al or manifr tarli
16
.
UP ta i.rruna
11
ina di rivo1(1 ridir ttamente all1 ffi!!'i . eh ' in procinto di man-
dar alla donna ( opra I m de imo ritra to mandandolo>) . I a fama cl 1r quilano
era le
17
ata oprattutto all a ua ahilil cli compo it r ed e. utore di t:ramho1ti , clr .
cantava i ol liut . ed' in que ta ve t eh . for . il pittor lo ritrn -
dobl iamo n ono .r i uoi tratti n IJa figura di uonat re di iola da braccio
166 lvi . 15. Cfr. ,\,Gf.Rl\\L 1995. \I: c\ '<"ra mri effi,,ie hae \llhu Dcfi ii aJ \ '"t h" ('
,.,,, . ( Q , .. . o . 1111 1 c1 1c. , um p1r w l'>I. 11011
>
11111
''. nrni ue la r un 1111mag111 vrri1i1ra drl mio volto. Qui man a ,ofo la vita Qua11do fu rli 1>inl 1 io
11011 l'fO 111"0 ). ' ' .
16? \Q1 li .\\O WO:J. 16.
H2
nell"aff'rcsco d Ila fusira n Ila ,' ala dell<' r1i Liberali clPll" ppartam nto Borgia in
Vaticano. cl oralo da Pinturicchio n
11
li anJJi 1-t92-H9 . . Certamente no11 ' qu ta
l"immagin . r aie o fittizia. cui i n tli rimiano. in quan1 i er i mbrano riferir i
piullosto a LUI ritratto su tavola, rna non . arrbbc I agliato immauinar 'crarino raf-
fiuurato e n uno tmmr11to mu ical c o nrlratto di uonare. intratlenitor dipinto chr
la donna anima com una marionetta p r il proprio divertimento (vv. 9-11). Fiaure
di uonatori sono molto familiari all"illu. lrazion libra1ia di primo 'inqu e nlo. e i
incontrano in parti olare ui froHI <' pizi d Il rac oltr di lrarnbotti u.s. ul fr nt pizio
di urdizionc <' n zian dell e Opere dcl Tebaldeo (\'enezia. lanfr do de :\Ionferrato.
1;)0? [ili. 10]). berauli di ' upido e LUl 11iovane u nator di Liuto. e in rnri dizioni
dell" lrdelia di limp da 'a oferrato. il p ta rappre ntato m ntr uona la Lira da
braccio. in. ieme a un liuti sta r a due donne. Leon ia Ani lia. cantat ne1ropcra
109
. I
tennini della rianimazi one d I ritratto 0110 prop ti in modo m lto inlil in un on t-
to di Paride Cr n ara r in un canne dj .\ngrriano. dov la donna ha il poter di lar
touli<rc ranima e l"immagine pu manif 1ar i ntimenti m
11
lio d Iramante:
\ ovo miracol come '> ia ,irn
1ia i magi.ne dipinta e eh ' io ia morto.
E d ll a godi et io enza con.I rto
Co tra morti in mill affanni i. 'irn.
. ull a pictura a qu I termine ari,a.
quella bell a cruda chr m' ha morto
Cli lrn I" anima mia in fu a, ondr. di cort .
Parlar v e amar quell a mi a di,a
170
.
I nunc ad do111inam. mea imacro; nit bis ah omni
Part e quidem. arther i ltL\ ubi oli ade t.
llla dat. illa aufe n anima!.: illa omnia tamquam
l111111ortaJe ibi lllUUeJl ade Ct acr it.
[ ... ]
Drindr, ubi ,-itali t mutam irnpl verit aura.
, u<Turral domini lune t ihi forma tui.
Du111q11e venit tacitis praert' p pcnni .
'
, I t f
ocP pi a. quac sunt 'u nera no 1 u. 1 e .
168 Cfr. C"11u 1988!. pp. 36-+t .
169 Cfr. i1i. p. -t:i.
170 200-t, LXI\'. " 1-8.
I
I I '\ h1 lm'1' drl ,olr relt,tt'. I .ri d t'
1. 1 c\ai orn dalla min do11na. 111io ritralto: :- pkm 1n11 111 ogm uogo. e 011 <'
1
. . .
. , . ,
1
.. I' [ J Poi <iunmlo lei ai rn ntmp110
louhe I anima lei fa 1wni l"O>U, com :,,1 n1<M' 111 :.!' 111111 e" 1111ta 1111morta L . . . ,
I
o . , o I . h 'I I Il' ' to I I luo 11adron<' t1 ien!IU 111 n1u10. l
n tun 1111nuwi11e 1111110 con il n-,piro 1itah, ullorn !IM' lll <' e 1 ll' H>pt t < ( . ' i . r .
t"> 1 1 rii l<' t' dei 0111 q1111h ono 1 1111e 1e111<
111 lllrt I Ol't"lhi our ,. i prr;, .nl!I, u prr i pizio, ron le u1 11 1 '' cnz1<N' . 1 1 e e n
1
t
(.\'iCLlll\\l!> 1995. L\ lii . l "Y. I-i 7- 10).
l-i3
Cc li nazio11e amor a cui il p ta ' sc)ITgett fa 1 eh il pi nor non po. sa vederlo
Yer<.lllH' ntc. dunque 11 an h ritrarlo in mmrnagine omialiantc
17
:!. ppun' la tes-
sa orn.lizion I tr " 'rt' r Y ciata a fayor d ll'arti. ta. rfr ancora I' \quilano
al Pinturi chio (Al pr fato pictor ):
e r opra tua di me non ha 17i molto.
non dc te. Bernardin. 'ien da colei
chr l"imaginc mia porta con lei.
ra pc t mio non ' d ndc m'hai tolro.
on tucto un I nao t mpo in e accolto.
mie per far cl I ,; o i membri nwi
prima te onverria retrar eo tei
e r i robbarmi intorno al suo bel \' lto.
ome la torrai h 111 n n ardi
al far <leali occhi. lei qurlli Yolo-cndo?
h tu rii ::-uuardi oi n foco e dardi.
ola una ,;a per tuo campo compr odo:
pinaer errati i p riuliosi -.ruardi.
ritrare I re to e dire eh.era dormrndo
1
...J.
Il pittor ritro\'er i tratti d I Yolto di rafin in quello dell'amata. he li ha
a imitati p r lunaa con uetudin (v . .3) e n a1 proprier furti amentr, faceudo
attenzion a vitar gli occhi della donna: poich bru ian biunque in rocia il
loro <Tuardo. dovr dipinaerli hiu i firwere di av rla ritratta m ntre dormi\'a.
' lo trataaemma eh . in forma di ammonimento. chiudeva il :on tto di iccol
<la Corr agio d di ato a L onardo. e eh co tit 11 i r a11t fatto cli un pi aramma
di Angeriano. dov la donna chi ed a.11" arti ta perch r al bia rappre cntata con gli
echi hiu i
17
"' .
\"el ritratt erafino in\'ia a li al etta G nzaga (e, opre un ritra to mandato
a!Ja du h a dTrbino ). ua prot ttri e<' futura patrona d lle ollelfanee (1. 0-+ ).
il uo volto appare figurato da.Ile lacrime. irricono ribiJe me un pae. aggi cl p
un acq u azzon :
1?2 Cfr. 2005. 18. "' 1-8: cl ritrarto mio qual hrarni O!!Ttura./ 111> ie aclmirar e pur cl"un altro
el mito./ non 111 ha rl pictor dcl natural gi 1olto/ prrchr el mio natural teco dimora./ Lnbo1111do lt'. do mP fu ( I
, pirto foru/" imorno agli ocd1i toi mna ('involto:/ io rr. 111i una omhrn. e acri C'h.io \'Cg11 a ,tolto/ 11011 111 i "l 1 ivo
\mor. !IP 1Jl r.h"io ll lOrll.
hi. 17.
1. i quare cxprc,,a Psi !a duu o l.u111i1w? pa:re:/ \.011 polui: lolw11jlo111111afuissrl op11s (Di111111i , pcrchr
1-2] r.btalil raf11guru11110 1. co11 gli ocrhi chiusi? Prrdo11urni. 11011 li ho po1111i dipin11en
11p(rt1: (1 I 1111.,,1fo110)111tta I opera 'ar1hhe ,111ta anoha dallc fiamme [,\,CERI\\ 19%. 'J\XX. n . :3-4)).
Poi cl longo pianto. ohim. eh "io spargo in vano
p( r gli ochi. dovr 110 mar d e none allo"gia.
facto ha chr 1111io non par pitt 'olto umano:
conu tal ora ad vi en rh \ma "ran pio11uia
muta i Pnt iPr. IP 'ir. li monti e rl piano.
tal (-h"ognr par cl" un ' altra fog"ia , ...:;_
. <'i . onctli di aeC'ornpa!!uamcnto. rimio d l ritratt i collo a idealm nt n l
ternpo dcl tc!-ito ( .. . ) o in quc Il o 11t_e _ucc .. ivo. chr alizza
l'intenzione annunciata n i \'Cr..,i. \el ea o d1 un n tto <l1 Fi.leruo Gallo la didasca-
lia rivrla in\'CCl che l cfficrje ha gi ra<1<1iunto lo pazio ambito fanta ticato
camrra ( Fi lcnio parlando con un uo ritratt eh ra in amera di \ladonna L1ha
di 'C ):
Poich dO\ e- madonna. m: (, colei
eh'( ola e !'11za exemplo e enza par .
rnlri che ola al mondo pu mo trarc
l'art(' (' la forza de dei
proibito a nw dai fati rei
potc r prr troppo tempo dimorare.
mandar te mr r' ident appar
I" aicr. la forma e . lllO\ imcnti Jll<'i .
acri r hc f u;,;, i un te-.timoro xpre o
dPl mio amor e che p nr . i cura
:::altri che noi nrl uo ror fu ' impre o.
Dunque ben auarda P non aYer paura
. e ne f rs:.e ingiuria, grida p o:
Auior pircol tempo dura
17
<>.
J U . I l }''/ p r onacr<TiO in un canz ni r che
cr 1 orn p n ono a e paco l' e 1e 1 enw. 'e- .
cli
. .,-... l al . p:
1
:
1
natto che ull nd imne!!nar
oprattutto romanzo ca 10rn n\' CTe p1 11 r
1 \ Ql 11 1 \O '.!GO:>. 18, '" 9- 1
1. 6 .'i Imita dr! 'Olll' llO n del rnnzonitn p1r Lilia ( (,\I.LO 1CJ73). . .
I I . d I incrolo ,onetto 11111 la rug1onr ptr ihlal!U't'
1 ? [ ... ]gli 1111r11i111rrni 1111otidiani dilr111Uno 11011 o o
11
'
1
i:- 'e . n-ronrmzo iun l'inL'f\'
I
. . , . I I . I 11 1 d1nrhllCO t 1 un -iUlZOlllt '
11111ia rnndw.11 drl rumpon11n.1111t1 ne co111p <.so ILIH
1111111 1
I
1
. . .(
1
1
1
1111
,Ue
1
ici-siti1lini amo
. . I Il I . . f I f l do il ror t <'" anm1 co1m ..
1111 11to d(-lltt 11re,c11za 11111111du11a 1 r a t 011na. 1 u1
1
( n '
111
. li c1
1
. ,
1
., Ili quali !"io Jiriro e phc1111
ro,c (Criin11111i. i1111od117.ionr 11 G 1u..o I 973 P 17). ,\ propooih.> dr e
11
!N L\
1
11
' nel,.
1
1
11
jn,
1
at
1
n in
1
1ro'a che li [i
,. . . '" . . ( 7 i ) QSol' l"Yll ('le e' " ' ' .
come prr,011agg1 1'ol 110111r d1 chlemo. hl 111 iu.i - P ' Il I
1
- .
11
iltt' l'Ollf"un1 il lin"llll!(l!IO
. . . . .
1
. . . I IM" uni 1r u 11 narra ., , - "
('llf11loh 111 1r1-,u rnnn] prrC' amp iano mo a rt1('( 11111 '" '
lr immiwini d ll'rhgin .
I-+.
come all at in un. d .I I ia funzion : come tc ' timonc low dirno ' trarc alla d ruia
rarnore cli chi lo imia, om pia dO\T a 'C rtar la fedelt di lei (w. 10-11 ). La pri-
ma part cl Ila 111. i ne perm a <laUe caratt ri ti h delrimma<Tine, eh<' I ll'amrui-
tc mo tra r att ggiamento ( aien) r-a. I fattezzr ( f nna) e I pre " ioni d I rnlto dw
rendono ,; ,ibili ntim nti interni ( m vimcnti, motus): t111 doppio p rfctto trullo uri
orpo quanto negli aff tti. che !!razic a qu ta ri , p nd nza tota I potr 111a11ifc ' tare in
mod C\id nt ( xpr 'O) alla d nna lo tato cr Ulim dclro1iginal . La \'C'rifica Jl('-
c , aria p r rnlcr r il ' rcondo in ruico ril crg in cla\'e narrat i,a il ruolo d 'I imula-
r nt rior com pro,a d'arn r : il ritratto dipinto dona controllar e ucl cuor della
donna iano irnpre r inunacrini di\' r ' da qu Ila d l poeta-amante. Cl finalr, qua i in
fonna di ncr do. 11a il ritratt a mndacrin attenta nza timori e la eia ap 11a
ru1terpr tazio11e d lr uJtim Yer O. p ' O tra , nt nza llllfr r;,ale e prirnt 111 acr-
ITTO eh il ritratto d webbe pronunciai in pre nza della d n11a nd caso 1l ac erta -
e ru1fed lt
17
Q. C llll' apprendiruno dal V. 6. lilrnio' cri ' lato accolto neJla carnrra
d Ir amata. ma di norma
11
li runanti ono e lu i da qu sta intimit. eh cercano di
ott n r n enfati he pr crlller o n pi avY dut trntecri di m cliazione. O crunc-
retta dO\ lei i po a/ d h non me la t n r tanto na co a. implora Balda. aiT Olimpo
da a oferralo 1 uu trambotto d Ua Gloria d'amore
180
mentre Niccol Liburnio
a
11
!rira il di'i. to con l'e' otica compii it di un pappacraUo: quru1do he la in cam.bra
e ripo a/ mira ' nel pecchio d l u lume./ all r dilli. eh 1 t mpo a dir t imita./
Ben he ia ca ta. puoi dirli O!!lli a./ h a 1m e r che <Tiac nell ocio e piume/ con
I uoco fer i pu dar
11
ran ferita
181
. La ronaca amoro a <li Filenio Cali C' l'i11vcn1iva
en uale d l Llbwnio i riportano agli anni ai luocrhi della micrliorc pittura \ ' C'll ta a
amllo tra i due ec li. ma non trult a Cior!rion qi1anto a i rnnni B llini . proprio il
pittor al quale B rnb . intorno al 1.500. chi d il ritrntto drlr runata
182
.
om abbiamo vi to. il rapporto tra ritratto can1bra non olo leuerario.
perch i ritratti pot rnno r appe i nella ran1era o nell'anticamera con aJui rno-
1 ili dipinti. com a oni. de bi da parto t ncli di ocrcrett r L<TiO o. I ritratti di
1?8 O andu re>pre sio11<". Prr ain cfr. R1f(. x11. 13 e G\tLI 198?. 28.+. \. 9 (Arte. mr.,1iru. an t desc-
). rfr. supm. 2.2.
1_79.1.;an10_n'. .,i peme_ a una lontanan1.a troppo prolungata o di,i-.o trn pi[1 oggrui: cdi,i-.o poLrC'bbr
',l 'lllo a d1 tanza. ma anche '('oncJi,i.,c). cio' amor<' con alrri , 1rn pi a111a111i. Il finale con
.. (' regolan11emf' in una ht'ZiOll<' cli mali ill!lll'> d111Ardelia di Olimpo da Ilo
ll's. o I 1lr1110 1 deve u.11 orwllo. il 229 dcli Rime a 'afira (C \I I o 1973), in C"11i il 111oti\ o dr Ila dl'lu,io11e di fro11tr
al ntrauo rii 11011 doppianwnte ro\I' . cimo. per i la donna rhc rinn l"oprra r d1t lamrnta que ta
.r p<'r('hr 1 ouoluwano gli a prui pci-iti,; di un tal< ilenzio: pianrr terr!'110 comi11uo t' frequenti'
\Wnr a nout; dunque -,e rir.lo 11011 conC"rde all"oprra il dono cli rrndrrr la pr<.,111za in modo complt ro a {in di
lun . prrrlw amor e dr,td!'no crr-.cano di ('Omegul'llza.
180 Ou11t>O 1 :>H. c. Bir. wuml 0110 Della canwra. , v. 7-8.
181 LIBl W\IO t.i02. L \Il. w. 9- H (c. X\'111'). Cfr. orn 199:>. p. 9S.
182 \ill1 ritau Opere drl Lihurnio (LtBIR'\tO 1:)02). i B llini ,Ollf> celebrali nei. omui XXX (C'. \ lllr). LXXXIII
(r. \ \lq. (\\\\Il (C". \ \ \ \ r). Cfr. Oro'\1 orn 199:). Per Br111bo rfr. infro. R :3. 1.
146
dim nsio11i minori erano tcnuti i11 una ca . a o in un armadio. come avvr11iva qua i . i-
curanmrte per quelli ccm il Lerso dipi11to
111
..:
1
l 11.cco di qu lr pra1ich i my rte for e
in w1 i11cregn onrtto del m cl rn'. e Panfilo . 'a . o. che a eia il t ma cl I ritratto al
topos drl laccio e della catena. ricorr nt nel uo canzoni re ( oru1. 39--t6):
Parrndo a tr d1aw sr d mio ritrarlo
proprio la forma mia dolrntr r las a.
co111r rl tyran che piglia hom eh
la oa rocca. r 1<11u o<rni atto.
tu 111e ' l tolrsti rum traclo
rhr da mr lill<'rtade in tutto ' a.s a:
tu mhai 'irn in catena r pinto in ca. a.
tanto rhr in ogni modo ho trarlo.
e tu me 'rdi in '>ogno o 11el pewero.
lllt' lrghi in ru110 ('l'altro in tanti guai
chr a una fcra cra qurl lacci fero:
ma gi per quc to legato 11 n mhai:
vi lcaarmr pinto. in ocrn ver .
lt' ;,tr:.;,a lrcra. cli m lecrarai
18
i.
Ila ricerca cli un d minio a oluto ull' amante. la d nna ne ha atturato il
ritratt . 11 po , e.. d Ila omicrliru1za (' -. 1-2) pr ura infatti tm miti o p tere ul
gcrctto rappr entato. La catti' ita <leirimmacrin ha ina prito quella cl I poeta.
che ora i trova doppiam nte pricrioniero: viv nelle cat n d'an1ore. dipinto in
ca a. rio'. prohabilment . clu o 1 wrn cat la com quell dove ' i u
i ritratti pri ali. '\on pacra dei u i trionfi. la tinuma de i<l ra ontr llar . an _he 1
imulacri mentali <l lramant , r nd re cl1ia, l immacrini di lui eh le appruon
nel prn. i ro o n I ano. wia ' P ricalata fanta ia di I o to1ale. eh
in virt1 d l uo te fondamento. la condizion aLcnata di chi runa: nono tante 1
lacci t<' i all'amante in carne a ai uoi funta mi. per imprigonrul vcram nt
dovr legar e t a.
1
rch lui ' in 1 i. lna nclu ione a.rda_ icilla non
a pr zza un te to up clau trof I ico. dow il t m1 n1o d arn re e tradott? n l li?-
11uagofo d Ila iolcnza fi i a e della tortura (ho tracto, "ri vo un di ).
farnili, rr ad al 1 ri p ti cl l temp . ln ol da orre
1111
i , h d fini I
d ila donna b li ma hin a l a" di
1
a>. le p n d'amore apparono P gg10n
183 Cfr. \fooo -'\IAR ' DEN 200 I. p. 81.
18
' - I ti 1h 11 Ro1..to'1 )008 1ip. l:l8-130.
"T 1 o I 996, 6. Ptr un ro111111ento dtt111'IUHO11 te 10 nnno a 1 nue no , r -
185 ORRl:.CCIO 1969. \". 9.
1-t.
d i, upplizi he la giu tizia drcr ta p r i criminali, in qmrnto ono pi doloros<' c.
mr <' 11011 ba ' tm, e. r stan ult pr urano piarrhc inrur ili: in !"aula
r gia li ratria d' _\m re/ perch i dann intrin. iC'ii tonn nti/ prorn 11011 . i pu dar
clii lor d lore t&i.
- 8 li pili or torna 111/a terra: riffe ioni poetiche sull'arte
indubbio he 11 J X\' e lo r I o-i di pittori e cult ri ispiri aran part<' cl i com-
ponim nti p ti i ul ritratto. ma 1uanto r ta. in questi 'rrsi. del loro inrrcrrno r
d lla l r arte? uam d Jrimitazi ne om Of razione e no itiYa mat rialc(
Wa prova d i t ti. la que ti n i intrec ia on l"indarrin mila fo1iu11 . in pof\ ia.
deJJ"intuizione r ativa h P trarca a ocia all a fiama di L ' imone in altri
tenmm. u il de ' tino di quella cornponent 'filo ofica '. spernlativa. di Rtf L XVIJ
eh abbiamo 'i tori no iuta dai c mmentato1i pi che dai poeli. PreYcdihilmen-
te. n Il rim per ritratto ' diff il ra oalier rrli 1 menti di una rilles. ionr ulr arte
che i pinaa oltr ali t r otipi fra ti i che non i e auri. ca nelle fonnule delo-
!rio ri rvate al talento naturale alr abilit acqui ita. La ama meditazione' clrl
po ta ul larnro d lrarti tare ta u un piano univer al . a tratto. o. pi di rado. i
ac ta a w1a pecifica perienza fiauratiYa. ome n l ca di \nrrelo alli antort>
del Pi an Ilo. 'na iinil ader nza alla realt. aJr . i tenza storica e non allo tilt>
dei ino-oli artisti. i ri c ntra in un onetto ld to-cano Giovanni Teta Cil lcnio. d1t>
pro lama !!ratitudin e tima n i confronti di una J unga chi ra di pittori <' uh ri
cont mp ranei:
lo ar 111pre amic a dipinrtori.
Forte e \larrho al mio divino:
\ta 1 gran Ciornnni e 1 buon Gentil Brllino
Fian empr di!!!1i di rei . ii honori.
Co tor on <]uri a ogni altra ente fori
Ch. n tracto r arte e prrso . uo camino.
Oui bei rat lii e 1 patre lor pi fino
\la u-o da f arnr in ver i 11i romori.
.\fa la. o C'l rnio Fran e dio da l'un lato.
' h. a r uno e r altro tilr ha 111(' ' o il e ano
Per far e al mondo un bel ra,aUo alato.
ntonio Riccio ben dc la ud dcano
'
186 "i. 28. V\ . 9-11.
lt8
E Cian Bolclt\ C'hr ropa ha parrggiato:
Coradi110 i11 rrl'la r l primo t<gnolll
7
.
L' knco, cb con l"ccrezio11c cli Pier della Fran e Ta ( Boraho") comprende
olo artisti di area padana. i apre C'On i pit lori ( _,iacomo Forti . Marco Zoppo. Pir-
ro. Giovanni entile Bellini e il pa<lr Ja op ). continua con la fi!Tura ibrida di
France. co d I 'o a i chiude con rrli ultori (.\ntonio Br ano. Ciornnni Boldt1.
Ludo,1ro CorradiI1i). Pt>r tutti ali arti ti n minati i ottolin a la fama ai ac yui ita
oromu11quc prom -_a per il futuro. ma Piero della Frane ca' detto dirino". il
Co a domina. da olo. tre vcr i ( w. 9-11 ): ntrambi ono arcompaanati dall"aff t-
tuo:o r..,. i\O mio. ma I . tat uto di mi ali r art f in cr ta ' ricon ciuto al
Corradini. modene.e attivo a F rrara. f re autor di un busto in r ta dj \'erde:.
188
la donna cantata dal Cillrni . cornr crnbra alte tare tm altro onetto:
R n11rat ia I factor tuo. rrrta formata.
In modo tal rhr degnr laudr rt>ndi.
E toa ,irt u. clw tut to el mondo intrndi.
Quanto dr ni111 ragionr rr pregiata
I : imago a ui tu . ri <'n'ata
Pit1 ..,imil. rhc , 1r sa ..,tendi.
E d. artr anticha e magi . ti cr . plrndi .
Ch. altro non mane ha a te eh e animata.
Qual Phidia. o Polycrrto. o man pit1 doeta
In marmori <' mrtal arte
qual fa co:,,tui r ulli trrra corta(
\ohilr in11e11110. pien c1og11i alta pane:
, 'e b Ila ll011 r pn (O rotta.
Fa. Coradin. dw ia r ullnta i11
La , rop rta memoria petrarche:ca che arri in que ti ,rr i - probabilm 111<' da
ricondurn . come i pr I nti . a(rli anni id I .ili 11io - r da du
fatti .muHiativi di rili v . l' upo tr fr diretta a1 ritratto (vY. 1-8) all (n. 1-: -
1-): dur fenomeni tranei alJ'arch tipo e in ntra t e n il -uo r ai 'tro in1ro pctt
1
-
187 Cito clnll"rcli1ionl' Frati ( 191 ;{ [Rime dt'I rndin isoldiano ]. Il , p. 3 I ) dellerimt dlI Culire (Bolog;
11
j
Bihliotr('11 llniwriluriu. 111s. 17;1CJ ). i>rr rni dr. lo iT1c:rn11 '.WOu. 111 Cillrnio nel q11ndro della hnrn to; una ( t'
Q
' 1 I' 1 (' 199) Perh111t'l"l"O
umtrorenlo rinvi o 11 l:il111t11 I t\ per In 81111 cu1Th.po11denza co11 h ll'l' e 1ruu10. n , iRR.U '
chI Co. sa ('tl\'lm110 <'Ome pittore 1 rfr. 1T11.r. 200 .. pp. 408-iOCJ.
188 19<>:3.1 . 101.
189 R111 dr/ rodirr isoldiano, Il. p. 50.
H
rn. cgni di un'estr ,. r:ionc mondana , 'iali zzant che abl iamo cri incontrai in
Galli n i pi gionmi i\quilan T baldeo. La d i a priorita <lei dato celel rati,o
drtermina re clu i ne dal te. to dcl rapport del I eta-amant con il :i imula ro. r
lega la . te a all uzi 11 al ritrailo, eh 11 I Cinqu nto ar 1ua i :C' mpre cl di-
nata in cn o amoro . alla m ravicrlia d ll'opcra <l 'arte. Lo s h ma trian,rolare eh
compr nd il I o ta, la donna amata (t' ritratta) rarti ta 'irne riprodotto anche dal
en B rnardo lii ino (Quando aperse .li alleo suo laraa cena) la i col Aucr li
(Quando il mio Liberal dipinse e/ riso Zeus i che ai pirz.re Elena e molte)
1
')(
1
: i nomi
delle g ntildoime antat (\'erdc. in wa e ran a) e deuli arti ti chr le ritra rro
(L dO\ico orra lini. Matt o di iovanni. Lib ral da \' r na) i o. litui cono. uu
po me canicam nt . a quelli di Laura e im n . i11 rac lt loYc !"evocazione drl
cbauaglio euri tico e linguhic dcl petrarchi rn > ( .arrai ) i combina c n celtr
in direzione d Ila forma- anzoni r . il parauonc tra la donna amata da Petrarca
e la pr pria talYolta plicit ( r tac ia qui el antor dr Laura ant icha:/ la mia
[ ... )/ d \'UT tal da non prepor D'iaua
1
Q
1
). L'id ntif azi n ( il uperamento) di
una mu a nelr altra i amplif a quando. in i m al ricordo di Laura 1 carn e o
riem ru qu ilo d I u ritratto. . I 1 -83 il napoletano France o Gal ota accom-
paun an France o di Paola n lla ua mi ion in Fran ia pre o Luicri XL e in
quell' o a ion rc nohz1 u Laura: rif r p i di avern Yi-lo tummauin . aJla
qual d dic un n lto riYolto alla ont a d'.\ rra:
Ecco qui Laura tal qual era viva.
le ch.iom cl'or. la forma drl bel 'i o.
do, rane o riguardando af1 o
tanfamii pian . e p r lui fatta dirn.
Ecco per cui crivcndo a la ua riva
piena di laude cl lauro al cirl ' mi o:
ceco l cJo,e amor 'i r conqui o
finch a lei pia que. et or ua f or a - prirn.
chi l"mpr cl 1 itol dr b lleza
ha retrnuto in fin a que t"ora
che appre 111a aU tue beli mano.
a te d rannc e rende a la tua alteza
la fama e 1 prc!cio e dir tur laude ancora
non ba ta inzerno o lii. n' vero umano
19
:!.
190 Cfr. C1RHIJ 1993, p. 132.
191 . 01.a11<>/Ja rredere h'ogni natura et aru. 1U ui rito i"'" 11. 12 e lt. i il condo onrtto tra i 1emidu
del Cillrruo lru,me;,si dal)') ol<liano (Rime del codirr isofdiano. Il . p. -+3. cfr. C1RRAJ 1993. p. 1 O I).
192 llaudalo a la errellenti.uima ronles.w d1 l'Arrrra rum la imaginr di Lauro. 11 te!>LO si lrggc in BnoNZI 1 1977.
li drilti('O in anafora (Ecco) <' prime il rapporto concreto tra un'immacrine
for e inviata<' e lei eh la ri cever. as umend un ruolo centrai nell'organizzazione
drl on tto r n l uo offrir i. letteralm nte. allo . cruarclo di una letni.c - pcllatrice.
1J ritratto di una donna cl I pa ato giunu a una dr tinataria d<>I pre em . il ct itol
de brll za pa a dall'una all'altra attraver. o il ae lo fi 'ico drl dono (vv. 11-12).
Om :.o il pittore. il ritratl diventa il m diator co11cr to di un en omio.
L'apostrofr all'arti ta o titui e un'apertura dialocri a all'intima meditazion
del oauc t to su un e prri r nza rir\'ocata ( qu Ila d I pittore tra ci lo tc1n). e in rti
ca i r trac('ia cli una destinazione rC'ale. fo sii rrtorico di un invi concr to
11
1;
1
. el
onetto che il bolocrnr. e \icol Malpicrli cl di a al piHor B ltramo> hr l'ha ritrat-
to (Bealo. o sacro e dico i11geu110 et arte
194
), il d I ito con Rtf L ' X\'ll-LXX\'III
inn 11abile rei c-ihito. ma 1 radi ce un 'a. imilazionr lincrui tica ancora pr caria e uno
littamento della dirnrnsiOIH' ollrcin ndana dall'opera alJ'arti ta: per i' 'CCZOnale
talento e pr r la nobilt di modi. Beltramo pare .T equi gi tra nui > (v. 5) dal ielo.
he lo ha cr ato con la massima ura (' " 1-t). La qualit prannaturale d Il u f-
gur . bell r . traordinariam nte orniglianti (e l tu rnaho natural di crno> [,. 9] )
una con rguenza permanente. truttural . del uo inu gn (v. 13), non. come in
Petrarca. l'acqni izionr pcrme a da un \'agcrio irripet:ibil . l'n'analocra cl ,iazione
dal per or di ' imonr \fartini i r alizza quand la compon nte paradi iaca del
ritrarr > \'iene attribuita all'ec ezic nalit I I modello. rileuuendo la ncezion -
cr azione dell'opera in chiave galante. Panfilo a o. ad -empi . piecra l'intuizione
di un \'Olto> celrstr con la lezione cli uno tra rdinario cvi O in carn o a (Y. 9).
riportando. p r co lirr. il cielo . ulla t rra:
pp. 3b8-:3b<J (' D\\111-.. 1!.1 1998. p. :loO. Cfr. ' II 1PP I. p. o:J r I 0'.i e F1.u11". I 9 I 0. P 98 e Fwn" PP T
e 29. Tra i po11i ' p1llrgrini ' ai luo!!hi laurani d u11rhc il :ornazano. dlC pa,,o \n!!none. nel .lib2. nrntra.ndo
in hulia ili ritorno dall'arnba,nria clw Fran('(,ro .'forza a,e,a mandato a Pan!!1 rer cele.brare I t11'\ento al trono
di Luigi \I (dr. Co1100'1 2()():3. p. 7-l ): un rifrrim 111 0 alla tomba di Laura nel E rl.temt!io in_rn'.
e/ terrrstrr 1111111/0 (C:oR"' \\O J<N?. L\' l). Con pi[1 -ofucata im enzione. Bcrar<lmo .Rota. o hngera
ri rcwrr dal roll r1ionb111 ,\lfon'o Cambi u11 doppio ritratto. di Laura r di I' trurl'll ((ambi.
111
pirrio/ leguo [Ro11 Rime rifiutate. C'\. 111 )) . rhiareutlo J'id1'111i1 d i so!!elli con lu sermom111/w ddlr hgurc
dipiutc: L' uno ni--,p111hra in allo humil l'hl' di ra:/ - Erro rol1i rhr le mie rimr i1111un1./ ft'ra. mm. _fotal. cl kt
nrmil'a -./ r ultra ri,ponda: - Tu la \ 1la. io r aura/ fui ptr lo m11r di 111a nobil forira -:/ 1in dunqut' I l'
. 1 1 I 1 ( " 11 11l ) 1110 trii (' b h hdll'zz.a
rnr i..aurn (n . 9- 1 i ). La Ul\ olu. prohab1 nwnu e 11mro r < 111111h10111 p11 rio ' .
(1. 2) - di Laum - 1 l'amor!' (, . -+ ) - di PPtrar('a; il puralltli,mo. -,chrma adeguato 111. ri1rauo <loppm.
11rll11 Pt'nnda quurtina (q11i11r i .. . indi ). ri , )l\'llin1111111tr \'Oli 1'0111otI t' lo >deg110 ddl 111111 e arn i I amore
d1ll' altro. Ll' 1t'1"l.i11t i111 r r1 0110 lu prn, izio11r tra Lu11ra r Ptrnn11. in quanto la pri111u riguarda 11 poNu. In ,tt:ond)
l'amata ( L' uno ... l'altra). in un dialogo he aUo 'oprttaton' '"111hru qua i di a-roltun ( nb entlira ... l'llt' dica :
il (lOfla 1irr-,e11111 Laura. o piuuo,to di Laura ( hl'co t'Olli ). rom parlando a o.,\nillon
I
. . . ( 'I' I I 1 ) La I . 1 11t1tn m1rtr 111111 'on pr111t 1-
mr111rr 11 ,.,.,pomle n1 olgt'1ulogh,1 d1n1 iamrntl' u a' e a. IO . uuru . . e lflh, "
palr, clw idr111ifil'a i ,oggl' tti del q11adro. m1ru't'N> il quale cont1111111110 a nWrt'.
19:3 Cfr. Cn "r1 2002, p. t .) I. . .
I
" Il 1 I I 1 t.. 'l l"lrtlw,1o nella . ,11lr : '1lt :
.,.. trolo. d11 prc r 11111 ri11u incatenate e nprc-u l 1 rn1111nll t 1 t IL ico pt ' . ; . OF\I ( \H\lf\ \
h11mil1: "1111ilr. si Il'""<' i11 /li111at ori bolo"ne i del Quallronnto. p. 20 (ma rfr. P 11 ): \I. Ell. .
PRO BE1':rn \\IO Pl(:TOl'IE ( C' . 18 1] . \l alpigli C' fr. P" rl'I 2002. pp. :3t -;3:l. l);J- 100. e ,u qm-to -om1to m
pmtil'olarr p. 98.
1 I
Colui chl' co:; ben ti pin ' in carte.
ma I ima. e fcrc alla loa forma quale.
nou hebh pt'r iug 1111 o naturale
che hrlla po1e,;:;e formane.
ch maaist rio humano. ina gno et ar1t
a ping r forma angelica 11011 \'aie.
e inru1ri a te fu mai forma irnmorcale
eh.abita .. ed 1 mon<lo alcuna prut :
ma rimpar nel tuo I aiadro ,; o
cl modo. la ragioM r la
d 'I figurar che u a in para<li o.
et indi l ' oli o wo opra nattu-a
fece ta11to dal vcr p co chi o
che non qual de <lui la pictura
1
%.
La donna' forma an
11
eli a. b llezza vnnnana. ma rarti. ta attinge al clau-
rar che u a in paradi o (cio alla creazi n I r pria cleWartefic divino he rlia
pla mata) a partir dalro nazione terr na d I modello (v. 9). non arazie a un
e:rcessus \i iYo ecc zionale. e p nata aH e trerne on euuenze. rimitazion di un
ori
11
inal perfetto tend per a oin idere con la riproduzione di w1 e:remplar unico.
un' Id a pu che w1 r re urnan
1
%:
Indarno. \pelle mio. ron tanta cura
erchi ritrar mia d a. C'h da eh. il mondo
Fin or e n novo inaegn aho e profond
tette a pen. ar per f aria la \ a cura.
l!i lei cltr imrnagin fia .. e la pittura
E terminata e non \'a rn ho al fondo.
quell a in cui mirando mi confondo
E una beh infinila oltra mi ura?
.\lira il bel 'olio lu ido enza ane.
Cli occhi. la borea. i crio. quella vaghrzza.
Ch imortalr r divinar ua paru.
\ la pur giurwer brami a qualchr altf'zza
In pingcr r ombra ua. ma chr ia in part
\.!>O 1996. 61. Faccio notare la ripre-.11 dPll1 olitr rime i11 -arti e in -i<.o ,. l"imiownza u e forma (v1 . 2. 4.
6 .. ).
196 Prr 111 11o?io1w di ld,a 1wll11 tt'Oria r rwlla p()('!>a del f.inqu"'' nto. rfr. infm. 4. 1.
152
, 'imrl a lei . dipingi la Brll1zza !
197
Di frontr alla contraddizio11e in anal)ile tra un ' arte limitata (tenni nata) Lm
oggeu sconfinato per bC'llezza r prrfczione (la donna-dea infinita oltra mi ura> ),
eh eonfo11dr la vi ta prima ancora del pennell o, il Cere:ara . uaaefrcr al piltore
di rappr<'. C'nlare n n una b llezza. ma la Bcll zza: an h co . il ritratto ar oJo
un ombra d lla donna. ma alme11 . ar omi"liante. Il lwwo lavoro ncettuale
r pia tiro clclla Satura-artrfice (n. 2--t). hc i r impeO'nata dafforiaine cl l mondo
fino al per produrre' le bcllC'zz di,,ine della dorma (\v. 9-11). rimanda a un
topos a ociato alla descriptio gi 11 Ila trattati ti a m dieYalr
198
Il paraO'one imer-
che a !->i mila il la' oro cieli" arti ta a qu 110 cl ila ' alla ba e di un onetto.
di .\iccol eia Correuuio:
Qwu1do el concepto rhe la nwnte in ana
f rrr di 'ui. madonna. a partr a parte
la lingua rxpre. la man po e in carte.
for i per 11on tanta opra vana.
forma ne nacqur -,,trana.
che 1 wpor da me ancor non diparte:
omrio - Pic1or. tu non ciai rart
a gionger collo equino a tesla urnru1a. -
\la el rnonstriioso parto in poco dc ora
nacque e p r. romo uol far natura
quando in qualche opra ... ua brn non lm ra;
p rch grazia e bellezza tal mi turn.
chr per <lorta man non -.i colora.
cl uo di-.. rgno poro temp dura t'l9.
n (' OllCC'pto, di a end nza petrar h a (R1f LX.\.\'IlL \'._ 1). n l pa saagio
dalla ment he lo f rma al a to eh l prim - dw1 1u all opera. alla parola
(lingua) al tratto (nHm)- i entra n i li miti d eh
11
? ra.una
rna rno 1 ruo a, p r la quale iJ p ta rimpr vera il pit tor . Dal I lr Poet1ca cl1 Orazw.
lr to acro d lrut pie tura paesi'. <l riva ri.mmaaine di un rnmp t ibn<lo ( , .. 8).
eh ' i fa pit1 oncr la a11atomica nel rif rim nto al rlrat1o com a un parto ano-
19? CfRt.i>\R\ 200-t. \ I\'.
198 Cfr. DL L Il 01 198CJ- t 990.
19l) C:OllRE CIO 1%9. 26.
malo. imperfcrto. eh in quant tal non pu sopra' i\'('re: ' C non affidato a una
dorta man. il tentat\'o dir nd r la delicata commi tione di grazi a r bcllrzza
pr due lUl di ecrn in \tabilment ffmer . l'n cont nnto consurt d Ila I oc ia : u
oper d"artc ' qui traci tto in una ituazionc funta tica curiosa m 111 ' hiolocrica',
h m ' lra una natura tut(altr he ip rura11ia. pi nam nt immer a nel pro , so
fi -ico e nella fatica d Jla crencrazion . L t cru to bizzarro evide11tc nel netto
ivo. a ua volla ledi at al fallimento cli un ritratt
Dir no alcun che il ca riatore ircan .
puoi che a la fera ti ar ha tolto i figli .
g na p chi tra ,;a. p r ch'rlla pi ali
di I i terror. ,; lo il uo a -pe 1 :.tra.no.
Per rontrnrio cl pict r con dotta mano
p n h a farti tal h te a omigli.
,isto il tuo h I embiante e ali umi] igli .
tuo ror Y r o lui ancor e fe uman;.
\la on tr lt a la fin da te mancJru1e
quel tuo b I imula ro. un rr PI affect
ba ciandol il ma chi'. non colpa d'art .
P rdona a lui. ch'el fu d'am r differto.
eh' tu ciai b n eh a leaae ' C1U>ta in car1
un libero \'Oler non ubiecto:! .
Il rif rim nto pr zi o. da b tlan da se11tentia. alla ficrr C'h i p cchia. ri-
corda e 1te eh era plinian d i Rithimi cli Vi c 11ti rirm rn in forma indiretta r a -
o iazion tra la donna w1 ficrurant omenzional della crud lt frnuninil ( frra
ti,!ff ). Il cacciator r a cli m ttere la tigre di front alla . ua . te a immaain rifle. sa
p r. pa''.entarla. di t crliendo la ua au nzione dai picc li rapiti
101
: il pitt re. al con-
lrano. ntra la donna omialiante n lla . peranza di rend rla pi pil'to a. La. petto
lrnno che la I igre i trova davanti i contrappon co a quello hrllo era icurante
che la do1ma dovrebbe ri ono cer . Il piano ' incr 0-11 o ma falJi . a cau ad Ife e -
e involaimrnto dell'arti'ta. che i1nbratta il quadro con un I a io (, . 10-11 ). I a
a .. craJantc aJlu iva. cli Rv/L IV l+ (colpa d'Amor. non gi drfrcto d'art )
r pia d1 uno p tan1ento ignifi ati\'O. he coJloca !'arti ta al po. to d l p eta-amant .
d
200 h i. '27. .'".no'.' ,j pu di un 1rro" proprio dittico. <'l'rtamentr la doppia prro1 nz11 drl pittore e d1ll11
Olla mano. 11 nf!'n111rmo a un 01J1ra rn I" , I'- d
. . . . a 11us(' 1 a e >.frano <Teano unr rrl<' d1 corri,po111(('11zc tra 1 111
tc,u. r111rarnl)l rnol11 alla donm1.
:_'i
rnrit> "'.'r>io11i d;lranPddo10. ad "' i11 Claudiano (De raptu Proserpi110P. lii. n . '!.63-'!.o8),
0
zmmi la11::R per la f(IOslm. I. .39) e Lorenzo de \ledici (.'elcr. IL 131 ).
15-t
1; io liri co. qui romc nel te. lo prec'('(lent , occupa una po. izion terna. qua i da nar-
rai re. ri pr tto al ritrauo e all'amor cli rui rriw: proprio qur ta condizione di tac-
cata ronccde alla riflc . ionr sull'art la crntralit ('lic l"att gCTiamenlo intro prttivo.
concrnlrato ui . cntimcnti e sull< reazioni dcl ogg tto. di n rma mrtt in rcondo
piauo. i\nch p r qu ta raaione. com vedremo. nri t ti il rilievo d Ila rappr . rota-
zione co111c problema lrori('O e pral ico t nde ad e ere im r arnente proporzioual alla
preminenza. identitaria o ..,r ntimrntalc. eh il p r onacrcrio ritratto ha p r l'io.
La clihponibili1 dC'I ritratto a far i luoCTO di una pit1 ampia rifl ion ull'im-
11uwi11r e s11ll'imitazio11r <' lcaata 11011 lo all'efficacia con cui ond n a I trn ioni
o
del parauone. ma anche alla po. izione he pu occupar in una pr p ttiva di tip
plato11iro: tretto tra la condanna fih Gca del!' idolo il ricon cimento della
vi ta COlllf' fondamento (lcl pro es O COllO 'CtYO. ella '011 ezion ri iniana della
cono e< nza. la cont emplazi one dclrimmacrin int rior co titt lo taclio inte1m -
dio tra la vi ione nhibil< e la compren ion intellettuale: l'imago' una o tituzion
ontolocricamente inadeguata. ma anche un primo 'up ram nto d I liv Ilo n, ibil .
Qur. to aiuta a piegare il caratter indir tt in i m int n deali chi martiniani
in poeti come dc' :on ti e monio Cornazano. ntrambi. p r ragioni diver e.
sen ibili alla dimen. io11c anO'elica d lla beli zza amata. e dunque al r pertorio t ma-
lico e l .., , icale dr Ilo ' tilnornw
2
. \ I canzonier di Ciu to. non p trar h p r la
toria be narra ma precocem<:'nte f del alla lincrua e aali tilem_i dei R1f pi ca un
componimento quella man. che ui tanti annPO:l) he. per l'imp tazion
i11terrocrati a r I rr il rif rimento alrimmagin int riore ( t virn Amor n I e r m la
dipin i ge :ti . alle mani ere. al vi o. ai panni? [\'\'. -8]).' tra i icuri prece Inti
tiri -on tto bemhiano O i111(wi11e mia celeste e pura. epi elio centrale d lla po ia
sul ritralto nel ' inqueceuto. 1 ella Bella mano. d ,e la di,inizzazion di I ab tta
' ompi111a attra\ r o un di . inv lto rie r a aratt ri ti i n tti n opl_aton_i
la lezion d I dittico pel rarch co ' rfr lata dalla n ibilit per al un 1mpl1caz10-
ni d l 1 edere e cl I ritrarre in g n r ign rate dalla rimcria corticriana. l_n una
trama di rif rimenti in e rntinuit. ricord ahn Il il n tto xxm (Jl1ratc omat.
perdio, l'aspetto sagro), co truito ull' anafora hc I rta !"imito al!a ,.i i. n (n-. 3.
;-, 9 12) ' O'flalo dal 110111 d Il arti ta antic ( lirat in terra l alto 1mulaoT0./
o nd tant"art Policleto fwa ,. [' . - ]). il , n tt ,.\\'HL h i incentra uJ
pr bi ma d ila rappr ntazion impo ibik pi eh ulla lod d Ha do1ma amata:
Quando talor ('Onclotl dal di io
Con gli alti p n. icr mi i trnsc rro in I arte,
I
(' r ->oo> p >->->
Pcr la prc>rnza di Dnn1t 1 d1i p<>l'li rklln .'1ilno10 in Ciu LO e 1 .01111nn
11
0
11
\.'T\i - - ---
>o; e r
1
,. 1 1 ''""1ioru di 1c.1n 11J1H. mu
- ) 'mmoF' Co:'\11191(>, \L\l. .' ulruolodiCittSIO ()IHllllll'llllll'iOllO ( ("l " '
rfr. andw 1\.,. m1 1998 1 2002. pp. I <l6-22:i .
P, :00.11 1 2002, p. 2 li. e dr. In 110111 11 :1.
Per i colpir. se mai pote . in cart
Quegli occhi che fan foco n 1 cor mi o.
Ri1ro,o altra opra. che mort ale: ond' io.
Fra tant e mara\'igli i"i cntro
Perdo rardire et la rnaione et l'ai1e.
d1e mc te s et ralta impresa obli o .
.\la poich rocchio ciel pensier i sbacrli a.
Et le' irtudi afflirt e. in imperfette.
offrir non p Il ralteza drlfobietto.
La \'oglia che o l'i11tell et1 0
1n mezo al cor. com ella pu m intagli a
Co e li
11
'iaclre assai . 111a n 11 perfet1.e
2
b>.
a ritrarre e n par l (ci e lpir [ ... ] in carte>:!Oo) crli occhi amati .
eh m R1f L X\ ( '"' 1.2-1-t) erano font d l canlo. i cfrela up riorr ali forz<' del
P ta-amant .J int rior . p r quam imperfetla. i forma comun-
qu.e. ma.!1on grB.Zl all art . pirazion muoYe infatti dal de id<' rio (, . 1. 12). eh
pmcre l .. no ad el var i ( condott [ .. . ]/ con ali alti pen irr>: so pi11. ) per
affr?nt
31
un impr a n n p rme a ad alcun e r mnru10
20
- . perch ' crli nunenti
dell.ar1 (' . 1 t fa olt ,; ive int me (w. 9-10) i ui. nihili
dal! altezza d li Per ?n ia.rd . la ment di . qual a tanta mpre-
a. _non cri conun iato til >
108
. La poe ia ta . il d idcri o n . ma
la e ntmmta tra J colpu (v. 3) e intacrlia (v. 1 ) uageri <'<'che I ro e li criadr >
del , .. 1-t f otr hbero di 1 I d Il
1
. lll lanto 1 lillu a ro e a donna 111 mezo aJ con quant o
e pai ole m1perfene he il po la con epi c per rappre. ntarla. e m firnmacri11
205 G1l rom: Com 1916 C\ rm mal BI
Cfr a
11
chr i oncni \[ (Q t . . .
0
tn nme panr: can : -pane: anr 1 in E obietto : i11t rll 1 t1 0>.
h. J li
1
uan puo il cwl. natura. mwgno, e/ arte). l' hc ha rimr in \ anr cart p'1r1r ' l>a rt r
.,, e 111c 11 a paro a omalto> (cfr R1f \\Xl\ \ 8 B ' . . .
l
>rc-cntaziom ( lltuiian . . e E.\JBO 1966 [RB]. \[\. ' 8) ed 1, pl il'i ta il trmn drll a rap-
. JX'll'>I C' ro a pren non puo nt rarlaJ Et '[ I I I J
non va tanto alto ( \'\ 9-11 )) XJ I r I . I I Jlll fiU 110 ll'O 13 (' paro c./ b rl 1111ag11111r
ln nu' zo il cuor con,. " . . r t "1ap2rr su la d.011 na da \mcm (L'alta hdt. di(' mr di pin1 \rnorr/
1
JlWl,((l lll "ti e. (n - ]) XL\ Il dJP 1 ., t 11 Il I 1 I Il ''
dal l'UOl'I': c.\1ad 11113 d 1' . . 1 b 1' . ' , ( Jll C(' ll ra >Il llll'!UI C{' Il )I Il a ( (' lll1lllll h'llU' (lJll UIU
l'Or rthato ardore} \.al' n'.110 p<llo 1' (' O\ a IUO nomi. !!i.il dipin.,r i\morrJ Fia ' )>t' OI O. quando al
i"1 oo 11 munr 1rra11 arnrne 12nte I ' I , 1 /
in mrzo 1 (' rr./ .\ . e . ' . I . . . () pnu \ 1\!I \'1\ a lii 1111 I ia111a11t r l o( rho d 01,,'l ll tr mpo
. . na Ort11na aHa mai 111 Htlorc./ Clu now r 1 giorno non mi , ii cimanti' (\ v. 1-8).
206 \(') can/.OOJerr di Ciu 10 la . . ,
) . . \ r,101u < om1111e nt.rar 111 rart 1 r pre !'1t1 r in \\I. \'. 6 r CXI\ , \. 1-+.
-O Ur. 1111 <metto d1 01.,a1t o Ciu>li11ia11 sul e I t . Q
t<nto ritrar \la
1
J
011118 1
n ian I I . . I
e nenrno: uando ta111 olt rr <'OI dr .. io mi ., pinuo/ rh io pur
'" c r pnma 10 1)('1Nrr d1 1>an / f' J I
impr<''a poi 11n1o marciri o/ nia .
1
.. d
1
.. r m purtf' \ O 1 ur1111< o e ne 111 10 cor d1p111g1>./ ,\ I alt a
,.. non giurwf' a 1 1a 111 aern I / . I b Il /
I
JOro a dentro il uo (C": "
10
e art< ldlll l' 111 r1 '>011 r 1zz r "rnz11 ., parli. r
ran meno att111rro ,1L'Sl l\f\\ 1998. lii. \T. 1-8). "
:!08 Bot\RDO 2002. 1. 2. "' :i-1-+ c\la la mia 1111 I I . , d. 1 .
il cornindato .,til
11011
abaricli ;'
1 1
, .
1
.
11
r e
11 1
vog ia
1
wcro11./ m1 fa .,111tfr 1wl cor cl oll'r no/ che
1110. )(' Il(' H '>l a e '"l'fJUal (' Il la t a I e . . . . . I I
ror , .. :wira un timidl'to "iil<i/ eh
1
.
1
. I
11
cmpr a. o. 1 om111c10. ma rwl co111111 c1ar a
. " arn<mho arr 1r <a 11w di rt /('I f' I 11 J ' I
111z<' 11110 wrndi-r dal l'iclo/ eh I I . . .
1
. pa
1
' 11 w ,. 1r ta w ta vr11"a a ntr1u1?/ n qua
" ' 'a11 rma1 rgrn1mrr1t1 111 rartr ?.Cfr. R1f C:CL\J.
<' il canto sorO' scr nono lanlc ri11acl guatezza pr a ncllC' quartine. 'n analo-
cro afllat o. piu eh pr trarcli c co. embra il pia e11tino Comazano
Fi \ iluppa il . ccon lo nucl di R1f X Vll . rauo creatiYo di ' imon e mc
acradi111ent o ccrzi o11 ale e nccessariamrnt sl "al.o dalla terra: Dubitando t.alor che
1
1
jcrro til ,. non ia adeguato a parlare d Ha donna. il I oeta frena la man_ medita
r i h111alza al ci<' lo. lasciando la loclr incompiuta:
Per. sr opra imperf Pctu mai rimane.
in qur.,ta. quando 1 ruor da mr i partr.
('olpaia !>ia \O:.tra l'-:cdl r11zi a tauta.
\l a e lr man. chr ,i .,on partrhriane.
:.rauino. s ran e :-.aera ( l' art e
I:' . fi ->()<I
t'Xerc1tata per rrura .
Comr in :\i eco lo da ' rreg()' io. la c ncezion delfop<'ra di tinta dalla ua e r-
ruziour: I<' mani 110 11 rie 'Cono a ecruir il cuor . ma m rilan comtmqu rappella-
t\'O di e acr p<' rch' i impegnano in un art he ' antifi ata dal proprio oacretto.
L' impli cito paragon tra il ritratt d li' amata e I inunacruli acr d t rmina tma
concl wionr non lontruia da qurlla dr! Tr bald o pi idolatri 0
210
. 1l \Tu b l: I lla
d 1111CI r ci(> che. rnnamente. !' amant t nt a di di O'J1ar . in \'Cr-i: ch'a tutto l mi
I
H1olrr 1' 0111brccrofo ' ncarno. leO'ae nel ' On tto XXlfl (Y. 8). eh fin dalrinc1pit
t>r e . . . . d > t1 ) Il
cl1ianw in rarn:ia Petrarca ( , <' quel cln pian, anrn tr ntuno 111 arnor . nome
delramata.
attira una nehul o .. a di t , r tiln , -j ti he .. in due ea-.i in.e .n-
ront anza con le pre enzr miti cament e anti he che aprivan e ehm lernno il d1t11eo
P licleto e Pigmali one ( \ ' Policl eto o man d'omo ba
rra fra noi farn qui fede./ chf Lui dal ci<'l uno aua l \ivo di de./ h I m ndo .li
hrnc mpie e 111 di male [ivi , rv. w. + ]: c]n terr 11 paradTho lUl a et lJl
colpito a\' ori un idol ,ri vo/ vidi ulr erta [ ... ]/ [ .. . ] et alor di., i . t oag1 l c1wo:/ -
Qucto . Pi (fmaleon. tuo : imulacro! [,, \'L n . 1-3 -8] ). . ,
11 modulo intallico che prrannuncia il tema d 1 ritrt1Te come peraz10ne e
di norma <fll llo temporal r. he pr Yi enr da RcfL xrm. e pr ci am ntr da quella
prin1a quarti11a aristot elica in nii Crlli rintraccia il procrsso d Ila
11
ueraziortc delle
f orm<' nal11 ral i applicato a Il <' forme arti licia.li . La on giunzione e quando> colloca
W9 Cott\ v 1\0 1 CJC)?. \ \ . " CJ- 1-+. 111111 , ilfogr del Corna7ano (In la11dib11.
11
moribt
lilwr), rlw trndt all a forma-r1t 11/.011i t' rt' 1d (o di' j, a in d11r parti dalla pnrt enzu dell 11111ma. l' r. ,mlBO'\I
r2003 t P1..,11\1 2002. pp. :1 12. :l;i?. 3:iCJ-:lb l. :PO. :r:'b-3-:"9.
210 Cfr. 1rn11.nrn 1989- 1992, 111 / 1, Ho. ,., .. 12- 1-+. prr rui dr. supm. f; 2.b.
211 'ott\1/1\0 1997. \\lii . ' I. -
' ' I I ( 1-t"b l-+b6) - 11 rni rfr I'\\ r\\1 :?.002. PP 3 -+-
1 Il Lu pi acr nt in11 Angela , roll i. di 1111 11111orc e rce111111 t' ;,
:1?5. 110111 :1:1 t p. 37b.
15
-
cr azion. n l pas alo e in una propo ai margini di Lilla prin-
c1pal dom111ata dal 1 mp pre nt da altn topOL (il lam nto per l"inadrcruat zza
lrll'op ra o l'cloaio dci uoi meriti. il ileuzio dcll"immagine ecc.). Lari<
d lrtmpul o fi
11
uraliYO ed Ile uc on r!!u nze impt>rfcttr occupa l'int ro sonrtto di
Gi11 to ( la 'icinan.za a r I i forte laddove i e pli<"ita il pr _
blrma dell m uffcrenza percettiva. dell oc ' h10 umano chr non pu o t nrre la vi-
ion del lll d 110: lo marrim nt eh conduce il poeta all'inazione non d riva dalla
e n aprvolezza dci propri limiti. ma dalla natura drlla donna. e prrienza en ibilr
ottunde e annulla le apacit meni ali e creatiw ( perdo rardirc et la raaion et
l arte/ ., t o r.ralta obli [\'Y .. -8)). Circa w1 ecolo clopo. in
1m on tto d1 ta Aanppa (Quando a ritrare in carte l'alte et tani<' ). lo
plendor d gli occlu brucia non lo la 'i ta. ma anch le ali drlrintrUetto. e dun-
que r nel in en'ibili ali trnmenti del poeta (lo , til. l'arte r le paro! ):
Ondal ,. der non pur. ma l'intelletto
arse dal troppo lumr amb due raie.
mancan lo til. e f arte le parole:
ma ba ta ben che dal lor proprio effetlo
rirrate ian. dapoi eh.oc hio mortale
non che mirar pos a in m zo al -oJc
2
rn.
L d ti d Ila donna clo\Tann r ritrau in modo indir tto e rifle so. dal loro
eff tto. per h, r O chio morta] non pu o ten r la \i ' la del ole:.:!H. In un
on tt? di Capilup.i il proce o qua i i tantanc deiri pirazione i dilata
m -lancio llllm tl o nece ariament Yru10. h nduc il folle ardir a in ' t'-
!!UJre il modello e lo ii porta. confitto (eh oc hi noi ecru ). al uor :
Quante volte ho prc o in mano
lo per farvi mani[ e to in part
il aran de ir. e 'ho cli ritrar in carte
i \o tri onor. tante rho prr o in vano:
ch ,edendo ogn'or pili lontano
de_ i \ ' O onor il a 110. e 11ir i11 parte
eh occhio noi . eaue. il folle ardir c11 parte
e torna al cor. r dicr i\i pian piano:
a tanta impr a Lu ei gr "r urnile:
quc ta ove ru.piri da ritrar con alto
e lieve tilc e con pi alda tampa. >
21:j HimP J:);j2, p. i?. H. 9- 14.
21-+ ."ul motil'IJ del ri1ram per gli 1ffef1i dr. infra .. i .2.
Tutto allor di v<'rgogna il avampa.
il cuor . agghia<'C"ia e fa freddo
. . J I 1 :i i:;
la 11ian nu lr<'nHI r m1 rac o li (' .
;\el quadro cli u11 "im1 rr a inutilm nte it rata (" uallte volte). I terzine tradu-
cono il ronllitto interiore tra il cJr:idrrio di cantar Madonna la con apevolrzza
della pr pria incapacit nella fonna cli un di al go tra il follr ardir (laspirazione
a ritrarla) il cuore. J1 rapporto nrr to tra la mano e lo til . h apr e chiude il
onelto. ri11 ia <"On forza a RLf L \'IJI. '" 2 e m tt in primo piano il ue to fi ico
li
1 d I t 'tt
21
1>
de a 1 g to p a-p1 or .
Il Iraamc tra la crntralit t mari a delrimma
11
ine il rr up ro dello tiln vo
r ancora pili , id 11tC' nrl carm nierr di Lorenzo de un o errntorio i<leal
prr la no tra indagine. in quanlo osi ita del o? tto. -ul
ritrauo drlf arnata (, LL ) e al contrmpo c1 offr ah e ili pm acuti di una nlle 10n
.,,ull' eidolon chr tra e ndr i confini d I ii tratto p r abbracciar . in hiav neoplato-
nica. l'intC'ra csperieuza umana. la po il ilit r l"impo ibilit della cono cenza (LX.
LX ':,\lJ-LXXXIII, L1 XXY-L , . ' \'I). \ I on tt XLlX. fatt a pi' d'ima ta,o-
letta cl ve ra ritratta una d nna. il p eta rn tte in e na. nel pr ente del te to. la
ituazione lirica propo ta in R1fL ' Vili. ri olaendo i direttam nte al ritratto:
Tu di ria. cu11 mio pensiero e cura,
cara imagine mia. ripo o e p rto:
ro11 h co piango e tero mi l'onforto.
a<h-ien che abbi o wr paura:
1 a lor. come f ,.i, a e pura.
teco mj cl lao d' ouni i1111anno e torto.
r farnmi il rnn pen ier I oco a e rto,
l'he altro non chieder<'i . r l"error dura.
\la poi 11110,i so. pir' dal cor ri rg .
fan gli or hi un la
bi rinnuO\an tut11e1111c1 martm.
quando la mi. ('ra alma al fin s accorge
che i11darno i pri('ghi 1 le par le pargo:
011d"io pur t rno a primi mi1i di
/lime IS52. p. :3!>9. . C f
. B , fr Jlif L\ \\' Il e prr le run(' t' r
216 .'11lla G"urn d<l n w1littort 'n1110 1nrn11rc. Ptr le rune
111
-am e. .
1
n r('\ .t' Pr
"' r OIYHllH'11tl' Il ll llll ('> ' '
llt.fL \'lii. ri1111 Jl Cli ugp:ctthi callo I' cli<'\!'> "
freddo :-multo rif<'fito al rifrntlo cfr. supra. not!I ->Q()$
I
. .
1
dom1t1) t rfr. 130110\1 -
217 1ro1c1 I C)C) I, X LIX ( cSonrt lo l'at 1u a pi d' 111111 tnvolcttu < ove ern nll
011
'
1
nlll
pp. 82-8-!.
L \'(irnacrinc conforto e rifuai ( ripo o e' porto) per l"arna11tc. { hr in ua pr _
t'nza ::.prime i propri alterni tati d'animo. paura e . peranza. attrawrso il pianto
la con olazion (' ' 3--t). :\ no tante la riprc.a del 1110,;m nto awcr atiYo di Hif
L '(\\'Ili (\. 9) man a un e plicito riferimento al ilrnzio drl ritralto: agli occhi dcl
p eta-filo fo il imulacro ' d !udente in . indipendcntemC'llt lai :uo in
quant , .j n ricono.ciuto c me illusion . rrore ontoloaico. copia di un originale
inat1 irnribilc
218
li !!Tup1 o onrinuo formato dai on tti L\XXll-LX_ ' XIJL L\XX\'-LX\\ \'I
indaga pr ci. amente il rapporto tra \'ana pittura e forma \era e si fonda ::.ul
dupli e tatuto al) loai d ll'immaain interi rr:!
19
: tra la cisio sensibili: la
ciio intellectualis i Ilo a la l'isio spiritualis. h coincide con la utcmplazione
dt'I imula r int ri r . uperi re al li\' ello sen ibil ma inf riore alla vera com-
pr n ion intell ttual . La m tafora mu i al illu tra il pr e o per cui il ricordo
d ll'id a Dtelleaibile della I llezza fa ri uonar iu noi !"immagine intrriorc cl Ila
rn moria:
e on dole annota du in munenti
n Ila mede ma ,oc alcun couc rda.
puhi.ndo l'una. rene! l'altra e rda
p r la conformit me<l mi ac enti.
.o;. par drntro al mi cor i ri nti
l'imauo irnpre a. a no tri o pir orda.
p r imilitudin mi ri orda
del viso. hr opra r umane menti.
Amor. in quanti m di il cor ripigli.
'h f u
111
rendo l' a pNto del bel \i o.
<l'una Yana pittura il or pa ndo,
Il !opos d J_,ilrnzio d1l ritrano '. ,oJto im'ece in un di Poliziano. clu potrrhhe rif1rirsi all11 tr"a
1mrnag111<> (!'.' puellae in delirii.J Laurrntio .lfedici est): \(' dubita. pieta c.,t q11a111 r1rni' 1 irgo:
!'d acrrs/ 111 _rc ocuhs fiamma. ria \rnor:'. I Ji,rr cxuJi, rnrem d1dit ars. li1111uarqut' nrgu1i1./ I lr11 fll'1r!
Nl nulla e t fuga: ,ulnu. l_1abe ( on duhttarr. la fanciulla clw Hdi i dipi111a: ma Amon ""a"lia 11 rribili
6am1111 da que li Ol.'rhi: a quc. 11 occhi I anr ha dato 101.'C. rn ntrr l'ba llf'"ltta alla li1wua. Fumri! \1a 11011 r" f1wa
po,,ib!l<: ci frr!IO [Epigramma/a Latina. LV. iJ1 Pow1A"\O 186 7. p. I i ( t rari. mia J}. Hi1 a Lor<' ll70. il 1r:io
r tlall clll' ripe1r il d itti<-o r sottolinra la prr,cnza fo,ira. comr il rif rimento alla vi'ta ( q11a111
): I a. -rnza d1 '<)('f' .,i combina ro11 il topos drllr fiamme clw \111on awenta dagli occhi parlanti' drlla fnn-
('lulla_ ntralla: \more dato 1oce r poteri allo .guardo. non allu lingua. l 11 ritrauo di L11rrrzia Donati co111p11n in
111
_lll lista dclii oprrc d1 Andrra del V11-rorrhio ( H:3G- H88) e0err11i1r prr i \I dici r ria loro 1w11 pagate ( \\"11.IER
. ZwPfJU 2006. P 29). li. la ti lata 11f'l li95 dal fratello di lui ' lbn1111arn (e Per uno quadro di le"namr. d!'ntro1 i la
h"l111rn della t<',1a di Ludrntia de' Donati). "
219 'u que to mna fr. l'i111roduzio111 e il co111 mr1110 di OniPto i11 \IE01c,1 1992. ad /ornm. I .11 rr11tr11 lit drlln pe-
trardu 1a forma vera 1"11 r' e 'no " li '' {' ' \"\11
. . , 1 ppooiztonr 11 1mrn11grnc 11tt11. s1 ant'rtr anclw 1111 .,0111111 J, \X 'I\' e L.\ ' .
mpitt
11
_anwnt(' ai '"" 9-11 ( L tanw tlf'nlro al tri IO 1or 011giornaJ chi l'ima"i1w fiuta al 111t10 tl'll""f'/ 1011 la
pn,<'nz1a 'ua la forn1a vera) e 9 ( Q1wito b111 1cr: rh!' '>r la forma ,era). "' ""
160
o rii<' non vrgglii110 altro i 11os1ri cigli.
o rhr il pii tor gi fus.,i in paradiso.
lri ,-idi propria. Or va cl' \mor fugg<'ndo
220
!
Il ricordo di ,' imone .\tartini qui vi\O r <'ntral . ricolto ato in un conte to
copertamente filo. ofico. in cui il pittor che for fu i in paradi. o in i<'m
l'a1frta e mor<'. L 'na radicale ambicruit tende a ovrapporr e confond re. nel
-,runo dell"immaO'ifle e mc rrore. r irnaao::t in cn.ibil ai . o piri(\. 6) e la \ana
piltura che nutr<' il rnore. con olandolo (v. 11). Il ritratto concreto potreube e. re
. rmplicr figura drll'imrnaain intrrior (01Yieto):!
21
ma il te to di tirnm lt- due
rffgi in almeno du<' luocrhi: al v. 9. n I 1;fcrimento plural ai modi in cui Amor
riconquista il cuor<' rhe credr cli sfuaairgli (in e i i po1r hhero ricono cere. appun-
to. il , inwlacro ud cuorr e la tavola dipinta. tanto bella quanto inaann \'OI ). e ai
\, 12-13. do\'C I due ipot i per spi aare rimpo. ibilit di. ottrar i ad .\mor (\'.
H) s mbrano riguardar<' ri pettivamcnt I' imaaoi. (prod lla dalla ntinuit della
,isione interiore che i traduc n lla co tant allu inazion cl i i ali) e la \'ana
pittura (opera di un arti ta eh . com irn ne. , lato in iel ). La f nom nologia
che a. ocia il ot re di amore alla ' OCIO'Czion all"immagin i pr trae nel onetto
LX: ' XIII r nei t eau nti. dover effigi \era n n ' qu Ila mat rial . ma quella
vera in , rn o platonico. l'Idea. Ri petto a rrue to orizzonte inattinaibile. il po ta-
amant ondi\id con Endimion . \'ar i o Pigmalione la tohezza dell'amare un
pitto vi o. una ana -,imiglianza:
Alm('n dar mi potevan qualch a11a
li orchi do fuggo r lr leggiadr hiom
qut"lo uon pu la vana :.imi<rlianza.
mor, la tua poi nzia infinita
(foUe chi il nrga . ). eh' ho veduto or com
... . . ))")
amar puo 11 tristo e r sanza :opcranza--.
Le bdlrzz rn ibili ( hi chiom ) pote\ ano alm no calmar il <l
r n parole o n un ri o ( ,.. ), ma proprio la lor l r ' C11za fi i a il p ta ha fuao-ito
dipropo ito(v.10). omeinL ' H(v. 10),illud ndo idipotcninc_cr
qu la \'Olontaria privazion . D ntatiYo fallimentare. in un aso e n Il altro. perche
1
imulacr.i tornano, invincibili, a stillare pa ione in un uor che pur ::.i conocr :.en-
1 199 l, \'lii .
')'>1 ,, Il I 1 1 .. JJ) ilt (ritrallo for,,t' rm-
-- "' a !'toncla On i l'Io (M1::01c1 199:2. ad /oc.) I ggr 111111 com >111twonr 1 1 11 < 1
pn qut'llo cli Lu rtzi11 ) 1 ali gorko (imrnagi1w dipinta du \more n!'l 111ore).
\li DICI 1991, L \\\lii.
11
<)_H. L primr clur quartini' riportatuupra. 1.1.
161
za p ranza. mentre il 011110. il riflc ' O la ' Cttltura, evocati attnwer o il rifcritlle11to
ai tre persona1111i mitici. affer111a110 rin Yitabil non-writ di ocrni imrnaofo .
I te ti quatu cent chi che affrontano il probl ma del ritrarre > com pratica
cono itiYa e arti tira embrano 1 mar ai temi di RtfL\X\' ll 1 er vie otterranee.
attra,er o ralterazionc d ila fiaura poetica eh in Petrarca ra rappr . entata da
imone \lartini. I p ti i ri' olaono direttament a pittori cultori. piegando la
privata meditazion , ulrop ra in apo. tr fe all'arti, ta. o. alroppo to, riportano il
ritrarre> ntro i confini d lla liri a. iu to cl .onti Cornazan > a u
di il pro e o r atiYo eh muoY daJri pirazion e aiungc ali" sccuzion . de-
::.criYend la rittura in t rmini fcruratiYi. La compar a d lrarti ta com lertiwn
logico-aruomentatiY rllll \'l }a \Tappo izion , tiln tra po ta C pittore.
con la auida di Am r -dettat re: 1 tavol tte u cui Oant di ccrnava (range-
li> tornan in mano al p ta. ma ulla loro ' uperfici lo tiJ > ormai dipinge olo
per m tafora. qu ta t nd nza i ontrappone il canz ni r di Lorenzo doYe la
rillc ione filo ofi a ulrinuna!!ine chiama in au a unoi ra d' arte di. tinta dalla
p ia. w1 1rnetto terno a contrapporre al imula ro int riore e alla forma
vera>. La ril ttura d l ditti p trarch co eh ar propo ta. negli anni Quaranta
d I inqu ento, da iovanni Della a a. raff rza il ru lo d I poeta proprio attra-
,er o r nfa i po ta u un ritratto dipinto
223
: non i pu e lud r eh la ua e lta.
o tanzialrn nte i olata. pa i da un p tra.rea r rternente laurenziano'. anche s nel
Jfaunifico l"interrogativo h muoY dal ritratto inv . t tutta la realt. 11 l \1onsi-
anor il ol domini delr arte.
L t ndenze h ho illu trato - e I bratiYa (.' 2.1--.2). amoro a (." 2.3-2.?).
filo o.fica ( 2.8) - trac iano un q11adro m ariament mplificato della p -
ia quat1.rocente ca u ritratto, ma offr no una mappa I iutto to affidabile per 11011
marrir i nella rigoulio a fioritura h il u nrr ono e nel olo ucce i o. '\rlla
conda m t d l \' olo la c lei razion poetica d l ritratto [ ... ] orarnai un
g nere tabilito ma il ri rdo di 'imon h e nt mpla rimmauine di
Laura in Paradi o rimane ben pre nte:.
221
: ro rvazion di P mmier pre uppone
l"id ntificazione d Il rime p r ritratto com ot tog nerr propriament encomia ti-
co (" elebrazion p tica ). rmai aff rmato n Il rti quattro ent eh . e i ola il
cric rdo> d l viauuio elr te di 'imon om dato in ntrot nd nza. n n a imila-
bil in un quadro purament el brativo. li fin encomia tiro e 1 oc a i ne d ttano
223 Per i t ti di Della Ca a. dr. infra. :3.2.
PO\f\llf.R 2003. p. -49. 110\e i leg"<' un te 10 di Filippo 11voloni, rivolto al \l11nt r<ma, nC'I qual anerte
I rr d11l'rspcri'.11.za di Martini ( cO pecchio. o lumr dri 1wrfet1i ingegni/ di ognun ch' orno
rhr fu o rhc m111 fia./ alito 111 ciel ne I alta if'rarrhia/ veder quei angelic111i ed gni/ prr dimostrur clii' qud hc
natura./ 11011 ol natura. ma reterno Idio/ ha fouo in ci lo(' IU figuri ili terra/ ("()li tuoi lori ( ... ) ( \Y. 5- 12).
Cfr .. IG,ORf'I 1980.
162
r oraanizzazion del oneuo e la crlta dei topoi. e r app Ho atrarti ta al ritratto o
alla clomia modifica n ibilm nt la lezione del dittico: i uoi irnifi ati embrano
in ec u toditi da ri crit1ure pi ottili e indirette, h ne condividon il caratter
mc litativo.
l di qua dell Prose della colgar lingua. proprio l'impo ibilit di ad rire om-
pl tament alla lin
11
ua di P trarca ti ne i po ti del Quattro ento del primo Cinqu -
c nto lontani dall'impa ibil formularit di tanta rim ria u e iva. Qu Ha linwa
un obiettivo eh non po no ma nean h intendono raa11iuna r
22
\ imp anati in
una diver a c. peri 11za poetica, imprendibil e itale: la loro crittura mutevole. ra
rozza ra uhlime. ' una r ta olutam nt profana a ali o hi di un qual ia i p -
trarchi ta ortod o>
226
un monstrum ini. lto ing gn o com il ritratto de critto
da iccol da orr agio. An h p r que to e l ito hi der i e la confitta dei
bald i ia tata da ro un vantauaio p r la no tra p ia.
225 c" Pri11 ipi-po e ( .. . ] immediatamente _guardano ai R1f( ... ] come ad un i'.n-
prrs 'indibilc di poe ia d"amor ; ma il dilet1antism che li arattenzza non me.I ro he d1rno
tra du e tremi lu fruizione 111 diata dalla me idata lirica di corte. ed c:;cr 1z1 luctramente mnratin. nelabo-
ruzio11i plirilt', di bituazio11i dei R1f immediatam mc ricono ribili: il tulio oli m1_a base impron i,alll.
ri ca di I menti tornii , b mpr accimto a prow ( ... ]in ncm'ri dr! tutto alla lt'z101H' ( ... ]
(P. NT I 2002, p. Q7).
226 Co i er.prinH' O ioni ' Otti 11 propo ito dci rimawri rl.w c.nza
1111 ht' hrnza r>t'rH' mcnf!lli 11118 frstu 11s,ol11w111ente profana agli oclu d1 un quabia>1 pet10n:h1>ta onod o
(010\1 fflT119'f , pp. 17- 18).
16
CAl:'lTOLO TERZO
DALLA CORTE ALL' CCADEMIA
3.1 Mandatemi La vostra imagine, Li priego
A uno guru:d dall alto, il panorama della po ia ul ritratto nel Cinquecento i pre-
enta come llll territorio vasto e irregolare, attraver ato da una traccia definita, che
uni ce 1re dei maggiori poeti del ecolo: Pietrn Bembo, Giovanni Della Casa, Torquato
Taso. Tte esperienze mblematiche, in epoca di petrarchi o :normativo, di altret-
tante stagioni d Ila liri a e della scrittura sul ritratto: uno attaTdo aWindietro: verso
un amore vi suto all'alba del secolo, che concilia 1 e perienza della corte con una
fondazione lingui tica e letteraria proiettata nel futuro; il fatico o adempimento di
una commission impo ta, che dall'interno della poesia realizza una con-
ciliazione quasi irripetibile tra elogio dell'opera d;arte e riflessione ulla poesia; una
giovanile ri rittma da parte di un poeta che cono ce gli obblighi dell'omaggio corti-
giano e dedica al ritratto innumerevoli componimenti d'occa ione emachigali d amo-
re. Intorno, la lirica un eh cambia, egnato da alcuni grandi mutamenti:
l'assunzione della poe ia di Petrarca a nonna linuui ti.ca e a r p 1torio obbligato della
lirica illustre, il sue e od ila ricostruzion p eudobiografica del \ellutello (15 5) e
la tendenziale ecli si della forma-canzoniere a favore delle antologie. La diffusion
di uno strumento come il rimario, al quale i affiancheranno raccolte di piteti e con-
cetti, conferma il cmattere di una poe ia e temporanea e formulare, eh pi eh nei
singoli e i6 vale in quanto appmtiene a un i t ma di s ambi, a un intert , to
1
Le
nuove modalit di cornpo izion e fruizione dei testi pre appongono la condivi ione
avanzata di w1 odice e 1 esi tenza di un mercato ditoriale he le a seconda: i poeti
prefe1i cono affidme l proprie fa1ich a raccolte di Rime di divem eccellentissimi
1 A livello delle forme letterarie la poe ia lirica tende [ ... ] alla creazione di un inlertc:to. di tlO compie- o t ' tualc
colleuivo e al limi te anonimo movim ntato dall'incr anlc ripn)porsi de.I nesso ripetizione/variazione, nel quale
il microtesto trova la , ua ollocazon 'on la stes a natural zza con la quale poeta e pttbblico r onosCO.llo
la lon appartenenza alla mede ima couche sociale. ( ... ] , i.no alla perfetta nt grazion che i realizza quando 1ma
teoria d( ll 'imitatio fornisc al ceto dci poeti 1111 codic lettenirio onnicompr e nuo,i
ca.nuli di diffusione (!11 stampa)[ ... ] Quando i circitili sono apert i e i codici condivisi, il testo lirico tende d per;;e
stesso a vivere autonomamente, a r.icono.%erc nel co111csto socio-culturnlc il pi emwema le ( ... ANTAGA-
'J \ 1979, p. l 9) . 'ul petrarC"hi. mo come sistema sorialc ed editoriale cfr. almeno QrnNDA,\t 19?-+ t' 1991. ' IJ\"t:\ GXl'A
e QuoNl.>AM '1989, G11 , ATA 2000 A1.noN1co 2006.
165
autori a e llettivi man ol i di parole (Templi), e il i1JO"ol t ' tO vi e opraltutlo in
una e llcttfrit di atti po tici ( ru11aaata) che repli ano all'infinito toni e franuu nti
di un lihro:. ompo 10
2
. La fo11una ili iniziati\'C' com le rult I
11
ie pubblicat da i li-
to tra il 1- -- il i.-60' legata a tma pra ' poetica di 'P nibile alla circolazionr. alla
orri -p nd nza al riu o, al far v ri com parte di un 'educazione e di un co tu me.
In un nt to in ui ra!rioni ulturali e comm r iali i intr iano. la tampa po. ta
r rizzonte li1ico lai irnrito chiu d lla rt in direzi Il di un pubblic indiff ren-
ziato I ot nzialment infinito e ttra il po ta all inc mb nze particolari e immr-
diat di 1uclruniv r o ociale ai riti del uo ri'pec hirunento letterario.
Il r p rtorio petrarcb o. ricondotto all' rdin -aanciato. per norma e per
un nti. daff p ri nza contina ut . produr iti mono rdi - nei quali 1 v tte . 0110
n ariament fu ri media dunque non e mplari - e al contempo vien ap1 li-
ato a qualunqu cir o tanza reale o fittizia. L'affian ar i, poi il o tiluir i, cl li' ac-
cademia alla cort ome luoao di er m di con mno d Ila poe ia. determina
una piu n tta d rirn d Ila crittura lirica Ycr o il m ti r r artificio. una nuova
pr ,incializzazi n . he nelle ant loaie i manife ta a partir da li anni e anta:
1
.
I t ti. compo li talvolta in r lazion on gli araomenti d Il 1 zioni accademiche o
nella mi di caar o-ITT.amenti Lra a liti. approdano a tm e a p rato labor di
Yariazi n -1. eh trorn la ua d m tri a privilegiata n l madriaal d e t nd il
r p rtorio topi o attraY r o un piu fitto ri r o all araut zz della Planudea: on
le u orone e I u uhirland , l'Antologia detta an h la forma i titoli d Il ra -
colte di fine ecol . orcranizzat . om le co ve raccolt d autore. da cri t ri m tri i,
num nr1 rial ina mo a d I di or o poetic pr nd il
opra' ento ul u 01111 tto.
Di tulti qu ti I m nti bi oana t nere nto nel valutar i camhiam nti che in-
ve ton I rime p r ritratto. La minore o cillazion n Il e forme lin ui . ti he im1 li -
ca una pi facil ir olazion d Il te r p trar h eh al ont mpo una loro
I i alizzazion mpre pi pr mm iata: parate dai nt ti onamari oggetto
di una fortuna indip nd nt . 1 formul d i Fragmenla uhi ono una pro!!fe iva
2 el monwnw in ui rliv nta po, ibil un'operazione come la . illou gi litina del 15-+5 chiaro [ ... ] 0111(' pt'r
la ma.,gioranza d i po<'ti non fo . e ormai prioritario co,tituire un per onal si tema liri o, ma fo, e pi con,urto
pe1han r ' ri\erc t ti irr lati da un insiem( co rente, 'iOllO la opinta delle orrasioni, ccrca11do nlinim cd f'pi-
odicl1r cocoioni tcmatico-fonnali tra i te ti. TI onteni1orc n I quale qu tr por;ir trovru10 quasi naturnl11u111r
o>italit r nel quale clii rntano in qualch modo i tema sar proprio qu Ilo drl ' libro' antologia. rh i ostituisrr
come n1wnorio aperto. ('Om luocro di incontro di ramhio. otto l'ins !!Ila di una linrua lirica 1endenzialmr111r
unifiranu [ ... ]> (Toma.,i. ln1rocluzio111 a Rime 15C p. ' L\ 111 ). fr. Tno1 10 1991.
3 ( ... ] ('t'."!o con il 1558 non i pu clirc co11clu a la tagion d(i \'Olumi miscrllanei di lirica, ma lr rar oltr souo
,,rmpn p111 I gaw ari inizintive circo1.rritte e so rivolte a un pubblico lo!alr> (ToM 1 200 I, p. 98). \cgli tmi
oi flf'ri111ema110 . pecializzazioni della forrna antolo1ria, ull11 ba e di nwtri e generi o in rnpporlo a sp cifid1e
cmihtanz!: la vera r propria e pio ione quantitativa ili raccollP (funebri. m111ri111oniali, douorali
r ahn an<ora) proprio i11 que ti anni ha inizio coinf'irlr. di fatto. con u11a prc a d'a110 d(I livello lornle ('Ui
dnono (, rn: de tlnalr I! ratcoltr. con il ron rgurnte coinvoli:imrnto dell't'ditoria di pro\i11ri11> (iii. p. 10 ).
i Ur. 11 RRO'I r Q 0111H1119?3 ( prallulto la pane in1rodu11iva).
166
dcs<'mant izzazion. !l' uniformit linaui;tica i acrompacrna la condi, i ione molto
an'<' rtita cl 1 odic<' p trar h<':co da pari di p rti che cono. ono i c mnH'nti al Can-
-:.oniere. lo rii
11
gon (e lori cri,ono) atlrm r o rimari r<'pcrtori. I lor , r i
il ritratto. letti in riunioni accad<'miche o in o a ioni celebrative. in gc nC'rC' trovano
una rollo aziorn editoriale n Il zioru <'ncomia tich delle ri petti\'c raccolti>. tra J
rime di on-i J ndenza o nelle illoai collettiw. dov il ritratto puo divt>ntare. pt>r i
curatori, lmo dei trmi intorno ai quali di.poIT una equcnza di componimenti(). 'ul
piano metrico, tanto Jr stan::;e che i madriaali contribui T n a modificare J'a . <'lto
e l'i -pi razione dei te. ti . ri prlt ivarnente nel en o delramplificazion<' rnumcratini
e della concentrazione ina gno a cd epiCTrammatica. D'altro canto. a mrt ecolo i
libri di 1itratti <' I<' hic)CTrafie combinano effigi r parol . e lelogio po tico
d lrat1i ta un f !lomrno di cui ha pima co cienza torica. Le 1iO . ioni ull' arte
di Doler, Pino. Varchi e a ari te110-ono gi conto d l punto di ,-i ta dci p eti e qu , ta
con. apcvolezza. a ua volta. iuflu nza i rimatori e la loro valutazione d Ila poe ia sul
ritratto. accentuando r appiattim nto del aen re ull' encomio e la ubalt rnir del
te 'to alrimmaITT.ne eh<' lebra. ell a fila (1:-68) di Iacop . Gentil e Giovanni B lli-
ni. Vasari tabili re un I gam tra i on tti tu ritTatto di Laura, ITT. rncati n Ila ,ita
di ,' irnone Martini. e tr t ti inquecent chi. uno di Bembo e du di Della a' a:
ionumi dunque ritrasse a me er Pietro B mbo [ ... ] una sua inamorata co. ,fra-
mcnle eh merit esser da lui . ,, come fu, imon dal prim Petrarca fiorenti-
no. eia qu<'slo 'iniziano elehrato nelle ur rim . com in quel om tto:
O imagi1H' mia el l pura.
dow nel principio drl econdo qua<lernario dice:
Cr cl hr 1 mio Bellin con la fiuura.
e quello eh utta. E chr maggior premio po on ul'anr6ci no,,tri cli,,idrrar d llr
lor fatiche che e ere dall perrne d i p eti illw,tri crlehrati? ' com. anco .;;tatn
r eccelicnt j.,!>imo Ti7iano dal d tti simo mc., er ,io,anni dt'lla .a,..a. in qu I "unctto
che comincia:
Ben,. aai , Tiziano. in forme nuove.
C'
et in quel laltro:
on qu<'SI<'. \mor. le vaghe tr cce biornlc .
I ola ndo il verso in cui B rn ho nomina Giova uni Bellini. \ asari con a ra il l crrurn.
cri i tituito e tena nella pra . i. tra po ti e pii tori , che, e t'mplato u cp1rllo na P trar-
5 La 11ormalizzazio1u d!'I wmacrlio drll1 ri.,oror 1r111111ida'. uwtril'hr e rttoridl(' an;rm n 1t111111ggio <li una mol-
tipli\'ala podbilit ro1uhi1111tori11[ ... ] d11ll'11lluoiour al 111odt-llt1 [ ... ] alla riprt,n qua i tcn1011urin [ ... ] (Tom:i-i
l111rodu1,io11(' a Rime 15-+.). p. \LII).
6 [ ... J u110 dri ibll'llli di Il run"azio11!' 1r11 i ll'oti pi1 difftM), und1r all'imerno dP.ll'ant?lol:(iH .. ormbrn 1111.l'llO
dti lcaumi formali ira ro111po11i111rn1i di 11111ori di1tJ"i. t'omt nl'llt rime di t'ambi o di O<'l'll;.1\llll' 'u un m1dt,11110
lt'lllll (il i. p. \L\ lii. no111 CJ9).
Ti'te 1068. 111. p . .+:l9. ,fr. nn\'hl' iii, Il. pp. 191- 1Q2 e \ I. p. 168.
16
ca e imone .\lartini. defi1 c l'clouio canonico d lJ'arti ta nel CinqueceHto. li Yalorc
di qu :.ta riile. i n ri -i de n Ila sua , lida prosp ttirn - in quanto tabili.ce
un legame tra mom nti liY r id ila t ria del ritra1t cl ila poc ia. fac< ndo di Bembo
tul eone.lo Petrarca-. nella ' Ua in \'itahile I arzialit (l'accent r tutto ulla C'Olll-
p ncnt e lebratiYa della -critt ura pcrriuat to. come il urcr. sirn ri fcrin1c11-
10 al fortunato .. can ne d i pitto1i .. d I Furioso
8
) e nelfintrlliO'cnza critica che rH'la
a '1:> ciru1do a P trar a B mb . 111a non a D Ha Ca a. una 'ic nda amoro-.a . . \n he di
q1. da un dato h . 111 ,eclr m . n n ' mermuent bi
11
ra1ico. pa. la cli tinzione
fondam ntal tra l due pi importanti ri critturc cinqu ccnte che di R1f L 1 \'11-
L.: x.rrn. B mbo r cui ra w1 t t rrioYanil n Ila ezion pit1 propriarnent arnoro. a
d I u canzonier . piu tardi -. rta Della ,a a a 1-iYcr du onetti ul ritratto di
mm 11 ntildonna v n ziana eh ali ta molto a cuor : iJ a a agio di on. egne tra il
ma tro che non vuol contentar la ua ultima mu a e l'alli \ ' O recale i I rantc producr
du - Il tti mirabili. uno cl i quaLl ar ri ritt dal ITTOYffil 1. Bembo r un nohil
h ha on iuto trullo la e rt che il mond d Ila tampa. troYa n I cardinalato la
anzion di una arri ra ecc ll nt : D ila 'a, a un l ia tir ui lr incombenze di
diplomati o e m n i1more qua i non 1 cian il t mpo I cr ri\' r ( uza imprdirgli
di r . on po hi ri,ali. il pi !!rand liric del , lo): Ta . ' un porta co n tto a
c rcar la protezion dei irnori p r vfrer . l'irnponent m e di rim cf n mio che
i ha la iato re ta a t timoniar il pr zz di qu to omprom
,. T ll Rime di Pi tro Bembo, u cite 11 l 1 30 e poi, in ver ione d fniti,,a e
po turna. n 1 1:- -8
9
. J rrITTan1 due on tti d dicaci a un ritratto femminil : pur
ompo ti a una ignifi atirn di tanza di t m1 o. n l canz nirr i pr ntano umt1
m qu nza. con chiara allu i n al dittico p trar h o. li primo t lo qua i rrr-
tam nt era tato ritto p r un ritratto di \1aria avorgnan rlipint da Giovauui
B llini. for il r trato> al qual i rif ri c la nobild nna friulana, inamorata
di B mbo tra il 1:-00 il 1501. in una l ttera del 22 lurrlio 1
un.immaginr
eh l'amata ha con .o dopo qualch itazi ne. d ll qualr r ta tracia in una
lettna di Bembo ri pota. n' lavo tra imaO'ine ho a 11ta, n alcuna par la
del vo. tr ntiIYi d ll'altra ra. [ ... ] matemi. mi lavo tra imaain , vi
pri aoi.
11
).Lamant ri vocainterminip trarrh chil'ac oalienzarh hari rva-
to alr ffiai tanto o. pirata e n d . rive l'alt gaiam nto. 1 tteralm nt mplato
8 Perl'dol{iOariO.IN'O (OF\ xm. 1-2) rfr. B\ROCCllJ 198-t. pp.
9 ulla CfllNione dl'il'ordi11amcmo dl'll rinu 11rllc due 1dizioni cfr. LBO'ilCO 2006, pp. 1-27 1 l'in1rod11zimw di
Donnini a B1 \lllO 2008.
1.0 [ I/i. w 111111 imagine] r 'o rh quf'l clw promelo alf'Oclo. [ ... ]Vi mamlo 11 rctrato, rhe 11u11 -.rn hrne; pur 1 i lo
rwomando. [ ... ] (, 110HG\\\ 1 Bt.'IBO 1950. C) [9]).
11 h i. 60. La data pi tarda (A' 2 di. <'llPmbre 1500). ma 11011do Dioniso11i qur ta I 11m1 aparten- blw
alla prima fa-e ddl' a111orr.
168
11 quello cl 1 ritratto di Laura (H1fLXXVIJJ. \'V. 10-11 ):
La imaginr. cornr rlw io I' ahhia rmpre nrl 111orc'. pure ho io cari . opra
qua111i clo11i rbbi giamai. \ eh \Oi la mi rareorna11da w. f-at e pur \Oi
cl1t io liia raeco1111.111da10 alla vera. alla quale drlla finta rendo qurllr urazie cbr io
po o T lolla ba. riata 111ill \Oli e in ncr di mi. e pricgola di quello. rhr io
YOi \'Ol111ti'ri prr
11
ltcrri , r \ <'
17
"0 rbr ella beniunn111r11le n.s.rni par rhe m ascolle. pi1
chr 'oi 11011 fai . se risponder. apr.m' n dr lii miei. [ ... ]I:!
rl carteggio \laria parla anche di un altro ritratto. ma non ab! iarno indizi prr
. tahilin C' i ' Onetti rifc1is ano all'uno o all'altro:
[ ... ] i\i,prt to di far uno l'l't rato noYo. ch non ho ro a bona. e qurllo a rete. ,' fon mi
scorder clii drapo fodrato o <li . ca riatto o di ,ari 1 do i. [ ... ] [27" ,'ept . .llD. ]n.
[ .. . ] :e dimane mandar 'olrt I c'r lo rrtrato. io ar di gratia prr aper norn di mi.
pur chr mandatr libramrnte a po ta prr r o. [ ... ] [/I \ ocemb . .l!D.] H_
mbra di as i. trre, ante lilleram. allr chcrmaalic pi tolari cl O'li amanti di
Lui i Pa qualiuo". ma quello eh I O'giam ' un autentico eart rr<Tio damore. pru1 -
cipe di una pa ionr ,era. an b e co tantcmrnte nutrita m diata dalla lcrt ratu-
ra . .. appiamo chr il pacfr di Bembo. Bernardo. avern commi ionato a L onardo il
ritratto di GinC\Ta dr' Benci. e aw,a chie to ai I tterati fior ntini Cri tofor Landiu
e ,\I andro Bracce i cli 1 brare !"oc a.ion
1
h. 'on ad ion pi compi ta m-
pio di P< trarca ' nunitt nte di 'imone .\fortini. Pietro' inv ce poeta in prima per -
na, r ,' 'rnbra riC' rdar. i l I . onrtto eh Lor nzo cl .:\ledili a\ eva d dicato al ritratto
di Lunezia Donati i;:
12 hi. 8. l(ltpra 11ffidal111t1111 dd 20 \forzo 1000. mu "<'l'onclo Dioni-oui da datar 22 luglio. La forti palina
lw1raria 1' le -,pirrul<' a;,(t111l11w' pt'lrarrht'>rhe di que tu pro'u !'pi tolarr ,tmhrwdibcro dar ragiom a im111111i_
Pozzi. rhr l('!Zl{t' la ripre'a dtI 1e111a del rilnll lll nel O imagi11e mia C<'i<'sle I' p11ra ('Ollll' pu--ag!!iO. 'ia Rij
I.\\\ lii. dal rontC' lo dt'll'etichC'tta mondana u qurllo di un rornponamento i-pirato a prt'l'i'i dati rulturnli
(Pom 197Q. p. -t). T11\rr 2001 (p. 122) r \\u.iTR r Z\PPfHI 200(> pp. -q_-.8) -i -pingo110 oltn'. ,ll!!!!l'rendo dir
l'rmulaziorw di Prtrana :l\nhhr agito an lu a liHllo dtllu mmmi"ione.
l::l ,\1011<.''' r 1%0. :i:'i [61).
l-1 hi S7 (67).
13 Cfr . . mpra.
16 li 1er.w del ritrallo lll(hlra un rani"lio 1011 il 1110110 \ 'in111em fonna drcornt ( Brlleuu 111lorna ,;n\1) t'
l'cimpnsa prr-onfllt di B(rnunlo. da Jrnnirrr Flrtch r, nella fon1111 tli dut' rami intnc\'iati. 11110 tli
lauro l' 11110 di palma. Sulla Cinr' ra run1r 'ri1rntto tr11111a111r' dr. \\ 1LTFR r Z 1r11 RI 200b, pp. :3 1--1-t. \ qua mo pan
Bmrnrdo pm.,rdern q11l'llu e Luura. forl>t' di ,luropo Bellini, , i-w da \lurca11w11io \lkhiel in l'lhll di Pieuo Brml o
n Padova. Sui 1 ;,ti di L11111li110 r Bra Tl'si rfr. \\ 11.TF.R 1 Z 1PPf RI 2006. pp.
17 J<JC)L .\LI\ (('fr. '11/U'<l. 2.8). 1hI q11af( il Ollt'llO di B1mb I l'Oll(li1itlr rapo,trof( UI ri1n111_0,e nlnull'
rime. L' imornzione dir<"ttu 1wll' lbO di Pttrnnn. 1Rl\'Olt11 rif1-ri11111 ('lrnw111i dd r 111011( o ntl uhn 11111ta ((fr. ad
es .. lltfC.i\CI\ CC\\\I\ , CCLILI CCCX?\!\ 1cc.). ma 11011 nl ritrn110 d Lnurn.
169
O imaai111' 111ia ccle, t e pura.
d1e ,pkndi pit1 che 'I le a
11
li occhi 111ici
mi ra-. ...emhri 1 rnho di colei.
che ::.rolpita ho n I cor con maggi r cura.
cr do cht 1 mi Bellin con la figura
t' abbia dato il co tum a mo di lei.
che mardi . io ti miro. e per t ei
reddo ...malto. a ui giun alta Yt'lltura.
E come donna in 'ista dole . umile.
ben m . t ri tu piet d I mi torment
poi . .,e m re' t n prego. non ri pondi.
In quc to hai 1u di lei m 11 fero tile,
n pargi le mie p ranzc al vento.
ch.almen. quand'io ti cero. non (a-.ronclit
8
.
La econda q11artina alda il t ma centrale di Rtf L/X\'fllt
9
_ di cui il on etto
./X ar un e pru1:i ne. con il n m del pittor . f d lmentc coJlocato (al er o 5.
nella t ., a h aveva imon non in L/ ym ma in L , \'II). Giornnni
B llini ha dato alrimmaain l"a p tt il comp rtam nto ( o tume) della donna.
e. proprio om l i. la figura dipinta ' fr ciclo malto ma genera fiamme amoro e
in cl la aua.rda
20
. Enfatizzando la relazione aff t>ttiva on il ritratto. Bembo po ta il
cedere. eh inRtfL XVII era il pr uppo t d l crittarr >. dal campo dclrintuizi -
n ruti Lica a qu llo del de ideri : il uo . !!llardo. al qual almeno la figura dipinta
non i pu elar :!t e quello di un poeta-amant pettator (occhi mi i. miro.
in Y ta) che pi che lodare il pittore m tt in cena il colloquio con l'i mmauine,
gi de rritto a :\1aria n Ila l ttera d l _2 luali :!:!_La celta di priYileaian il rapporto
18 RB >..I\ .
19 'o n1111ni<111e, m riprendono lr rim {in B la rima Cdi L.\X\'111. in C la B dello tr ,o ;,m1<'t10). Le 1rrzi111
sonoro tmitr 'u tre rim<" (COE CDE).
20 Comi -<irnala Dioni,oni. nrlreclizion 13:30 11i v..-. ?-8 ;,i lrgg<va crhr m'ardi . ,io ti miro. 1 pur 11011 uhm
chr in_ h
11
no una b pi1111ra (liB. pp. Unt ra prinreps ;,1ata ripropo;,l!I da Guglielmo Corni in Poeti
( lllf{11ere11to: do\e. propo.ito cli RB Xl.\. 111111oia: c;,t il Prtrarca. co11 gusto srpii;,ito e ;,ingoiare 1c1111 r;,ti\ilt.
1 compuwqur d1arcogherr11rl Canzonil'r< il rirordo del ri1ru110 di Lanra [ ... ], 1111dw il B1mho - imrro con nwno
auta a11111zione alropm d1lrancficr. "ron >r11;,o pi gala11t1 chr profondo - \oli!' rnr11zio11an in wr'i la turnla
drl iaml>l'llino ( ... ] (Poeti rM Cinquem1to. p. 73).
21 terzinu rpil!I la ripre a pi[1 chiara clf'I nuclt'o 1111111 tico di Rif LX \lii (pi t e ilrnzio cl I ritratto}.
".'a 11 f111al<' ,\olta ?Pi;,anw1111 ri petto alla rhiu;,a p tranlu.,rn 11 Pigmalion!'. propon nel un motivo chr ;,ar
;'." 1,rmpio. da Torcll.i (O per mano d'Jlmor dipinta imago [ToHbLLI 2008. /lime, l. 81)) 1 da
\ ca1110 I 1
11
1101clh (Da 101 St bl'lla imago il li1111e prPnde (P1c,11 LLU 1996., X w.
22 Il 0111110. l'ome 11 dm let1!'rr df'l 22 lurlio 1300. alludi' andw al imulnl'ro interiore rlJ!' ha .,l'dr nel cuor!'
(\.i):( .. ] ("()Jll(' rhe_ io rabliia empn 1wl cuori'( ... ] (. \\OR. \'\e BDIBO 1930. 8): cPiHC!'Jlli dw mi .,i111r
radrloppw1a per ronfta dclla rn.1ra imagi111-. la qual mrr11perJ11n<o nel ('UlH"I'. ., e me da jtri in qua in nw
170
arnoro o dell 'io on il ritratto. costniendo il emetto ulrinvorazione diret la ali im-
magine. troYa conf rma n I reimpieao di til > ( . 12) p r indi are ra11raO'iamrrtto
d lla donna non lo trum nto d I pittor 2:1_ r
In un momento impr i ato, Bembo compone un econdo onC'tlo ul ritratto.
che fin dalla princeps compare di auito a O imagine mia cef Pste e pura. cui lo lrO'a-
no hiari rimandi formali ( mercr>. Yolto. trrrurdo>. wder> ). nono tante
pi d Yiazione dal m cl llo petrar he , o:
on qucst i quei begli ocrhi. in ui mirando
senza dife;.a far p rdei me te :o?
qu I bel riali . a cui pe. o
invan del mio languir merc
on quc te quelle chiom che legando
vanno il mio ror. h 'ci n more expr . o?
o ,olto. chr mi tai n r alma impr .,..o.
I rrh "io virn di m mai -,empr in bando.
panni vecler ne la tua front Amore
tener uo maaaior ggio. d' tUia parte
,-olar p me. piacer, tema e dolore:
da l'altra quasi tell in ciel con patie.
quin i e quindi apparir e11no. valore,
bellezza. leauiadria. natura et arte
2
-+.
L irnpo tazione iut rrogativa, h ac o ta, nelri llu ion del oaa cto. bellezze
dipinte e bellezze reali ( on questi quei ... ). individua rimmaain nello pazio
raddoppiato qurllo ardon', rh io non crrdr11 dt(' potr:,, pur 're cere in parte alcuna. non che raddoppiare.[ ... ]
A 22 di Luglio 1 00 (ivi , iO}.
23 La diwrsa accezione prende rilievo. p<'r dal confronto con il le>to chr prrrede il dit1ini nell'tdizionr
1548. una hallaca mrzzana indirizzata 11 Elisabetta onzaga (Come si co111wria. dr co tri onoril. don c,1ih
indica imrrc [a pOt'-.ia: la \i. ta della donna. diretta O ripen ata nella ru nte che deo;icJera farnt' l'Ol(f:l'llO cft'l l'lllllfl.
aru1ichilisr1 la o cirnza l.' il lu1"11armio. dt<' pu produrre solo :.nulacri lonta11i dal mo<lcllo tfU!lnto il >0!!110 t'
l'omhra lo sono dal \'rro ( q1mnd'io \O ptr ritrarlr./ tal dilrtto e norn a me oi mo,tra./ eh ralma in ta!110 l't''ta
v1ta e sgombra/ di e lo ntil 11011 p(> formar! J eh 'al \er non ian pur come sogno et ombra [RJJ, .\ \ lii.\\.
8; 12)). Visto il t ma. ign.Hratho rh<' qur'>to 11 to do\"S e 1'.'l'IYire p'.cft11ione r d_rdica a
duna raccolta d Ue sue rum rhr il B1111ho uwva m " iusie111r ad Lrb1110 mtom i I. IO (D1on1-ot11. /l)ld
commento ad /oc. ); .orni, Poeti del Ci11q11ece11to, ad /oc .. nota lu. tre parolt-rimu, rugio110. plnlono. -0110.
d rirnuo dnl onc110 proemiale dci Rif 1lla princep I ;)30 il dittico mi imwe preml'.uo -omuo . Ocrh'.
leggiadri, onde sorente Amore, con rffrllo di eontinuit 11 ll 'allocuzionr: cnilloquio (Corm) 11'1111poetae1 png1
di madonnn ( ' Vili occhi, cri11, man). i11voc1wio11c al ritr11llo (Xl\). individunziom _interrogati\ a d11le b
( , vv. 1-6) nuovo uppcUo nll'in1111aoinc ( , \" .. ). TI lc11a111r 10. tantr 1rn 1ltme11u del canune e
uttravcr:11 la qiunza e si rnffor1.1 nrl confronto. 11 dis111nz11, con Cn"11 ere po e llodero/1 de m,
1111me11.vo ardore {rb.ptllivam n1e \ ' lfl-1\ mlla princeps r \-\'I 1wll'rdizione D rko, I i8).
2'1 RR: .
1 1
approfoudi.rr l'rsplorazionc d I rapport o tra io e ritrai to a\'Yiata 11 I so1H't to Xl'\.
IJ H'l''-0: ripropone rapo trofr al \ Olto e rilancia iJ rapporto con l'immanine in-
teriorr. coin\'olg ndola in un nodo di simulacri chr rnhra ri IH crhiar<' il rontrsto
onirico cui la formula interr gati\a (/l1:f C .CLIX. \ 'Y. 56-38):!i. La dcscri-
zion d i , r. 9- l-i tra:-mettc fogo-etto di una ,i, ione inc rta r allucinata (panni
wd r ). h p trebbe e scr e ntemporaneam nt il ritratto, l"immaainr intrrion r
il ,olto rcalc:!u: intorno alra, se di un ,i o ul quale reana \morr (chr ha stde nella
fronte ) i mu ,. no da una pai1 I pa, .,ioni f ndam ntali (. pt' ranza e timore. pia-
c rr r dolore). dall'altra al une 'irt o qualit. interi ri rd trriori . drlla
\[entrc n l1 quartin !'indi tinta lumino it dell' imagine> omi crliant r (HB \!\.
\T. 1-: ) i c ncreta in cl ttaali del cru1 ne bre,e> (O chi >. tiO' li o> e chi ornc ). a
eia:- uno dei quali corrispond un effetto prod tto n I poeta-amante (eh si perdr.
hiede pi t. ' ali nat da . tr o). ncll terzin una orta di yi-,i onaria allegoria
o di mi t ro profano rende ,i ibili di p n n Ilo pazio gli affr tti u citati dal
iitratto (e daff runata) e il costume d Ila d01ma. 11 leo-am trn ouO'ctto d Ila \'i ionr
(e d !l'amor ) onclizione d Jr amant . rapit o-!!ioO'at dal uo plenclor '. inr-
orabil . a ost o-no di 1uru1to affermato in RB 1.x. (' . . ): ed qu to il 'rro tema
rlel dittico. h n n iip t il nome del pittore. ed raccolto n lla nione pi mtaria
e am r a d Lla illoa . Di miti tra f rrna1i in mappe dcli" interi orit ar ma . tro
Pietro Aretino. e di ritratto de critto o dipinto prr ali effetti ari ranno altri porti.
ormai pronti a ae' tire con di inYoltma il corrfront on f immanin dipinta. lontano
dalla ma!mifi a parit tra le a11i ' h caratterizza i primi d cenni dt> l XVI ccolo: pa-
rit autentica perch' onqui tata palmo a palmo. nci fatti c nrlle roncretc relazioni
tra po ti e pittori.
:3.2 . \ in ci me sol. ma l'arte inseme. accuso>
Tra il 15-i:- il 1 :- -+6 B mbo . ollerita il pi 11io,an Dr Ila Ca a a comporre una cop-
pia li on tti prr w11itratto. quello d lla nobildonna wn ziana Eli:iahrtta Quirini .
dipinto da Tiziano: un ricono, ci in nto e un pa .. acrgio <li errdit che i compir.
25 'on q1w,1i i rapi i hioncli. t'I r nurl'o nodo/ - dkh"io - rh.a11cor mi -. 1 ri11gc. c1 quei belli orchi/ clrr fur mio
[; l . Cfr. .mpm: '1 .6. I: irnpo. La1io11c i111 errogali\a di RB X\ ha prrct' dcnti lwn noti . eia Ci11'>tCJ di: :cmti a
ruu1a:a1ro ad \rro,lfJ. t coma 1111a \a. ta sd1icra di imilatori tra roloro rlH' cli ritra11i I' di 'ogni (eia Cw. pn
ra tampa a Curzio Go111.aga). iu <JllatllO forma farile 1 aclaua acl artompa/!lt!l rt' 1111' in1111agi1w o 1111.appari1ioul'.
26 Pn 11 ragio11i a fa1or1 e co111rn riaM111ia clellP tre intcrprrtuzioni. rim io allr n1i1 nole iu Ror.1.0'<1 2008. pp. 90-9 I.
27 .'rnmclo Diorrisoui (R/3. c-01111nen10 ad lor .. p. 522) 'i 1ra11mHH ri pr11in1m1nw clt' "li affeui dt ll'amanu
I'. cltllP _ pi1 f' 1r,a111rn11 ratalogmi nPi 'orwui \ e \I. Corni uno.,,!J'\a.donr di
' eglwnr. 'ercmdo 11 quale gli aff111i san-hl1ero qui 1lc11n11i . ,1co1Hlo l11 rn11111111razione rlw nr fa ,' rwr'iuo Boeiiu
n<l l Libro dl'l la Co11-.olazio1w (Poeti del ( 'inq11<'rento. p. 7-t ). Lr trrzirl<' sono costruite ;, 11 d111 rimr (CDC DCD).
i11 !11(LX\ \:li L \ .\\"Ili. e rornc ,ar1111'1 corri po11cl1ntP ,0111110 rasiano (Dt \ ( \. 1 2003 (!W<l \ . \I\ '):
la nma Dr la B 1lt li1:f L. X\ li 1 il\. i rimanda al' 11 cli IU3 \]\ ( rrH'rr'r w11 prl'go ).
1.2
almeno in partr. attra\'('r o 11na te ura a q11auro ma11i . comr attr ta il carte11<Tio
che, , ia Carlo Gualtrruzzi . uni. e i du po<'ti
211
. , 'rriwndo al C11alt1ruzzi. Drlla Ca a
non 1ui<ico11de il proprio contento in mc rito al s11vizio> cbe tenuto ad aclc'mpirre.
mar amico i> costretto a ri ordargli l'impazienza del cardinale (e. dirtro. qu lla della
Quirini . , ua capriccio-,a n111 a seni) ):
lo rni .., w a \!urano [ ... ] r tanta la molr tia che mir data di andar hora in Collr-
gio. l' L hora altrow chr 11011 mi ri fcnnare alrnrn tamo ch'io u quel
srnitio a ,\\ado11na lsalH'tta:!
9
ll Cardinal [ ... ] di ce di r ha una rrrande et firra irwidia di quC'lla brlla
da \I urano dow drsidPra ad ogni modo eh< i faccia quello irnpia tro a qudla buo-
na p<' r:-.ona dtc I" U'>f)l' tt a:IO_
Della Ca a apparc au 1er i e pazient ito. ma a molto ben co a i i attenei
da lui . come di1110 tra e n il trntatiYo di 11irare l'incarico al ualt ruzzi te o o a
quakhc g nero o cribacchino. e comr conferma una 1 tt ra a<l .\I . andro Farne e
. critta poco pit di i m i prima (il 20 ettemhre 15H ):
Quando ..,,,er Ti ti. no har fatt o il ritratto. alhora \ tra ' im10ria Rewr ncli ima
ltm er quello r b in sah-aroba. rt non prima: rt que to ar il mio: o voi fate i
'>Oll l' tti \ OL l' hr ali :-.apt> lt' ben fan quando \Olet !:H
Dio v Lo p!'rdoni ch !lii hawt e dato carico di far i opra il ritrailo eh io
11011 far mai. aLmr no che l tW :-. tiaino. O ..,e {u:,;,i quakh per ona mi ... ericordi 'a
eh!' rnc ne pn .... tare almeno uno <'t norninan i ntro et la aiornne t Titiano.
quanto gli h<' nedirci le' nrnni !:!:!
[ ... ] r ;,e Don lulio [' lo, io] gli manda lo rhizzo dllla t'O!!llata ddla Camil-
la [Conzaga] . lo fad1 gra11d r t ..,omig]jaralla ero: et io ' Legato conH' \"o..,1rn
Signoria u ha fatto. son per diromper un Quando criu11se [a] 'i-
111011 l'alto concetto:n.
28 " ui 1h1t11gli dell11 to111mi-.. io111 cfr. T\\ ll 1111 J()81 t D1Lt'l'll J<J97. d1t illu ..1ru lwn: il t"Olltrih11111 d! B' tnlio al
' llll C' lt o /1111 re"!!;O io, 7:ia110. i11 forme non (/WC \\\lii). Lu l1111ru dtl .1111lteruzz1 111 (.11,a drl pnmo ngo,lo
l."i-1.) (D111 \ \..1 .. \ 1 <J 8h. 89. pp. 178- 179) eontiene lt principnli rritiehr nl_l11 >_tr nra rhr fin'' a
po1u10 1-,umi11an'. 11pp11mi <f<i l(llHli Drlla cu ..a in purlt' ftrn l'Olllo: rn111h11ru I Il t'!lrh' (du
prn1111 a c\h l) 1 il 1r rbo "'1nlda ili cparla. l'limillt' rI uno dei rdn1i1i ul ' 7. tm,;lonm>ra 1. l_I e al' li
pu>-.cr1 du omma fia gloria 11 e fin .. 0111111<1 1r(oria. Il primo -0111110 (RD( \\\lii) fu 1ompo>lO m u: ..
il 18 lugli o I ;)-t.) r cmnpl rnt o il 22 ottohrl' drllo , 1r,,o alino. Pl'r l'ullali,i d1i ..orwtti di Btmbo e Della Ca-a nm w
nnehe u 2008.
2<J Dn 1 1 C\s1 198(), n. >:t l11t1rn dl'll"l l 11prile l:l-t;) .
:rn hi. 11 . hu. ll'lt r ra del f.nalt Pruzzi d1l 18 aprilt l:l-t:l.
l h'i, li . 7i . lrllrrn di Drlla C:usa dt'l 111uggio L)-t5.
:l2 ki. 11. -t8 (5 frhhrai 1:- -t.i ).
:t3 La l1t1Pt"ll M'g11ularn d11 Z.1PP1111 199 I. p. I'? 1.
I ..
In corri 'pondcnza di un 'i11m11:wine femminile da cl ofare (in que to a o u
11
di-
eon d I miniaturi'ta iulio .lo,io ). I 'incipit di RifL ' X\'lfI pror 1111 e dalla I rn-
na di \fon ianor e n la narural on-iet di una formula, la f rnn prr e Il nza.
i dirrbbe. per primere l'ammirazi ll darnnti a lUl ritratto. Qu ' tO conf nna la
tabilil di un mod li po ti o e n 1 conLernp la ua riduzione a clich. ad auto-
mati m r torico infinitam nt r pli abil . a patto di m dil are di volta in volta
il nome d Ila donna e delrarti ta. Bemb i ti n lontan da imili eiti in quanto
ri criY il dittico p trar h o dalrintemo di un e p ri nza p ti ca e amor a. in-
aolar al tempo te o filtrata dal Canzoniere. mentr D Ila a a i tr va in una
po iz1 ne pi in erta. forzato a omporr ad adottar la ma chcra <l li' omaggio
aalant nei confronti di wia prot ttrice . . onotante la part nza rnntaaaiata. ar
ralli Y non il rnae tro a r alizzar un mod Ilo di on tt pra il ritratto> f dele
a Petrar a eppur aaaiornato al pi no inqu nto, ritrovando in quc to chcma
poeti o un luoao d lla rill ion d lla lirica u te a rico truendo i uoi leaami
con il ma rote to.
In una raccolta (1 --8) alrin ma del formar> di artefi i umani e i du
on tti ul ritratto d Ila Quirini hanno una llo azion p uliare: il u tto Ben l'eg-
go io, Ti=iano. in forme nove (RD r Xlii) apr la e nda met d I anz niere
rimanda al primo (Poi eh 'ouni esperta. ogni spedita mano )3-1 e alr ultim (Questa 1ila
mortai. che n una o 'n due) pr p ne una conda invo azi ne (Tu. Febo ... >). di
evident rili vo m tap tico. Qu ta truttura for e emplata ulrordinamento d i
dieci p zzi casiani ra olti nel Libro quarto delle rime di diversi eccelie11Lissimi autori
nella lingua volgare (1 -.-1 )
3
s. pi la illoa u ritratto for progetto di anzonier .
om ha mo trato Tanturli. la dj po izione a ni pond nz p ulari cl i dieci te ti
forma una figura bipartita e imm trica, ap rta e chiu a dai on tti uJ ritratto della
Quirini, che includono la erie nell orbita del t ma: XXXIlI fa da pro mio muo ndo
da uno ruardo ul ritratto di Tiziano ed nw1 iando l argom nto d Ila ra coltina
( ra
11
!!iw1aere il vero volto della donna [ ... ] ritram l'a p tto int rior >
3
b) TV
funziona da pilogo. a chiuder il r hio di una rifl ion n 1m nuovo invito a con-
templar l'opera del pittore. Du on tti v ro imjlment ncepiti in i me (1545-6)
diventano o la ornice di una quenza che pand la rifl i n u1 ritratto (15. 1 ).
p trovare po to. nuovamente uniti in w1 organi mo pi ampio eh ripr pon , u
un altra cala. una truttura di imm trie (15, syn: il percorso prime un'intenzione
3-t . f'O !bil!t, da RR11 1996. <li identificar< la clr,,tinataria del on tto prormialr con la . te a
Qumru a11ziche con Crumlla Conzaga rui rmbra aggiw1grrr un ult riorr demento in quel.la dirrzionr. P1r la
que,,rionc d1I marrot to cfr. Lo GHJ 1979.
3;- Prr le raraueri. ticlw di qur5ta illogr quarto 1551 ). i11 cui i trsti casiani o upano lr pp. 74-88. dr.
To11A 1 2001, pp. 88-90.
36 Ll\fllll.1 1981. p. 167.
3? di e pan ione I' riconcJ Il azione r reso po. ihilc dalla fonna rlrl dittico. rh i compone di due
ie,u pl'r
1
quali
1
1 enso i rica1a da cia<,cuno clri due presi singolarmente e al trmpo tesso dalla lor interazio11c.
174
cl1r
nono tantr la dovcro a l'edizione po tu-
rna ci 1111pon . F 1n dall uz 1pll d<>I onelt .1 Jll. Della Ca a 1 m ttr . ullr traccr
di Petrarca. allin ando. 11ello tr o v r o. ali el m nti e nziali he inquadrano la
rifle::iionc ul ritratto di Laura (il vedere, il pronome di prima p rona che indica
il , oO"getto lirico, il nome del pittore e l'op('ra):
Ben vecrgo io. Tiziano. in f nne no' e
l'idol mio eh i begli OC'chi apre e crira
in vo tre viw carte. e parla e !:ipira
v rarem('JllP <'i dolci mr111bri mov :
e piarerni rii 1 cor doppio ritrovc
il ronf orto. ove tal or o pira.
e. mentre clic l' un volto e r altro mira,
brama il '"ro trovar. n' n dO\c.
\.la io come potr l'imerna parte
formar cri mai di qttr:.ta altera imago,
osrnro fabro a s hiiua opra letto?
Tu. Febo. poi h"Amor mrn rende \ag .
reggi il mio stil. eh tanto alto . ubietto
fia omma gloria a la t 11a nobil arte
3
<>.
Jn. i me all'appello dir tt al pittor (Tiziano>: \'O tr ( ... )carte>). il \ea
11
0>
d Il' ordi d tta l'intonazione del t che i ne ntra ul ritratto inte com
opera d' m1r pi cht' come o tituto amoro . ull'oaa lt d lla vi ione pi eh L-
la rt'lazi ne eh tabili cc con l'io. L 'cidolo> ' ci' eh i ad rama ' innanzitutto
un'immaainc-1. la ui gradual animazion . dallo !marci alla par la. al r piro al
m \'imcnto (' '. 2--)"
1
m ra\ialia I p ttat r onora il pittor . n h la ripr a
I dird tr. ti dir ro1111 D"ono lu raccolta tiri 1 '.):)I -.ono. nrll'ordinr ( 'ecomlo la numrraziont: cl U"rdizione 1-58).
, X\111. \LI. \I.li. \L\'11. "\\ IL . . .\\"I. \lX. \LIII. \LI\ \.\I\'.
38 \011ostn111t i legittimi ,o:,prlli circa 111 natura imperfetta dt'lla rnrcoha. fuor di dubbio il Casa ave
co1'.(epito il di-.t'gno <li organizztH'I' le propril' rimr in un ranzonirn'. [ ... ] (G11tR11 19?o. p.
clefmisn .\XXIII un so11r1to dai connotati allol'utori tanto e' itlenti rhe en da proen110 alla raccolunn ( ... ] 'dttn
nell'antolo"ia di Errolr B !lrigaro 1' rhl' , rolloc:at u m t della nm lta ma/!giorc. ha uma l'aria di i111rodum'.
appunto. 1rna pit1 cog('11tc 1 ica bipartizione (il i. p. 497).
39 IW .\\\lii.
-iO In idolo (rfr. Rtf XX'\, 1. 27) cal significnto r1i111ologito di f 'ira. in111111ginr [ ... ] quello di 'og-
grtto di adorazion<' [ .. . ] (, irntagata in P1rn1HC119%11, p. 171).
41 Lu la11sola apre(' "ira 1 irnr dnlln pri11111 delle canz ni cl cri i ordii' (R1fL.\ \I.' 06) .. 11 cltllu
erie hrmhiann per la Q11 irini (RB ,, ' :\\11) ,i dtiude con un rifrrimtnto (o fortunato
(i.
li]) alla 'tl',Sll t"Ull/.Oll!', \ . 67 ( Felice rulmu che per 1oi 1.hpira).111 rorri-pnndeuza tra nn11:
1111
rn:
ospir11 ( 1v. 6:l , 66, 67) dello n111zonr petrnrchc ca e la ri11111 O dd ;,01wtto di Bembo (mira : g1ra : hO prra l
I. 5
n Ila cc nda qmirtina, del tema di Rtf LX.XYlll. piu che di con. !azione a111orosa
parla dC'lla qua i idC'nlit tra dne 'olti. 1u Uo dipinto e qu Ho reale. ribadendo i
p 1rri delrart di Tiziano. Da que' ta lettura. -ostrnuta da munerosi ri contri r dalla
fortuna di un lopos (rin<li tincruibilit di ritratto e oriainalc), i di co ta qu Ila cli
Tanturli, h intcnd il vero (' 8) comr il modello prrf tto. ridea in 11so plato-
nico. e utrapp la a du coi ir dfr r am nte inadecruat (rimrnaai ne rraJ r quella
w1"interpr tazi n fatic a for -e n n n e saria. malia il merito dico-
11licr . per elli i. r o cl lr e pcrieuza oltr mondana <li Il .\1artini. li pa . aaofo
dallr qua.I1in ali t rzine marcat da uno noci avYcr atiYo
1
:
1
da un rH t t o e arto
tematico. dalla celcbrazionr d l ritratto ,-j, e cl i uoi ffrtti -ul con all'inc rta
unzione di tm ornpito mim ti o. da una ra1 pr ntazi ue cri compiuta a una
a.I1cora da compi re f r impo ihile: il ritratt d lranirna ( l'int rna parte - la
divina part di R1:f ,\'lll). dell qualit int riori, alto ::-ubietto che becondo
lill llt ra tradizi 11 p tta alJC' p310J H. C me Cambia l'ocrcrettO dell'imitazione. CO
carni 3110 r ai1i ta r arte. menn rapo trofr non ' ditig pi aJ pittore. ma ad
Apollo. on una celta co rent . yaJorizzata n I onte t delri11rncazione a Febo
nell"acco tamento aJ po irn (mio til. 11 ribadit in RIJ .\XI\'). lo
rii r uperato alla ua funzion prima ( trumento del1'ai1 ta. in que to a o
del p eta). mentr r (Y. 9) ri mpa.r in p izion rilernta: al ntro d I lC-
to ., il po ta h defmi ce la propria erienza in l rmini pl tiri. n metafore
anti he (formar. fabro) rinnovate dalla pre nza li un ritratto dipinto e con
chiari rimandi ai on tti I ( til .formar. tih) L IV (copre)"'; La unzior1
d lrimpr a di ritraiT in wr i l'interna parte riclu e ma non annulla la li tanza
tra po ta e pittore: entrambi i onfrontano con i limiti d ll'art ma. comr wdr mo.
approdano ad e iti di' er i.
illocutivo e qua i pr miale. il onetto, llf r ta . o p<' o u un int
ap 110 (:\la io come p tr ... ) e u una pirazi ne. in uno lancio in erto m
potnbhe awr la memoria !'lli>iana ad aui11gere pi1 e,1e,:u11rnte alla prima canzoni ocC'hi'. do111i11111a
d'.11 tra I rmpulo,o a ca111are (e/o a ritrarn) r la 10,rirnza dl'lla propria in. uffiC'icnza . \il tema drl ritrnllo
\1\0 !'fr. \RP\ 2003. pp. 11. -1:33.
t2 Co111111e1110 ad /oc. in Dw. 1 C1. \ 2001 {p. 86). In una . lrs11ra prl'1rdc111c il v. 11 conlc11rva. in '"cli' cli ri11111 . lu
P.arola la scelta. ira a Br111l>o. ri1rlaH1 una pi1 '><'Of1Pna purrnt la mli R
1
f L\ \\"lii : rnm1 ,rri1r
(,ualwruzzi. Qur_I trr:zo 1er-,o primo tnnario [Bemh ] dire dlt' lo wd1ria \olrnrirri mutato rwr 11urll11 H><"t'
rhe uo11 h molto 111 qu 1,111,0. el rtiandio per quelli dur <'orri.,pondrtllif' di roco el chiaro! (Du IA
Cl!' 1986. n. 89) .. 01,io il rimio a/11/CLLX ( 111 qual pane cli'! cil'l. in qualr ,dr11/ rra l'e.\rrnpio [ ... ]). ma
.,.,_gnalo aurhe aJ <rualt il so111110 ru.iano potrebbe rimandare p r dtu el mr11li: rapto per rn1111 d"Amor.
n: "hrn doq./ '.lolcezza in un ,oho tlclibo (w. 7-8): !lor insem , in 111
11
1r1111 palmo [lo . p111io clrl 10!10
ili Laura]. appari'/ \1. tlJ1lrnrnu quanro in qur i.a \ila/ arti'. ing1gr10 rt \at11rn 1 1 Ci1l p) far!'(\\. H). Prr il
prol..tlima drl \ ro in ruppono al ri1ra1to 1100 e,ducleni un rirordo del ca11zo11iere lourcuziano.
rl L'uwrr. atirn. mmc nhbiamo 'iWJ. rni i111por111111e anche in f{
1
f L.'X \'f 11 .
+t Cfr. PO\f\11111 200:l p. 16 r infra .. i .2.
i:i .T\\ll ll_u 1981 (p. indi\ idua. a<rli Pstrrmi e al !'entro del 11111zo11im. i 1rr 0""1'tli d!'I mirar: la do111111.
11 nrrallo. 11 !"nato. "'
176
coscir11tc. Lari I o ta arriva. dopo la pau5a d Ilo !> pazio bianco (che n ila raccoltina
del 1551 era occupato eia otto t . ti). nrl onetl X,\Xlr. a11rh e. o ch.iaramcutr
attravrr ato da u11u fratlllra temaliC'a tra quartin e tcr1ine:
' on q11rstc. i\111or. le \aglic 1 rrccr hiondr.
tra rrnw c puro la1tr partr.
cli i JH'!'rHlrr li ramo. <' far 'Pndrtta in parte
dc lr piaghr d1'i porto asprr e pr fonde?
qu<';,lo q1H'I hrl ciglio in cui
chi le mi ,01rli . corn i 'uol. compartc?
.'on qu<'sli gli oeclii Oll(f 1 t110 . trai si partt'r
(\ con tal forza U"i<'ir pot nbhe allrond ).
Deh clri ' I bel rnho in hrcw caita ha chiu o?
(Cui lo mio ri1rarrr indarno pro, a.
n in ci mr . ol. 111a !"arte acrno).
' t iamo a wdrr la rncra,i11lia nova
!'he n \dria il mar produce. !"antico w.o
di panorir cric. li d!'t' rin ' a-+n.
Della Ca:ia ripre enta la truttura int rroO'atirn prop ta da B mbo (RB X\),
ma J'O\'C. ia l'ordine dc i d ttagli fi ici ( lr ce, ci11li . echi. im di occhi. ciulio,
chionH'): lo tupore duhbio. o eh altra\' r o le tre domami dcfini la pre- nza
d ll'imma<rin i iutreccia con le r azi ni del ogcretto innam rato'. cl tenninando il
mom nto <li m ima vrcrnama n il dittic bembia.I1 . L'io con. en-a per un ruc lo
pi atlirn. in particolare 11 'IJ'imt ul o ad aff rrar le tr '. e crli eff 1ti della do1rna
0110 t nuti. r toricrun<'nl . a cli truiza daJJa e lta diAm r c me d tinatari iI.ucr-
no ( \Jnor: tuo -1.ral > ). D p il se nd cruardo -ul ritrallo, il po:ta in
di ri1,1 ondere Ha domanda la:iciata aperta alla fin l I onctto " XIIl. La pruua
terzi11a i anima allora iu un i11terrogazi n ammirat< e ris nl ita ( Deh chi .. ). che
rimarca il sue e , o della pit1ura a fronte d i Yani t ntati''i drllo til>. m1 fallimcnt
al qual co11corr la poesia tout cowt (l'art ) . on qu s1a conclrurna nza
i hiude, per la nobil art di I o. la parabola aprrta dalrirno a.zione e dm uo1
alti au. pci ( fia omrna glmia ... ). rl u ce iYo ritorno. in ultima rnn-
ternplazionc dcll'immacrin pitt rica. ' in f ndo 1111a r azi n au10ch trutt1rn della
io //lJ(' X.1 XIV.
7 L I
. I (l'j' (' ''\ 1-") \l'll"OllO da Dnntt' (R 8. n.
i ,1 trrtT!'>, 1111r 11na 11w1111z1011t p11rare 11',ta 11 " '
1
" "" .
" ) 1 11 11 indifr o 1' 11n1ilor11ntr. 11110
1l6-7.! . In Bemhu le rC'lauw lt'"lllt' 111 dt'H1wli dl'I c1uno1w nttn lllt\ ,1110 n 10-anu11 ' '. . .
. . . . "' "' . . , . I
1
1tc dill'11111111 lll\"l'l't' 111
Iulo d1.,oflpre11z11 (RII\\. \I . 1-6), non una ('011d1zJOt1t'
1
'
llDC '>.\\!\'.ai 1\. :3-i ).
1
poesia. be da' anti alrincapa it di formar il proprio oggrtto non pu che far"i
im ilo alla ,; i ne ( tiam a" d r ... ) e annullcio del ritratto. in 1ue to annuncio
cane llar i. L o diRlf .XCH. rY. 1-2 ( tiarno . . \mor. a v lcr la gloria no. tra/ ro c
sopra natura alt r t nore'
8
) raH rza rimpre 'ione eh rinc ntr con il quadro
dipinto da Tizian ra chiuda ircolarm ntc il dittico nell:i morsa li un trionfo vi:ivo
in 11ua11Jiabile. traordinario (in f rm nove: m ra,ialia n rn. rin va) . eh
annichili e la parola. La celta di collocar ai due e lr mi cl I <littir quei nomi dir
D Ila Ca a apeva b n di do,er in erir nel uo impia tr p rrh fo e brn ac-
e tto (Tiziano al v. 1 di X: ' XIII la ,enczirurn Quirini, de iITTrnta con una compie sa
p 1ifra i. ai \T. 1 -1-l di ,' ' Xl\l l'e\'o azione di Y Il r nata dal mar "'
1
ri h ono
in en o uni\' r alizzant liri o a.Il h il re iduo pi ontincr nt .
Le pur ,;denti diff renz trn i on tti ul ritratto di avor11nan e qu Ili ul
ritratto di li ab tta Qtr: non i aiutano a di ti1111uer J irnma11ini h li hanno
i pirati. il poc h ne la ian intuir non \'ien muui ato ul piano rcf r oziale
e d crittiY . pr nd imo alla I tt ra la raff.11urazione vi ta da Bembo. otter-
remmo un OYale \'UOto. un vi o nza tratti. dalr e pre ione ben vola. circondato
dalla ,; ualizzazi ne m taforica di qualit int ri ri
50
: ruendo Della Ca a. irnma-
ain r nnno un volto altr ttanto 11en ri o ma prob ilm nte pili animato. qua i ,fro
ulla t la. ntram.bi i ritratti no p rduti, ru1 h e p r il primo i propo. ta. iienza
r:ov attendibili. I identifi azione con un di !!no
51
. d J condo abbiamo una opia
mqu ent ca (Roma. all ria Boruh e). ,\l di l di qu to moto dorumentario. la
pazializzazione cJell"interiorit in c nata da 8 mbo b n i adatta allr fi11urc hju, r
e di Giornnni B llini. e alla o truzion di un p ra com J"A/leaoria sacra
deuli Lffui: la vitalit attribuita al ritratto d lla Quirini nza dubbio w1 raratt re
femminili cli ma' anch e I rattulto un topos rh riron-c n -
gli logi del grand pittor ;)
2
. Pi di qu to non . i pu rao'ion volmentr ri a ar . in
-+8 Le <'0'> altere e nove (in rima con mo1e al 1 .. ) . ono rn,e ., ufilimi 1 . traordinarir ( 'amaaata. ronunento
ad lJ prNma u1111 triplite anafora di 1r<li (n -. 3. t , .-). Prr il mo1imc1110 iniziali dr. anche R1f
CLX).\\ Hl. 1. > ( tiamo a mirarla[ ... ]).
-+9 Il "'"wtto X: \"Il d Ila ronda cl Ue Rime di Curzio Gonzaua ( ;o,7\G1 1:)83). ripropone, rol fu1orr
d I cognome della .dama celPbro1a ( hiara P ani Quirini ). la chiusa di RIJC XX.\IV ( La lwlla Donna. 1111zi la
Dea rii<' 1rnc11ur/ d Adria mI ma vlo , d' I Il I I ' 1
,1rlla [ n. J .; ])
- , " na 1 111 11011 a. e i nnorn a1111co thO ne I al'que/ aJ.,1 d1 partorir cC'lt., tr
fortuna dcI . r
11
go di A111orc. Corni (Porli drf ( 'inqurrento. ori /oc. ) rif'orda R1f CXL. 11.
:- . (:
1
1
Cg<io mag!!lor n I m10 ror IPn .I tulor armato ne la fromc 1m'> ). Come e <'mpio ,trrmo di 10110
1
m 1. 1u1 " e dalle metafrirc r' 1rord11 11 110 t 1 'I I " 1 I J J
r . ' . ' I ;, ruoso rii rallo (I 13rllC' (' I p111 (I un ol'l'O o ( opo, Allo(' 1111'
e 1p111grra per Lyo1s n I Berger E.ttravaganl di Charlco orrl (1627-1628).
51 otizir 111 p rduto ritrnuo di \Jara I d I di
1
. . I e una npro< UZIOllC (' ,(mo lll que. IH)llt' 111 OH t' 1989. P 196 ,.
f.l!Pf CT\I 2000, pp. 168-169.
02 \on molto di pi a1111rendia11111 dal t J 1
I - . . , onc w arrumano 1 "' 1cato a un ntrauo drllo a nohilclonna. li te 10.
' li' npono uifm t ? <' allraato a una I 1 ' )" f 11 I -
. , . I
1
. - r tera
11
1z1ano 'r ott irr 1.)4.3 compo;to appon1111me11Lr ou solle-
< llazwm ( (' J>lllore (' 110110 tante la cfrbrc h . \ . I , ( I
III. p.
60
). e r
1
0 Lnnw reuno a etto ma non s1wgnc la M111 cfa11Lasia /, .
178
rapporto ai du dipinti . da te ti che ci appaiono diver i oprattutto percb diver i
011
i po ti. i m di l circo tanz della mpo izion . l due onetti di B mho ono
dorniliati dal rapporto appa ionato ron il ritratto ( imao"ine mia), g mello dipinto
del irnulacro int rior r interi utor coimolto in una rhenna11lia amoro a. e per
questa via appro<lauo a tilizzata rapprr d:I mondo inl -
riore d uli amanti, compo ta dall \Jrtu cl lla donna e dall pa 1001 del p ta . . \I
contrario, Della 'a a elimina i riferimenti all'immauine nel cu re e a um la re a
delr int rna parte om compito della po ia. ma non !!iun11 a formare. in con-
creto r nel te t . un ritratto interior della Quirini. Cn'e cuzione he pr . inde da
dichiarazioni pro11rammati hc (RB I -, r) i ntrappon a un pr !!ramma
rhr Yien formulato ma non compiuto (RD III- XXIV). Qu ta div rgenza
conf rmala dal e nfront e n i t li ordiali d i ri pettivi anzonieri: Piansi e
cantai lo strazio e l'aspra auerra Poi clz 'ogni esperta ogni spedita mano, pur
impar ntali tramit le \1u -
1
rifl tt no molto di\'er am nt ul dir' ullo til .
ui proiettati ver o l' emplarit e er o la gloria per B mbo, inve in di u ion .
0
olo incerti potenziali. p r O lla a a (Poi eh 011ni e perta. orni pedita mano./
[ ... ]/ pi!!ra in eguir oi era alma uentile./ [ ... ]/n p ria lirnma od uma-
no/ f nnar ua l da a voi par n imil [' "l. 3. 5-6]). una on lu 1on analo
11
a
porta il raffronto tra du finali , quello d Ila eri dedi alla nell Rir:ie di
B mb ( ... Xll- ' ' YII)";.i qu llo della equenza a iana edita m antoloITTa nel
155P:; . Il neuo C , VI ha una hiu a nergi a p itiva (<eh non pi chiara
a ai , p r entro 'l f col d la futura t. con l mi rim I !!i la vera
VO tra [ . 12-1-l]) p r quanto ror 011lio O onn nt f i de] Y. : p
11
gI. lpOt "l
e onliale ( ' in me. uirina. da lodar in arte/ [ ... ] I f er pan al d 10 I
e l art ( . 1, ])5; rauspi io ripetuto, con pi enfa i, nei veri c.he
II5 : h ' i p ro alzarmi. ov uom per ' non ale./ orto dai dol i amati
53 1RR.\I 19% ha mes o in rilirvo eh il prin ipale mo<l Ilo del primo n no drl ca111oniere ca:.iano re on:lio
di /IB r non di Rvf
" o . . . ( il I 3 il 1""9) alludrVR Jlrobabilmem Bembo
.1; \j lo1oro u que 111 crie (compo tn.., condo 1orw:.ott1. ra e <> . . .
nrlla lel!rra alla Quirini d 110 mami 1;"38: c\ 'oi potetr ( .... ] veder quanto
unpre:-a il iolere
8
im
I
. ' !:' I h' 1 nto penato abbiano o Jli"liar 10nna e stato. e
e< 11 01 orrivere, quaudo e awnuto e lt' que- n m111 por 1 1en:-1 co a r- .
1
..
" altr prima cht io ap1J1Jaar di oro 1111 10 m
a vm p111 volte \l'nut1 iano e mo. 1rat1M ora 111 una malllrra e ora fil a. . .
1
1
r ..
parte akuna potuto [ ... ] lY: '.1. 1930, J.1P l\rl
al onctto , VI i trol'U un altra coppia cli tr 11111 Olllll" 10 alla Qmnru (/WC ' X'
1
1
d'El'
1
p pp
, ( ,, "\' Il ) ' . I e I o Q 1irini fratel I ,,a }('lC8 e cani
aallo) e Jlr prio il n Il in mort e di Brmbo . " ' r mo to a tro am t .
1
. b .1.
" . . d di riuu luorr u enw1a111
amico dd cardi nale. I ,onPlli XXXIII-\\ \I\ diulogano ctmtemporm1eam nt con uc
0
"
(RB I ' - , p<'r il tema, r ,/XXII- , vu. per la donna celebrata).
55 ' fr. UNTI. RLI 1981 , pp. 1 o(' 1. .
l iote
1
omt' saranno in RDC X\ I)
56 Il sonetto ha rim p trarchrorhr ( rnrtl' : nr1c : parte: parte'. - p d T Ora
7
io. t'
rechi di Rif LX\\' 11 ( minor pnrte. ' ' 6), rd rvora grandi p .11. ant1d11: Omero. fil aro, tr!!l IO.
Prtrnrrn (1'011 Lnura che ol . 10 ' cllJ .alla cxpnssa dnl ollO nob1l ro ('0). .
. e . \ "\' " 6 (il cci11lio chr "Ol'Crna le l"O"ht'>
57 Il netto contiene un motivo opli itamcnt riprr>O 111 RD ' n . >-
del p tn amaute) in , une ra rim ccart : art : partt'>.
17
lumi. e part e/ dal suono a r armonie ce] ti eqnalc [ vv. 12- l-t J. A fronte di qu sta
deci:a prnfe ' i ne di f d nella poeia. la racc ltina edita da Bottricrari i chiud con
un giudizio molto limitativo ul poter d Ile parole ( 011 queste, le mghe trec-
ce bionde), che n l uccc ivo a , etto dcl canzoniere i sit uer (RD Xt'XXIV) proprio
in una equ nza profoHdarnent ernata dal confr nto con Bembo. Il onetto XXXVI
oncepito a concorrenza di e stata foste 1oi nel colle Ideo (RB CXXXJTI)';a e il
, , xr. compo-to nel 1 -l6, nello te o t mo di temp ciel no tro dittico. r pondr a
una propo ta del mae' tro (RB CXLI) on una dichiarazione di po ti a nrtla guair.
ancora una rnlta. il tema del ritrarre alnenta la rille , ione ncaati a della por. ia
-u te a (mentr'i olore al mie cart ap rcro/ aduco [ ... ] [' . ,)-6]).
Que ti Yer i accolerono rer dit di Bembo in ieme emano una li -tanza. ri-
fl ttcndo fapprodo radicalmcnt pe imi tico della meditazione inne cata dall'im-
magine dipinta. La p ifi it della ril ttura ca iana d i due onctti 1:iul ritratto di
Laura i e prim -oprattutto nella ignificativa e'ten ion del ruolo de'lrio-po ra;;(
1
,,
che rif ri ce a e te o re pcrienza della rappre cntazione (formar) e , i mette in
di u ione come arti ta sen::.a eliminar dal rampo lirico (e dafforizzont del suo
ragionamento) il pittor e il ri1ratto1>0. Proprio la r i tcnza cl l paradi!nna figmativo
nella ua fonna concreta. incarnata dal dipinto di Tiziano pre ente insierne alla ua
fomia metafori a (il cpinger antando ). riv la racutezza di Della Ca a lettore di
Petrarca. Per entrnrnbi I' arti ta un imi] ma oprattutto un altro da . e proprio
in quanto tal un termine di paragone
61
Il di cor o chf' Petrarca trui e attra-
Yer o il rapporto tra il dittico il Can:::.oniere, tra il ritratto dipinto da imon r il
tentativo impo ibile di cantare Laura, in Della Ca a rifle o nella t:ruttura della
raccolta e riportato alrinterno del ditti o te o. dov r ammirazione p r il capola-
rnro di Tiziano e il fallimentar ritratto delr inierna par1e ono du facce della
te a intuizione. D lla Ca a int nd il dittico ome rgani mo. come rnoclto con
potenzialit . trutturali in o al enizio di altre co truzioni. n Ila ua architettura
doppia riproduce la parabola delr arte eri de critta da Petrarca ( daff ammirazione
.),8, I! tra 'e str1ta coi nel colle Ideo (RB C 'XXJI J) ,. La beffa Greca, onde 'l paslor ldeo (/WC
XX.i '{\ I) P tato studia10 co11 attcnzion<' da D1LEmu 1997 (pp. I 10-111 e 11 o+ - I );') ). dir 1omt aurhP iu
qticol? ra o la rru, u a pwno d1i due lr ti (11 almeno in pani' realizzata in rollai oraziour. n oncl10 di Bembo
a:;sor1a due .luoghi romuni d lrrnromio <li oggf'lti fl'mrninili. il giudizio di Paridr e l'ipoirtiro ann111lameuto dr!
ll'lll)JO nrl pian? ed rlf'l'llO d1%1 ('Cll'brazionc: Elrna ('Laura. altraverso OntPro (' Prtrarra. ('Ol'l'i pondono
aochr alle l"J iL1lita p1u alte dclla poe ia.
59 Di altro ani'-0 ffAus l.'DRO 2006. pp. 215-216.
60 .;1 molte ris;rittw:e quattro-cinqwrPntescl1c di R1f LXXVII. il porta perimrnta i11 r < 11011
.irti U! l 1ri:uff1.r1e112a drll corch10 ed Ilo stile umano (cfr. rnpra.: 2.8). ul e s1wli (ffrtti 11(110
scompar.,a drll dalla cr11a dtl te.io dovr mo i ornare.
Casa a da Volterra di plasmare in t<rra u11 Davide(: ,olia e di copiarlo quindj da due p11111i
eh ISIH OiliJOSll sulle due Jarrr cli una lic f .. 1. d ., 1 11
. ' ., 1.i < 1 at cs1.i. ogt1 a 011tau1c > rau. Monsta11orr. che nel Galateo cvorn
cornr modrllo 11 ranour (cii Rcgolc1) cr110 " t 1 [> 1 I d "'
. . . .
1
e 11gma o< 1 o w ew. 111ten Pva I opera comn11 101111
ia. q11<1.1 un d11no tra1110. con un 1ra1111LO (Cou..ARET,
1
1988. p. 577).
180
per l'opera di imone al ricono cimento d i limiti di ogni art<' umana), applicando-
la alla poe ia. dallo lancio dell'invocazion alfinevitabilr rinuncia . .\el riprendere
quel di . corso interrotto.I il poeta drl Cinqu ento lo adegua a tempi mutati. i11 cui il
uc esso dcl ritratto ormai trionfale ed la po ia, talvolta. a dov r riconqui ta-
re un ruolo: quc to forzo. for incori.ap vole, di attualizzazione. riv lato dalla
trn ione tra il carattere chiu o e atemporale di un nucleo lirico. quello dell ' arti ta
di parole he riilette sulr opra <li un pittor . e J'ap rtma impo 'la dal pr ente (un
ritratto. un artista, wrn committ nza). he i e prime nell.appello diretto al pittore
e a un pubblico (Stiamo a vf'CJer. .. ).
3.3 tmtegie retoriche della presen:::.a
Pro pcttando un <leci ivo cambiamento cli orizzonte tematico. dalla memo1ia e
dalla p icologia <lelramante al ritratt come opera: il dittico p rrruche co aveva
offerto alla lirica lma traordinaria occa ione metapoeti a. l'in tancabil rifle -io-
ne dcl ritrarre in carte al cospetto di mmmaaine delre ser amato prodotta
dall'arte. 'onostante la parziale aldatura impo ta da D Ua 'aa alla polariz-
zazione tematica eri in atto nrl Quattrocento. n I XYI ccolo runit liri a di Rif
LXXVrl -LXXVlII. interazione compiuta cli di corso a.moro o e di di coro ulrar-
te. appar irrimediabilmrnte comprorn a, inattuale e enza redi. mentr le linee
rincenti ono pro1 rio qurlle eh ac ntuano lo 'Collamento tra molo o titntiYo e
ruolo e. tef ico dcl ritrai to. A qucota altezza cronoloerica. la di tinzion he ho prn-
po to prr il Quattrocen10 (intrrpr tazi ne en omia ca. amoro a. filo of:ica del
onetto 11 ritratto) non solo r ta valida. ma i rafforza: il proce o di rarefazione
concettuale e cli parcellizzazi ne d 1 t ma fay rito dalla tmttura d 11 raccolte.
or anizzate u ha e mrt ri ca ( ento sonetti. Jiadrigali cc.) tematica (rim amo-
rose, funebri. encomiastiche ccc. )h
2
. La ri crittura ta iana del onetto XX:XlV di
Della a a e in que to n o embl matica. per h' pr 'icn dall" officina giornnil
di un porta eh nella ua carriera criver de inc di madrigali amorosi e di . onetti
Pncomia I ici oli ritrati o. ('perch non appartien a un canzoniere unitario. ma a lm
imme11 o co1pus cr autor . muli ifocal olo parzialmcn le appr dato ali tamp .
Il rifocimrnto ( 011 queste, Amo1; le L1a<r/1e chiome d'oro) procede al limi1e tlel
(v\'. 1, 5. 9). ma i di tanzia da ll"ori o'inale n ila maergiore , corre olrzza, nel finale
e oprattutto ai V\'. 9-11:
'"' 1' I I 1 E 11 h . 11 " ccolo plorano in sen,o
v- rn t' por 1 N'nz1oni a quesl!I trndcuza. lr nmc e 1 . 11r11 1rp1110, e e. <l 11111.10 ' . -Q
paradig111ut ico le potl'llziali1 dell'immagine. i.ceglir11do il ritrailo rome barin1uro !t.RClll
1
.::-:
B!hNCJll ' lRJ\E 20(J: e IJ01.zo, [ 2008, P rn:3. 1egli ulti111i anni rl<I C:inquet\'1110, 11 canz(lilH'l'C di C.hWHI
l .. . t f I I Il 11
1
I >a 11'zz110 intorno 1tllu mortr dd 1
1 ta1uu Il<' uon n1(cha 111 un panorama l 011111ialo e a r 1 og1 lt'!llll 1c 1e. oic.
1
" f
I' I 1 I 'fl I . I
1
1 11 , a 111110 da alcum' meta orr t'
amato. r w t J\11 e la prnnu dalla scc ncla porte e 1 n rtll' ne 1110 o "ru1 urui '
da! ;.in111lano intrriorc.
181
Dcli_ hi dimo tra il paradiso ap rto
in br ye carta. clic ritrar Yorrei
I crcli'io non :ol. ma !"art an', e merto"
1
?
Lo littam nto di br YC arta> p r far p to a paradi > re up ra w1 fram-
m nt di R1fL/XYll a . o iandolo airauaettiv ap rto>, he si pon in forte con-
tra t on il chiu > dell'orio'inale. om r a pirazione a ritrarr la donna. he
ompr nd . tutta la t rzina n I uiro a endent della domanda. i ntrappon al
fallimento ui dato in D ila a a (cui lo mio til ritrarre indarno pro a). La ri-
rittura r ve ia ra cu a 1iv lta da imor a te o e alla p ia m una
peranza o p a. pi vicina a quella fonnulata da B mbo alla fine della corona p<'r
la Quirini (RB C XX\ II. , . 9-11). Allo t o modo, mentre in D Ila a a l' in-
terrouazione riman in dubbio almen un i tar1t prin1a di ribadire il trionfo d Ila
pittura. qui il ritratto <limo tra>. nz.altro \'ttorio am nte. il paradi ap rto/
in br ve carta>.
Di front al dittico ca iano. o u}i di imitar il econdo on tto. realizzan-
do una empli e Yaiiazion ul canon br v >, h mette l'a e nto ulla pre enza
dell'immagin non fa il nom d ll"arti ta. Leuato a una u nealogia eh affonda n l
nella !!ioia di ri ono c n1 le bell zz amateM. r rdio int n-ouativo-d itti o
( on que t ... >/ Que t on ... >) ' un mod ilo he i po ti adottan per e primere
un dubbio ir a la pre enza d li' er aniato o el brato p r indicar immagini.
iano e fanta mi ritratti o orpi
65
. ' no deuli hemi pi fortunati nella tradizione
po ti a ul ritratto i forma dunque al cli fuori d I ditti o petrar h o - anche a
partire da mat riali d l Can::;oniere - ace d al nu 1 o d l t ma dall' t mo e 'in
pre a dir tta . r up r8lldo una funzion tipi a d ll' pigramma e co tituendo una
cerni ra important tra ritratto vi iliil e canone d crittiv : dei i allo uzio-
ne t ndono a portar il ritratto ulla ena d 1 t to. m ntr il modell t mporale
(Quando ... >) r cup ra l'attitudin intr pettivo-narrativa d i onetti ul ritratto di
Laura
06
. Di qu te t.r modalit i rve on grande ma tria Balda ar Ca tiulione,
in du componimenti critti in anni non lontani da qu ili in ui B mbo canta il ri-
tratto di Maiia avorunan e Raffaello ritra il lor comune ami o Ti baldeo. Pi della
tretta coin id nza ronologica. conta l'appartenenza dei du ditti i a una t a
irriperibil ta
0
fon di quilibrio di pa ag!!io (con indicazione ommaria ma en-
ibil . i prin1i enf anni del (' olo) h uuarda all corti in i me alla R ma cli L -
on . tempo in cui un canzoni re mano. critto <ledi ato pu an ora onvi er on
6:3 R7'217. n. 9-11. u cui rfr. D1BF.,f.DLTIO1996. pp. 143-1:-:J.
6i Cfr. supra. 1.8 e 1.6.
65 Cfr. ad <empio Co'iZACA 1585, -7 (ma <fr CovACA 1998, p. 91). TA\tP\ 1976. V BORRA 1994, XLIII.
66 Pn il modello rfr. supra, 2.8.
182
una raccolta a stampa. tempo in cui un ritratto(' il onl.'tto che lo celrLra na:cono
in i<'m" e partrcipano ullo Le o piano alla elel razion di una prr onalit e di un
de tino i11dividualc. I cclrbri so11etti dcl pcc hio. v rsi di viaO'gio d'e ili o. for r
ru todi di un platoni o amore per la ducltr a d' l ' rbino .. i riferirebb ro a un'effiO'ie
di Eli abctta Conzaua che a tiglione a' rl.'bb portato ron durant la mi. ionr
diplomatica a Londra compiuta 11cl 150 ), e tando alla t timonianza di ntonio
B ffa :'-lecnini. arebbero . tati ri11 cnuti. pi di C'inquant' anni dop . nel t !aio di
uno pccC'hio. h for av va cu.todito a11C'he il ritratto ( condo al rnli r ffigie
della durhe a altribuita a Haffacllo. ogui agli [ffizi [ili. 11 ])
67
. Il dittico i11treccia
tre climcn ioni t mp rali. il pr ent d li' e i
0
lio> londin .., . il pa" ato d I ,iaO'!!O
dall'Italia alrlnghilterra. il lontano futuro del 1itratto:
Ecco la b lla frome. e 1 dolce nodo.
gli occhi. i lahri formati in Paradi o,
e 1 nwnto dokemcnte in divi o
per man cL\mor compo to. e in dolce m do.
O, i\o mio bel !>OI. perch non odo
le oa\ i parole. e 1 dolce ri o
come chiaro vrggio il 'i. o.
per <'ui b( mpre pur piango. e mai non 11odoi'
E voi cari. heati . et dol i lumi
per far gli o:,curi miei giorni pit1 chiari
pa . ato havete tanti momi. e fiumi.
I lor qui n1l dur es i11Ji in pianti amari.
o. tinet . eh.ardendo. i' me con:,umi.
v r di me pit1 rh mai ar i t avari.
Quando il t mpo che 'I cil'I con gli m111i gira.
havr di. trutto que to frn11il legno.
com "hor qual he marmono antico
Roma. tra tue roine orrJJ "huom ammira.
\ ' t rra11 qu i, do\'(' ancor qui vita 11011 spira.
a . ntemplar re prc a in bel di gn
belt divina da l"liuma110 in
11
crno
011d alrnn ha\T invidia a c 'hor sp-a.
( 7 I
. . . .
1 11
. . : 1
1111
Si11uoru di 11111110 di R11f1wl nn
l so1w1t1 onrel>bcro hlu1i ron un ritratto d1 U' 1,suna e pnmipn ist-1
1
' .
1
.
6
.
I L' I . .
1
I , . > . ., l' diiudel'l' d11 rlu sipna nru no.
110 t a r 11110 [ .. . ] dittro nd 1111 rundr l' b Jlis,uuo >[IN'l' 110. r 1e '' pott 'n
11
1
1111
1
li I f .
1
I
. . . , "' . . I I 1-60 I li I' ,.a 'llt'rina \ lam t' a, e lt' u poi ,u,
101c cri1t1d1sua1111111od l11111110J;>17fur nontro\lltl<t' :> cn neon i "
160
11'
nuora, rwl far rinovnr lu logora dello operchio e terg1'n' lo 11111 tli qudlo (Bui
1
\ EGRt\I o, P '*
18'
Altri a cui nota \'Ostra scmbianzu.
e di mia mano i.nsirnH' in altr I eo
YO 1ro \'alorr. e 1 mio mar1ir dcpiuto.
quc t ceno cliran quel chiaro fuoco.
ch.accro da desio pi:1 hr
nt'I cuor del Ca tiofam mai non fia
L"imma!!in altra,er a i Ire ccnari temporali con funzioni diwr e: prrsenza . oa-
vc rppurt> crudcl perch' n aa a chi la auarda la con olazion tlrlla parola: pirto-
a compagna di m1 diff ile ,iaaaio attrm ro monti> fiumi>: magnifico relitto
opraYYi uto al uo modello e al uo proprietario. capace di mm Yila inun011ale
da\'anti a infiniti futuri. Dalrinrontro tra il quadro. lo. auar lo clei po Ieri
e la loro memoria di lettori ca turi ce anche la pos ibilita di nna .. rconda vii a. nel
ricordo. per il po ta p r la donna amata. Il primo on tto. alla manirra di B m-
bo. mette in -c na il colloquio con il ritratto. individuato dalla cl i i (Ecco ... )
e daU'apo trofe (O vi\'O mio bel ::-. l>: voi >) e oagetto di wia Yi ione ri enata
aali oc hi del po ta. che cono ce il funzi nammto d Ila ca a da hpccchio: rrira11do
u cardini o corr ndo in una f ura. la up r(icie riJl Hent rivela rimma!!ine eh
tiene na co ta. ,ome ha uagerito Lina Bolzoni1>1J. il I ano che il h condo onrlto
immagina on umato daali anni potrebb re proprio qm Ilo della cu. rodia. non
qu Jlo della tavola dipinta (il bel di egno> ). huperstite ma ' copr1ia e re. a pub-
blica proprio dalla di truzion della ca, a. I ver i che fanta -tica110 ull reazioni
deali p tratori futuri danno \ita a una crna in ui il ritratto di nuovo presrnza.
u Tita ammirazione e concede la . opra' i,'enza terna alla duche. mo trandone
l'a p tto. che qualcw10 potrehl e ricono rer e a o :iare ai ver:,i nei quali Ca tiglione
ne ha cantato le lodi. Perch que lo a cada. n e ari w1 d ppio ritratto: qurllo
realizzato dal pittor e quello d pinto> dal poeta (cdi mia mano>). in quanto olo
dall'abbinamento tra la embianza> e il ritratto verbal del va lorr drlla donna
e del martir> cl 11' amante d ri" r il ricono cimento ( cqu , ., ... > ro. Le immagini
enza le parnl po. ono conrnni arr bellezze. ma non 11stodin1<' l'id ntil irripetibi-
le. quella data dal nom ( chr qui a i!!illo del dittico. omt> una firma o
un rpitaffio fittizio) o dal moudo morale ed rmoti o d u indi' ich10.
11 nomt> una parola. e parole ono qu lle eh po ono cl criv r ra11ima. ri
Ritraili cli Tri ino. come vedrrmo: l'mlivrr o interior di f. abella d'E te .- i aprr al
(.,. m;uo.'1 '.WOi. \JY:X\: >!meni tra,mt'i da 1artc a111ograrr (\1ruuo,a. ,\rd1i' io Ca,1iglioni. Compo11i111111
11 poet1r1 mn . . H: pcr 1:u1 ulla luda di Hobcrto \'rtrngno in PnocA<uou <' Hrsso 2009. pp. 1::15
1t1 ). P<'r la b1bl1ograf1a r,,,,rnzrall' r per una l<"t1 ura dci d1u i c-fr. Bouo:-.1 2008. pp. !>8-6-i e 221-226.
69 Bcn w 1 2008. pp. 62-63.
70 La donna ri1rana \'frr rironoociuut in q11a1110 fuoco inl',,tin"uibil(: hr mrtonimia rhr -.r1rli< l'rff<llO al
fHNn dl'lla rau'a di pn f. arcrnt11:t il ruolo dPll'amunte. " r
18-t
let1orr olo dopo chr B mbo l' ha ri onosri ula nellr parolr di J1arro. lv r i ai quali
Ca tiglionr alludr con .. ione in altro loco> potr bbrro r ere altri compo-
nimenti dedicali a Eli ahrtta. rna, a lH'n eden>. anche il primo dei e onetti del
pccchio canta ci11 iemr > lC' doti e tniori drlla donna r i tormenti d tramante.
cli<' piangr e arde; a rigore per. i I valore , i ri f rise a qualit interiori. e in irm
al marlir> crea una comliinazion chr ricorda piutto to l'imrrrcio di co tume>
r caffrtti nrl ' <'Condo onPlto brmbiano (RB XX). n irnile rr ,piro oncettuale.
molto raro nri te ti che parlano di ritratto e lontananza amoro a. in Ca 'liglione
deriva dalla raffinata cultura umani. tica e dall 'ammirazione prr le rO\ine di Ro-
111a"1. ma oprattulto clatrapparten nza a una taaione che i tr va a p rimemar
la fine di un mondo. quello al quale il lrtt rato auarder. qual h anno dopo. nel
C'orteaiano: un mondo li roYinr i] rni pi ndor intearo non potr ritrarre> e
non da 1111 allrove. con occhi po turni. comr un 011110 al quale era pre nte rna dal
quale preferir finger i lontano. in qu lla L 11dra nella quale for con p i onetti
prr la d11che :;a.
3: Lontananze
In quanto . o-,tituto d Ila pre enza amata il ritratto m aaaero di tari cl' ani -
mo. di paure r prome r , e oagetto di una contrattazione appa i nata. fatta di
richie te. rifiuti e conce ioni. MuoYendo-i all.intemo di que to chema enziale.
i poeti del CinqueC'cnto ripropongono oluzioni e topoi ai p rimentati dai pre-
dccc ori, ma innalzano la lingua l tile . nella onda met del pr di-
ligono una maniera intensam nt artificio a, be eredita le arauzie di Aquilano
Tchaldro. In un son tto di Fran co B ccut i ( d tto il oppetta ). il p ta in ria tm
ritratto all'amata, in quanto lei non C'wtodi c in -' la ua immagine colpita da
\mor ( n '. 1-i):
, ('da la mano, onde fui pr r \nto.
scolpito nel cor 'o 1 ro anch "io.
come voi drn 1 ro a I petto mio.
non man lcrri me o a 'oi dipinto.
Or, !I< \'annoia il \Cr almeno il finto.
clw cmpre ta e in 111to umlc pio,
mi ritolrra 1alor dal cieco oblio
l do\'c m' ha \ ' O 1 ra durezza pinco
71 e
1 I ' . : o la famosn lttll'rn li Leonl' \ (rfr.
11>L1" m11r 1 rn.110 1w.1P111t a Huffarllo r 11 1101111 qmN crrtamr1111
1
"'' ' . Il
1
1
,_
o. '>008 . . . . . . I I Il ti .. in dr Laurn a e, nt1q111
IXll.lO\t - . pp. (> Il 11111a dl'llc l'O\ 111r rwlln lrnru r111a-1'11neuU1 l. <Il ' .
1
' ""
di Du B<lln) , ' attualmrute 111 rrutro dtllr rirt>rdtt di \11drt' \\ I lui (Prinntou l mwTrt)
185
e, contemplando nt'I su '" 110 o
i miei "Hl\ i manri e 1 chiu o foro.
quakh omhra di pit'tade in mi i d ti :
ma, ci non mi I ia eia Yoi conce o.
comien che manchi il '\O a por a po o
l"imma
11
inc :,ola a \Oi ne
I..:amant i augura eh la figma dipinta ri ,. a)j n Ila !orma iJ . uo ricord .
qu ll"irnmagine eh la rudclt I ha cancellato dal cu r . e chr i egni cl lla pa. -
ione \i ibili nel uo rnlt > l'ffiQiat la ren !ano piet . a "':
1
. L'alt rnativa in orabile
ar bbe una I nta e n unzion : di lui \'l\"O (contrapp to a finto) rr tcr bbr non
il corpo enza uore, e m nei Yer i pctrarche chi qui rirch gaiati ( fri 1 mio cor.
et quella h 1 m"inrnla:/ qui Yeder pOi rimaain mia ola> .,
4
) . ma addirittura la
ola immaaine dipinta. fraail opia di wia coi ia. In du on tti del \C'ncto Crlio
il dono del ritratto i l o-a a una part nza rmai pro ima (DoLendo eglij(Lre
un lwzuo l'ia gio. manda il suo proprio ritratto a la sua donna ):
Poich, da rio de ti110 altrove pinta
mia frale p
11
lia. o mio bel ::.o! lucente.
luna e n rn. qui re li almen pre nt
a rni con !"alma iu que t"imaofo pinta.
o . mia dura orte in parte \inta.
avr pi rerta p me il cor dolrnt
rh mai non ,,ia nel \INro petto arei nt
per riman r la mja memoria tinta.
E "allor gli ocrhi per pi crudo fato
chiu i mi 6a11. o dipinti almeno
terroali aprrti nel bel vi o amalo:
e p r epolcro av ndo il ''O tro rno.
f1 Ji i e equir avr. pianlo baanato
da la pi t drl civlio almo e rnno.
72 CoJ>l'EITA 191? \Xl 1cliz1'c>1 e 1 t d 'I 1. 1 11 Il Il I I
. . - , 1 ur 1 a a uoruo 1 e < 1 1g ntenlC'ut contro ata ne a rziom. ar )ltr:irm
nrU orrlman;iento. o., na Corni. che i ;,nfCnna ulri,olamento e ulr cocca<,onalit della por ia dcl 'oppctut .
perugino lo a or;la Ca;.a uella rarall<'lta di Ta.,.,o (PoPti del Cinquecento, pp. :)07-509). L(' '-11('
pubbhra1r olo 11:11:>80, un lrrntcnnio dopo la un 111ort!'. Cfr. 13\LOl J;\O 1969 e Pr,1Rocw1 1972, PI"
In uu altro oncuo il poeta. nel conte lo di un innamoranw1110 prr fama. diirdr il ritrullo: critrath' in
ca.ria da mae 1_ra man.o./ un rhr ro gli 0<rhi an or mai 11011 I!' vid ./ bench- le wagia col prn.,irro O"llOra.I clc..,i11
mirar. mentre r eia \ '0t lontano (CoPPFJT\ 1912. CX Xlii. n . 9- 12).
7.3 Cmnc: arcaduto quando l" ha oguuto (dr. CoPl'ETI 1912. I ). 1:a11cggi11m 1110 hilr11zi1J.,o r b nevolo cl1 I
ntrall o nmimda a quell o di Laura dipi uta da imour .\lai1ini.
7-t R1f C XL\ . n. 71-72.
186
O qual "razia mi fia raccol10 e tr tto
e er talor da qurlla bianca mano.
r p r q11 I volto . imulato P vano
lontu11 rapirvi nel mio proprio a petto.
1a non vedrete in lui prr vario aff rtto
turbar la fronte, r me. per doa)ia i11 ano
i be \O. 1r o chi i.,o pirando inva110.
la ha!mar d'amaro pianto il petto.
Ben ne lo p cchio vo tra effiaie e rta
,-i potr far con uc b li zze ante.
qual . ia 1 mi stato in q11es10 e ilio accorta:
a me d' uopo non fa vo tro mbiant
m co ritratto aver: rh ' Amor mcl porta
in \'iva forma e pre o ogn r davante
7
'.
L'impieao del dittico ha qui una funzione enzialment narrativa. che i r alizza
nei du tempi di una br ve finzi n pi tolar : prima l'anmm io di una partenza im-
minent . che coincid , n l pr ent , on la on ema cl 1 ritratto (. 1. "'" 3--:1:). poi la
rrittwa dal luoao d Il' e , ilio. Ha conv nzional <lepre azione d I de tino a\ er o
om rarri ne cl I cli tacco ( ri d tino> e dura ort >).le terzine int.r ducono. in for-
ma di ipote, i fataJ (E 'alloro-li o hip rpicrudofato/ hiu i mifian[ ... ]). una
fanta ia f unebr h non tupi ce i11 un anz nier eh i apr ul epolcro del p eta-
amant '
0
: quando gli o chi mortali cl I p ta arann chiu i p r mpr . l"irnrnaQle
ontinuer a guardare la donna con i uoi o hi clipinti; Il ando Ja propria epol-
tura n I ritratt (per ep lcro av ndo il \'O tro eno> ). l'i p rta all treme on -
211 nz l'a . nza d I rp h part (vv. 1-2) il tra. f rirnento d lranima neU imma-
gin eh rrsta (' . 3-4). D ppio a tutti ali ffeui. il ri tratto, app' o al collo o u toclito
n I cuore. sar p lto nel p tto d Il amata e ba!!Tlato dall e ue lacri.rn . fratt mpo,
per il dono dell' ffgie con ola l'amant an h da vivo pennert ndoali cli imma-
ginare l alt nzioni fsich. d m tive che la donna ri erv r affimmaQlc (7 _, V\'.
1-i), di proi ttarl u t - o. JI volto> di into ,apr rapir . m taforican1ente. la
ua p ttatri atiurand n il pen. iero irmn ra ndolo nella contemplazione cli W1a
ernbianza ent , ma, in ompen, o. n n m tr r pianti e tmbam nti d lforigi11ale
(w. -8) il mutar d i uoi tati d'animo (i l rnri aff tto> ): la condizion delfamant
lontano ar rivelala, indir ttament da lUl altr , piu labile, ritratto: l'inuna!!i.11e d lla
1997, 71-72. Le Rime di Celio M1wno furouo pubblicale a \'cnczia n111 600 imit' lll t' a quelle di Or atto
.u1stu11an.
76 ul ('Unzonirr('- cpolt-ro di ,(li Magn , e in particolar ,ui primi tre nctli delle li<' Runl'. cfr . OR\'I
1
Q8Q.
p .. 16.
d nna rill --a nello -pecchio. eh le <lar della pr pria h('ll('zza r dei suoi
effetti su di lui. Dall"incipit dcl , (' ond tion<'lto i de ' urne che il ritratto che la donna
ricen' di picco! f nnato. com qu ili che gli amami U!-.anmo , cambiar, i. e la ..,rrna
deU.nmaaine ha!mata daJI lacrimr potr I b far pentiarc a un ritrattino da t('l1C'H' in
mano o da portar(' al coll . come quello in do ato. due ::, coli dopo. da Jacopo Ortis. 0
imorno al 1 -91 da Yirninio Orsini. amante pi oraoglio o e molto 111 no infelice: p('r
wrn miniatura attrawr o la quaJe il committ nt manif ta un enti111rnto ambiguo.
un i, tint pastiional n-ndicatiYo --. Tati::i e mp ne un ::,onetto in cui la prio'ionia
mat rial delramcta dipinta([ ... ] al coli app a/ craur a catena [ ... ])cerca di
ri cattarr. ad armi impari ( rd malto es \jy cuorr ). la prigionia spirituale
d n amante ( [ ... ] al la cio -.uo lo tien" pe o \mor r
11
La limpida certezza interior con cui Celio affrrma cli non a\er bi oano
del ritratto delramata. in quanto la ua imrnain empre con lui (72. w. 13-1 i:).
condi,i a da qua i tutti i poeti. ma molti rn 11 a rerlamar dalla donna una cou-
.olazion \' ibil
7
Q tro,ano chi ' di po t a intere d r p r loro. procurando i in -;e-
gr to le effui de iderat . [n n tt cli Y ronica Gambara ml ra acrompagnarr. con
benernl incoraa!riamento. l"im1o di un ritratto feruminilr a un anonimo amantr:
Cono rendo. , i!mor. o. a pi ITT"ata
non che awr \irn c lei
he pi eh te tes. o ami ed amar dci .
per r:,srr di bellezz un ira nata.
ma non potendo a'' r talco. a amata.
com "io pel hen d. ambi 'oi duo ,-orrri.
penso che. 11on ,fra U\ er poi J i.
caro ti fia ('he in carta a t ia data.
7? Co_uw in una ll'ltl'ra di Ta,,o all"Or ini in cui ,i fu cenno aJ ritrattino (1:>91): c\011111i ,0110 di111r11ti
cato d! r_hc \o,lra ?li _rom11!a11d ru1ti111a \Oltu ch"io la \'iddi: [ ... ) LC' mando il 0111110 cli!' tunlo
mc1>1ro di dr,1derare: e 10 fo,.,, cosi p1rno d anwrc. come \ w,tra Erel'llf'nza. o d1e mi i ul111r110 -,1'ntir nrl
cuort' in r1uald1e par11. imec-1 rii qtwlla malinrnnia chr di conti110,-o mi 1ra,a11lia: U\TP for-i rn11111aguiorr afftt10
r pi 1011\('1J11111nw1111 lodata la bella dm111a rhc \'o ira [rnllmza. o p1r iua"1doria o p<'r '>(""110 di portu
appe-11111rollo10 gentilmente dep1Ut ('I\s. o 1832-18.):). \'. n. 1:31'.;. pp. "
78 hella do_nna. eh 11el fido cori'/ tilt amoro,,o riel pr11oier dipin e.I ('0. dolci nodi priu coi. r anin..,t'/ 1'111'
al Jarc10 UO lo 11_-n .\more./ \'Oi f>f'r consolar ra.,pro dolorr,/ d1t Jlt'l' troppa tfolftna alfin Jo tri11.,t .f
c1ualr \prllc- lu d11a lii fin ,/tal I a\C'tt per man <laltro piuorr./ E ri1111win mira1e al collo appc,a/ daurra
t' ,- .a' _alr./ dol1r 1 rndctta 3"!!ltaglia a f!ra offc,a./ \hi . non pari il /!O('O o pari il malr./
g11hta 111 1 unpre al far 'orcio malto a virn cuorr caualP (/{'/' 1510. 1on111wn1ato in 801.10\1
2008. JIP -
'9 \I . . . C J
1 1
'.'111.1p10 1p101u onzaga Jrl'ga la s1111 dorllla absl'rtll' a fwgli grazia del suo rii rallo 1 srnlt11m: e Poi rht
"
1
r mota pari!'/ dal hrl lc'_"!!'i11clro or mi rii gi11ngf'/ [ ... )/E 1 tolto, i li11 poMia il c-cl11rn1i./ come (cru
dd )_ud or ad or :''lete./ la dr e p11ra./ 11on vi ia gran: r q1111I diletto durrui/ p11 fra tani i
manir '
1
' q11ul \'OJ >rt'tf'/ tul f1a I 11nagu1 vo Ira I' frrdda (RimP de"li 1ccademil"i Lerei. 1 , '- <) - 1-t ).
Il ronfono offtno dal ritrn111111111'i n '"n t. I I d ,.. I I
. , . . ' . lii' rro1w e-. a< c.,1111p111. a oru11111prr111u1 a rr>11111z10111. rorm 111 un
><mrllo cli lorquato \rc1110 lii c111 Gli e tolto dalla s1w do11110 il ritratto c/w Ol'ea di ll'i ( c;urro 1 CJ87. CXI).
188
non in d1 'ul1ro don fa1ir
pi1 dr.,.no rd rxrcllr11tr dw di quella
rhr tanto ami . .'ignor. r danr.
onclr la mando. 11011 romr l<'i hella.
p< rchr '><' insi111w fo. ;,r ogni 11ma11a arti'
dal \!'I" non potria far , ('hiara . tl'llas
0
.
In qursto , ignor forsr dobbiamo 1-ic no e rr Pietro B1mb . invahito drlla
.orel la cli V('ronica. l::iottu. probahilrrwnte la Brrc11ice raffiaurata in una mrdaalia
che il po<'IU imano l'hirs<' al Tri .. ino. B n pit audace d Ila portr a di Corr u!!io fu
la ua onwnima \'cro11i<'a Franco. capa e di 'antare con lo tr . o orgoalio la propria
militanza n lle chiere di .\pollo in quel! li \'cnerc. La cortiiana onc ta d dica
un dittico di hOll tti al proprio ritratto. donato al ventenne Enrico IIl di Fran ia
al termi11 di un incontro am ro ... o. in occa i n d('lla ua ,-j ita trion-
fale a \"rnezia nel lurrlio del 15 . -+:
Come ialor dal ciel umi) tt'tlO
Ciove tra noi qua "i 1){'11ig110 crnd .
r oerhio trrren dal!' alt <)C1g tto
non re-,1i ,into. umana forma prrnd
cos wnru al 111io P' ero rkrtto.
po111pa real eh.abbagliar -,plendr.
dal fato Emiro a tal dominio 1letto.
eh. un -.ol mondo nol eapr <' noi romprrnd1'.
andi"i1l 111io corr
tal raguio drl di, in suo merto.
chr n 111r il natural ,;crore.
Di di ' ri. di tnnt"aff<tto 11011 incerto.
l'irnagin 111ia di di olorr
prc r al partir con "rat"ani1110 ap Ii
Prl'11di . rl' prr \'.rt 1 sommo r prrfet to.
quel rhr la mano a porgt'rti :-i tende:
qu<';,to colpito t' colorato 8'-pctto.
in Ct 1 miu 'i'o natural ,,inteud.
Gi)1U\R1 16. Pt'r la po--ihil!' idrntilrnziont' di Ren'11ic1' ron J,01ta ri111in
cli Bull(H.'k
l\"I . p. ? i ) (' a B1 \180 198?- I ()l):I. I. Il , 21 (' llll. :W:! (:!I llllll7.0 I ;;o;;) t' :!:!7 (9 lllillW_ d_
1
('lii Ct:Ol
1
:
11
(pp. I) proponr p!'r rii in\l'r1irc rordinr. Proprio Il \'('ronicn Pietro .\reti110 ili\ tt'rn I ,uoi ,omiu '
111
nlnllll
dii dudu d l rhino. cfr. infra -t .2.
189
E a e' empio ba o s imp rfetto
la tua vi ta beata non 'attende.
ri O'uarda a la cagion. non a rcff etto.
Poca favilla an or gran fiamma accende.
E come 'I tuo immortal divi.r1 \'alore.
in armi e in pace a mille prove e perto,
nmpo l'alma di nobile stupore,
co 1 de io, di dorma in cor offerto.
dalzarti opra 'I iel dal mondo fore.
mira m qu I mio embiante e pre o e certo
81
.
T1 re che i reca in lllCO.<YJUlO al pO\ero ri tto d Ila poete a vien para<Yonato
a Giove eh a urne forma umana per unir i all ue amanti mortali h altrim nti
non potrebbero o tenerne la vita. Il raggio del uo valore per non fugg alla
donna e u cita in lei uno tu por che la fa tra.salire ( vv. 10-11; 9-11 ); que ta r azio-
ne prova il uo affetto e indu e 1 o pite regaJe ad accettare on gratitudine il dono
del ritratto. probabilin nte una miniatura ( imacin [ ... ]d malt'e di colore: col-
pito e colorato )
82
. - J priino onetto, narrativo-rie ocati o. il re un personaggio
di cui i parla in terza per ona. mentre nel e ondo te to, che coincide idealmente
con il momento della con eP"na del ritratto ' apo trofato direttament ( Prenc.li.
re ... ). Il volto dipinto manife ta 1 a pirazione d Ila po t a a lodar Enrico sopra
ogni misura intento confermato anche dalla lettera in cui rievoca ed e alta l'episo-
dio83. Nella co truzione chia tica del con il paragone a<Yli e tremi (Come ...
co ; E come ... co i) e al centro i riferimenti alla i ita di Enrico e al ritratto, lo
ma cheramento del r otto mentite paglie corri pond truttmalmente alJ invito a
pas are dall immagine ali originale, dalr effetto alla cau a.
81 1995. onn. l-11. commentati, con riferim nto al mito di Danae. in Ro E.'\Tl lAL 1992, pp. 106-111.
82 Per Croce (nella nota iconografica in FRANCO 1949) e Bianchi (in FR.ANCO 1998. p. 119) arcbbe un piccolo
malto colorato. da non confondere con il ritratto dipinto dal untorello (forse qurllo d I '\ ore lcr Art eum
di \'rorC' ter, :\fas achusetts), sul quale torneremo. Per lo smalto. di a cendenza petrarchesca. cfr. anche JUJ I.X
e RT 1510. Per natural vigore cfr. 2.5 e RvfLXYJ , vv. 65-66, in riferimento agli occhi di Laura.
83 All 'altissimo favor che lo Vostra :\focst ' degnata di farmi, venendo all'umil abitazione mia, di portarne
seco il mio ritratto, in cambio di quella vi\a imauine che n I mezo dcl mio cuore Ella ha lasciato drlle . ur ,irt
eroiche e del uo divino valore - cambio p r me troppo avem:uro o I tice -, io non sono bast voi di corrispon-
pensiero, n col desiderio:( ... ] posso con al.cuna manirrn di ringmziamcnto supplire in parte
ali 1nfii:1to .mento delle sue benigne e grazio e off rte fallemi uri propo ito del libro rh 'io sono per dedicarle,
alla ua ed al uo wcni simo plcndor regale pi che ad alcuna mia qu11lil. E nondimen?,
I nel ?re e. paz10 .da) Una angu liS ima rarta ogJia talvolta di egnar i tutto il mondo intierO, ho fnltO
que ." P?ch1 versi , che mando allo Vo. tra Maesti , il disegno, bench ri stretto e rozo, della mm
e .d.clla mia a cd ardculis ima volom rii celrhrar opra il termine d'oani mondana speranza
le mnumcrab1l1 e opraumafl!' doti che dentro del uo gcncro o petto albergano feliwnente. [ ... ] 1998.
I. pp. :30-32).
190
IeJlc antologie tardocinquccenteschr di madriaali
1
com in Ta
0
e in !arino
questi fortunati motivi cl Ila lirica d'amor . empi" uruali n i ecoli. embrano
dcre otto il pr o di variazior manieri tiche co trnite ul filo di una logica tr a e
bri1la111c. In due madriaali o e ibisc? i ofi mi di un
1
ingegno a trattativa (Prega
la ua donna eh . e non g11 vuol dare il uo core. <Yli dia aJmeno la ua imaaine. e
poi couclude clic ali debba donar runa e r nder l'altro
84
). e in un sonetto rende
la caaion perchr pi tosto abbia mandato a donare il ri1ratto de la donna che il
uo m dc. uno
8
:;: il poeta non im ia alla donna il proprio ri1ratto {immagine odio a
ai uoi tr i occhi. al punto che arebbe tentato di e entare la donna dall'amarlo).
ma quello di lei. per h' non c' niC'nte di pi bello. a un compiaciuto
narci ismo {in voi foti le almen vo tri de::.iri ) un.ottima trate<Yia per l'amante
po essivo. perch l'insuperabile bellezza rleUa donna la rend r iinmune da pas ioni
(tiver e da quella per se t es a ( , ..... 9-11): la ola po , ibile cau a di aelo ia coincider
co con la fonte dC'll ' amore
86
.
:3.5 A corte, in flilla e in accademia
ome a cade nell' epi odio rievocato da Ycronica Franco. o nella cena di ricezio-
ne immagiuata eia Ca tiglione. la cena del te to lirico pu allaraar i nel tempo e
nello pazio. dando vita a una breve narrazione. In que ti a' i il ritratto aJTerra dal
primo piano teatrale' allo sfondo di un racconto. dall 1zic et nunc del te"to poetico
alla cl.i.men ione tra po ta d l ri ordo o cl Ila fanta ticheria. I pirat a fatti reali o a
ituazioni pale emcnte fittizie, qu t e'ili tTam pe i co trui cono attra,er-o
l'interazione di ver i e didascalie. I onetti di Ja opo Marmitta ul ritratto di Vittoria
farn e na cono da un 'occa ione concreta (l'invio di un quadro da Roma alla Fran-
cia e gli eff ctti eh produc nei du luoahi)
87
com i due te ti di Pomponio Torelli per
l'effigie della mo<Ylie dipinla da cipione Pulzone
88
, o il onetto che Ta o i11dirizza
84RT154 1!'5.
. D nni 111r ste o: P sr prezza tr il duno./ eh donaJ"\' pi rnro or \i Jl-Otr!'?/ La mia
i'";1to mole,111 quanto lungr i' sono./ Tal chr qua i d'amaru: io "i perdono,/ h 11che um 1
iw_i;I fll' ruor t'./l'un bel SC' JllJ)iaJlll' nitro aprei/ donar, perdi{> '[ gradi te; C' quel vi dono./ In \' \ll fin.ne io lTI
dcs1ri/ n li torca vaghezz11 ud altro ohbietto./ rh ' men hello di \' O do\'unque io miri.IL ol
11
elo o. nu faccia il \'O tni
n;pe1to./ ch'11111ando il pi11 e i miei martiri./ amerete 1 mio amore e 1 mio, perto (R7 101).
86 Cfr.ivi,44.
87 l tre testi si leggono in Rime 1.)6 , cc. 3fr-3f'ir e sono tra critti e conune11tuli in B1Asc111 1 'lbRRE 2003. PP
19-t-198.
88 fl ritrutto fu <:1 erruito nr,,li anni 1577-1578. li sonetto, en g d'oro e d'/1011or rarco et altim> (ToRD.U :W08.
Jfi 15r.) ' b !' : J 11'' 'di J' che prclllfo 1
11e, ,) e un dog10 molto dcl pii 1ore ( dnuso dal . o Ilo motivo! l 11 1\
1
a e
1
' . .
la parola nell'ultimo vcr.o): ri p<'tto al arand<' artista antico. cipione i di,tint'11rn per la doic di :nporn' ho.r
I nffeno. hor il pensiero/ 11 rulll1ginc altrui bella r urndi111 (1 . 5-6), di dare spirro e C\:iiu opern rnn
1
,
1
MIO stile>. 11 madrigalr 158 afferma che, risp
1
110 hdli i begli O!'chi e 'I dmtro l'lSO (1'. I) puo
191
a una dama h l ha incarirat di con egnar un 'imrnaain retto dalla contrappo-
sizione tra innamoram nto prr fama e p r ritratto ( cda lo di colorite carte:
[ ... ]da finte imaaini non finto/ rin ndio mo.:e [ ... ]
811
). I econdo \Olunw cl<'lle
Rime (1-81) <li \nnibale ua co. il rie rd di un episodio probabilmente reale 1r -
nrra w1 arauLO canon1cci narrativo:
Il d chC' la cremi! Camo.a inrnao.
pompa dei Lu-itani e de rlbt>ro.
prr far e I paragon pi hiaro 1 \WO.
,.i vidi oppor ben fui del fo1 prrsago:
b n ape,:io. he rn n I crgiadro e rngo
dC'I rn tro fora qu I . mhiante altero
qual poi m . tro ,,i: alor drntr 1 pen icro
al Rodru10 i renda. di i. 1 Tacro.
\'idi (o mi parw <li Yeder) che segno
d"ira mo. trma la r al 6rura
con chi tent qu lfodloa prova:
ma ,oi di trulla crloria umil. I
le p !me:.te. affermando che natura
mai non re tal behad antica o no\'a<>o.
Il poeta ha a i tito al e nfronto tra du b llezze: un e 1 bre ritratt . vanto di
p pa!moli. la dama fran e cui ra i riv la . .\ l ilenzi !ella ment .
non ha potuto eh aiudicar la donna in arn e o a (il cR dano) UJ rior alla
i11nora dipinta (i l Tago). Fin qui i ver i ad ri e no fed lm nit' all circo lanze
illu trat n Jla relativa cdi hiarazione. he id ntifi a la dama ritratta n Gio' anna
di Portogallo:
Ritrovru1do i una ignora France e ornata di ,irt1 b il zze rare .1 d"1m grn-
tiluomo. dove anco in quel punto :i trov r utore, fu a lri fauo wdrn' dal padroni'
<li ca a il ritratto di Donna Giovanna Principe a di Port crallo. timata una d Ile
formar< \ atura o \111ore colpir 1Jl'I cuon. ulln ha; di <JtH' w a' ernbhwgio di luoghi comuni. dtc p1m', 1wlla
fin7iont. prend< forma da\1111ti" alrimmarrine ( \f'"gO). uon ,arebbl> pw.,ihile rapirt' eh il ritrutlO a 111Pzza
firrura e a grandrna naturalr. c-0me i de. umr dalla ua probahil de>crizionf' cfill\<'utario: cl n rl'trall o della
Co1111'" a Isabella mogli1 elci .'ig. outr Pomponio. grandi al naturale. dul mrzzo iu su, on 111111 \(' !>l e di \tlluto
nera r mo trP d"armcll i110. a mano [r io di . cipionr da ,aeta]>.
89 RT u::1s (, 'crire ad 11/l(l .yirrnora la quale rarem ffl(Jlf(/a/o (/ donare del SI/O ritrai/o fallo ad isl1111za d"1111 fra-
Mio de la reina di Francia ). V\.-+. 9-10. La rrgina !li Frarwia ' Eli abettll crA11hlriH. lrl glie di Curio I ': il fratl'llO
(vocato r probabilmente 1100 degli arri1lurlti che piu.avano a Frrrara ('Il Firrm:I' iu vi ita oli< nilrl' !>Onll1 (rfr.
'k.o 1898-1902 111. p. 1:9).
90 Cu co 1:J81 \I. p. -+.
192
pi1 li<'ll(' SignorP di t ttlta Europa. p<'r la cui lwltade gi si ono fatti inlinici ritratti
d"es a: onde' r \ulon \ d111do qurl ritratto in paragotl<' ("()Jl <1urlla .'iirnora hanre-
. <'. dalla qu.al<' <' ra fine lodata bellrzza clcll" r ,1111plar di qurlla figura. uri
. uo ess11np10 qtwsto . 011ct10
1
Limr11zio11e pori ica ade! Ili ra pc>r in una . rirgazioJW fanta io a prr lr in-
terr11i11abili ( enza fine ) parole di lode ri ervate dalla i11nora frane . e al iitratto.
0 pi al uo modello. r es emplar di qu Ila fi11ura,,: olo queU.eloofo
iprr!JolicO C riu Cito a plararc> lo sdcano dC'lrimntaainc. irritala dall'off n' iYa aara
di bellezza ( proH1 : paragon) nc>lla qual era -.tata. uo malarado. coitnolta.
Lazione cli e ibire il ritratto. qui lalranonimo padrone di ea a. in un
madriaale di \1uzio J\lanfredi r compiuta da una nobildornia. la contc> \Iarahrrita
Lango ea. che di comandamento cl Ila i
11
11ora Prinrip a di \Iant rn gli mo tra
cun ritratto della Si11nora Duch . sa di arnia. il q11alc non e . endo in tclaro. nel
mo trarlo. r ') l<'tH'Ya ron ambrdu I mani ' piraato ul p tto'l
2
: ra enza del
telai e il 11 . to drlla dama rrean le condizi tl per un nuovo confronto tra una
bel! zza dipinta e una vera, cht> . i conclude a fayore della conda. p r h il po ta.
imitato ad ammirare il ritratto. i inrnahi ce della conte a.\ Il ca e prirnte ome
nei palazzi di corte. i ritratti oggt>tti e ihiti e collezionati. la poe ia non manca
di alludere i11g guosament<' all pratiche e ai riti iali che li riauardano. U Gua.co
approfitta di lUla 'i:.ita compiuta allo tudiolo ili un tale Jle er Yitale breo
per fare un compli111 nto portico alla dama h lo ac mpaanaQ:l: condo la finzione
<leL onetlo. 11 1 cor. della' i ' ta raut re a\T bb rtato il a ntilu mo a fai ritrarre
la ua cleagiadri." ima accompaanatri ([ ... ] ti/ ha mirar,. di le tue
intenta> [ vv. 1O-I1] ). p r arricchire di un pezz in1paaabil quella ai traordinaria
colleziont> cli meravialir naturali e artificiali: il luoao id al p r a coali r il ritratto
di trn apolarnro dt>lla natura.
l11utile arebbr tentare di tabilirr qual fondament r al abbia l'epi odio nar-
rato in un n tto di \[uzio di e per la ignora Giulia Zambe cari BO\i. dow
il <011,enzion<1l dono d I ritratto i ri11n rn. tra ferito ulla c na d l ouno:
' turn mia b Lia do1ma in parte OY.io
era a vedrrla ed a udir b uto.
QJ lii. e lid1iara1ione. p. 5.
92 \h\tRWt 1587, X. 11. p.
9
:3Gt1 co \'Il. p. -+ . c.\fr,,,rr \ itnl< Ebrr . abitaton in \lt,,nndria. ha anita 11111 di ran"Olirlr.
da 11" I 1 I Jea 1n \"l'flllllt'lllt' ti l''-t'f \ edull' t li
11cror p11rt1 l'Oli mo tn dd1gr nza 1 "JlC'>ll m u11 ;,110 ,111c 10 o, \ "!lfll' 1 o,r. e r-1' . . I .
. I Il ' ' I I I I \ tt 1r 110t1w11n 111 1
'"
111
ll' 1111111w, 11011 1111110 prodottt' dnllu nu111ra rh1 fnhnr11t1 dnll 11r11: t' qua 1 essem o
1
t
101111 <l' I . . (" 1 I .
111
1 )-b) \"iml1 non potrd1lw
11iania una wuora. ferr 'omtto 1\1. < u 1111niz1om .. ; .
llllrrwre unn i111il1 brllcuu 1011 n-Ji abituali mezzi d<I ollczio11i,1a (e( ... ] p1rfomltl aurt1.I nt' [ .] ''
6- ) I 1
1
ri . irr d I . . !I fn,..h q,1111.
1
unc1ur1 piw1a o a farla ntmrrr t' a t 1 on err a nouz1<1: 111111 nct ''"
193
tant pi a dea, quanto m dato
men rappacrar di i ralma ' l d io.
vea, che dotta man vera colpio,
l"imagin he nel r m impr e il Fato:
a me la di de, e 'I d n mi fu grato,
eh ocrni off rto mal po i in blio:
indi volea. U era a ' imile
pur h ' io di i a l'aur a te ta il v lo
tolto. eh noi fincrea ropra g ntil .
.Ma la ri po ta il crran pia r conte e
eh f ucr il onno 1 don fu.rommi : o Ci lo
an o il dil tto 'arma a fi re impr
94
!
L'indi azione che i legg nella ta ola a ert iamo in un onte to onirico
dato non ovvio fino al ' ' 13: ogn 1 utor CYli dona a un uo ritratt , e
m ntre gli domandava ' era a lei inle. i tra va di t ta il lo dovil di ndo,
"quando fu fatto. io non portaya v lo .. > . . ell idillia a ituazion ri YO ata all'iln-
perf tto. la econda quartina mett a fuoco un ritrart olpito ( . ). h la d nna
porCYe ali amant : la rottura d ll. equilibrio inizia! ' andita dal pa ato r moto eh
d ima pr ci amente il g to d l dono (di de . 7). D po aver on egnato l' ffigie
(petrar h camente opra g ntile) la donna i touli il vel eh 1 copr i cap Ili
biondi int rroga il po ta ulla omiglianza tra ' il ritratto: in un CYoco di p hi,
col i che ' gi un ilnulacro natural (la donna appar a in OCYno) int rroCYa il p ta-
ornator ulla omiulianza di unirnmacin dell art ( he a ua olta ritra col i che
mpre a nel uore). L' ta i ' int rrotta dalla ri po ta cl 11 amant ( c nte e>),
il ri veu]io lo deruba d J don ricevuto in orno - un d non I dono per h' 1 appa-
rizione onirica ' di per un privi.I gio amoro o. Il ge to con ui la donna i t li
il v lo. h ne indica lo slalu d il cr a 1 ndizi ni per un giudizio orr tt
eliminando un attributo che non tro a ri contro n Jl i onogra.Ga del ritratto. In Man-
fredi la lezione di ingoli d ttagli fi ici iconografici in corri pond nza <li ia cu-
na g ntildonna e lebrata preannun ia gli orci in ui la po ia baro a fi er i uoi
anonimi 'tipi femminili. mentr la truttura eriale d ll ra olte dove ntano il
numero, r affollamento e la ariazione, e oca 1 pareti di una aall ria o I paaine cli
un libro di ritratti. La illoge enlo donne cantale (1580) ' rganizzata. ond un
crit rio o a ional et mati o per rie ia cuna dedi ata a una d ile cento ianore
e o ate n l titolo, nei Madri ali (1606) oani gruppo di t ti, pr e duto da un titolo
in maiu colo e da una dida alia, i trasforma in una pi ola ar hitetturn. Dal! i11di-
94 \h,nu:nr 1:)80. XXIII. p. 119.
194
tinto 011v nzionaJ bru io di qu t gall ri m r ono olo i nomi <leali arti ti
d li b llczze ritratt alorizzati dall maiu col
Il ' tr mo oppo to i llocano le qu nz di stanze divaCYanti talvolta
narra tiv , in ntrat u un uni a figura. e n i madrigali un framment di r alt
offre il pr t to per w1' a n i n mu i al eh dura il tempo di uno h rzo o
di un
n il slan::. quello t o framm nto diventa ogg tto di una l -
brazi n al rallcntator . eh pand ampli.G a ogni detta lio. u commi ion
d 1 cardinale Ipp lito d ' Mcdi i. ran co Maria ompo un poem tto
di inquanta tanze in lode di un ritratt di Giulia G nzaga. prima ancora eh il
dipinto fo compiut n 1 m h ba tian d l Piomb tra cor e nella tenuta
di Fondi (1532) per e eguirc il ritratto, anch andolfo P rrino, eQT tario drl-
la n bildonna. n cri altr ttante
96
In analo he ir o tanze, n ll"auo to i-83.
'D rquato Tas o comp una ri di on tti ul ritratto di Marfi a d E te: proprio
nei giorni in ui il po ta fu u o pit . nella villa di M d lana. la dama i tava fa-
cendo ritrarr dal pittor fior ntino Filippo Paladini
97
. I on tti critti in quell' -
ca ione e a 11ara on iulio
1
uti fur no tampati. olo un m dopo. a Fir nz da
Giorgio Mar otti i due pilt not voli furono poi riediti n lla rac olta d 1 1593.
con argom nti d po lZIOni.
ull fondo di vili e alotti on lla ornic di ri imenti e riunioni a ad mi-
h , la po ia cel bra na cit nozz , r 11i tra vi it a unzioni di cari h com-
memora lutti di per onalit ont mporan e. cleri ano r i n i quali il po ta
aff rma oprattutto il proprio ruolo 1 brativo, m ntr la narrazion d ll'evento h
' ogg tto di n omio affidata qua i e clu ivament a di da ali di ma.razioni in
pro a. ia una di que t o a ioni pu pr v d r la pr nza o il oinvol!!m nto di
un ritratto la e mmi ion di relati' on tti l nni lurubri o f to i ri p tto all
'
altr ir o tanz l' a oluta p ifi it d I lutto ' data dal p uliar rapp0110 tra la
mort il ritratto la m moria di nomi e mbianze uman
98
. Alla morte di iuliano
Go lini !ff tario di F ITrult nzaaa e prolifi o rimator lcaato ali' cademia
d i ni i, molti poeti ri ro er i in uo onor all t nd un vero proprio
Mausoleo (i tl frammenti appai ro an h in altr illoai in al uni a i
tra formarono il ricordo del 1 tterato in w1 omag11io al pittor h l ave a ritratt ,
il milru1 Ambr aio Fi ino. d .mpio in un antolo11ia a ura di ioYan Batti ta
95 e ' !terzi i intitolano, ad i di Torelli e . c?mpr anche componi-
mcllli sul ritratto ( 111 BRERA J 998, cherz1 11 , , JJ; clzer:.i lii, Ll IX, X.Xlii [/111 ila Bernardo aste/lo
a ritrarre una signora]).
96 fr. hLTER e ZAPI'Elll 2006, pp. 85-87. Per I '1a11;;c I loro ed.izi ni a tampa 1 .58) rim io a
2008, pp. 205-206, con bibliogrnfia. Entrambi i poemetti on citati nelle Le--...z1om di \archi {15i7), P r ui tfi.
infra ' i . I.
97 Il piarevolr soggiomo alla villa venne poi rievocato da Ta o 11cl dialouo La ,l/o/;:;a Ol'ero de !Gmore (1586).
Per deuagli e bibliografia cfr. Bo1.z0Nl 2008 pp. -38-2-i2.
98 rr. Ro. o 1981 , pp. 293-308 1hoM Ol\ Ob Rll rnoxo 1975.
19
Licu1 ( 138.) j l aae un sonetto di h rardo Borcrocrni nrl quale il e mpiant per il
Go elini '.<li fatto, in a. tonat in un loaio detrarti ta ,itt rio contro la mort
9
'
1
:
nelfillu ion della mbianza il oelini non olo gira i lumi I ira (come la
Quirini). ma e mbra cantar il 110\'0 .\peli che !"ha ritralto al 1ualr. in vita.
<ledi 'molti onetti. Pii a,anti nella raccolta i in 011tra110 altri du onetti dedicati
al ritratto d l Go lini ( QC , TI, FIGl.Y. che s rimce spira e BEXjit di te, Pi/lor iL!u-
tre. deuno
100
). che fmono poi ri diti nella illoa urata dal Boraogni ( 1;""99)
101
nrl
prim . il pre ente in cui il ritratto pira e il lini ri org . di1 into. i alterna
n il pa ato he n ricrn a la carri ra i i poetici (vY. - ). per approdarr
al futur n l quale la aloria d l pitt re. elebrato dallo te o o lini J oeta. ar
terna. Il tema d ila recipro it della fama e dapprima int rpr tat n l ano clell
parole. poi del col r . h aT Y c uono del poeta. Lo tes o parndo o
di m zzi i pira alcuni te ti ul ritratto del I r di ator France. co Pan.igarolaw
2
for e
!"opera pi elebrata d I Fieri.no: per Ta o rarti ta agguaalia (r nde imilr) il
color mut a la onora linaua ioa_ il lito Bora ani
10
-+. rillett ndo ulla morte di
quell" aur a. e ri onant tr mba. o erva h n re tan il nome in t rra. l'anima
in ci lo. la memoria d lf a p tto mortale ( dunqu il mv ) nel ritratt . dipinto da
w1 c: maao he re titui e la Yita a chi n c: fuori .
Quand la comm morazione 1iruarda forme femminili. -j ac entua la di ponibilit
ad a i:m.ilar topoi d l repertorio amoro o. com n llr Rime di d,em: nobilissimi et ec-
cellentissimi autori u1 mone cli lr ne da pilimb rao (1-61). ra colte da Dionigi tana-
!!. Tre dida ali leaate a que (o asione rumrn1ciano i r p t ti vi on tti ta iani onw
modulazioni u un con olidato h ma cel brativo in cui il ritratto ' l"ag di un ttil
<.,
99 .\I signor .\.mhro io Figino. che I oro avanti la ua mortr mirabiLnrntc lo ritra.,se (Rime 1587. p. 206). I
\'Cr-.i >ono rivohi al pittore (FIGI\, presago rhe dol'ea da noi} il rifrrimPnto atre, rnt o lut1110 or incorniriato dal
prc emirnrnto delfani ta <'dalla dcci. ione di ritrarrr il Gm.r lini.
100 Al '[imor) Fi<ino. p<r il ritratto Jet (ip;nor) Co <'llini (Rime 1.)87. p. 269).
101 \l ipior Cio. \.mbroio Fi11iao. prr lo rilialto drl iunor Giuliano chr,,li f<ce t e, opra il mede-
simo oggetto (/lime 1599. pp. liO- H I).
1 La '>ezione della Calerin di cledirata a oratori e prrdicatori fa ampi o u o di topoi r arg117;jr I p;ate alla
p11111ra muta e parla11tc.
103 le_l'.igiQ rlie Ta 136.!) tributa al ritrauo d I Paniuarola muove proprio dal de1111glio drlla bocca
Le la b0<ca. a11z1 e qui'! chiaro fomc). rhr inau rura u11a ol<1me t rir di deittiri (n . 1--+ ) che riguardano
trat11 rnlto " preparano il rirono cimPnto drtreffi,,iato . .,imile 111 modrllo nell"w,p Ilo e 1wll'awggia111 1110
co or le faneur ro_me/ e quel suo 111a11 u!'to alto co, 111m : (n . :J-6)) . leni 1898-1902)
r_1pon_a la d11la In lode def .Ytgnor 1tmbrogio Figino per un rituali' del padrP fra1111'.KO Panigarolri ; un libro di
l1turg111 drl prrdicalore era <itaw rormlato cl"inci ione ritratli. tica dal Figi110 (Ba il<. io R'l'. ad lor. ). Cfr. anclw
Cl\RDI 1968. p. 78.
10-+ \rll_a i1111a rarc?ha a dPI Bor,,0<>11i (Rime 1599) il 11sto bili ritratlo del P1rnigarola compare due volti :
a I' 111 ronh''>l? rilevato. m aprrturn della ilJcwr (prrceduto olo dal >onrll al dr ti1ia1ario Ciulio Arrsi). r
a I' l:>'i. 11Plla t-z1om antologica dcl Bor11og11i . iJ1 una cquenza di rrsti rivoli i al Figino. In e111rarnhi i luoghi il
11. to 1 1orredaL<J da una didasialiu (a p. 10 \L ' IG\OR CIO./ CIO FICl'.\O./ I\ MORTF: 01 \IO!'\ .I
I_ia lo ritra1w in ca a. fallo dal >110 l:(wll. pi-1111rllo. inwcc a p. 1S4 c/\I Signor
C10. I 1gmo. m 111onc di/ Panigarola, di cui lia lo '>LUprwlo ri1r11110 i111as11 ).
196
equilibrio enc mia ticow:; _ \cl primo ( Il si<rnor [Giorcrio] Gradeniuo per la morte de La
sua donna lre11<' da .. jJili111bergo ) il porta invita il collega. in quru1to pittore caro a F b .
cio( pcwta. u dipin11rr lrr1H' ( pingilo a mr con til Jecrgiaclro " raro/ che im.igli i11
0
a 11 i part e al vero [ v. 12-13)): nPI conci ( ul ritrailo di do11na lre11<' da ipilimbe1go,
dopo la su 1 morte) . i eone nLra inv re ul ritratto. im ntando un ruO"uta pi crazi ne
p r !!iu:i ti:ficar lo plendorc pri!!i.onato da rnbiante finto/ da mortai mano:
Cert o. po-.cia che 11101ir im ida r,,tinto
r bl.>r il pi caro. il pi prrgiato fior
cli brlt ' ra. t' . mal tuo grado. \morr.
te dal brl -,errgio tuo cacciat o pinto:
tu .. qua1unq11r altro a1brrgo mendo a ,il .
nr J"inunagin di lei chr -. ti piacque
t" annidi e iedi oltr 011ni u ato i.tile
100
:
_\rnor . non potendo pi alh raar in lren . che era il uo eaaio pr diletto. i
' annidato nel uo ritratto, producendo la lu e eh ne promru1aw-. Il terzo on tto
(In morie d1rene da pilimberuo, sul di lei ritratto) i chi de quali g:rancli pen ieri
lr n doveva i pirar da viva. ai dipinta i fa on rare e u cita d ideri one ti.
el onrtto In persona di Bernardo astello nel Ritrai/o di sua moglie morta.
d la parola al pittor , he i riv la in tono aff ttuo o alla con ort p rduta:
Po eia cl1 ' a far h' io dfrtro a te non w
11
11a
debil (quautunque fo11e ) quel dolore,
per cui dal cli r h "al tu 111 rir non mor .
\' ver quc ta 111ia ,ita aborr drana:
deh mira al.men, romr la man di" !!Ila
r ffai tua. che mi re t 11 l ror .
e di temprane! in la!!rimc il colore.
ingannar ali echi mi eri ' incregna.
E e ben tanti pegni amati. quanti
di te strs: a mi la i. o Li,ia mia.
son drl tuo ,olto imagini spiranti.
I 00 Wf' 00.l-50 . . Cimiamo Zarw pant'ripa ulla ,illoe dtl "61 con un nmo pi1 anemo alla prN1ua dt'l
Q
I / di ' I d a e l)llaJ opr1 l\ d lr t ne mmu lren . ed ella/ ,.
e ll('Sla. dw 11 tl'la p11r (' Il' b)lll"I (' \ ll' U. )Jlllla 1111UgO I ('<>gta I ' ' '. . , ' .
. I r . I . I p . . li .... I 1011 . "lit' !!' I 1101 1110-m (' ,lll'Jl(U <111rllti! rhr tal Il
con 1101. 111-.orc li 11gg1 t . l' JJ\"ll. iagru, lllllllnt. t -en.o pm.u 1 'e ' "' . . r .
free. h crnda, ah fl'rn chi di tiuno l'alor 11 pri a? (Z.1..'F 1997. CL.\ \\li [Runl' 15b I.\ I) .
1
'" 1-8).
I 06 RT 50(>, ,.Y. :>- 11.
I 07 \ cli cseugi e '>i di t' del 'oho drlla donna e me di .\111nIT l'fr. supm. \.I\ t' il '
011
1
e
1
1
1
1
. " I di L 1. ( f .r.. s ') I ci Hs o 111otil'o 1111v1111111110011ttto tt' Il
11rel111iano per 11 ntrnllo della due ies'>a rumo 1. lf!Jf(I , , -r . - - ., : l
( IS9:3) di Erl'Olr Taso. cugino di ' lhrquat . per il quale <'fr. \( 1cc:1 200h I' Bi " ''
1
_OOCJ .
197
pur novello d'Amor 111iracol fia
che de l'anima ua cara ai embian1i
. . d' 108
un cada\'erc e tmto anuna rn .
Poi h. nono tante il dolore. non pu l'amata Livia n lla morte Ber-
nardo la imita a ruardare il ritratto eh ta a o nare com la man
di ecrna> r imrna crine rima ta nel uor e orne rea di in crannare gli occhi u ando
le la r11e p r t mprar il e lore. P r quanto cr]i trovi n i ficrli ( peo-ni amati >) al-
tr ttanti litratti in carn e o a d lla mogli
109
proprio da 1 i embra attender i un
ulteriore e impewabile mira olo cl.Amor>: lo doppia.mento tra mod 110 ritratto
fo ia nel parado al au pi io eh la pocrlia nza vita dia anima alla propria
t a immagme ( embianti> ).
3.6 Il sonetto sul ritratto lra elogio e descrizione morale
Parlando di lebrazione poetica del ritratto Pommi r implicitamente propon
una lettura in hiaY rnsariana d l fenom no. ricono endo la funzion tori a e
teorica decrli elogi letterari tTibutati agli arti ti
110
. Qu ta int rpretazion , eri hia
di tr cmar alcune implicazioni liriche. ha il m rito di indiYiduar l' ori ntam nto
dominante nell ri critture rina cim ntali d l dittico p trarche co: in iem alla dei i
di mat:ric epi!!rammatica. la lode rappr enta un el mento ntrale della rittura
cinquecent ca ul ritratto on modalit he i tendono dalle trategie del potere
al campo delrarte. La fortuna dell'encomio. h affonda 1 ue radici quattro en-
te che nella cel brazione d il effigi prm ipe eh , giunge al uo apice nell' et di
Carlo \' e pervade con monotona onnipr nza la rim ria d ila conda met del
e olo, dai grandi. ai minori e minimi, dall corti alle ccad mie. Quando annuncia
a Tornma o tigliani il primo prog tto poetico frurativo della Galeria, Gio an
Batti ta Marino la immagina come una raccolta dei [ ... ] ritratti eia cheduno col
uo elogio
111
Il t rmin compare an he in una ucce iva 1 tt ra a B rnardo Ca t I-
lo, a propo ito delle op r di er e dai ritratti: ' ia cuna favola vien e pr a in un
di eano di mano di al nt uomo; e opra ogru di gno io fo un bre elouio 1 loda di
quel mae tro. e poi o herzando intorno ad e o on qualch capriccio po ti o
112
.
108 .\IAR1-..o 1979, Pillori, e 'cultori, [9a), p. 192.
1 OCJ Prr il motivo dei figli come immagini pi rami d i genitori cfr., ad e .. due . onetti 1as. i ani dedicati alla
to111e sa di candiano Leonora 'anvitalc per la nascita di una bambina (/IT 1994, 561-562).
11 O Po,1Mtf.R 2003. p. i9.
111 \1AR1i-o 1966, 53 (Di Havenna. 1609 ), p. 103. 1a cfr. 1111ch l' ipotrsi di ri o truzione propo ta da CARU o
2009.pp. 191-195.
112 \hRt\O 1966. 78 (Di Torino [161:3)), p. 143.
198
Gambi al nza nell ' u o mariniano illumina un punto importa.lite. prr h la corri-
pond nza tra logio e lod del pittore ' auto vident . quella tra f'lo!!io e om-
ponimento poeti o de tinato ad ac ompagnare un'effgi ugg ri c con idf'razioni
pi compie e, eh coin voi crono la f unzion e lo tatuto del no tro genere.
La e onda ac ezion , m no on notata ( ( ... ] ritratti. ia cheduno col uo elo-
gio) rimanda enza dubbio al m dello del Museo di Paolo iovi.o. in particolar
all ' id a di orr dare una coll zion di ritratti dipinti on i crizioni-dida cali eh
danno indi azioni ulla ita e il t mperamento dei r lati i per onaugi efficriati 113.
Il l game tra ritratti d elocri materialm nte realizzato nella villa o-ioviana. ,-i n
m no tant nell dizioni a tampa degli Elogia dei letterati (15-i6) e decrli uomini
d'arme (1551), quanto n Ila aleria (1619) di Marino. olumi inizialment pen a-
ti per e er illu trati da in i ioni, che. con rammari od gli autori cono muti:
E inguli enirn imaginibu ingulae exemptile tabella.ed p ndent. in m mbrana
vita atqu op rum ummam ontintent , tali erie ut impre oribu xcud ndi
de iderium iniciant, ed p titione p rab urda: nam sine elfiuie mulae pr r u et
in cr nio vider ntur
114
. na imiJ aff rmazion . eh puo uonar para do alr a
chi abbia in mente il cel br d tto di imonide ulla pittura come poe ia muta . . e-
gnala quanto l'abbinamento di imma!!rli e parol fo e enziale n lri pirazi n
di qu t opere. L elogium come lo intend Gio io non ' infatti privo di lecrami col
ignificato originario di eleueion. indicante il di tico pi!!rammati o o pi vene-
ralmente 1 'i crizione
11 5
, o ro con una nozion molto pi n utra, dove non conta
tanto il cont nuto del t to (non n e ariarn nt locriatiYo
1
H') quanto il lecramc
fi ico con l' oag tto h il te to a ompagna: una nozion molto vi ina a quella an-
tica di epi-gramma o pi-taffio. Tanto pi icrnifcati o ' allora eh n Ile due
edizioni degli Elouia, anch olo n lla onda in forma i tematica. le pro e ia-
no ac ompagnate da pi!!rammi. a omporre una truttura id al.mente tripartita,
fatta di immagini (a enti), pro a veri. ul modello del p rduto De imao-inibus
di arrone
11 7
. Qu ta uddi i ione implicitarnent ri ono e ruoli diver i alla pro a
e alla po ia: la prima i fa ari o d Ila d crizion rendendo conto in modo an-
113 li rapporto con I immagini r rrt'upcrato nel te to gioviano dall'indicazione secondo la quale
11
li Elorria in
proba sarthbero tratti dalle tabellae exemptiles app e alla base d i ritratti cu toditi nella 1illa-mu. eo ,u) lauo di
Como. Cfr. C10110 1999. p. 160. ull'importanza d l pre dente di io1'io per rfr. D1ox1sOTI1 1981. Br. 0111
1988, R o 1991 e 2009. , ulla Galeria rfr. anch nLLER 2006 e Rr\'Ou:rn 20 I O.
114 [ ... ) d ocrnuna [ ... ] di quc te immagini e rrispondono uwoli cartigli mobili. contenenti u rartapetora
punti salienti drlla vita e delll' opere, in serie tale da indurre negli stampatori il d iderio di pubblicarli: ma la
richi ta (a urda: infoui cnza imma!rin embrrrebbero muti e enza carattere (I nera a Daniele Barbaro del fi
dicembrt 1544, in G1011019 8, 11, p. 'l; trad. e commento cli onia in C10\IO 1999. pp. 160-lo l).
115 ' Sl 2004, pp. 130- 131 , in particolar la nota 28.
116 L'ha oltolineato li.nonzio nel uo oaggio in1rodut1ivo a C10110 2006, p. LX.: uJ piano fom)(lle. elorp:un!
vale 1wll'opera gio iana iscrizione: un 'at'rczione neutra e non laudativa, b n !riusuficata dalla l'Ompkmrnrnmta
dei lesti ri prtto ai ritratti[ ... ).
117 fr. faff i in C1ov10 1999, p. 161.
199
rhc molto dettaaliato cl i dati \'i i,i (fatt 'ZZ 'attributi dellr figurr ). <' traccia
1111
profilo hiografico e un quadr morale dcl . oggrtto ritratto: la rconda r
rille-sirn. non cl crive ma piuttosto com111rnta ingrano:.amellt(' rimrnagirw o
il per onagaio. Problematizzata n Ila . truttura li un.op ra intcra111 ntt' cl dicata
a immagini indiYiduali. ritroviamo co quella diE.tinzionc di funzioni tra pro:a e
po' ia che abbiamo ri contra! n Il elida calir quattr ccntc clw e he inco
11
tr -
rem nell"cpi tolario di Aretino. ln io\'iO reLogium si compone c:scnziahnent<' di
una de crizion \'i\'ida dell fatt zze. in particolar nel a o d i condottirri. e' di
un comp ndio cli ac ta ('inclinazioni: il] aame tra i due clementi r a icurato dal
caratter morale d lla cl crizi ne li ira dal modo in cui la de ifrazione lei ,
0
1to
in-cri - i uoi tratti in una ete uniwr al di crnbianz ignifi anti. non . enza ri-
cor o ali at uorie 6:-iornomi h
11 8
Le fattezz d l \ olt n n u citano l"inter :.s
d Ilo crittore in quamo tali. ma in quanto indie di t mperamenti eco turni.
Qu to dato oerente on la lta documentaria 11011 e:.t ti a che anya aui-
dat la tr ntennale formazione d lla coli zion e con la qua i a enza. nel te:to.
riferimrnti auli ani ti. I ritratti ( -omiulianti t ri am nte affidabili. non per
pr u rnu o euuiti da urandi arti ti ) n n \' na no de ritti in quanto opcr
d an . ma in quanto t timonian rnbianz aut nti hc. n Il quali i pu l agrre
e tramandare la \i.ta in t rior dei grandi p r onagui
11
'1_
Tutto qu to ' 'al per la part in pro a. ma la p r noi cl ci i\ a riauar-
da la pr nza o meno d Ila de crizione n uli piurammi che orredano uli el<wi,
i commi . i nati ad /zoe
120
dall"autor . I carmina eh ace mpaunan ali efo<ria
d 1 1. tterati adottano qua i mpr la forma delr epitaffio. igill ideale di oani hio-
!!.rafia_- ora dando par la aJ oug tt ora ap . trofancl 10
121
. I" r i rip r orrono
mt t1 am nte la \1ta d I p r nauuio o viluppano una trovata aruuta. ma t ndono
a iunorar l"effiui ,i_ ibil : tranne iH rari imi ca i. il rinYi aJ r lat\'O ritratto in
quanto tal 'minimo o a nt . t nd a oin ider n il d ittico. tratto dominan-
t drlr pi
11
ramma anti 1 d firur 1 til d gli ELouia iovio crivr eh ha-
rurn ima inum populu [ ... ] p r lo ia iuillatim aruu/a bretiitalf d cribetur r:!:i .
118 11 que 10 1cma cfr. \hm.1 200-t.
119 Cfr. i,i. pp. 2:H-2:j.').
120 \linn11Lio in CtO\IO 2006. p. L \J. 1 cfr. la nota 3.
121 Qui mi limito a una brr,e 1,1111plilicaziom: 'epitaffi ' (C10\10 '>006 111 Xli ''"In " "\'[ X\'.\\"111 111
I\ 11 I \ Xl\') - . . . . ,,,,' . -" " . . .
, . ID pruna prr 011a (I\. \\I. .\. \XIL \L\ ). \clt 1lngio di Banolom10 Co!"le. (LIII) ,i d rn<'r
a una un:a figura (Parla Copono ).
122 Ca. i di d1i,i i lianno L 1 111" I \ ' Il \Xl
. . . . ra 1 anu. 111 1 e""' - . . .Llll (l\1). P1r 11 ruppono ira l'fll"ntmrn1 lat1111 r
uo1111111 1ll1Nn fondanH'11tal1 I \I RE'> 1989 [ ' 11 " , I t 1
\I
' rr . . I . . . . ,a "llZIOllC di tratu e l'I \'()Il (' arr I a11nbu11, '('f!Jllllatll da Olllll
"
1
'
1
e mo to 11111 fHC'C'ata fJtr 11li 1101111"111 d" Il
0
. . . . . n uflllC', ma cmprr 11(' I' prose. llOll 111'1 n pet1111. pur lu11al11so11111.
rammlf1 prr 1 quali rumo a \h,o,z10 2006. "'
12:j La moliitudinr ili <tu 1i rilrttti 1' dc,1ritt' 11 I [ J
I
. . ' ,111 I' orrr. 11n111a"ll1<' ptr 1m1111w111e 011 arg11-
1a ll"hlla. C'llalo eia C\ I '>00-+ fl rn1 1 t . 'I" . I . . "' . . .
[ ]
, . . . :- . . : rar mia . .> 111011z10 trac 11c1 111\'CC't' : cl enor111r nunwro di qu<'>li ritrnt11
0110
dr,c ntu on rlog1 clw li .,1g11lano con 111111 bre\ i1t pic11a cli ar ruziu (C1m io 2006. p. 20).
200
Larp;uzia nella forma dl'I capriccio poetico evocata anchr da chr prr
:.crin un.opera fatta . olo di \eri. 1111 \'ero e proprio trionfo drlla m<:'trica nel
a petto pi musicale
12
-1: r ahha tarnm per pieaarr il carati r<' non de criuivo cl<i
te. li raccolti nrlla ezionc Ritraili drlla Galeria. ue La por ia fatta di anC'ddoti.
1ri11gute hiografir r giochi ui uomi pr11. ala in relazione alle immauini. ma non
le a:;:c>cornla rifuage prourarnrnaticanwntr dall '<'cidenlia: no11 fida le opere n Ila
re a del dato figurati\'O <'si a1tic11e inve r al ruolo torico e memoriale della parola.
o in alternatiYa. come chiari Tr la lrttrra al Ca trii . procrd in una direzion auto-
nomamcJJtP artificiosa. In. erita l"inci ione. al porta comp te cli l dar brevrment
il mar. tro t' cli giocare con lr parole intorno> al di euno. Il metro eh pitt . i addic
a qur:.ti ::id1crzi rstemporanC'i r il maclriualc. rrrizio cli acutrzza in ui il vi ihilr
i as ottiglia e rimane. alla fine. un puro pr te:-ito. ' imili pre uppo Li. che di per '
relegano lr iuuuagini ai. rnaraini drl te to ( e non oltr i noi confini). non potevano
rhr <' a. pcral"i con il v nir m no della parte figurati\ a cl lla Galeria: e tretto a
rinuuciare alle inci ioni. Mari.no acwntua gli a p .tti letterari dcl prou tto. a;, econ-
dando una cecit 11i connaturata alla ua i pirazion ir . Il ri ultat . -ulla corta
dei carmw gio\'iani. una trrandr encicloprdia di narrazioni minim . di'i. a tra
racconto in prima p r na. allocuzione e d i i. eh raccouli l"er dita cl l uener
rifondato da Petra rea lo rianima auar<lando alla fa pi anti a della ua tori a.
Gli rpigrarnmi d<'ll"4nto/ouia Greca o Litui ono una font s nzial p r :\!ari-
no, per Tasso e, prima. p r Al andro Piccolomini. p r Anton rance co Raio ri e
per ahri poeti della Roma farn iana. in una fa in cui la lirica allontana dalla
. ua forma canonica. amoro a e pctrar he. a. e al bandona r q1librio formale d I
-.onrlto in nome d<'lla niri eta druli aruomenti e l ll o -ca i ni. n ' un"ap rtura
o C'
tema I ica cli(' i ihri<la di vita e cli e perienza. comr t'ra tato per uli 1tmani ti e p r
alcuni poeti di corte. ma re ercizio di carietas di una pot> ia che e lrl ra oprattutlo
. e . tcs. a.
Marino rappr . enta crrtament. un Ca ' -lim.it . rultima propag!!in di Ull< tracli-
zio11r. ma il rapporto tra ritratto. d scrizi n ed cl gi nella Caleria. ome Yeclre1110,
rornisce 11111:1 chia\ r di I tt1u-a com inc nt an he prr molte rime su ritratto composte
11 I cinquantennio pr rd nl .
U-t P1r lu Galeria. R1 11 "o :.wo:; pnrlu cli cd1lihl'rata 111r,sa i11 eo,ilio cftoll"i11111111gi111 e oN'rrn chr la rncrolta
' 1111 'r,plora1io1w d11l1 po-. .. il.1ili1 1 chllu pnrolu t' cll'lla nwtrica. 11011 di fJlll'llt ddlu pi11urn [ .. . ] (pp. \ \ \-
XXXI ).
12:) c' l\igliato , iu. 1011 I i11l'i,io11i . og11i p1i-:,ihil1 rl'frn111r. o ,ja il rispl'l'rhi11mt1110 drlfi111111atrin1. n _ i
1
_1
un rornl111ivo Yrrbult- i11 una fiuura li11gui,1irn. In Galf'ria pare rirhimltr,i su ,1t--a. nlla m?trruiltta
le11m1ri11. Drllr pit11irt', co . p11rl1m un ri1ro (Pieri. h11rod111i11111 li \ I '""o IQ79. P Sul para-
dO!. o 1hll11 ' 1ed1 di \luri110 11!'1lu G11/P11 (i111ui1io11e l'ritl'a ehr a 11u pan ft'lier. 111111 rnltn dli'
1
romprencla la
111rtuforn) <' .,ulJc na1i1111i ehr ha nei nte11,ori, Pil'ri 10rn1110 nell'introcluzio1w ulla
<'dizione cl11lu nucohn (M 1111 o 200;)). \!urino cdisla ca il ritrailo in_ por>ia eh
1110
<'011111 pittura. Hima111 imc'CI'. 1hi11ri,..i1111tmrn1t r pre--a. lu rorrrl1111011 lnt ntrnllu rd dogw ou l,i qualt [ ... ]
i11tTOclurr 111 .,un st'lt>7illlll' cli ritrnlli (Bn R J<J%. fl t;)Q).
:Wl
3. .1 Ritratto come elogio
Come abbiamo ' to. in Giovio l eloQo in pro a ' compo to di tma d criztone mo-
rale e di un brev r g ' to delle irnpre del ogo-etto che n rispec hiano l qualit
interiori. Ho !ri ricordato come nella r tori a antica ekphrasis d enkomion condivi-
de, ero alcuni ogg tti di e er izio (per on , eventi. tempi e luoo-hi)
126
; la poe ia cinque-
cem - a 'ul ritratto eredita rimod llat ma ben ri ono cibili, l compon nti e enziali
dell' loaio epidittico
127
: lo chema quadripartito eh pr ede biografia, impre e effictio
(ritTatto) notatio ( topea) il frequ nte ri or o al paragone e al topos dcl opravan-
zamento. e l"1eyitabile o tentazione eh tecnicament qu to tipo di discor o fa di
e te' 0
128
In una proi zione in ui il po tari ev luce dal proprio oag tto il t to i
muove u un piano complementar a quello o cupato dal ritratto, ponendo i tal olta
come effi!!ie alternativa. all'i.n egna di un'auto lebrati a po ia-monum nto. RisaJ n-
do. a iitro o dalla Galeria, nel XVI ecolo nel nutrito gruppo di te ti per iitrntto com-
po ti da Torquato Tas o i legge un onetto apra La statua del principe di anca:
Que' tO che pira imperio o in fronte
da ' 'iva imago e placido e evero.
demo di cettro par, degno d'impero:
ben il cono co a le fattezze conte.
e are fu. n fece oltraggi ed ont
a r alta patria, ingiurio o altero,
ma caro a uoi, caro al po ente lber
ebbe al ublime cuor pie voglie e pronte.
Nel vi o mae t, tenor nel p tto
mo tra, e fortuna d l'orrihil armi,
swru di ua virt, l involve e copre.
Manca la man gi pieto a a l opre:
plende or nel fiO'lio, e 'n be' metalli e n marmi
plende via m n ch'in uo ortese aspetto
12
9.
Il pr ente ci colloca insieme al poeta da anti alla viva imago di iulio Ce are
di apua (vv. 1-4) mentTe il pa atone propone una succinta biografia (vv. 5-8). Le
126 Cfr. supra, 1.1.
127 ( ... ] clir e Verse auf 6.ktivr Portriit ind teils chmiihung. teil Lob dcr da:rgestcllten Per onco (Krw z
1981. p. 336).
1
.28 Per .il cfr. Cumus p. 183. d di coro epidittico cle nozioni di ' bello' e buono'
vf'ugono m ns
1
b1lmcute applicat non olo all oggetto dcl discorso 111a al dis or o stf',S o (ELLeno 1997, p. 35).
129 RT1595.
202
inru azioni sull 'asp tto nobile ma toso di que to non tirannico Ce are. fcdel e
caro alla pania e al re di pagna, ono poche e gen riche, in aper1 ura e nella prima
terzina (mo tra). Le fattezze ono ricono cibili p r il poeta- pettatore ( h n
il conosco )
130
, ma compaiono in prin10 luogo ome indizi cli qualit interiori cli
grandezza: fronte, vi o e petto eh man.ife tano dimi.t, ma t e terron.
Allo te o modo, il fatto he il principe ia armato (vv. 10-11 ) un particolare che
non vale per s te o, ome pura traccia vi iva, ma om segno di altro (di ua
virt)
131
La liberalit di Giulio il cui tradizionale attributo (le mani) man a
nell'immaoine, si di tingue lumino a nell' aspetto dcl :fialio (Matteo), che. econdo un
fortunato tereotipo ' il miglior ritratto del padre. imile l'effetto dei ver i ta ' iani
Per il ritratto del Signor Latino Orsini, che i aprono ulla ma t che promana da
I ima.gin per poi i olar un dettaglio i onografico ra enza di lmo:
Da l'imagine illu tre in cui dipin e
dotto e felice til il buon Latino.
qua i pirar veO'g io l' onor latino
e qu I valor che re- e il mondo e vinse.
D elmo potea coprirlo ond' i i cinse
la fronte d al uo duce and vi ino;
ma celar non volea pirto divino,
ch' indi par che risplenda, inerme il finse.
udo e nza plendor di ferro e d'auro
porge pavento; e l'Africano e 'I Trace
m n temerebbe al folO'orar de l'armi.
Mira ancor senza oliva e enza lauro
qual ei prometta altrui trionfo e pace,
e gloria pi eh mili bronzi o manni
132
Come nel sonetto precedente, il sogaetto rappre entato, incarnazione onoma-
tica dell onor latino ernbra pirar dal! irmnao-in , e l'e p rienza percetti a
di cui ogaetto coinvol in primo luogo l'io ( veaa'io ). L'c plicita o cienza
di una m diazione arti ti a e mim ti a ad opera di uno til dotto feli e non
ne indu al una caratt rizzazion , ricono cendo al lavoro d Li anonimo pittor
130 fr. il'" 5 del onelo Hl iano t ritratto del Paniaarola ( cBrn ricono co or I fattezze conte [RT 136 ]).
Per il ricono cimento come prova della riu cita di un ri;atto rinvio al uauato di Creuorio .omanini intitolato al
Figino (Il Figino, overo del fine della pillura, 1591 [ OMA.'ilNt 1960]) pp. 3-+6-3-t?.
.131 Per le armi o la pada come attTihuto principale deJJa virl11s "Uerriera cfr. 200-+: P 243. Per la
discendenza la parent la come g nerat:rci di omi .. Jianze, di ritrarli in arne e o sa, cfr. supm, f; 3.5.
R'l'1619. JJ oggetto Latino Orini, capo delle milizie pontifi ie. che nel 1586 cmlde combattendo contro
I Turchi (Ba ile); il uo cduce Ales.and10 Farne<> .
203
olo la scelta di rafliuurare il condottiero 'enza rimo 'senza arrnalura (v. 9). prr
non na ondern lo pirt e il cipigli . pi temibile dcli anni le c. Pr prio
qua nel rimprratiYo mira imita altri guardi a partl'l i par della grandio::.a, i-
sionr. i I poeta d rive I' a pct t vi ttori o e pacifico dcli' 0f'ini per ncgazi ne.
attraYcr o eani a enti ( sen::;a li\'a r sen::;a laur > ). Il riferiment al ritratto
com oacrett nello 1 azi rom oricriu materiale dcli" -pericnza visiva i ri-
e.luce. ancora una rnlta. al gc to dclrin li azione (Da l'imagi11 ... : cfr. uchto
h pira[ ... ]/ da >)1.1:i . Del tulio ianora10 inv il aratt re l Iropcra com
prod tt d !l'arte.
:-... Ila cel brazion di pittori cultori i t rmini d I rapporto tra I dc ritratto
ambiano. prrch ambia la rrlazione. r ati' a e n n pi identitaria. tra de tina-
tario d Jr Joaio irnmaaine: eppur . anche in quc -to ca o i vcr i 01Yolano sul-
ra petto tili tj . W larnr lei ritrnt1i la e ul 110 Ii ultatO
\ pittori('
ultori onori errnt I o he formule ricorrenti. che ne 011olineano ora la panecipt>
cortesia (
11
ntile. mio buon >). mem r di imonc \Iartini. ora l'abilit de<rna
di Prom teo od ila \"atura (ma
11
0>). P r pieaarc ru od uattributo !'iaaaio> in
riferim nto alrarti ' ta Ta o annota h capi nti, om dice \ri t trl di Fidia 11cl
t de le .\1 rali IJ.
5
no qu lli artefi i eh aiunaono on r art loro a ultima perf -
zione>. 00\-e i attend r mmo.., netti oncentrati ulle qualit d trarti ta ed I u
til . il poeta n ne ita a mett r i al uo fianco. addirittura a rubargli la cena. La
recipro it c n ui pittori p eti i a i urano la fama e tentata dai re n li come
e\'ent imm diato qua i fatale. come in un onctto di herardo Borgogni in onorr
di Arnbr ofo Fi<Yino:
co n10i alnti colori
tenti di far etC'rno il mio cmbiant .
fatto dal tuo p 'nnel. Fi ino. amante
canto i !ITan I r !!i tuoi. ('Unto O'li on n.
Co tu mc o fra i pi[1 d O'lli all ri
li to t'assidi. al nobil f'Oro a\ant .
I' fra l'oprr cli te gradit<' r tante
plcnd 'l 1 uo nome. on e l'oggi 1 mondo infiori.
1 eh dop 1 crirar di millr mille
111 tri. n'andrai da l'Et'iopr adu. lo
al freddo 'cita. e da !'Iberi a E?flndi:
1:33 ull'11''' <l(i dciii id negli Llot;ir1 di Cicnio .,i ,offerma \hn11 200-t. p. 2:36.
1:3-t La <tntralit d111'rffiofa10 r' 11i tto 11 1111 rI 11 1 Il I r 1 \I ("
. . . . " ., u1 1 Hl n11a1to <' 11np 1c1111 111 r rllatr e<' 1111z10111 e 1 11r1110 s
.i:6). dtr
1111
h\
1
duano.d11e oggrui di l()gio prr due <zioni rlclla (,'rt!eria: il hOl("<'llo raffirr11rnto p('r i llilmlli, il
p11ton [J('r 11 fanh. 11 di,1i11zio1H' ragio1111 anrlu C\Rl"hO " "
1:r; \ri IOl<'lr. Lhirn \'iro111arlwa. \I . 11-tla. Cfr. RT898. com11wn10 ad forum.
20-t
n di C"i pago. fu poggiando quindi
dr rnrrti tuoi . cl I tuo va lor
\C'drni le olori!' altrui fa\'ille
1
:l6.
'i tratta di un eloo-io dcci amentc aut 1 brativo <' d l tutto ITenerico. he i ola
nel trmpo ( Mcntr ) ma nou d . crivc il momento della rcalizzazion dell'imma-
uin . riwlando la pretC':tuo it della elida. alia (,1/ ianor Giol'an Ambro:io fiuino
mentre lo ritraem dal naturale): la formula rnentr lo ritra 'a dal naturale> ri-
manda a una situazione codificata. non a un dato reale. p r quant il ritratt di ui
i parla i pos!'ia foce idC'ntificarC' con qu<'llo cui i allude n i ,. r i finali del on tto
I/ , ignor Gio1a11 4mbrosio Figino, essendo l fotor a f ergruzo
1
:r. T -1-i em-
lirano <' eauirr quanto annunciato al'" -i (canto>): la gloria del pota ed l pittore.
con'>egu nza c rta d I cant (Co tu mrco ). matura nrlla e onda quaiiina. ma la
ua immen ita pazio-trmp ral i "ping dalla prima alla econda terzina. ai limiti
dcl mondo e oltre. J\J1aloao inc1jJil trmporal ( ntre [ ... ]ne tu i colori>) pr nt<
un n tto di ,\nuelo Grillo in cui la dida calia i formula me rin!lraziamento (r1
J!esser Bernardo astello pittore Eccellentis imo per ar rio ritratto al naturale):
. ...aggio pitt r. nr tuoi e lori
hrarna Ycder la ua . pira11te itml"o.
chi cl'a\' r ,-ita dopo \ila r \ago.
tu gloria acqui ... ti e ,-ira in mili cori:
e mentre que-;to e qu I fingi e colori.
1 tuo ,alor ...ol di e ..,te .... o pa0 o.
io cl'r..,:-.er da le finto anco m'appago.
prrrh'o11orando altrui . tr ... o 011ori.
(' ere..,., r opra tua qua i mi ooclo.
comr del pensicr mio tu fat1ura.
dal pruncllo cl' \mor 11l'I cor dipinto.
Tu 'i' i mrrn. <' 11r la tua pittura
io tl'eo ho vila e come -.o pur lodo
un'art' ,. ra in un cmbianlc fintol.
18
.
kntr a11011imj m delli aspiranti alr t rnit affiancano l'i (chi d'ayer ... ). al
e n u to ri pcC'clam 1110 encomia lico tra pittura e p e..,ia -i aao-iunae il parali 1
1:36 /lifll(' I :)99. p. I :io.
137 I, il '011 Ilo f',,i11. qui sollo 1111biloso riC'lo (i' i. p. 180): Qui. fni rurc. e frn i ;.u;.piri:/ Il
I " ' ;" I 1 1 1 Il / 1 i111 [1"1 Il 111l' 1wne e fra 1 u1ur11n./ (1t sol
<' t 10 l'Ol1111t c111oro quanto w ( 1 pn'"IO 1 1110 < n 111 Jlt'1111c o; 1111 I
111c111hra11do) a111miro ' I 1110 lnrnro/ d<l 111io ,1111biu111l a mcra,igli11 bdlo (\\ . <)-H).
1:38 /li1111' 1;)87, p.
20-:
i t1tmto tra ritratt dipinto ritratto interi01 , dal quale pa a, attra\' r o la m mo-
ria, la fama onf rita dalle parole. Dal ntr d ll 'opp izion tra pittor po ta.
mar ata da pron mi in po izim rile a.t (tu, io. Tu io) e da po i i m-
-i t uti (tuoi. tu . tua, mio>). la critturn torna in prim piano, on apevol
fal am nt mod ta (io te o ho vita e m o pur lod ).
cli rim di qu ti cont mporan i di Ta o. affidat qua i lu ivarn nt al
palco ceni o d li ra lt antologi h l'clo io irco tanziato di wrn inrrola op ra
embra un' ventualit molto rara. a nferma di una e olar t nd nza d lla po ia
a non valorizzar I p cifi h aratt r ti h dell imrnaaini. I confini d l ritratto
ono pr idiati dal! t parol h lo l brano: i t ti n di on I pr m , e.
pochi e p di nti del pr nd r f rma ulla t la. ali effetti. con un' tentata elli , i
delfoaa tto in 'tJQ. ;'.\lono tant l'int r p r la fi ionomia di .f ur cl l pa ato ia
molto vivo n 1 inqu nto car a mbra la ricaduta po tica d l dat propriamen-
t vi ivo. Il po ta- pettat r i oncentra ull 'identifi azion d l oa tto o di inaoli
attributi qualifi anti e. tra curando l amm01mento he Filo trato a a rivolto a
te o, i dim nti a eh i eh ha da\'anti ' in primo lu o un 'imma ine: 1i no
la ciato tra inar dalla pittura, cred ndo di ved r non delle .faure ma d ali e eri
reali[ ... ] uardiamo dunque il dipinto. poi h' davanti a un dipinto he i trovia-
mo> Ho. Xel produr i di un co radi ato oblio poeti o del vi ibil quanto hanno on-
tato la tradizion r tori le re i tenz del odice lirico. la natma dell immagini?
n primo campo di rifica di qu t influenz ' offert dalla fort di ontinuit
tra onetti u ritratti m hili e femminili. l ondo libro De le rime di diversi
nobili poeti toscani (156 ) a cura di Dioni!!i tana!!i i l ggono ver i eh l dano il
miniatore Giulio lovio la nobildonna romana Fau tina Man in.i tta anti il ui
ritratto ra tato ommis ionato intorno al da Ale andro arn uo illu tre
ammirator . Il cardinal ollecit i m dio ri rimat ri eh la ora ano n Ila ua om-
a lebrar prontam nte l'oc asion . Antonio All gretti elogia 1 impr a del mi-
m.ator com avv ntura re a po ibil da un rinnovam nto piritual lit, m ntr
G1a mo C nei m ena un quadr tto di mani ra:
lo tuoi de gli Amor che b lt par
a la mat ma gli ha ingannati for e
tutti i colori a l'opra n n ti por e
d le co . cha 1 ciel pi degn e rar ,
Fin ?alle nf'lla .notional ecphrasis (cioe nell ' l'rru;i eh ha per 011 euo un'opera d'art puram<'ntc fil
IJZJa) neo tnmonc d<>lla creazion<> ' pri,1legiata rispetto alla descrizion d U'oacr tto finito. Lo rir,0rda, a
propo;,ito d llo udo di.
HotJ.Ml>ER 1 al seguito di L<'s ing. Almeno nella no tra trndir.io11e poe1jca, il d1no
sembra valere anche 11c1 ca.;i d1 aclual ecphras1 >. Per i t ti che i concentrano ul lavoro dell 'a1ti la fr. infra, 4.1 .
140 fiU>STRATO 199 . 28 ( cJ cacciatori), p. 111.
1.41 A Giulio miniatore, sopra il ritratto de la Mancina fatto da lui. in Rime 1565. n, . 4v. Il sonetto r
riportato infra . . 4.1. ma cfr. an hr Ptc. m 2008, pp. 305-307.
206
nrl tuo til come tanta grazia appar ?
h' Lia non ol qual pinta i or .
ma vi a beUa come al cormi core
p r porvi f o. e tram tille amare.
Miracol IlOVO. nr da porlo in art :
calda il rmialio. il candor vivo pira,
non o om e c da I ombr il giorno.
c<lati or e 10, hi tanto alto a pira:
h' non inganni au ei, ma fai c n rart
' . . 'di I H"
a aggi m 1 a, a a natura orno -.
La iva it della orni lianza h inaanna gJj uomini non gli augei (com 1 u a
<li z u i).' tal eh il ritratt r pira e la donna vi appar pr i ament ome> quando
ha fatto innamorar il p ta. Una riu ita co 1 tup facent i potrebb pieaar olo
con ru1 interv nto d ali Amorini. he, attirati da una h lt> pari a qu Ila di Vener
avrebb ro oH rto al pittor una tavolozza di olori attinti alle pi rar b il zz d ila
natura
143
Attrav r una domanda ( p r h' ) una pr alera (Volgi>). andr
uamello gi ca ul f rtunato moti o d li amanti in ri eh au picano il fallim nto d l
ritratt p r h' t mono di er vittim d ll'immagin com lo no tati d 1 modello:
Cl LIO, eh
per h. la. o, formar vacra fiaura
d la ca ta e " ntil Romana int ndi
nova Gamma a' no tri petti accendi?
Ba ta b n ila ol l'alm ne fora:
o Ieri , pr go lo t il alto pittar
altro e mai eh' gli o hi uoiluc nti
h
. ' d d 'I IH
an pur troppo \'Irtu ar m 1 cor .
H2 A Me ser Don Giulio miniatore, sopra il ritratto de la fancina, ivi, . 60r, commentato in Bouo:-ii 008,
pp.
143 P r l'intervrnto degli morini cfr. I 'ta11:.e sopra il ritratto di Giulia Gon:.a!!U (' -1-38) dr! r
1979, opra il ritrailo drlla suo Donna. d Ambrogio Figino (9c'] (lasciate Cipro e qua l'ola/e Amori) P 2-1
14-1 A Messer Don Giulio, minialorr si11gularissi1110, in Rime I. 6 , li. '. 90r. La paura del ritrallo un Irma cht'
compar , ad empio, nei madri"tlli di Muzio lanfredi.
20
aurayersa tutto il t to come intrrl utorr. ma chiamato in ca usa
iu quanto iucon apeYole creafor di Pi crmalioni . cli passioni rad I ppiat<". pi chr
p r la . ua abilit . . \ llrgrctti. , ullr om1 di P tra1'C'a 1t:;. induofa idi inc rlrzze e sui
pr (llimenti I Jrartr. C nei ccl bra !'in ffabile mira olo cl lJ'illn io11r. Guarnello
ne nfatizza I e n ecruenze e ali ffrtti uJl pettatore: tr . Yol11imcnti
m ho diwr i ' i frolrnn cos in tm a tratto rlocrio dello tilc di lovio e in un
omaggio alla lancina. ignorando cprn i e mplrtam ntr I'inunac:rin . prohahilmrnrr
una miniatura indip ndrnte. da cu todir in una atolrt1a>
1
1ti.
e\idrntc che i t ti per ritrat1i fenuninili. non m no d i corri. petti' i ma chili .
ca.ne Lia.no i dali \'i ibili. ' altrettanto vidente che ri mpiono e 11 I m nti diY r i il
vuoto la ciato dalf inuna!!in . Formul rruttLff atte eia un onetto u un ritrntto
f mrninile non ono non in parte l te e prc i lr per un analoao omagtrio I tt ra-
ri.o a una f.!!lira m chi! . )fary Rog r ritiene eh l"i onoarafia cl I rirratto pittorico
femminile tra Quattro e inqu e nto p a det rminato il caratt r dri t<' ti IH
lo elebrano: a immaaini eh in tauran un ra1 po110 particolarmrnte \ ' \' O e n lo
p ttator con-i-pond r bb ro ,. r i "bilanciaci ull"a petto emoti ' o relazionaJeli-.
Qu ta ipote i' mentita da molti ritratti ma chili di i pirazion intima. Gc:rm colt
nella I ro olitudine. in im pazi priYato e fa.miliare. o di po t alla com r azio-
ne> n lo p ttatore
1
"'
8
La netta cli tiuzi n na ,. r i u ritratti ma. hili e f mminili
mi mbra im e ii alir a due fratture I tt rarie ( he a I ro " lta pre uppon11ono
videnti raaioni tori h r o iali). una interna al a n r liri o e una ereditata dalla
pre tti tica anti a m di ,aJe in materia di elo!!io d crizioneH
9
. La prima diYid
po. ia _d.amo1: f oe ia d"en orni c. nte. si at1crnm quando
I dei ruoli contrawi lle all pi con uete r a I cl i grncri e.' suali: <\
ad mpio. il p ta e I bra tma cl nna p t ute e n n il su ron ort . o e il so1111etto
femminile non ' una onda o una t rza p r ona. ma un io. e co t t -
pich ruotano allora di e nf tta.nta !!radi. con oTruJ rumor di in!!ranaaaj metaforici.
in con ruenza di un rOYC. iam nto nei t rmjni n Ila ituazione lirica1.50_ 1 na cono
1-t:J eg1'.alo i l I cl 1iso. la 1ontrappo izionr trn climrrn.ionr ten-enn e idea. r opera "truill' . Prr il
tr LO cfr. 111fra. -+.1. "
1-+6 [ ... ) alruni f>rhati JlO 't'tll'\3110 in C"ll<>I 1t0 n"tra11 I> Il' 1 1 1 f' d"
I
.. ' ' I J Slllll . ( I llHUJO ( I ,. t Ili . ( I s1anon. ( tlllltCt (J I
t omw da loro amair (f 1/e 1. 68 \I J -> 19) \ 1 I Il . "
f . . . . , . . -_ I - .. ahan nro111hce 1 runuw e 1 a \lancuia 111 u11a rena d1ll Offirn1111
,
1
1
'W
1
111
'
da Clo\lo per 11 rardmalr farne e (i\c \\ York. J>it'rpont Librar\'. .. 69. c. :H1}: ccle11tro
'' a tona 11 ntralto dt'lla "
1-t'? Hoc1 R 1986.
H8 D1I n,Lo gli ti' i ..- t t" rr r
r
1
1
rai
1 11
t ia
1 1
111ru11cngo11 0 u11 h n prrci .,11 rapporto con "li o:.:,rrvatori dii r' 111 a
irinc anwr11ale prr rap1rnr la funzirmr e l"cffirill'iu. "'
1 i9 La 11 'a Rourr., non i"11orn drl llJllo < t ' I 1
. ., . . . r . . . . . (IH., o a.,pello. cornt nw a 1 . uo u o dcli sim,sionr panr21rici>
111 nJt rnrn 1110 a ll'>ll ;,11 rttra111 n11Nh1h clf H ' , I ,...
I
..
1
I . . . . 'nai s.mcr poems on 11111 portra11;, nrr pat1<'")'ri co pur1>onincr lO
( ('('[ I )f o Jjt'rtnc nal11rc,, IJIJ('ltlS 011 frnmli )( t. ' t . I' I I k I r . . r
I
"" f
1
' I
11
iai s
1
111 lo Jr b f'[( 1es o a rcla11on lu
1
1. 11111>ha>isi1I" 1hc su-
JJI e lllll) o I u Jl"rlator/poe1/luvrr (Ho .t llh 1986. p. 29:3). "
1;;0 Pi1 compliiau ri1lcfi11izioni cli 11111afor1' t / I li 1 ..
opot e r a por w < umore :.1 vrnfwano quando una \'OC'!' mn:.cf11h
208
,.
0
ci i11tr11 ' cornc Loui <' Lab o Ca para. ' rampa. ,' ul frontr drll'alrra frattura. Ruth
\\ . hb o-.. rlYa chr in o di \ 1'11dom I descriplio11e: p<>rsonarwn i e ncrnrran
ulle qualit morali <'sui do f'ri cl i p r onaggi e olo la de crizione di
Elena. il cui tratto cli t in1 ivo la hrl lezza, ricca cli detta11li vi ivi. l n appr ccio cle-
rrittirn eh coinvolaa e olleciti i scn i rmbra appropriato per . 0110- tti pa ivi. tm
pae aggio o u11a bella donna , piutto to chr per principi e r
1
:;
1
. A couf rma di qu to
principio. la I ellezza fisica. talrnha acrompaanata da un impeccabile on r. da
nobili natali o. h<'n pit1 raramente. da qualit intellettuali. r una compon nt qua i
irrinunciabile nel ca:o di tl'sti su ritratti frmm.i.uili. Per quant in frammenti on-
ranata alle forme t reot ipat dr! canonr>. la bella mbianza pu' e rr d critta
rei un rl<'rnento d ci i\C> p r il ruolo chr . " la n lla liri<a cl'am rr. per I poten-
zialit lll<'tal ett<'rarie di OO' lli di.' cor o ulla b Il zz
1
:i
2
. Per ali uomini. al ontrruio. il
, lto il coq o contano in quanto O'niftcan altro da ': n I mom nt in cui appa.r
ulla uperficir del te to. il loro U!-ipetto ' ai caricalo cli qualit morali e anmmcia
azioni glorio i.;:i . I\ deriva una mac:raior narrati\it d i te ti u ritratti m bili.
do,r l<' rrnbiauz . mae. to e d roich piu che b Ile. ten lono a mpa.r:i.r a farnr
delle \irt e drllr impre c. \aturalment ' po i.bile trovar ace nni alla bellezza
fi. ica di un ign r o di un re. compon nt p r hma temp t'!:I nziale, com ricorda
Curtiu .. nel pan girico cl i ovrani
1
H.
'i rirnli:r a un uomo (em11e in \1idH'la11grlo o in .'haJ.e,prare) o una \O<.'e a una donna in
lniz de la Cruz). 1\011 r m re, ,urio (';,h('I"(' drtm,1ruzioni,li o erruaci clri quel'/' prr \ Cdcre I unportanza d1
'i111ili qt11,tio11i : non rico111hrrrla ;,ig11ifin1. anzi . non prt'ndrre >ul 'rrio lo ,tudio dri lopoi t"' i loro l(:mni con
-1oria dt'lla ruhura. l 11 di,cor.o u pane ,j do, rt>bbe farr prr i p(){'mi narrati\ i t' ta,allrn,t'hi. dove I 11. peno cl11
prr-01111.,gi ma-<hili l'll' t'\ r pi1 aw111io11r dw 1wlla lirica. Comr r,1111pio t'daum1t di infrazimw alla nom1a ritordo
la ll:arn cli hrllnzt 11111;,rhili (P Il' rrlati\'r lu11gh1 dt>"crizioni ) alla line d(ll" ldo11e di Gionunhalli ta .\!arino.
151 f BR I ()C)2 (p. I<).)) 1irnrcla dw Gtoff di \ in,auf fomi,l'l' rlut' e-1.111pi di de. rriptio. whid1 appeal to
i!lt' '""'t'' : r inttn,,mur dw una uhhiu ptr ogruo una donna ( in the forni of an enumerau D Of pnn of hrr
).l'altra 1111 hand1e110 rralr. Comr la ,1uditN1. la definizion di d('>crizione chr l'oc<'idc11t' latino aw-
1a cr!'ditato cl1111"a111id1i1l rra piutto,10 diwNl da 4mllu familiare a partire dalla trudizionr bizantina r.
tmto. 11011 implirarn 1't\tW1l7i011t' ,rrba.le r,11,a di un.irnpn sionr 'i,irn . . \ cl r'rmpio la dt>finizi nr di
nella Rhetorirn ad l/en1111ii1111 cliHr,a da 4111t>lla di ekphrasis 1wi prtH!'l111mw11ata: il conlt'llUto dellt tmmagun
dw lo p. t't1tlo Cicl'1'011 t' di;,tutc l' ,( 111plic11111111t desig111110. non cr rlahoramt , udi l'''o.
l.i2 Cfr. ri,petti' anw111r \ '1cun. I 99CJ e Cn011LR J 98o. t' infra. :l.b. -+.
l.i:3 .;'wll a drll" 1101110 d'arme. 1n11lizionalmt111r. gli ti-1wtti di _trn. fi,i1:a ed
indo!P, \irt1 morali . 111ili111ri (' pnliiii'hr. t'lllht' tlrll"t11iom' in grtwrale. --<Jll O 11 1nfonnaz10111 pm 1mponan11_
l'i1ulagim l.,iog110111ir11 . ( ... J 11 m('(odo di o"l'l'\llzimw dt'i traiti fi,iorrnomiri cli rui i . enr CiO\_io.pt'r la de cnplt0
ptrsomw 'rn111ri \a e' id(11tc111 ntt. anror pri11111 dello ,tudiu drllt' inunagini. dallo 'h('1!111 i_lt',l'rtltlrn 111 1111'.-
tio oratoria di Quimili1111n. e in p11nirolan dallo ,d1r11111(b11mibil11wi libri lii e \ . dcd1<11t111lla /a11 et nl11perat10
ho111i11is t ui lori personae. i11 mi ,i delinin1 il <a tnlogo dr.,li rl('lllt' 111i utili nllu l'OlllM't' n111 della pt'r,ona [ ... ]
(C.1si" :WO:l. pp. 10 - 109).
1.)-1 Pn il pan(giriro in lode cl1i ,o\Tani, fin clnll"epo('a 1'lleni,1ie11. 1 'rpidl'iris ,iata el,ahornla in 6
'i l'lcnnm1110 doti in i.!'rit\ nd ts. hrllrzim, nohile , !irpr. \alor (forma. ge1111s. 11rtus). Ln ultrn 1'
111
r>tt'sa ll os1wi11 quattro pl'ivilr11i nut 11rali ' ( 11ohili, forza. bellezza, ritThen11) t' quuttro ,irt1_. I .11 h
01
:a noli
manca umi r pa;,a anl'lw 111 \ dio E' o. 1011 111 cliffrrenza !' he. al posto ddlt fi 1?11n t'.'emp!un "'!urht'-
01111
'
1
'n' tom>
<jlll' ll r hibli rhr [ ... J La 111rda .\n1i rhi t1 q11t';,lt' 1 cl alm qualit l'01111 tlom parncohm dt>lla ;\aiura: [ . ]
(Ct Rnrs t 992, pp. 20:l-:205).
10
A pre cinder dalla .6 ion mia l id ntit d i oaa tti ritrai ti mediata dall
tatu ial an h u qu to front i ri on tra un' Yident di parit'. Ad rn-
pio n Il partizioni d Jla Galeria ali u Dllill n d finiti da al aori prof i uali
ru li ociali (ad e . Prencipi capitani ed heroi) ond il modello varronian le
donn da connotazioni morali , per h ci h le cont:raddi tinuu I apparten nza
al ner femminile d ' olo pa i am nt , tramite la b il zza 1 on t he i r -
lazi nano al mondo (Belle caste e magnanime). na parziale zion attinaihi l
attray r o le doti arti ti h e int llcttuali (po t . pitui i ... ), la n bil a ndenza
l cari h riv tit (r uin . princip ... ). Alla que tion d ll'individualit i I aa
an h la pr nza del nome, introdotto n Ila di da calia n 1 rpo d I t to. I -
mento qua i o tante p r i ouu tti ma hi1i ma non p r qu lli f mminili, h n lla
maguior part dei ca i non ngono identif ati
155
. Pro dendo da un ma imo a
un minimo di ' identit', i in ntrano f:gur con un n m un unom o un lit lo
(Donna Caterina d'Austria Duchessa di avoia: Giovanna Reina di apoli cc.) 1;;o
pr enz anonim ma 1 gat a un ruolo o ial o po ti (gentildonna, iunora: la
sua donna. l'amata). nerich donne o belle. Formul m sua donna o uafiam-
ma a rnano alla forura ritratta uno tatuto liri o w1 'id ntit d bo! , h deriva
da qu lladel po ta-amante: W1 fenom no imile i verifi a an h quando all 'amata
i attribui e un nome onvenzionale. iamo davanti a pr enze f mmi ai li puramen-
te lett rarie di incarnat evocazioni eh i tono olo di rifl o, n 1 confronto on
il po ta-amante. dal quale clip ndono anche u1 piano irrammatirale e r torico: la
donna i empr. d tramite una perifra i che la r 1 ga al ruolo di oggett
del d 1deno e pr01ez10n d'amor in uno tato ubalterno rafforzato dall'e cntuale
pre nza della ua figura nell'animo dell amante. Il ritratto n 1 uor att ta un do-
minio ma anche unins parabilit material e imbolica dal dominato.
e non rie vono un id ntit un titolo dal padre o dal marito, le donn re tano
fi ur enza nom . di ui onta olo la belJ zza. Ri tta li di virt tati he m -
ravi?lio i di cont mplazion non agi con e non parlano ( e non nei ogni
amano) , ffetti nza e r una ol nt ompiono piccoli
e tJ he hanno igmfi ato olo per h11 o r a. In que ta pro petti a, ' tata
a:anzata. r ta m part convin nte 1 ipote i di on id rare 1 tante belle della
pittura mqu nte ca figure f mm.inili nza nome cl finit olo dal g n r
155 ' RJCHT 2000 ricorda eh ai bu tirit tli di fi r inili. '"
. h I d lif . ra gur Cmm non era qua 1 mai n ano as ocuire un 1 m-
r e "
1
en . amente, auribuendo loro un nom e un' idenliJ (cfr. anche J\10 1995 e 'TINAcLI
d
. le di Beatrice e di Laura, o le gentildonne clai nomi parlanti he il prolocoUo dell 'encomio
e e enigma impone d1 celebrare le do ' d d )
. , nnc amate ru poeti e mquecento quasi mpr non hanno nomi e
pe.,50 non ono unieb .
1-6 \1Aa1M 19 9 pp 227 e 236 fr I u D I
Muz
0
i' 1a f d.
1
anc e i uc 1essa di Mantova m una Medaglia di Piombo (ivi, Il 302).
" 11 re 1 m cn rcgo armente nor d 11 bil
crlebrative (dove l' id ntificaziou d
1
11
e " e no donne che omaggia, ma 11(') onte lo di raccolt
l )
e etenn1nante) e mt ram nte on aerate a fi uri' femminili (ad Cento donne
C(lfl ate. .
210
dalla b llrzza iucarnazioui di un ideale di hell zza e tra -rizi 1 i figurativ di un
modello letterario
15
La t nd nza a trattar 1 individualit m paradigmi val
anch p .r li u mini, hc p r n qua i mpre id ntifi ati I o ono tradurr
te qualita a tratt in azioni m morahili. ome ri e Pommier 1 retino in i t
[ ... ] ul fatto h il ritratto cl 11 u mo ' un 'immagin d l uo potere e d Ile u
virt er i he. quello d Ila donna unimmagin cl lla ua b llezza delle ue virt
dome tich [ ... ] f ur mplari, immagini d I pot r d Ila b 11 zza [ ... ] > i.;s.
Que t cl ppio hema di al ri tr a nf rma n llo pazio indir tto parali lo
d lla imilitudin , dov roi di init riproponuono una netta di i ion di ruoli.
Per le nn i t rmini di paragon on oprattutto V n r ed 1 na, ma anch
Diana, he introduce la ca tit a anto alla b ll zza o uuerrier cl eroin della
toria paaana aera. M ntr l nuove Lucrezie o amille ono pr entat om
mirabili e cezioni, per ali uomini il confronto on dei d eroi ' un dato di fatto
e una on uetudine cui i vien meno m lto rarament . La te a biforcazione i
ri contra l pian dei topoi dell ' n orni . Quando il .ogu tto ritratto una donna,
il ricor' a formul della o ia d' amor pare in vitabil : per lo a ion il poeta
encomia tico ri e te i panni d ll'innamorato e i di pon a e altar ffetti emotivi
ed eroti i dell b 11 zz h anta p r ommi ion . In un onte to o d finito. un
onetto om quello ta iano opra il ritratto del principe arlo di Guisa, ritratto
dal signor urzio Ardizio pu apparir d i am nte in ontrotend nza:
Carlo, que ti ei tu eh' d I bel \'Olto
io ri ono co ben l aria g nt ile
l'or t r o de' rini . a cui iinile
altro non fu mai par o in treccie avvolto.
tu, ma finto; non a colto
la dolce v e man ueta umi! ,
n mi <limo tra in iem il dotto t il
la b Ila man. eh 'a l'altr . il pr !rio ha tolto,
h'io la baci. Dunque il vero a p tto
fa eh ' io empr lontano ami pin.
e I care a oali nz e i d t ti accorti?
Ben par eh tu m a colti par che I iri
un'aura d Ice di pi to o aff tto
dal fr ddo smalto h'a pcrar me orti
159
!
157 I on si pu es luclcre tlll rapporto tra le innumerevoli mezz figurt' di belle dipinte e I anonimato di rnnt
do1111e 1vocat ncll didascalie por1irhc, ma ulla que ti n cfr. infm,, 3.6.4
158 2003, p. 89.
159 RT 65.
... 11
TI poeta j ri\'olgc dircttam nte al princip . eh rico11o!:lc H<'I ritratto ( "" 1-i ). r
re 1)1e ion della ua dnozionc i 8J propria di topoi e toni piutto lo in oliti per liii
te l .,u una figura maschile (:!aria gemi! dcl bel volto. I' or delle chiome. la
,
0
ce dolcc. la bella man ). 111 ntrc il on ucto motiYo dcl ile nzio dcl ritratto (vv.
:}-6) c deffimp . ihile oddi fazione B.ibile j comrrte n II"omaggio cortigiano (il
ba i lelJa mano)
100
.
La cli tinzion ideologica ret rica tra te ti u ritratti e f mminili si
imrecria c n il probi ma I lla d rizionc. Tra I partizi ni d lrcl gio cpiclittico. la
poe ia sul ritratto rie h ggia gesta notatio. ma di rado arcoulic r effictio. come
il critratto> o fo e re up rflu dalla pr nza delrimmagine dipinta o incisa.
l ca o dei ritratti ma chi li . I" impermeabilit d i te<iti ai d Wtuli \'i iyj '>i pu pir-
crare n il ruolo centrai d i mores dell azi ni nella dinamica celebrativa
1111
Lo
o
t o dato appar meno ompr n ibile quando tto la I ntc appannata del po ta
si fermano figm femminili. p r I quali la bellezza li ira molto piLt di una carat-
teri rica: una fonte d'identit un pa,.ag!!io obbligato ciel rapporto con il mondo.
Eppure an he p r que to fatto i-te una pi uazion rhr. come la precrd nte. ri-
i d nelJ' u o cli un codi e familiar alla p ia: e,- care nrnt e im1 ree e nominarr
parti del rpo - no ntramb trat gie eh tenerono chi . criw aJ riparo da un wro
onfr nto con il vi ibile. I rch co-trui e no un cli-cor o tille imrnauini attrawr o
mat riali non vi i,i. che pree i tono a quell immagini - mat riali codificati la cui
finalit intrin eca non la decrizion indi,idualizzante. Come v cfremo. da una
part il onetto u ritratto tende a tra formar i in elogio ( :3.6.2) - 1111 modo let-
t rari o w1 e ercizio r torico - datr altra in una \'ariazi ne ul anone ( :3.6.-t)
- un i t ma de, crittivo pr d finito.
3.6.2 lrmi e imprese scrille nei colti
In una I ttera a :\iccol' .\1 lino del X a tale 1.-10. Pi tr ,\retino riconduce -
11e cl I pro) rio . onetto per il ritratto tiziane: o di Vincenzo 'appello ali' arnmirazionr
provata cla,anti al quadro. in t rmini be p r il maninat automa1i m cl Il la11 -
cli > ricordano la citata l ttrra cli Giovanni D ll a a a a<l 1\le a11clro Farne
[ .. . ) \'f'dendo comr lo. tilr <li Tiziano ha mirahilmentl' ritrattO il mirahilr \"inc nzo
Cappello. 11011 mi son potuto trn rf cli 0011 farei . uso il srqu 11t c so1wtto. [ ... ] Et
' crrto eh la ma< t dr lo ai petto di quello. I' la rccrllrnza drl colorir di <]li(' to.
1
60 PPr Il' Iill<' '' paml1-rima B P<'r il I'. 12 l'fr. /11fL, X\' 111; per cfr ddo ;malto rfr. R1f. ' X I\. \'. 8 r RB \I'\. ' 8.
I (J 1 cTlw -candard fonn or thl' (pid!'inic onuon i., the ('JICOmium. [ ... ) Tlw hody or 1hr ('(l('()JlliUlll ih deHll<'d IO a
. 11111111a 1" or thc !ife or the m 1 11 h< , , I [ ] h I I I 11 1 .. 1
' lll f( praJb( <. . . . ' li < nintrna ' 1ould lw .,11011dtll'\, lw"'''' l'r. to "' 11 0 1 e r t te'
(J1mxe1.; lai.. grsta) (I I V101-.o:-. I %2. p. :m).
Hi:l ('. fr.
. .' : e1. 'l''.ndro rl.i '.iziano (1S-+0 ca .. \\ '11shll!-(ton. \ 111io11al Callrr} of Art. Krros C:oll l'rlion). il
Lupp< Ilo e ntrauo m pH'd1t' 111 an111. 111 q,11 di lllllmiraalio.
212
1110\'<l llO in lllOdo ('hi ](' ('QTI[('lllpla di ' fo forza di lr lor ]audi. O ('011 la
liugua, o con la pruna. Ondt llH' rito u a . (p<r awrmelo paruto romprrndrre nr
lu . r111hiaHza dr I' uom clarissimo) ho tentato di e primerr qurl mo\ i mento rhe i11
IH'n fizio dc la patria. in gloria clC' la religio11e. rin numoria di r. f cc a la Prrvesa
il MIO con iglio gravr r il suo a11imo invitto. Ma rin virttt di fatte azzioni il buon
i <rchio oi vin n(I ron di qut'gli dH' 11011 lo ,idder mai. che debbe crrli fare nrl vo-
. hr gli.., te nipot Di \ 'inrzia il sarro uiom di \ atalP. \l.D. '\..,'(\ \ .
Qu<'I ;,r11uo q11rl 1alorl' ardr11tc
(Qual Ce,,,ar r Pi!'r con \larco uniti ).
... tro dal gran Cappcl ru i al-.i liti
011dr t rrmaro i cl"Orientr.
Hi . ple11dt' in qut'sta forma ('rcell!'nte
\lo ... sa co i propri :-.piriti gradii i.
Da Tzia11 l'iva1ncntr u-.citi.
Ch'ognun di lor re. pira. intrndt. e srnte.
Pl'rtl i in lei ( oltrr lo in"egno.
Oltre l"ardir ron cui -.ua-.c' il Doria
\ dar,, i raie. r a torrr al Turco il Rerrno)
Qual p<'r Cri. 10 arm. a quanta gloria
La patria alzm a. ('('Orli(' a ruomo dccrno
li 111a10 combat ter fu \ttoria
11
.:i.
Pi rtro etino
rrt iuo ancora la e l brazione d I ritratto. che mo tra il )app Ilo in piedi. in
' str di ammira11lio. a m1 pi odio i11 parti olar . la battaulia cl ila Pre, -a. com-
battuta e ntro i Tur -lii n l 15:18: proprio la nobil cond tta ali ra caturita lalla
.ua ag zza e dal uo animo fiero e q11 I m \'im nto h il po'ta ha recluto li
intLrr 11 I uo asp tto dipinto ( crompr nd r ne la , mbianza: . corg ..,i in l i)
ha t ntato di e"prim re in paro! . La pr ' a i Yer i pr don c n ' 'identi paral-
1"". rinsaldando il legam tra p rtat r . ma t d Ila irrma ritratta 'alm:
dimo trato sul rampo. ma il n tto n n d .:pazio a <l ttagli bi i: il rnlor eh n-
ph'nde n I ritratto 'i n azionr ', . il it (mo tr ) in un "irnpre-a che il appello
hacompiuto,ed' 1uc stoci' h j,cl nlrimmagin pr nt ( Quel enno( ... )
i11 c1ue ta ua forma) l h.i.
ln una J ttera dE>l nov ml r 15-: al \a all . r tin int rpr ta il pr pri om-
porre 0111 ap r cd.ire e
11
ringE>crno opra> tu1 ritratto. ri cono ' c 11do l'inY nzi n
come lem nto d ci i\'O n l lm ero della po ia ulrinu11agi11c. La p nua puo d
c1frere i che il poeta" I . ma la i1pE>cilcit d 1 u contrihuto ta n Ila apa it
16:l LJI. 11 , 2:3'+, pp. 2CJ:l -26-! .
IM Alla lllUl', II dcl Cnppcll o (\\ . 1--+ ) fa ris('Olllnl re(' cllL'llZtl di lzillllO (':" ;}-8): in. 1,2-H a:.in
htrll'fizio dt la p111ria. in glorin de la n'ligio11e t'l'C.. Il'" 2 ra rifrrillll'lltO nll alleanza trt Carlo\. il I .ipa e \ (' UC'Zlll.
I(: P (L I \ I )Q I >"'J I'>)
l> rr il \Who rrsphndPn rfr. 11 onrtto sul ntrathl d1I \ - P - - ' -
di couitare e o truire par I intorno a un ritratlo, on m zzi 1 ttcrari indip n-
d ntement dall aratteri ti h :
E CO\"i. ianor Abbat . quel tanto rh h aput dire n rina gn opra il ritratto
del r n.i imo Trivi ano, Duce e me ottimo ma imo. he faten
part on la olita e rre-ia a ria cuno eh i diletta de le rim e eh inchina i Princi-
pi. n n altrimenti che av t fatto di quello da m rompo to in laude de rEc ellenza
d rlmba iador \'arua . d uno che mauuior peuna, e non indotta yual la mia. lo
de rirn. Di a a. Di . ov mbre in Y nezia. MDLlll
Poi he rinclito Due lri\'isano.
ompo to de innocenzia e di one tad .
La !!fazia de la lebr bontade
Lo rive per di\'nO e p r umano.
Hallo ritratto il olo Tiziano.
on l ombr d la propria caritad .
E rilevato in la \'iva itade.
o i lumi d I uo animo oprano.
Onde chi 1 mira in l'aur o colore
E di porpora ornato. in eucio vede
La mae t del enno d l'onorr.
U !!fan diadema in te ta li ri ied .
on quel placido tiL con quel rigor ,
alla l menza e a la ragion ri hied
166
.
om .on tto ul ritratto del app ilo la dispositio dedica la prima quartina
. o??etto dipmt e la onda al pittore. m ntr n ile t rzin olio a le con guenz .
VI ibili ulla tela di que to in ntro cli e llenze: hi v d il ritratto del Tr vi ru1 i
rr:ova davanti alla ma i del enno e d l'onor >, qua i alla loro p r onificazion
VIvente. <in eggio>. Qui ad Aretino non importa rn tt r in rilievo la :fier zza come
ar nel ca o del d' rhino
167
, ori vo ar un ino-olo ento, m p r il app llo,
mal la_ rettJtudine la tatura moral del doge doti tabili che tra paiono an-
che nei e plicitati (la porpora e il cdiad ma che e primono qualit
astratt. ) a mo trare il onetto ( fat n part ) a chi i diletta di po ia e a chi
i pnn.c1p1 n .ntra tra gli e pedi nti abituali di un a entwi ro d Jla penna, h
. a a_var il m uno antaggio dai propri forzi omp itivi, ome la ia int nd r
1
1 nfenmento altro onett ispirato a un effigie ( qu ilo da m ompo to ... )
1611
ullo fondo i mtraved un intr ccio cli int r i e di rnmittenze eh oinvolge i du
\' l,
3
1.? PP Il !!Uito p r la ala del Ma"gior Con iglio, and distrutto n<'ll ' inccndio
e e e;i te UJla copia. probabilmente non autografa. al zpmiiv z ti Muzcum di Rudap l.
167 fr. infra, ' 4.2.
1
68. p :r. riconosc r la. destinazione pratica di qur ti l ti forse non ' n cc ari o arrivar a p n are che fo ro
co0<epiu per r,. re le1t1 ad alta voce davanti ai r lativi ritratti (ma fr. KRu e 2006).
214
ritratti in que tion quello d I Tre i an
ni. om onf rma una I tt ra dello te
uello d 1 arga
169
i relativi ver i aretinia-
me rivolta al B ca.mazza:
la i1moria d I a allo bbate. a quella d I \fartina Ferrante anc ra. ho dato
i due in laude de la Republica e del ardinale Burgo , e compo ti pra il ritratto
d I er ni imo Due e d lo lmba ciador \'arg m d imam nte. Onde parmi di
mio dovere far mo' a voi un pre ente d lo in gloria di Tiziano, nel natural de la
pittura invitti imo.[ ... ]
[ ... ]
L lin e poi, 11 i I r propri uiri
be11 tondeg ria, eh il Do dipint
Par che parli. eh pen i, e che re piri.
Ma perch il moto n l'e empio fu1to,
Dir pu i 'atura. eh n l'art il miri.
e Lo pirto , in lui. d'o a e di carn cinto
170
.
Ar tin dona all'interlo utor un on tto in lod cli Tiziano. non prima di aver
ri pilo ato, com un ammini trat r z lant la pai1izion di un manip lo di t ti
che compr nd i due onetti " opra il ritratto del Tr vi an d 1 ar
11
as. La vita-
lit del cO dipinto>, illu ion d finita con pro!rr ion inY r a (dalla parola al
pen iero al re piro) ,' un ito tili ti o ( L ]jnee [ ... ] b n tondeo-gia [ ... ]/
Par>) e culrrna n l moto he. p r ammi i n d ila ' atwa t a. d t rnnna una
riproduzion ' animata d lla embianza. n' pre ion analoo-a ( opra la figura>)
e il riferim nto al movim nto, allo pirto> e alla aine ri orrono a propo ito del
on tto uJ ritratto di Dic110 Hurtado d M nd za, n ila lett rad 116 a
11
0 to 1 -0 a
Antonio da rbino:
[ ... ] i mando il u tto che lo bligo i t o e la per ua ion d'altri mi ha forzato
comporre opra la figura eh il mirabil Tiziano ha mirabilment ritratto
ral Don Dieuo rtado di 1 ndozza. uioYane tal qual do,erebbono e re 1 vecchi.
e bu no a io h n' pi avio n' pi buono non pu e r .al uno. D la ma-
gnanimit e <l la ci nza non parlo. concio ia h'io non ono ab1J a omprendere
la omma d l'm1a, n' la arand zza d I altra. [ ... ]
hi voi ved r qu I Tiziano p il
lar cl I art w1a ta ita natura,
169 Mandovi il uoscritto onctto da me mpo to opra il ritratto dr lo lllw,tre ignor Fran e
0
.. l
Fin eteci gi da ba. o una <'art a fac' nd elo p i cri\ er da qual he penna omigliantc al carattcro!o e .
8
r
11
1
' . 1 I , O e Tri,i ano l\larc Amomo non
a tampa. lnianto faro quello m d imament ne la 11naa111 ue rem
. m . r . MD m.' (l
come la di lui . ublimit mrrita, ma nel modo <"hl' il mio ha so in"eano potra. D Ottobre
111
\ enezia.
1
"' '
VI, 29 l. p. 272, al cc lli ) .
170 Yl, 312, p. 287.
... 15
il \lcndozza ,.i\'O in pitttLra.
,ht 11rl uo par che fa, t llr.
. 'igor. anw. o;.:,a. r pellr
Li d lo , til chi in piedi lo figura.
Tal eh 'ri ritratto rsp1ime quella cura
'hann di lui I 11en ro"e ::it Ile.
Dirno I rn anc r n la cmbianza 'rra
\'on pur il acro. illu tre animo arderne.
E de lr \rt l'eroica ra:
i prn:.irr alti d la nobil mernr.
Che in le ue gra,it raccolta e intrra.
Tani se r
11
e il futur. quanto il pre ente
171
.
La pro a a comi aana jJ onetto (\i mando ... >) logiando il _\1endozc. puerse-
ne:r d Ile ui dori n n ' pu dire , n n per pr t rizionr (non parlo ... \e] con-
ueto incipit univeral d , rlativo (Chi voi>). la po ia ornprim il paraaone tra
il piuor antico e il m demo e la traordinaria illu ionr cli tu r capace lo c
0
til di
Tiziano. he infonde ner!!i \itali (moto. pi110>. \igor) ohTe che !iOmialiauza
(carne. o a. p ll ). L'apparizion d lle \11u nella embianza> ' m diata dai
oliti v rbi-filtT ua e t mo d intem (e prim >. cdim tra >): il ritratto riwla
quanto e come l t li abbiano favorito il 1 n loza. he nella embianza mostra
non . lo ranirno arei nt >e 1 virt eroi h . ma an h la mcntr. lucida ul prc rnt
e ul futL.lfO. 'om accadeva per il ,appello e p r il Doar. ra p tto ' ('011 idrrato
compie l\'aJll nie. non i tabili e una pr ci a a : iazi nr tra virt dati fisici. e
delrinunauin dipinta i 1ile,a un ol particolar . h riauarda la po. a d l oaartto
(in pi di>)n. r ri
11 appello ' ritraUo in ,. te di an:uniraalio. il Trrvi an on il cdia I ma> che
n atte ta la dimit doaal . il in pi di>. li bilancio del ,isihilr. de. critto
' nt car o. ppur la o tant eh d en o a qn ti I imita1 i si mi cor i
pr pno il fo.ndamental nelri pirazi nr del p cta- p ttatore1"-t: un ,rdC'rc
parado aie. che 1 pmac da ubito oltr i propri limiti . oltr J"involu ro d ll"ahito r
dcl a e gli re ci eh appare alre&t rno pennette' di a crde-
r ali 1nlerno. nr denva Lma forte rnlorizzazion cl ll' e p<'ri nza "i iva. riC'on iuta
come pa ag!!i 11 e n I momento . te. o in cui div nta inad cruata a &e te sa.
1. I hi. Il. 19
7
. pp. 218-219
172 \l'Ila parli' fi11ulr della lrlltra \rrr' I I I
. J' . ,. . . . . .. 1110 < wc " 1c 1 ver,,1 \ lru i r corr Ili dal Fori 1111io r rhr il . 110
gw tzio !!
1
\rna:a poi nfrrno. L11111tC'rc.,,11m1 lcnura dcl ,onrtto i in Ktt t: 1 2006.
17:3 Il dcwwlio ri,,po11rlrr,.fibr nl \ero < 1 . , I I 'I I r
I '('.
1
,. , .
1 1
Hratto e<' "r111 oz11 100!.e ffet1inw1 n1t quello che aleu11i 11
<'llll
1
omr ta
1
' (1 irrnzi. Ca lima Puln1ina rii Palazzo Pitti ). Cfr. Po11\11tn 2003. pp. 87-88.
17-t [ ... ) 1 lo pe1w1orC' rht rl 'i"11ifca10'11"11 I
.1 1. . 1 " a
1
u ioni' \'''eme r Il' "11 pro1101w il 1>it1orc 1i1rch : <a11111p di 1111
1:1rr 1 e 1ru1110 ron 1 ,11a fa11111.,i ali j' I "
' u. \ a< lfl' 1'011 a ua 1111magi1111;rio11r rna1irn (h i, p. 8.)).
216
. , irodanclo a ci che 11011 si vrdC'. attrav rso il c ntributo cl Il' occhio r cl lrirnmaai-
:crondo la cJefinizionr rii<' Lod 'iC'o DolcP attrilrni cr ali' \rC'lino nell'omo-
. llO diulocro della pit111ra. la fa11tm;ia P C'f'lia imacrinazio11e di chi mira. Cali ata
1111
b ' ff . ' d l l . , .,-
da cliwrsc attitudini hr a no &er 0110. r non e tto o propri ta r a pittura ).
r,altro principio !iOltf' o ai . onetti aretin.iani r la eh i veri no_n
d(' criv<'rC l'effigi!' che crlelirano, ma e , rrr compo ti lib ramrnte opra il ntratto:
il r mpito dcl poC'ta non \. ! uali_7:zar o i ihilr. ricr arlo la
, fantasia >. in\'C'ntarr. aflat1car l mg ano . Quando 1l poeta ntra .non r!lra
il corpo. ma l'ani1110. com(' _accadr con l':ffi
1
1ie del n mi ono P?tuto
a ten re di non ritrar an h io non la faccia Illu tr d1 ua, icrnona. ma la sembmrz::.a
. .
del di lui ww1zo c
11
rcg10 .
Lo !i"tiar<lo i mma aino. o che Aretino porta u una aallcria di natori. doai
amba. i traduce in un meccani m cl bratiYo-dr crittirn inaolar . e-
gnato dal rapporto per 011ale con p lla olio azion
tolarr. P r la co'>truzion drlla ua Lmrnaame. \rctm ha mter e a ra oah r
lr letterr che provano la ma!!nific uza e la fortuna d Ile r lazi .m 1t pi
rhr a radunare lr sue rime. che pu rnlorizzare proprio in oda a m1 l\'e che ne
ce cimoniano la dr tinazion pratica l ambizioni on T t
178
. A.ali antip di di
qur ta cl minata dall"ing mbrante temp ram nto di un inaolo :
. tanno Jr czioni dcdicatr alla celrbrazi n di arti ti n lle rac olt antoloa1 he d1
medio pieno 'inquecento. dovr l' omagai al ritratto divrnta pr te lo di e. er
r imp r onale partccipazionr a un evento olletti\'O. Ri 1 no dei po
farne iani per la h Ha lr rime he elo!!iano mbr "10 nell d.loa1
a cura drl Lici no ( 1587) e d l B rgoani ( 1 ;)99). la pie la ezione lll onor . di un_
ritratto di Filippo IL aggiunta Mila ri , tampa 1 -. d 1 Libro q.uinlo delle rune d'.
dicersi illustri signori napolelani
1
-<> : i uliano o lini ,.i partecipa n du onett1
I 7.i Ool('r. /Jialogo della piftura ( 1.).)7) (Dm e r 1 %0. pp. 152-153).
1-:'6 Cos \ n1i110 ,cri\'l'rt 11 ella le1tm1 u \'ero11i('a Camharo >lii ritraiti dei duchi dl.rhino (cfr. infra." -t.2). D I
mio 'lr o fl\ \ iso r K ltl SI' 2006.
LI.\ I. 1$2. pp. I-tCJ- 100. Pt'r 1'11n11li'i di que-.ta l<'tltra. delfouohrc 15-2. dr. -t.2. . .
I
I I' \rrrino i i11d11!!llt1l ron nfen- 1':'11 La ge,tim11-. scaltra e iu itme impu<lemr. d1 la propna 1mmag111<' t a pa.rtr e'
111111to ai >uoi rii ralli , da \foons- \I \lt ot.:-. 19CJ-t .
" -- "O 1 1 \. I I 11io B n-i \lid1clan1:1lo \'irnl-
1'?1 La ,ez1011r" lrrme 111 Rime 15;>.>. 1>p. -t8?-b .. C'Oli tr,u e 1 -e 1111. !IIT 11 . . . ., .
I. "'"' - I 1r1 1 -' 1 I"' arrine ru1 1 te n s1 m1n,ro110.
11. Lul'io Oradi110. \1.nO\lt.0 19<>0 (p. 2.>8) an11ota e ie e 1 1 ic1 e 1m11111carc 1111111 , f
1
.'
1
. F' .
. f .. \ . dir ) 1'1n(o11zaua "lilli l'rtll11le.
'll""l'ri'<'I' di c1rcarc Ira le medn1rli1 r le llf('t
0
olt .. , propo>llO PI 0 1 ' "' "
1
l'
11 l"t' ' . " [ J . I I . f
1
1 , frdr le belle e ran 11111 au ie
111 dmag1111 drl tempw C1wl'ppe Bc1t1s,.1 "l'l'll r: ... come na 1 a nr o 1111 . .
1
"
J I (
. 1 1 l au(' 110 (' Fidia e c1ual a tru 111111rn ,13
11 ,11\'ali(rr LEO\E \retino. cl1r 1011 I impronto e ro11 urli izio 18 !l"!{Uu<- 11 Il b Il I d'
.. r . 1 I ' 11 " . 110 '(' ,te -o ne e e l' lll!l"llll I
p111 11111cho, <' M1pernto qua'i 111 \ atura, ,1 rouw umo puo,,1 t ire: t' lt
0
> iia \li . Il'' d"I i 1 . I cui
I.(' I Jl 1 l" I
1 1 q e I' di hh11110 . 11g 11 u 1 ra, i.
rumc 11 .uro Quin10 lm111r11dor , di H'"lllll e 1 .11g 11ru1: 11111. n u . f' . . Lv
11
. . , ' t '
' . r'. ' I l ccltbrn111 da 111 111111 ll' I stnu spm I
r11n1 !>IUlllll pPr ill l'llllfll'l'M'lll!lZiOlll' I' (ll'r I 11rllfiz10 C "t!IUI l':l lltllhl. ('"Il lii a e . , f
. . . . I I a eh he t rom1>0-ca quanto aia per
m 1an . uli r i11 diver>r li1wue di m1111itra eh 11011 canto< urcra prr 1111111rn 1 - .
1 1 " . d' I , bol wu -e -111r111 mrn e
ft nxi clw ('hunno tantatu. ( ... ) (Bvn SI 15;-6, pp. 38-' 9). \ummi-1 tt,u I t\111 lll ntr 1 "' ' ..
di pit1ori. si l1ggo11 0 in l\.1u'l1
21.
in lod d ila imal7ine del re d'In17hiJt rra di br nz a cavallo fatta in
dal
dfrino L on ultore ar o ( lava il mondo a mirar la vera ima o Questa
del uran Filippo eterna imauo) B ned tto ar hi n il onetto LATT NZJO,
se 'l mondo lza nuol'O Filippo. Tra la Lombardia pa
17
n0Ja Fir nze, tm circuito
inint rr tto Wli c po ti Je17ati all'a cad mia d i Feni i arti ti om Leon L oni
Bernardino ampi. Lu a ontil d di a allo ultor ar O un Di COI'. o a
ommento di un te to d 1 o lini
180
e apr la terza part d 11 proprie rirn con un
onetto al L oni uno p runa m daglia di Filippo 11. Il o lini Antonfranc co
Rain ri ' i cambiano on tti ull'eff
17
i di lara Albil7nana realizzata dallo t
0
ultore
181
. na d ina di t ti p r ritratto ono n rvati da w10 critto di le .
"andro Lamo d dicat al pittor r mone B rnardino ampi, autore di lUl ritrat-
to di Ferdinando France co d \'alo , dipinto int m al 1- 2 01717 perduto, che
for e i pir ad AnnibaJ Fontana la m dal7lia ricordata da Lornazz 182: p zzi forti
del !lruppo celebrativo. che i r 1717 ulla di tinzione tra ompiti d l pittor e po .
ibilit del poeta ono due anz ni, una di iuliano o lini
183
una di iovanni
r ndrarnini. Ladozione di que ta forma m tri a n Ila poe ia uJ ritratto' inqu
c nte ca: ri-petto alla "equenza di stan::;e - l'altra forma lunl7a atte tata n I a n re
- la canzone i addic a una materia illu tre pi mo a, grazi alr alt manza di
ende a illabi ttenari a un pi compl o chema rimi o, chiu a dal con-
u do. che la rende idealrnent non ampli.fcabil . Data p r rta la opranivenza
delr a petto e teriore ( ernbiant ) del mar h e. a i urata dal quadro. Go clini
i hi de hi i oc up r di cu todir la m moria d Il u b Il zze int rn , :
Fortunato pittor .
qu ta tua bella imago.
fatta con art con mirabil cura.
ben omiglia il Pa tor
DAY.\10. forte vaao.
eh rea [ ubria in pa alma e ieura:
ben far la pittura
del uo mbiantt' alt ro
1 _Disrorto .Contile renicio sopra li cinque sensi del corpo nel comento d'un onetto del signor
CUJwno Cosell1m. al camlter leone scultfJre Cesareo ( 1\Tll.E 1352).
11
1 quale fr. f>ErrERt'TI PELLEcmo 2009.
181 Per qu t rime di corri pondenza per i 1 ti cl di ali al minia torr o tino D io rfr. infra, i .1 e i .2.
182. Disc_orso :Ile andro Lamo intorno alla scolluro el pillura ( 1584) ( .u10 1 . t . pp. 52-62]. Pfr altri In ti
:u.
cfr. n. PP- -. ubiLo dopo aver Iencato i principali ritratti ruiti Lnmo
pi a. . pra. alcuno de quali R1tratu Don meno flPr (' I brar reccell nza d il vaJorr d . dipinu Pnnc1p1 furono
da diwrsi onorati Autori diver f' poc,ic, delle quali s end m nr ''enute alle mani alcune. ho pen uto qui
di
iocch il no lro Campi non rimanga n anche in p
11
rt dPfrauda10 d!'I meritato onore
(L\MO 17 .i, p. :>2).
183
' opro !"' del .lfarrhese di Peuara a Bernardino ampi. fa prima ranz 11 della raccoha d'autore
( ,o f.JJ\I
1
88 ' cconda Pane. pp. 200-20.1). La canzon ha 9 strofe di 13 vcr i (pi u11 con aedo di 3) con chcma
ah , abC<d eDff.
218
fede di qui a mili annj ,
' avvicn eh tanto i daILni
chivi dcl t mpo, e 1 mor o in ido e fi ro:
ma I b ll ezze i11t erne,
184
tantt' altre doti ue, chi rt'nde ett'rn ?
, ) d he riman ap rta e medita dubito am nt ulla po ibilit
E una e ornan a r nd"r tern l qualit d U'ani-
. iano in
17
rad di '
eh I arti \ ' t t\' . , . . . d l d. val oltr ali ue fatt zz fi.er . l'arti ta
R. tra ndo I Lrtu mtenon .
mo. t d t fama terna1s:> ma co i non , tato. alm no non p1 na-
avr bb
17
ua a
17
na
0
- nf d t o tra
I
onda trofa. o pe a ul o ne tra e terno m ern .
mente. Lo rivela a
pr nt e futuro:
AMPI. quel eh i edt'
che incarni e b n mo tri .
di fuor eh tanto a oli o hi aa rada e giova,
fa eh 'entro an or i ered
eh r !!Ili e di par gio tri
animo invit10 virt rara e nova:
ma uua ed altra prova
qu ta n ' ha i to, frutto
pu trarne ogni altra etat -
vorrei !'alte e lodate
pre far ont e a l'univer.so tutto,
P
er darne a luj uo preg10.
. . 186
a l'et future empi C!IT <no
184 fbid., vv. 1-13. . .
1
.
1 1
.
1
bello:/ ampi, d1 gli occhi
I . t lto/ d1p111to iru t ut o 1 R. ti lei
185 ome . crive il a alicr endramini, e, rom
11
n ra
11
I .
1111
,alor. .. (cauzone opra' itra 0 <
. , , . ff ti I pres o eco que o ,on
no. tn appar eh fuora;/ ro 1 av li tu a o c.
8
_
61
).
ignor marchese di Pescara, . 27-32 111 Li\ito 177-t, PP . . i-'
6
d
. p B tardino Campi, cit. , '
1
-
186 opra un ritratto elci Marchese 1 escara a err
....1
do hanc , co (onori ci\'ili e militari. si irpr o-Iorio 1 co 'taw a I .
rappo1to con Ja Fortuna. matrimonio di ;Il"') z ne le avYrr !l r nel
rifnimenti al pit1 rr al ritrai! I e l"t' I 1 e hanno molto piu riJic,o dri
. ., qua 1 a e 1 1 marche cl" .
armi. come ammi11i tratore e o , I : imost1a 111 toaa C' in
.. me< om rnttenlc e amm1Taaf (
1
.
grand unpcrio nal [ \' .fJ)) co
11
r . Il
1
10
parco tnde11tr a]
. . - ., . i, 'mano a o ' C 1 ma I I .
itata mcdaalia di ,\rnlibalc Fontana 't1l I J. re. . ce rati\" attr tato dalla
. di e. ree o ua1c m anna1 1 .
maom < rcole eh h . il dr . . . e e ura, su terso J im-
i
. . . a uc J o ago c al' J pomi d 11 E, . .J. .
muone di ,alore militar a aaezza 188 II . e e Rf nui. a prnnrr
c. e ' e a canzon 1 mat j 1 i
ntTatto uanrari\'O sono YO at , j . . na ' e 1 mguaaaio del
h
I O O p I 11 aazJOll parali . (" f. .
hanno affrontai . impo .
1
.
1
. I . zzati f
1
1011tr all nnprcsa
in legno./ n, in m talli. n, in marm1/11<'qp111 a.po ial .t a ( \la chi pu in t la o
J
9
)
1
. ue o 11trar. c 1 a p na .. .
- - - : 11 puo mie to in colori I l ,
1
. . 1pe m carte(> [n.
u I uo con a 1 carp Ili/
qu, onde de1fra? [Y\' D . . mo. trarci. com eiuac-
:_r . . , ( a rum po 1z10n debol di I
lllleIJ nta [ ... J rn ntr io le riY I I r d ili [ . I e. a e moc stia nza
comunqu ilt timon alpitt r :eo a on ro ... ) [n.100-101)).ilp tapassa
Quinci a m r - o piaccio.
mentre col r zo mio
dir rroppo (la o) d l uo pr uio im I
\( o.
a tu. poi clo tac io.
di ritrrufo hai d io.
rati ond"ei 'inalza a mio:
po.,c1a mtcnte a lui olo
ornar I Grazie intorno.
con e nto I pi l t l
oron e pi p rfett
\i pinui. h"ri cli tante ancor fia ad
I
1
. orno:
e u dentro no 1 mira.
1 !!Ili coro-a ow 1
uo cor aspira.
E \'Oi Divr da J te . 1 I
e , u e 1eront
guarclat il ommo Duce.
Qual ., ., d
p1u ne eo-no? o qual pi chiaro luce'll'I?
:\ono tante que ta . .
1
con e ion m e-rt rem h
pare a ena. di . pen ando con J" ( . .''
1
ciw nnnua di fatt a cu-
Crazi he lo omano di o10111CT i al . ggnmgJ: pi nrTi ) . u pedienti i. ivi (ali .
I J )ne I rm lt d.
e met ambizioni d J mar h ( . . ranno
1
nv lare qu lita intrriori.
1 ea111 corrTa 1 .
v uo cor a pira). a oloro
187 Per il marche-t cli PcCara ,. I I '
familiari. 'r \ asi o. go1 Pnllltorf' cli .\filano rhl
1
- . .
188 p . ' J
6
0. C
11
nip1 a1(v11 ri1ratw 111wli altri
Pr 111111 drsrrizirn11 d1tt1Jgliata ciel ierso t riel!' . .
189
0
. armatura v 1 ihil. 11
ipm un ritratto del lfarc/use ,1 n uc iu to UJr1so. rfr. CRl.CORI f 98!i p '>60
I/ r PSCflra a fJe . .J ,., "
mww110 ' ampi. rit.. '" I O:l-120.
220
eh 11011 I os 0110 veclrrc dcnt ro iCJo. La re a pittorira clrl mondo mora! una . o-
luzion di ripie110, per li piu orche trata dalla J>Of> ia. 111rntr r ro- alio d Jla parola
tro a conferma n ll 'inv cazionc rivolta aUc jJu (Div ). prrrh prot CTaano il
D' valo daJr blio dalla mor1 . PiL1 g nero. a di I m nti ricondu ihili al dipinto
p rclu to 1 cauzonr drl \' 11clramini, che di chi ude il sirTnifi ato i.mb lico deff ar-
matura. pm:i ione visibile drlla virt1ts CTU rrina:
Qur-.ti mi t mbra \1artl'
<lai natural dipinto:
r elmo. la mazza. e r1 oro il ricco
rhr si pui'J ( tanla ' r arte)
dir pi vrro rhc finto,
rii 'ti -.ia clrlrarme il Dio mo tra pale e.
che dico io'( il e
r quc to di Pc cara,
[ ... ]
La perfetta corazza.
per opra di \'ulcano
cli mille croiri. e duri in 111 ri altt'ra.
non m no clrlla mazza,
di Cuni al forte pian
'oppo e contro la nr111ica clera
1111
[ .. . ]
Pr piziala dall'iconoornfia. l'erronea id ntificaziou del march e e n il dio d l-
la au rra ( vv. 1-6) ' un orna a aio ant noma. t ico alla ua Yera natura ( n. . -8):
la momentan a int rruzione d l il nzio poeti uJrimmarTine e in id e con la
m sa in rili v di un . pedirnt r torico. con r a lozion li una ri or a cl Il' lo!!i (il
paragon on \ erTli altri te ti rac olti dal Lam ri on- l'id ntifi azion d l
marchr. r con les andro Maano, e u cric ta ha r ' tato , ugO' rito hr il quadro lo
raffiauras r a f!l1tra int ra in armatura da a,ali r . in una 1ta cli ritratto in l'este
o .
di , m qu Ilo dipint per il du a di e a ( 1111 llessandro Jfagrzo. la :m t 'ta o-
mi gliava p r a D 11 Giovanni d' valo
1
<J
2
). Il ptu-o vi ibile dunque doppiamrnt
filtrato. p reh ac ed al te to attraY rf:I una ma h ra mitolo,giea e w1 attribut . la
corazza clw clip r un trav timcnto un inYolu r d I e rpo<J:J.
190 Tornn la purolll csrg11i (cfr. nr l!)Q5. I'. 11 ). lllll ('011 ahri Le dcl poNko auge
in qur>li anni. il crOll'>iglio al pillOr<'. qui non :,ono e;,ploratl' dnl Cos lini rn11 I oltrall7u duno uata nrllu tanzouc
. ul ritrall della propria moglie (efr. . .' -i. I).
191 'opra il Ritrai/o dr/ 111arrlt1se di PP.mtru, dr .. n. 1-8. -3-58.
192 LIMO 177-i. p. 51.
I CJ:3 Per J"armuturn ronH' habitu. l' pir la oun importanza nt 1 >Onrtto an1i11iano sul rim\lco tiri 1lura d"l rhino.
rfr. infra, -i .2.
221
L"elogio ii enato a ritratti ma hili i ba a ulr altazion di qualit attiv , d ti
morali eh i ono prc in a ti azioni apa it di ao,, rno imprc degne
di memoria. Que to d termina da un lato il uperamento d Ila de rizion cl ila
pura fi ionomia in una d cifrazione di tipo moral dall'altro l interferenza di un
elemento .narTatirn. p r e.amo . c?ntratt J.1. I r aime lirico. Jn un ingoiar
onetto di Antonfran 'C o Ram n ( Qw dt duo Regt ti /ero ardir estinse). la ntra-
lit d I rapporto tra azioni \irt cl l oaaetto i combina on il rif rimento a una
ofi ti ata o truzione ,; iva tQ-1: tma orta di tudi lo di t atr d Ila mem ria. dov
Margh rita d' u tria i ri p chia nel padr arlo ritratto in Lm bu to di manno
fini ."?10> circondato .da t I eh ne raffrurano I impr . Per pi aare la rii tica
d n ita del te to. ao tmo a u ha portato I'attenzion u un tipo di omp Ili.mento
u-a me o dal IV libro della Planudea un e er izio di bra\'Ura nel qual il poeta
do va numerar le fatich di Er ol in un ma imo di tr di ti i t%. Lo forzo di
conden azion d 1 narrati o nel liri o produ e iri in vitabilment o curi m ntr
ali oag tti ione compaiono nono tant il d itti o in anafora ( qLti ai vv.
t 5, 7, 9) . P r re olo nella d ttagliata Esposizione in pro a. Ri piloaando
1 > di arlo il po ta mbra riprodurr , n ilo pazi di un on tto. lo t
0
marchingegno mn mot cni o alle tito nello tudiolo. ma omette il fulcro d !l'intera
il di ui re ta traccia olo neff appeJlativo olennem nte
m i o n il.e ole ( l.1mmortal aenitor E ARE o tro ): p rch, le impr e e
non le fn!!l ono il ero ntratto> dell imp rator t96.
1
immagini di condottieri g ntiluomini Ta o e Marino ricorro-
agli te . I pedienti: la d i i l'invito alla vi ion , l'individuazion di attributi
e 11 mitologi o: ondo un onetto d I Co lini al pittor Fran e-
co nv ilo. il gov malore d1 Mlano F rrante nzaga un ero no o cio' del
pre ent ma dovr e er rappre ntato com un altro Al id un altro . tlant ,
per h, a que ti eroi omiglia p r a petto e p r impr
197
n cenno di pr
194 R.u.'\'ERI 2004. LX.XLI Il rap >on I c1 I h mb
126) . . . I
0
con
10
o. c e se. rcr bbc 1 p1rato a quello di Giovio (C u 2004, p.
dcli '. &\ f[ostzl]
eh
1
ento sonetti attribuita al fratello dcl pocta. cl son uo eia rric
1mpre e aro . .. e anche un 'unplic"ta cli ' (.
rim del B z 1 . . . ', i .enumerazione 'irtu ivi , p. 135). Allo I s o modo, nrlle
ea.iano
1
ntratto poeoco d1 arlo \ e dilatato in po e eroich (Docuo 1993, p. 105).
195 I caraueri cli tintivi cli que U1 erir di e i J J
ponimento bre,e il riferirne d . .P grammi
0
.no a < .nzi nr d1 un riclo di pisodi rroici in u11 com-
nirua unit
1
[ J nto a. und. P.ondente la ronce11trazionc della materia nella mi
. a .. . pr nza J stile1ru mnemotecnm ( 2004 132) d e ,. J .
dei I tLori cinquecentesch ' li . P eron o asu rmu azione
1 o rnalllta dal difficile "lib I' '
del rifrrimcnto vi ivo {i 133) .
1
. I equi no c:ra o unta 1ncr nre alla brevtlas e l' rvid(nza
roin idere con la d i i alffuma i. e appare prrpondrrante ri petto al erondo, che tendr a
latine. coin. aveva fat;o con; I . . :PtrOs1::ido11lel, Rruln l i quadri dello studiolo on i n. rrittioni
o o n atti e a co ez1one g1ovia11 a.
196 Dunqu i uoi veri essempi/ aranno i su i " f . r . . .
canzone opra un ritratto del Ma .
/
d' p
0
ran
8
atu,
1
archi e
1
t mp1, criveva il Go clini nrlla citata
. . re tese t escara a emardmo Campi ( vv. 103-104 ).
197 Coslu"' 1588, econda panr I ( . . .
208. L'arti ta invitato a realizza.re ' .
1
opra
nt,_-atto di Don Ferrante Conzaga, a Francesco .rive/lo), p.
1ompi11La. h . ta pr prend r; ( ipingi ). rn ntre n1gli ultimi ver i si parla di un' imma.,inc quu;;i
222
( cTa rio .. .>) ana il pa aggio dall' elen o di pr dezz ,, all"illu ione del r piro
(reco e co)eilte t i biud onunadomandaLiri a,,t
93
ullimperituragloria.
i rirnan in d1tbbio d I pittor di F rrant . i e !ud il rapido ac enno al
, . mbiantc, rn diato dal parag n e n due orpi monumentali (Er ol tlante).
ne una attenzion d dicata alla faura umana rappre ntata, mod ilo pli ito e
pirant che i ttrae d 1 tutto alla vi ion . L li i del vi ibil non i attenua nem-
meno nella pi coperta imulazion di pr nza dell "immagin he i realizza quan-
do il p ta fng di dar al proprio tupor davanti al ritratto. N 1 onetto eh
Marino drdica al Ritrailo del Cardinal Borghese in rame la con i tenza dell'effigie i
di olv poco oltr il d ittico in incipit nono tante la econda quartina ia co truita
u du anaf ri h clarnazioni:
Que La, h pr a da I agiadro til
in picciol foulio appar nobiJ pittura,
' cli qu I u-ran BORCI LE I ombra firura,
che nutre in frc ca t . enn eniJ .
Oh qual d'alta prudenza in verd prile
rno tra neuli o hi ac rbit matura.
h qual neuli at1 i uoi po a tura
gravit dolce e ma t g ntil
1
qq.
Il on tra to tra pr enza irnulata e indi t.inzione di luoghi omuni ancora pi
' trident n I on tto li ardzale doardo Farnese in cera
200
eh adotta la for-
ma allo uti a privil gia interrogative d invo azi ni, 1 impre ,.ione
che i er i iano pronunciati davanti all'imma!!n ( < tu> q.m. 10> ).
i dir bb h in qu te finzioni 'p rformativ i e ca.tutto cru1 o dir
r nzialit i i a che la lirica pu ten r . Fran o Mrnonzio ha ncordato ah
Elogia d i 1 tierati p r i quali ioYiO non di ponern di immaai1 (C\ I- C u:)
n n ono a compagnati da v r i: la coincid nza atte ta in prim una dif-
ficolt mat riale legata alla mmi ion dei carmina om al r P delle
ffigi. ma al tempo t o ottolinea il l am fi ico e tra ed
pigramma. Com il lo p ibil rapporto della poc ia on l rnunacrille fo ,
matcrialm nte virtualm nte piITTammati o: ci intrin e arn nt (e, r
0
dire, ontol aicam nt ) u idiario, parat tuale, m qu ilo di una rmc
0
di
198 F'
r ali cli d I 1 " pr po' ta da FRra>Rt 11 1975. p. 120.
11cr10 n nmento a noz1on e Ullllt( a ima . ,
. . li I . l 1, di ,aggeaa e mo' ane eta
199 MARI o 1979 . [7) 1-8 p ')6'> li onctto ms1 te su a com imaz
11 1
e - . o . .
' ap11cc1 , " ' , . w ,. d" li . ) e rirorre ad altn due o uuon pt'r
(<he nella prinrn terzina coincide ron il riferimento all 111canco car
1118 710
'
1 1
I paNlle cAmulr ai
I
. . . . I' . t . tra nbizione e ie anr 1e e " '
crrnvcrghartid IBorrrlH'sc(v.8). Laroncl11s1oneo1rtrr a e no u ', ( 1"))
marmi ( . 14), lirumo dcl suo imularro ( . 13), cio di ritrarlo con cnov arte " -
200 lvi, Rilieti modelli e medaglie, [i), p. 301.
... 23
LUla didas
Il ' onetto ul ritratt dt'v . ere non meno e non pi cli una erie
di deitti ', cio una finzione di pr enza: re tare tlo questa oglia ia11ifclH'rebbe
perdere qual ia i accenno aJ r f rente ,.i fro, up rada confinare in un ierritorio
cono,ciuto, doYe la parola approda di armata.
3.6.3 L'elogio del ritratto come eloo-io della poesia
Dall ' tanze pogli di una allen'a enza opere. attribui c al pittore Bernar-
do Ca tello la apa it di rendere Y ibile rinvi ibile:
Del Liau tico :\larte hai la figura.
Ci\ TELLO, al vivo in \'iYo lino e pre::i a.
L'inYi ibile ardir ,.'de i in e a
pirar de l"alma intrepida secura.
Dubbia tra 1 finto e 1 ,. r. non a \Tatura
n r artilcio tuo ceali r e te a:
e mirabiJ del pru Yinta confe a
il dipinto. il Pittore. la Pittura.
.\la io come potrei po to in fra due
mte e
11
uali di aloria. auue] tru-pato.
cantando alzar l mera,'iulie ue?
Taccio. poi eh 'al mio til ci uon dato:
parleran ben per me le tel tue.
poi che per t le tele hru1 linaua lato'.!02.
A! ia ompeterebbe l'eloaio del march e pinola attra er o la parola. ma nel
uo .drr 1 m _( Ma io come potr i
20
3
) e n Ila pretnizione { Tarcio) il compi-
to v1.en . re titmto aU arti ta, perch le ue opere ono gi parlanti'. Con w1 parado so
che mdica l approdo finale di una parabola. Ja po ia ontinua a imporr la propria
pre enza perfino mentT fing cJj concerl re alfart l' ultima m ta, l"accr o al rn zzo
201 [ ... J the cpigrarn in it,, primar\ u , e I aJ .1 I 1 J lu t
, "" <1 v r J ul. cnpuon on S<'tupt urr or tom istonr. 1111p 1r11 \ ac 101\' -
edg d and et rn rilacr the ub,idiar" r(lat f d J k f I . )
.' 1on o l wor "lo t 1r wor o p astic art that 1t acco111pan1rd (1'p1-uram
[. .. 1
.
1
_991. 15). o l"epiwamma era to ll1c rlf-cffacing fu11ctio11 of calli11"
to1t e'. u effertlvene s of 11.s pia tic-art romparnon as a 11a1urnl &i rr11 t likr the li\( per on-), 1hcrchr
re C"anon 11.>elf to mere YCrbaJ Pxplanat'o d I f ,..,
,... " . '. . 1 n an rmp 1a 1zmg ll s own ar lllrary- 1g11 sen irr a no more than !I "loss
011 tl1e tangiblc and ueressfully 1llus1011aq prima11 obj <"I (RATJi 199-t. p. 1-). "
202 1979, Il Marchese , pi110La (Pm1cipi Capitani ed flr>roi [76]). p. 11.3.
20.3 L attacco .\ la io co1111 potrei ncorcla f'V(' XX 111 ( " )
. .
1
-. .. 11 10 rome potro. cmpre 111 aprrtura dl'fl1 t<' 1'Znir sia
p1 r 11 <'ontraprior 1 della porsia a w1 rn , '"I. , I d Il I I
. rm1 10,0 nsu lato e a pittura. ia p r l'as u111lab1J1111 parad1"111a1w11 < 1
grnrnco auge! tnniato al <"l iano o ' b " 1 "
-1 ' scuro 1a ro. p1111mp1ca10, prr drf111z1onc, m u11a pocsm rh fa. dwfonna.
224
Yerhal (pure iute o e m " ce e r piro piu che com lin!!uaagi ) .. 'el onmarr
imili conce i ni. la poe ia nqui ta cLl fauo un pazio pi ampi . comr la
prrfetta compatibilit r tori a era i--pirazi n ni al pin_l r : I
!ri.am nt <lrl I oeta che inunag-ina di orregg r e il !!I.:\ t del pittol't' t l
nt m ntt' rontraddinori ri I tt alf . di !!"in .cia
In \..retin ramonomi d l p rn c. m re d1 ntran1 d1 ... 'end talla luareva
--uoi prof , iti: un'inte!!fazi n am.1 .... ti a_ una ip r-,-i i n . l ... n
ea... del .-0 ... lini. la ' nqui t li un m I d lla I arol. da mm all mun !!lll
im t'1'e da lUla di .. tin.zi Il . unzi ni ( f... tt am nt lipin_ re r anim e il e
i e 111 i n lJ nua I cr i ... al pin >. riY n :li a il IDf it h fin_ li
... dere. E. j ... 1 i una terza ,;a. t nuna" im . h la ... ja f rre per a t m1aN
la forza del pli prio crirrarre: r ... pli itazion m tafori a del cping r :a.rnandl . in
rui la ... rirrura i aut pr ma ome di -. gn e m architemrra. Parado ... alm me.
(iui h la dim n. ion i ni a rientra in. c:imp : la p .:.ia t -sa. a ::-m1-
irla. quando la troYa non in un ritratto dipmt ma m. -r e pr?pno nnemo
n in te e le truttur . o tiJe. <z l'ece cJj colonne e di trof e1. e io eh il napoletano
Gittlio Ce are aracciol on -aera a Filippo II olpito da Leone Leoni:
Col mondo tutto alzar ben ti de\T i
e tempi e tatue. o uran Filippo altero.
or dir ' inchinan al tuo sacro impero
telk ciclo, fortw1a. uomini dei:
ma debil nel gran poncio. OY " rrei
de la mia f e' mo trarti w1 ' uno' ro.
lo til ti acro e l'ingegno, e 1 pen iero.
in vec di colo1mr r di trofei.
E r ben ebbe il L on \alor
di far formando in bronzo il bel embiant ,
che qui l uo nome oagi non trovi eauale,
io prro a I alta imago un d darnmc
cantando il tuo reale eterno ouorc
otto il di,'ino tuo farmi immortale
20
"'.
. . . (Il' ' I e-, 1Q3-I9-t) Le quartinr del primo !'Ollf'ltO
20-t Il 8011 tto il elt'1.nrnlo di liii
1
'.m. . ' r' pp. I w lllll;Ortllllf'lll() al pri\ ileaio l'OllCt'S o
(Form Pitlmafeone il bd sc111bra111e) narrano il m1t I io1w. t 111 i.111 9 1-' lo l::u10 dl'L'Ondo il
v r e tt vcr,;1 sono rl\ o 11: 1 \ \ '. - -r t '
da Venrn. alla q11al , piuttosto ll1 o itam nt .CflL '.
1 1
li .
11
ira come po sin IJIUta c-11<' laceudo
tipi co <'dal e ace ntuano la funzione cckbra11rn e mc1110nl11 t r .. a p1 Q1t11rt1'11e e 1crzi1:l' to dul'
' , . ' ' ' "llCO l>lOllll . ! , ,
rn('cOnta le 1111pn'8C d1 I d1ppo ( pci far dl'I
5110
, \ aloi tni
1
. }
11
d t1:r.a irn . !'
11
hori (Pi11m11liom' t' Lco11t
blocchi e tro1wi t assc111hh1ti a Yirl'.' di uJnalllabdc rorn,;,p l la.Ile ,; .. e nalit dw il
Lro11i, Fidia. Pirgottle e Lif-ippo) t' lrn l'on11naz1onc a tatua ot c11111 1
poeta <011c dcr nll ' ar1 istu.
_2
una o tituzion i nifcativa. che prim e contrario 1 ambizioni di una
p ia monum tal h pu' fari anto oprattutt d Ila ua apacit di durare
nel tempo. Il po ta avanza ulla e na I r via di e:i:cusatio, prendendo po to lctte-
rabnenl . davanti ali imaao>: d bol p runa rni ion o alta, eali n n pu h
r it rar la el brazione d ilo ultor attrav r o un pi e pli ito parall lo tra la ua
e perienza e la propria ( P ben bb il aran L n ... > ( ' -11] cl pE'ro ( ... ]
farmi immortal [ VY. L- H]). Il confronto tra arti ta po ta tro a n 1 ritratto ol-
pito da Leone il pr prio fulcro l i o m taf ri p o tra il pa ato non lontan
in u.i lo u.ltor ha m ritato una fama OO'Q'> ri aputa il futuro in ui il p ta p -
ra di far i immortal > cantando Filippo in pr enza cl ll ua immagin . La te a
on ap volezza' pro !amata enza mbr in un on tto eh irolam 1uzio rivol
al mar he del a to. Al.fon o d'A alo :
aJoro o ignor. i vo tri onori
d'ardente tudio acce a han l'altrui cura
a dimo trar in lin e. omhr e colori
raspetto \ ' O tro a la gent futura:
altri i vede andar traendo fuori
con incude o carpe) vo tra f!!llfa,
i vi va inta di i vivi allori
che tupir n far I alma natura.
Io, poi che le man mi tanto non anno.
prometter non vi po o altro lavoro
che d'ir crivendo ornior de i pregi vo tri:
1 pittur i marmi ' I ram e l'oro
verranno a mort . e in vita vi terranno
i ritratti I tatu d gli inchjo tri
2
05.
Il pronom di prima p r ona, in po izion rile ata all inizio dell terzin , con-
trappone la propria ingolarit all'indu trio a e plural animazione eh a1 lrav r a 1
quartin . P r emular gli artisti imperoati a t mar l' a p tto del mar he in li11ee,
ombr olori> {pittori) con in ude o arp h ( u.ltori) il po ta non di pone di
abilit diver e dalla crittura: l'appar nt di hiarazion di m de ta i r ia n l
uo ontrario p r h le op r d'arte arann di trutt . m ntr i ritratti 1 tatu
de gli inchio tri
206
a i ur ranno !'et mita al ignor . Raff rzato dalJ ' om t 1 uto il
hia. mo del v. 13 oppone una ontinuit (in vita i terranno) a una d ontinuit
20:- ,\h t10 1997 (ma cfr. ora \luz10 2007). C VJT. ' fr. \l uz102000, 11, 6.
206 La forlllula fvoca il final! dei Ritraili del Tri ino, ma an he la matri e oraziana di <jur ta traclizion .
226
futura ( rranno a mortr > ). imma<Tini ompiut {ritratti e Latu ) a imma<Tini dett
p r metonimia, attra r o i ri p ttivi mat riali (v. 12): pitture. marmi. ram r
oro E'voca110 una concr t zza apparent m nte pi oli da ma an he una rnat rialit
indi tinta, impot nte e inutil di front alla cor a del tempo.
Le Rime volgari e latine cli ao tlno Beaziano. dit nrl 1-33 e ripropo t n l
1 . 1 \ no dominat dalla convi.nzi Il he ol r inchio lro ia de!!Ilo/ [ ... ] di
morte hemir r xtr m orror I ond om' ruom pinto pi non rnore>
207
Cn lunao
eloai -ritratto di Carlo della n ort I abelJa inauaura una rie di altri elo!ri .
al !liti rnin ri in una ra lta di i pirazi n radicalment ne mia ti a. in cui ali
unici inl rlo utori, in i me al tt rati d arti ti. on i pot nti>
208
. Dopo il onetto
pro mial ali imp rati , ull' int nzion l'impo ibilit cli lebrar la aloria di
arlo , un aruppo di e anta on tt:i compon e r plica il ritratto d ll'imperator >,
un ritratto mulo (e alt mati o) di quello di Tiziano>
20
'>. La poeti a cl 1 ritratto di
parol ' ' per guita con tr ma o r nza u.lmina in una eri di epitaffi in otta-
ve. L' pitaffio rappr nta la ma ima auto lebrazi ne della rittura-monumento
in i m il luoao in cui la forma po tica br ve e pli ita 1 propri potenzialit di
oagetto vi uale me a frutt n 11 rac olt di omaaaio funebr (lombeaux) on. i
Templt2
10
Que te truttur , eh di hiarano on aran di p ndio di m tafore
v la propria doppia natura, archit ttoni a e verbal , potevano e er orr date di
un ritratto in i o d tinato a ampeaaiar ul tempi di arta com un bu to u un
edifi io di marmo. Il Tempio in onor di Flavia Peretta r ina. pubblicato nel 1-91
p r l ure di Ta o i apr con un ritratto d Ha donna lebrata
211
, _rroa ttato
tombeau in onore di ian omma o o tanzo do e a ontener un mclSlone, orn
mbr r bb indicare uno d i on tti h Ta o ompo per ro casion
212
Il te t in quanto i rizi n p i neJ u molo funerari . introduc la on . -
olezza d l pa ar del tempo in e ntrasto con l'immobilit del L
taffio pu parlar a nom d 1 def unt o del uo ritratto un br ( ur lii U!!llI Jli
207 Apparrcrhiat pur I inchi tro, d gno/ ol di morte hernir 1 xtrem onde om' l'uom piI
non more: ono queste I ultim parole della rac olta (Bi:..m. :\O l 51 . e 11 . Il. lll Docuo 1993, p. IO.).
208 Alcuni 1c 1i d Ila raccolta omparv ro anche in amolo!rie (cfr. Docuo 1993. PP 102-103. nota 7) .
?09 I I 04 T ali ti t" el brati Tiziano. Pordenone e an o\'ino. cli netto divi ne cos lo
- i . p. . ra ru E 1 . . 6 o cnrn
pri,;I giato ciel rin carte"" la ma t, la regalit. il potere, il ' U e ' o. ,
1
ntrano pomco pre !!nra. n
prolun a e dilata quello del pinor (hi. p. 10 ).
210 'fr. supm .' 2.3.
211 Per unn dc rizion clrl fromespizio del 'l'empio in lode di Flavia Pt'r<'llll Or..ina cfr. lrlsl ; c
1
'.
1
P
511 . Il cli 1ko che a compaana il ritrauo td' o ( no in lri, qurui 1dlc al cid.co'.bpartel be !!la. a. na
b f ali d" RB s at" o ma"!!!O m pres nza di un LIJlJlla
0
mc. a un
t1ua cd arte) riprcn<l<' da vicUl 1 ,. r 1 n 1 '. : un .s ig.u e
1
' " RD XX'\[\' f '3
3
)
testo che Ta, so aveva gi onorato, indirettamcn1c d1 11110 nscntturn (e n 11 uo cako di . < r ..
212 p b Il I d I' li alma/ cli trionfo li spo"li 1111 (re"io ad mo/ il .ostanzo n1n1110 nn ol"e 1111orno./
r
ilu l' o cl tCI o wa oalnpurc/(p li n1tt ll<' 111 11u ne' cltirui' - ritti/; ITlll'"'ior simulacro. e pit1 risplt'ndc/ e
l' lll"O 11 UO \A Or C"" ra . 18. .. 803 808 G' ....,
(Trr806 . I i t -1-l) I onerti p<'r il tombca11 0110 RT - . ian 1omma-o
, piega po ia p111 n<"rn pompa , '" ' - . . . . d iwlle !merrc di reli!rione 1 Francia.
o tanzo ol diriassrttrnnr ovrva c0111hatt1110 t'Ont.n 1 Turdu r enl morto . C'
22
imauo L quarn ,;cl ma anche p r . definr11do il proprio ruolo (Per dir de
Clizia il matutino occa -o/[ ... ]I I iuramma , 11 qui :-.culi to rima. ./ [ ... )/ emi
Fidia. e di ua man re il va o:/ [ ... )/lui il ci11er di lei erba. io narro il ca
80
,21-1).
L:uma u' todi. quel eh r ta I 1 rpo. mrnlT l'epigramma ra conta un fatto
0
ria um wia vita. nza parol par impo il ile contra tar razione del tempo: Per
formar t ' te u monete tTante./ coronatr di lauro O\ er cl'oliva./ non :;emo et<'rni al
tempo che Ya inante:/ be uloria ha il far. i 1far11011 ha chi 1. crirn?
2
';;
.6.- Belle sen::a nome
Pctrar a ha colto il fiore cli mtt qua1110 r bello e morale nel carat1Prc fe111111inif( ('
ha intrecciato una ahi.rl;Ulda immortale per le tempie cll'lla tl'rrr-
tre runica. che ha ,i to in gio\'e11t1 in un luogo o in un altro. chi era la mogli<'
di un altro uomo maclr e che for e non capi ' a qurllc [ ... ).
Johann Got t frird 1 lrrdcr
.\ Ile did cali del 1 etrar hi mo inqu c nte c . bella ' qua i un inonimo di rlon-
na. L pit to 1 ua indi olubilm tHe il uenere femminile a una qualit e t rior e
pa irn. la b ll zza. E terior per h involucro vi il ile. uperfcie m raviglio a ma
imprigi nant proprio in quanto evidenza invali abile. con lu a in . tr a. Pas i-
rn in quanto n arian1 nte oug tto di w10 uuardo e deriva daJla bmevolenza
d I ielo e del anuu . non da un merito per onaJe. L' na donna dunque non molto
di,er a da un ritratto. ondo un pre rtto drl De re uxoria (1-1:16) di Fra11c sco
Barbaro. bi orrna Of\' gliar anche uli !!nardi delle mogli . che I o ono comu11icar
nza parole. om nella pit1ura. quam ta 111 m po .. im v cant
21
1>. Il ilenzio e il
nt uno fanno dell'immauine h Ila muta un modrllo di ndotta per la cl nna in
21:1 C1m10 19'72. p. 9i (Que 10 dw \Cdi ' il ritratto di \unlio \urrur!'llo (rrad. F. \l i11onzio i11 C10110 2006.
L.\ \ 1.11. P 199]: co' il \fr,o drll'epii:,rramma e mpo,10 da \urrlio \ugunlli per lu propria tomba:
,. _t rumul o !ff1gies. ru1 ho1 'fl"'' carn1rn uh. rTip;,f'ral ('tilla tomba .,lato dipinto 1111 .,uo ritratto '>otto
il quale egli ste;o aw1a fa110 ,crivrrr ciur ti \rrsi [/bici.]).
21-+ CoruttGcro 1969. 10'?. n . 1. -t . ;. 8.
21.i CoR'V \.."iO 1997. L. '' CJ-12. dw conrinua ('Ci.: "''ol don('hr el ;wdio quel dir en 101a111d 111iliara 11"11nni
una per 01m ,;,a(". 1:3- 1-t ). "
iri.ae J>rllf' en1ihus maritis ro111pareant wlim. ah' ntih11 :,enrtae domi int. ()uo<"imt ornli.,. quorum
f'Uam 111 p11wra. tac1111"'.11 por.,im rn1aiu .. 11,11 acPn-imu., e 1. 11 nu111 1u reliquo ('Orpori' l111it11 dPrn-
nim 11 hoiw:nun rruiwant. D1\1 d<' \ 11h11 cI '<'il 11. nuur dt wrbi., dicam ( cPrr1111110 sorrhhr au.,pirnhih'. 11 111io
U\' YhO. rh1 '' in pubblico .,olo quando i mariti ,0110 prc1' 111i . che'"' ne t<wro appartare 11 111.,11 in
loro a"rnza Prrc1ci ,.,,,,
1'11t tt' 1 ] 1 ' 1 h I I f'
. > a 1 1 < ewro t' onel!I con "1 'hri1ard1. ,. audi(' neU11 p111ura. r w e,. 111Mono
P'"''
111
,,frnzui-a. ha
1
111
1
! una ::rancJi.,_inrn capacit di 1mm111irazio11P [oppure 'co11 gli orchi, il rui potrn 0111.,i1irn
r ohnmodu
i crnni clrl 1apo <' 1011 gli altri att1ggianw111i. Dopo ,;\'Cr p11rl1110 dcl 1h,o r dcI por-
lanwuto. ora 111w1c dcll(' p11rol1 (cior 'del modo in cui dnono purlareJ ). da Dr r1 11.roria librr in partes
1> 7-t e 79) Il (/Ji 11 "l"t's .rr . ) lii (/) d ) I 1
f
. . . " / o11u10 . rnp. <' 1110 emt1011e. trul. 111111 . proposito e 1 r11rn111
1111111111il1 n I rr111ze 1111 Q11a1t1(11c111o ,, I <J9? I f I
- IO\ - o srrva r lf' e " poi"''''ve 11w111orie aud htatrmrnh o '"'ua
a"''''""'fll. 1mr1rair- ma\ t<ll 11111r alir t ti 1 ( 3)
rn terr aru. h. own r , ,. 1 wwcr., t ia11 ahout dwrr "" trr., p. i .
228
carne ossa. La posa irrepren ihilr' un hel quadro. o piutlo to una bella tatua. e
diaino r Ila a \iccolb Liburnio. che enza mezzi termini raccomanda a una wdova
n<" ta cli r tarr n Ila cambra. anzi cli non 111uovcr. i dalla ua edia (Dal tuo
. edil di cambra non ti mo
'e i nobili natali prrmetto110 ali d nne cli . fu11girr l"anonirnato. tramite un'iden-
tit rice' uta da ma chili (il padre il marito). i nwriti intellettuali portano
alla conqui ta di un' intrriorit e di una vo . attrawr. il confr nto con una tradi-
zione cultura! a volta ma'>chilr. prl'C'h co tnta clauli uomini. Proprio la ura11de
attcnzion dedicata lai D"e11der st11dies alle pot't e drl Cinquecento ha ri rhiato di
releuarlr in un crhrtto d ,- non meritano di true. per h' il frnomeno che Je 1i!rnarda
cli portata ec(?fzionalc: una vera rivoluzion coperni I di cor o. ? lrio
tu. ron cui le po occidentali non metteranno mm cli confrontar 1. Beatn e
avrebbe s Titto come Dante'./ o Lama cantato il tormento d'amore?. i hi der
.\nna Achmato,a. ma gi 1 ullia d'Aragona n I Dia/ouo dell'infinit d'amore ( 1-- ?)
avrva la lucidit di in inuarc che bi ounava che madonna Laura ave avuto a
cri\er dia altr ttanto di lui [Petrarca] quanto culi ..,cii e di lei. d aver te wduto
com fo e ita la hi
Quc' ta te a po. ibilit di cri,er Jeaittimata
in hu na part da w1 ma chi] . quello d il Ileroides ?"i.dian . epi. tol in
vrrsi critt da un I oeta ma attribuite a eroine miti h . Pr pno 11 a.
17
!!10
finzione enunciativa cli una , ce a una ,-o autcnti a m dia la u e 1dent1fica-
zione drlla poesia critta da donne com poe ia pecificamente el . amoro a.
Rilke ha in ment Ga,para ' tampa e il m1to d Ile p te quando .. n Ila
prima d lle Duineser cri ,c an ora a_bha. tanza i:im1 .
famo o, ntir :!l'l. 1
11
una lunaa rlruia latma rompo ta mtorno aJ 1J19. a ll l10ne
rowscia la ituazion di amoro a ront mplazione in c nata nei on t del , pec-
hio ( cfr .. 3.' ). ollo anelo t o n I ruol d ] ritratt quell da
Raffaello:!w) e la gi rnn m ali , Ipp lita 1 r Ili , nrlla . po 1Z1one della e-
1
N1 L' t , te cli> .. le Ea tlak hprna tm
a111m1t e ie .cnve-- . r, con qu . to te o m mtn . t- .
ingolarr ritrai 10 doppio in absentia (Ippolita Torelli. 18 1 )- raffiuuran lo Ippolita
( 11 ) 11 8 I o i o> re :\L\ lr-XL\ lllr: c. \!Xlii.
217 cEpi-,1ola tcrda ad I lo11oriam nuptr \ 1duam I . " "' . ml ll\J 1 - .
) 18 'l \
0
lQJ l I> >()I \pi ronttIO <lei dialoo-u. la ri,po,ra polt>mica riwlm u \urdu. d11 ha
- t tu i n RAC \\ - . - . . I P , ' I I . no delle pottt,s(' ron11 po-
11111ir1111 1fftn11ato ri11!'0,1u1m1 amoni-11 dclll' donne e11um o itrnrrn.
11
pcmtr lbt I l
'
1
1
f \'1 c111 e 1111 >ooo p '>OQ t'. per 1111 quai rn 1110 10
1,iu drllu po( ia. ar1 t' natura <' a 1rmpo ,11--0. ( r. 1. ' - - -
dol'Ulllt'lllHIO l' innO\lll ilO. (.o\ :W08. .
I j I / I In t111'1trhlil'h "t'llll" ;.,1 ihr hrrnhmte- (.t'fuhl./
219 c.'1 hnt e., did1 aber. >e> d11 L1r >Plltt'll; angt llO(
1
im . i::.
1
, I I drr l'di(htt'
[ ... ]/ ( ... ) I ltbl du d!'r Ca.,pun1 .'t11111pn/ dtnn gruiig'.nd 11rgt''.1d t1111111 11l11' <"tilla
I
. I . I I r 11 d-11 I . I wun t' \\Il' 'Il". (. ' ' ' ' - .
c1111rhw 11111 "<' tl'icr1tn Ill'i,pi1l/ < 11,er ,1!' ll'llC ""
111
t: '
1
. [ )
1
. 1 '1 . a/
"' "' "' " I 11 f noso 1111m I ( ]/ lt11pr11,utoH1 ui-tnnz
olloru le 1111111111i;/ Jton ' onrnra ahi 1i-11111zt11111111orla
1
'
1 010
ai ' : ... . I 1 , . I ..
1110
.
. Il I cl r . ( 111111111 t' ,emp10 tlt'Cf(',('flll(l ( I 'liii ,1a l Il 'I .
a C11,pam ,'111111p11, che una quakhc fom111 11. 11rr
llllt.l
0
.; '< .,.., -
8
. t \I l'ill\othl 1'.unl..kr].
I
I' I " ) (I' t<)n- r
1
11111 0111/lt"'I I \I ->(J-.1 -t.1--! llll< "
e w 10 posh!t <'g11ug 1ar a r . \ILt.. E 1.1. 1.1 ,., '
2W li qundro ( l.JH-1515) (oggi al Lou\ rt'.
221 Per il lt'hlO, rim io a 1301.10'\1 2008. pp. t:l-t - 1:38.
229
in atteaaiamento p n o o. con la t tap aaiata ulla man dc tra. int nta a fi a.r
qualco. a alla in i-tra d I quadro. qua i 1iam nte il ritratto cli a ti11lio11
22
2.
i\ei on tti , u ritratti femminili, l'indubbia centralit d Ila bellezza fi i 'a non
i tradu in wrn d crizion pit1 att nta o in tma mag!!ior autonomia del vi ibile
tto a sianificati morali e narrativi. La fiaura dipinta, pur d id rata cantata
proprio per om i offr allo !!llc rdo. in quant bella h ri vo a w1 corpo vi ibil
,i to. tende a mparir dal te to. P r rie truirla iJ lett r pu' contar u par i
clementi cl I canone br ve (qua i empr il Yolt il embiant ) e u qualit che
-;tanno a m t tra corpo o tume: o l h a ce ano, pi t e ilenzio, imp ibi-
le crud lt. na pi rilevata pre nza d i dettaali f i i ' p o a , o iata all' azi ne
di auardar . e all u on auenze, la meravi lia o il ricono cimelllo: nei te ti il
corpo ritratto i manif ta in quanto oaa tto di per ezion - dunqu in ieme alla
p r zi n -. dendo il ruolo e ntrale a un oaaetto pettatore, he ia ramante o
l'amata t - a che i ruarda allo p chio. de empio n I itato carm di Lancino
.urzio I b llezze ripr dotte dal ritratto boltraf.fe o ompaiono n 1 t t in quanto
il poeta i ff rma a ont: mplarl in e ricono l'amata
223
; analo am nte. in
un on tto ta iano ri olto al pittore urzio Ardizio. la m a a fuoco d Ile chiome,
della fronte e d ali ocelli n' ad prim r rillu ione p rim ntata dalfo rvatore
(<tu fai dubbiar vera chioma vera/ ia que t:a fr nt veri oc hi i n qu ti > )
224
.
Tranne in ca i di que to tipo. as i riamo al parado op r ui n i te ti u ritratti di-
pinti la nominazione d Ile parti del orpo. dir tta o m taf orica, i dirada ri p tto alla
den it media del anone lirico; la te a nominazion t nd in e a inten ifi ar i
quando il p ta i urne in prima p r ona il ompito di riLrarr ,e men lle can-
zoni della Bella Donna di irolamo Muzio o nell lanze di B mard Ta 0
225
.
Del olto del corpo di una donna ritratta la po ia tratti n pochi imo ma
ancor m no con erva di ci eh potrebb identif aria om una b 11 zza individua-
le. In quanto u cita ramore d' la meta in guita dall'arte la b ll zza' oau tta
' o
a una duplice idealizzazione. Da una part . gli epiteti h la a ompaanan ono
I gati al uo ruolo n i confronti del po ta-amant , non allo tatuto della inaola
figura lipinta
226
. Dall'altra. per la trattati tica h fonda il canone d crit1ivo la
b llezza ' una, empr urual : 1 rare e ezioni al odic , om la p Ile cura, ono
222 . 11 quadro. Ippolita Torelli {1851, Londra. Tate Callery). po to nel 1851, an110 d Ila nomina di Easllake a
pre ident Academy, fu distrutto nelralluvione del 1928; riprodotto in HAPMA , I IENRY r Pt.AZZOTIA
2001. p. 301. f1g. 139.
223 Dum cultwn et reputo dccu iuvcmae/ crine , frontrm. ocul gen . lab Ila./ n quitia , mauum,
fub Ila (De se el Boltraphio, V\'. 5- ). Per il lr to completo r la trad. cfr. supra. 2.5.
224 78? .(. opra il rii rallo de la serenissima signora principessa Hargherita di Manlova del J 5 J, del signor
C'11rz10Ard1ZL0). V\'. 7-8.
225 Cfr. infra. in questo paragrafo.
226 Lr fattezzi dipinte pc o vengono ricono ciutr p rch imili a qurlle he ramant - pel.lalorr lia ui 11el prtlo
O lii'( ('UOf( . o
230
inl nzionali, ibit non fanno h conf rmar la r troia. Il compia iuto indugiar
ull doti anatomi he tipi o di Angelo alli o di Olimpo da a of rrrato
227
' fortr-
ment fi ico ma non arr ta la frarnrn ntazion d I i ibile: il rov cio . cn ual df'l
canon illu tre, h ad gua ogni oag tto della vi ion a un i t ma ba ato ulr nu-
m razion ariata dell parti, u lu nt zza e proporzion (Pozzi). La el zionc
lirica d I orp diventa tra lit:t razione di una b ll zza concr ta in una bellezza
ovraindividual . ublimando il contingente nell'id al : un in i me perf tto di parti
perf tte. L' anorumato d I ag tto femminil non dunque ol qu Ilo di un tu liri-
co e di un oggetto pa ivo ma anche quello di un'ld a. dell'in arnazione umana di
una bellezza esemplar , i ui t rm ini <li paragon ono ener El na. i ono volti
e auardi di certi ritratti eh ri ono er mmo tra entinaia, p r il taalio d gli o chi o
per 1 in linazion della te ta. ma lo t o non i pu dire p r i relati\' on tti p r
un e rto tip . di imrnaaini (belle, ortigiane, Flore) he nella loro it razion o lo li -
ement variata n l loro on d r i a una l ttura in chiave alleaori a i a ricinano
molto alle bellezze de ritte dai po ti
228
. Giovanni Pozzi ha cautamente uggerito
un acco tamento tra gli ornam nti d Ile belle dipinte e l m tafore del canon
d ritti o mentr Elizab th ropper ha vi to in que l immagini un luoao vi ivo
d l paragone tra pittura e po ia
229
. empr una e rta mi ura di m tapittura
p eti a nella crittura lirica he pii ita il tentativo di riprodurr la Bellezza da
part della pittura.
Leonard in ntra proprio ul iitratto femminil la el bre ar11omentazione eh
contrappon la lin arit della parola alla imu.ltaneit d Irimma!li.ne: [ ... ] un m -
d imo t mpo, nel quale 'includ la pe ulazione di una b ll zza dipinta, non pu'
22 Nel rampo clclla rapprc ntazion drlla hcllezza une tendenze .di lunaa durata che
il petrarchismo italiano eia quello france e o in"le c. hanno radi 1 profonde, he nsaJ ali . celte dai
icili.ru1i rispe110 ai mod lii prownzali. Le linra pi - o uale, rappr ad da Rrumhaut d
tutt' altro che , incente 11('( 'otaro r. per que ta \'i.a, nella 110 tra trad1z1one. D1 pm. a prc,al. r n Y mten io>C
dci no tri poeti non r l'ogg tto dell'amore (la domm) ma l'amore stc-so, con .la sua e I _10:
pr val u madonna. il di. corso d'amore tend a di incarnar-i - il corpo pru:isce [ ] mau"llra la lmea
[ ... ] rifie ivit ehe ar ('t1rat1cri. tira della lirica icaliana [--.) fino a e I 988b. P- 8 ). Lo
conferma anche il fatto che non ri no canzonieri italiani, rou poche eccez1om (qualche silloge quatcr
le ra colte di Olimpo da a .ofrm110 o ad la f'irginia di Er ole Taso) che i i.n:itolin?
di
11119
d
f d. .- a onA (rrr >oo. ). u1 hbn eh bla 011s.
onna com acracle 1nv1re nr1 canzomen ran 1 puma gen r z1 , - -
d di in"olr parti del corpo. taJ,olta accompa"nate da in i;;ionL cfr. AU ' DERS 1981.
228 BlER 1996 (p, 138) dcfini,re l'idealizzazi ne pitlorica e retorica tipica del eia ici .mo com.: di
codici rappre entnlivi e di hterrodpi che pre indono in largn mi ura dalla rappresentazione dell 1or-
. ai p I B Ll c1 P l a il \'eccl110 RrL\,'m t 9Q2 ha ot1ol11w11to
porea p r 111 zzo di una ra onughaitza re 1,ura. er e e e 1 a m . . . .
I 'd e o e tJA ritratti ad e empio 111 un 11wc11rnno
che anche gli u1vcnlan d I ttmpo non e 1 c111111cnvai1 . co.n 1101111. 1 ' -
d 11 52 la 11011alrice di /iulo eia Tela della Oo1ma m mo al mto (pp. 93-90).
'>'>9 f n . . 1979 19 i. cli ritratto (v rbale e
1
1it1ori ) rita"lia ali interno cli un codice l'tilturnle
- , r. FOZZI e ROPP[R u. cliff '
(l' idealc eia i i la d Ila bellezza f nuni11ilc) i connotati di 1111 . oggeuo fcmminilr che 1
' 1 I ' I a" ,.; ma rlli - p r mezzo di r!lnah 1cono!lnthc1
za di liii alltent 1 a ra >Om1glia11za, mc l\' I Cliii, an ora p1u t e1 o.,..,. u , ..
(11biti , oggetti, impr . mblemi, a.llc<'orit ): proprio p1nh1; la della e P r d ud
I
11 d' I d lei b Ilo la rnppres nt11zione dell 1de11 ' tc:.sa d1 bellezza. chl' l' tlr-md1-
r as 1 1>1110 1 llogo 1 mcc to 1 sc
0
m e ,
vidua.lizznta (13lER 1996, p. 158).
231
dare una bellezza d 'Critta [ ... )
230
. Con apevoli di non pot r i ttrarre a yu<' ta
accu a. i poeti i fanno forti del loro rilr':lrre clispie(Tat? nel lempo. dando fonda-
mento teorico alla ompo izion !in ar d 1 orpo propno attrm-er. o un e.remplum
fiaurativo: quell cli Z u i a Crotone. diffu o tanto in poesia quanto nella trattati ti-
retorica e arti tica
2
:
31
Per r alizzare un ritratto di Elena la piL1 bella delle rnor1ali.
il miti o pittore avrebh copiato 1 parli pi b Ile <.lelle cinqu pi I ell fan iullc di
Croton . me Z u-i dipin e Elena enza av rla mai vi ta. ma con la mediazione del
testo om rico. co ha fatto l'autore del ritratto di Pantea de critto da Filo trato:
enofontc ha dipinto la bella Pante a otro il profilo morale. [ ... ] ma come fo srro
la ua capigliatura. le ue -oprac iglia. il ' UO guardo o la sua bocca. Senofonte non
lo ha detto. ben b fo e moho abile a soff errnarsi su dettagli dcl genere: ecco ora
inwce che un uomo non brarn nello crivere. ma abili . imo nel dipingerr. che non
ha mai incontrato ma che aveya dirne tichczza con ,cnofontc. rappresenta
. . J'j>
Pantea, coi com I ha 1mmagmata nel uo animo--.
Il procedimento elettivo e combinatorio he avrebb perm' so al grand arti ta
antico di rappre ntare m1abellezza eccezionale - enza modello umano possihil - nel
Cinquecento viene impiegato anche per ritrruTe in parole oa-getti in carn e o a.
Una donna che abbia in tutte le qualit fi iche e interiori di un monstrum ideale di
pe1fezione imporr a lunque intenda de cri rla 1 elezione e la ra colta di ma-
gnifiche parti. accade in un pie olo capolavoro del genere, i Ritralli di Giovan
Giorgio Tris ino; ultimati nel 1514 ma editi die i anni d po:!::1:i . L' op ra -egue da vi ci no
il modello delle Eikones di Luciano2.
3
-1 e il clialoao ri vocato nella once muo e daJla
curio it di Pietro Bembo. che de idera cono cere ridentit della mi teriosa ferrare e
la cui avvenenza ha tordito ramico in enzo Magr (Macro): una bellezza senza
nome, ma probabilmente nobile; in quanto la ua compaania e i uoi ornamenti ap-
paiono a ai maaa-iori di quello. che a privata donna richi dere i pote se
235
. Per
riconoscerla. Bembo ne chied, una descrizion dettagliata una ' de crizione-come-ri-
tratto', che Macro potra tracciare olo attraver. o un montaggio delle parti pi belle di
cinque nobildonne d 1 tempo
1
identificate dai nomi o dai ti1 li: le quali (mie parole)
imparando da Zeuxi, con pi convenevole iuntura: che aperarmo faranno tmo rit.rat-
230 LEONARDO 1995. p. 18. e cfr. infra, 4.2.
2.31 Cfr. infra. : i.1 .
232 FcLO rRATO 1997. 9. cPantea, P '1-t9.
233 Ro111a, presso Ludovi?o degli Arrighi e La11titio Perugino. 'ull csi tenza di una prwdc11l1 ('dizione, nza
tipografiche ma probalulmenlc tampata a Venezia da :\ic ol rrAri 101.l'lc Zoppino, d11 collocare intorno al
1;:i21. cfr. BrnR 1996., p. 143.
:\elle Eikones di J. ,uciano i crlcbra Pant a, amant di .I ,ucio Vero, che nel nome porta memoria della
d1 a prop.o 1to della quale cfr. supra. il riferimento a l-i.osr1tATO 1997, p. t .+9. ' u differenze e omigliun
ze tra 11 dialogo lur;1anNJ e la prosa di Trissino si offcnna B1m11996, pp. 1,44-157.
235 T111ssu.,o 1981. p. 20.
232
to; il q11aJe le parti e ccllenti <li eia cuna di que te haver
2
3b. Que to ritratto di paro-
le ' a1traver ato da una co nntc cli c1ninazione di metafore figurative riaoro amente
applica1 al codice verbale ( cUsegnateci [ ... )con le parole quali i ono le sue fatteze:
per le mie pruolc [ ... J dipinta
237
) chC' culmina nell evocazione cli al
momento di colorare il (li egno appena compiuto
2
:
38
.
Davanti al ritratto (Use
0
11ato da Macro. colorato con le metafore del Poeta e
completato dalla grazia
23
(), Bembo re ta profondamrnte ammirato ma non anco-
ra in grado cli ricorro ere la d nna. Lamico allora i offcrma lungamente ulrac-
conciatura. i ofoielli. l'abito, la caretta che la portaYa e il libro aperto che teneva in
mano, tutti indizi che permettono l'individuazione. nel t sto e fuori dal te to: olo a
que to 1nmto che Bembo ri ono e la Marche a di Mantova. ed olo a que to pw1to
che il lettore pen a a certi ritratti di I abella d'E te. La coni pondenza i!mi.ficativa
e ha valore pi uen rale. 'i che permett di di tinauere bellezze altrimenti tutte
uaua:U' l'habitus un comple so in i me cli elementi che compr nde i dati 'i ihili pi
compcrto di a pet1o atteggiamenti, un luoao di connotazione
ocialc e morale e di caratterizzazione temperamentale. Da qui pa a la po ihilit
di ricono cere le figure, che siano in carne a o dipinte, ed u que to fondamento
che talvolta po siamo stabilire un confronto pi pr j o tra i ritratti dipinti e i te ti
che 11 parlano. Ad empio echi di una m da dai iitratti di Leonrudo o
Raffaello i tro\'ano anche in po ia. come n i citati onetti di Bernardo colti
241
o in Angelo Galli ( Oim le perl . oim l'alto f nnaalio/ che fa t fronte angelica
divi a
2
"'
2
). Come p r rrJi uomini rannatura o i egni della forza ed I potere (la pa-
da, lo cettro ecc.), co per I donne r abbigliamento e gli ornamenti della bellezza
0110 i oli a petti vi ' ihili che la poesia ' in !lrado di co(Tlier ed elaborare. ono dati
J ici ; ma la loro matrrialit, non u ttamente corpo1ca. non i e ami e in "ci eh
i ved : gi egno di alt:ro
1
e proprio in quanto tale la parola la pu affrontrue.
236 lvi. p. 21.
237 hi p. 20.
238 [ ... ] ri 6a llll"tieri di ptrso1ta. che tutl<' pote insit'me [11 parti] ce le colorisca: et a qmto i.I :\.(ante:
gna, n il Vinri, Aprile, C'I F:
11
phrnnore, e ci fos>ero, sa rehheno (H'r awnmra .uffieie11ti: mu uno di
tutti 1" pirtori fil!' . <'r Frrumsro Pctrana cbiamerrmo. e que tu a fare h druemo: [ ] {I\
1
P 22). 't'gue
ima sorta di cr11101w di 1essr rr petrarchrsclw, appena venato di parodia nel suo i tematico ricor;;o alt: metafor'
(caprlli d'oro. volto di new. ciolia d' f'hiuio, occhi come 111a11i hian he come peri lT.). econdo il procedi-
nwnto he sa r b11 cnsificato Charles Sorci.
23<J F:lcmruti 11111ct trn eorpo e
1
u1na nano cvon1ti iI 11l'i ri1ratto {H o: il ri o cl il antisimo pudore, l' la
11
ravil dell'andar<'. e la w11trati ne dcl surn (ibid. ).
2 O J
' / l ' " 1 I I 1 t1e trn1li mimt'tici che drsi.riurno
i , w 11/us, 1'11e 1.111 n rno ha molto p111 n 1rvo \' w m ,mrnno, e t, "' . . o .
la p1r ona. imliYitJuaudola (Br.en 1996. p. 1.) I). I ,'iconica imago drlla do1ma - secondo lu tt.nnmologm retorici!
li J Il d
I I" I r I Ilo )' "oi1a ( J - si "'111110111 !Il" d1,e1-,,anl('ntt' ehe
quc A. parte 1 e a esa1pt10e1c 1un11 w11z1orn' t <' . I '. ' . _ '
nel prntolipo gnco. di un co tu11u' nl 1
1
111po sontuoso<' 1nw\'1dual1:011to (I\
1
P l;:i-t).
24 1 rnr. supra, (' injo, 4.:3.
242 AI.1.1 198 , 99, , . !).().Per altri ecmpi per altTi nspeUi questione dr. tfra.:: -t.2 e -t.3.
23'
:\ i Ritratti il pa acrcri all qualit morali di 1 ab lla d E t a ': ne ol a id n-
Lificazion avYenuta per ompl tar I immacrin d li mar h a con l u ma cr1on
b llezze. i b ni d raninia>. up riori all' ffcri ( qu di fuori ): tra u-
rare di logiarli ar bb far com chi pi la v ta, he la d nna con admiratione
ricruarda- c
2
"
3
. L donn b Ile dall' animo vil on om i t mpli decrli antichi E i-
ziani. I cui pi ndid ar hit t1ur u t diYan id li anima! hi p r h' la I ell zza
11
n ba valor non a ompacruata dai d biti rnam nti he on le virt.
e i lo I mli o turni h da que t n na con >
2
H. Di fr nt alla richi ta di 1acro.
eh lo precra di e ibire uno ritratto d ranima di I ab ila. B mbo ot.tolinca la
diffic lt d l ompito icrnifi ativani nt e r a raiuto non j Pictori. n' di Po ti.
[ ... ] ma di Plzilosoplzi )
24
;, . Le virt di I ab lla. 1 n at dopo la voc il anto e 1
doti poetich . ono uddivi ndo la tripartizi n platonica d uanima: Prud n-
tia. \1run1 tudin . F rteza ( oltr il n u to d l donn ); 't mp rantia.
Contin ntia>: Giu titia>. Lib ralit, Ma nanimit>. Il ort o ompr nd doti
interi ri che i tradu ono in mores pi he in esla. ma i chiude con 1 qualit pi
atti, ( m no pas iv ). h di tinguono I ab ila dalle !ITandi donne d lr antichlt:
la Lib ralit n I circondar i di oucr tti pr zio i nel di p n are b nefci la crrandezza
d'animo. che la rende incr larm nte metta cren r a
2
"b.
IJ mo ai o di beli zze par , teriori e int riori. eh i ricompone otto ali o hi
degli int rio utori diventa il ritratto a tutto t ndo. fatto di par le, e di ent ntie da
le J.-1u deuat
2
"
7
che Tri ino offr a I ab ila. ull' onda dei Ritratti, il modello
d ll'irnitazion el ttirn ar ripr o nel Dialouo delle belle::.ze delle donne, intitolato
2-+3 Tn1. S1'0 1981. pp. 23-2-+.
2-+-+ hi. p. 2-t. \el Libro della bella donna d I Luigini (15- -+ ) r empio d i templi d'Erritto \i ne ripr o uhito
dopo il paragone del corpo con la \'e te. per il qual i riporta un argomento di Giulio Camill o: cPlatonr, romr
l'l'C'ita ancor. nelJ'/dea dPl teatro uo, Giulio 'amillo. induce ocra te. nel dialo"O intitolato Primo Alcibiade.
ammrrtrre la prima opiuione [cio che e l'anima ola r uomo]. Percioch di ce il ami Ilo . . come la ' ta rhe
portiamo non r noi, ma co a usata da noi. 1os il corpo. anror che ia portato da noi , non noi , ma ro a u ata da
noi (LllG"I 191:3, pp. 271-273).
2-+5 -rcondo le loro rtgole che dipin11er il quadro dcll virt ( qur t(' irnagini ). 'ome abbiamo vi sto ( 3.1),
nel rrondo on tto ul ritratto di Maria , avorgnan (RB ' ). Bembo aveva me o in cena l' animo drll 'amantr
proprio allra\'!rso uno cJ Il pa;, ioni di matrice fil ofica. t il mondo interiore dell'amata mediante un
elenco cli \ irt.
2-+6 ugli irnponanti cani ri petto alle virt propchll' dal moclrllo lucian o. rinvio a BEER 1996. p. 155, rhe e
la romponente platonica. l'll{(!!iunta dPlla lih ralit e l' arrcmuazion (attravcr o alerio Ma. simo) di piet
c devozione co111r virt particolam1eme adatte alla clonna.
TR1. 1-;o 1?8.1. p .. 28. li finale rkalcato u quello dell' originale greco mutati i rnat riali : [ ... ] riuniamo
1w'.1c111r 1 no tn. ritratti, la statua del uo e rpo clw hai modrllato e le pitture eh ho dipimo della sun aninin,
un1arnol1 LULte m una ola opera e mettiamola in 1111 libro offr ndola nll 'ammirazion di Lulli , ia dci no. !Ii con
1rn:pornn.1i ia dci pooteri. apr oppor i agli a alti del 1 mpo pi delle oprrc cli prlle, Parrasio PolignoLO e
'ara alla.dama_ cui L pi1 ili ogni altra immagine di quel tipo, perch non fotta di hgno, nr di
r1 ra. r!r rii colon. ma e ntratta con I i pirazion che provi ne dal! M11 e. s . r v roche sar il ritratto pi fedele
p('f(hr contcmporanenmcnt la hrllezza clrl corpo e la vin delranimo (Li; IANO 199-t, p. 109 [ trod.
.
234
Celso del Fircnzuola (1. 48) . dovi:' il verbo di egnarc11 u ato in l:'n
0
mrtaforico
in n o l .tteral , p rch' la pro a ff ttivamrnte int rvallata da cliemi2"a: nella
fnz.i n del qu t. rozz immagini mutano l a coltatri i a compr nderl' i
ra0'10namcntJ d1 eh illu tra I perfett pr porzioni di eia nma paiie rop r-
ta del corpo fenunnnl . Per l brare la bellezza f rnminil . li libro della be/In don-
na (155-1: ) d l Luicrini atting vol nti ri alla ede natural d Ila ua franunentazion .
la poe. ia: tra le u fonti , P trarca, B mbo (tra crli altri. p r i on tti X. ) e Ario-
to2"<>, el. brat . ritratto. di Alcina. an h n l Dialouo della piltum (15:-.)
di Lo lo 1c Doler. P1u ad rent. al mod ilo 1.r iniru1 ' l'op ra con cui iw ppe
B tu i pen di corredar il Tempio in on re di ioYanna d ,\rauona (155-1: ): I . uc
Jmauini del Tempio (15. 6) realizzano pre i am nte ci h il per onaucrio-Bembo i
ra propo t n i Ritratti: io p r eia una d 1 "irt cl l'animo un ritratto intendo
di dimo trar i
250
. i t.raltava di rifiutar . a un primo li Uo. il modello combinat -
rio, r alizzando un inaolo ritratto p r o!!Tli virt, poi di ripr nd rl . a po teriori.
m tt ndo in, ieme i inaoli ritratti. Betu i applica il paradicrrna di Zeu i al ritratt
mora) . ali t ndo una ompl a ar hlt ttura en ona tica. rtan1ente d bitric
della fontana del Furioso (XLII 78-96)
251
:
[ .. . ] Ed affine he non ia chip r al un tempo po a mai rimprov rarti. per adorna-
re co b lla ima!!.ne far non al trim nti che i fa e anticamente r ecce LI ntis imo
Zeu i nel volrr a Crotonia f armare il imulacro di Y nere: eh dopo lo aver voluw
veder ignude tutte qu Ll c ali quali di pi belle av vi dato il n me. da akune
tulle belle ei tta olament la belli ima parte n quella rarit inuolar fec la
divina fi gura. o v alio m trarti . dir'io. eh tu fac ia in que to. che di tutt'
quell . cl lJ quali per al una rara ell nza ru hai alzati i n mi. quelli tu mi rnda
ricordando d io in ramente fa ndoti pale e il pi rar d il pi perf tto dono
rh abbiano, quel! po he rhe ci parranno c 11\'en ,. li el l!.'1 odo. di quell faremo
il ricco mpio della b Ile D nna, non meno, for , pr uiato p r le deun tatue.
rlt per la ce] br Di a. Ed a iorh i veguia quanta mae tria abbiano ad avere in
' e come abbiano a durar rt me, eia cuna a\ r a piedi d I uo I mbo quel de!!no
artefic che a aver dato pr gio e nom , col valor di qu Ua. [ ...
l or o di un dialoao tra la \' rit e la Fama, il ritratt di i vanna. ania-
to dal Tempio ompletato on un ritratto dell irt. ocrnuna in amata
248 FiRENZUOl..A 1977. ad . p. 741 (cdi-.(g11a1rci ... : cf:crovelo qui .. . ; c\'rdece le linee .. .>) .
249 L ICINI 1913, p. 23 .
250 [ ... ]io 11011 ve nt voalio componcre di molti w1 , me YO fatco ri il t:h di :at?ca P<:r
".1mor , e co a pi conwnr ol
11
pictori, cl a ultori, eh ad altri; ma io prr eia 1111a_ dc lr \ irtu dt' I 01111110 uno
ntrauo intendo di dimostrarvi pi a l'originale simile, h potr (11n !NO 1981, P 2,)).
251 fr. s11pl'(I , ' 2.3.
252 1 15 6, p. 21. ,' ullc lmagini del Tempio rfr. Roet 200 , cap. lY.
eia una nohild nna ontem1 oran a. Le do11ne-\'irtli. tulle mini tre di lei nel ri
0
ono immaginai come latue che circonclan qu Ila di Giovanna. come
una r na di bellezze interiori:!'.i-1_ La pro 'a procede econdo uno che111a fis. o: la
\'erit indfridua la qualit principale della : inaola dama c. u richic ta d Ila Fama,
nr d la d lnizi n : indica poi quale p eta n ' co11scn-at re r ricorda un compo-
nim nto critto p r lei (in a n r d dicato alla qualit di cui eemplar ). li ruolo
che rio to attribuiva ai cartiali o t nuti dall e tatur dai poeti. alla base della fon-
tana. i allaraa. Yirtualmente. ad int ri t li. formando una struuura dama-\ irt'1-
po ta-, r i' a , imilabilr alla tripartizione ritratto-cloaio-epigramu1a o al 111odello
emblematico (imma!!in -motto-\" r i). La familiari l di B tu .. i con q11r ti nodi
di par I fiaur ' e,id nte anche n 1 linal dell'oprra. che si chiud annunciando
un.ult rior fa cl lrimpre a d coratirn d l mpio: a cos gradite Imaaini . ono
per aggim1aere d a ia una una Impresa COJl\'enernle a quella ,irt Lt. sotto la cui
forma la ho fatta intaaliar . ai di tutte nrlle mente mia ne ho r ordire [ ... ] ,:i:;'.i.
Il mo I Ilo monumental qui portato aJl"iprrbolr mctalettC'raria i fol1(1a ulle
tendenze autorifl iY della d . Tizione poetica. I ui oalie ono spe so marcate
da preterizioni. topoi di mode tia adden amrnti <li m taforr pittoriche. Qu ti
e p di nti incorniciano il Can ne>. mettendo in CYdenza roperazOll ritratti -ti-
a che la poe ia compie in quella ezione del te to. pe o la promC' a l"annun-
io del ritratto in carte> di,enta pi importante d Ila ua realizzazione. rivelando
ome n Ile trate!!ie rli autopr entazionr drlla po ia non conti tanto e C'guire
que t compito quanto e primerne I'inteuzione. -C'I on tlo C' n I madriaale i <>-
anali le i ali del ritrarre> i riducono a p che formule. m ntre mi ure lunghe
come ranzoni e stnn::,e ernbrano favorirn l" e-pliritazione. p cie in C'd liminare
(incipit e conaeclo o apertura chiusura cli equ nza ). un n1Pcra ni mo eviclent
nelle tan::::.e di Bernardo Ta o in onore di Giulia 'onzaaa e din'nta ancora pit1
, .j to o. ad e. empio. uella Bella donna di irolamo J-1uzio. dieci canzoni comccu-
tiv in cui lo eh ma del cano11c br ,e:. . i cornpon i di la la (La bella donna.
I capelli. La fronte. Gli occhi, Le guance, La bocca li collo, lL petto, La mano.
La bella donnat'" ignific:ativamcnte J'C'hOrdio e rcpiloao. clic segnano i ('()!lhll
delrr periment descrittivo. hanno I te: o titolo (La bella donna) e 0110 due
2:):j 81,1 L SI 1 :).)6. p. 119. dow ricorri' lo u,.,o ipiteto d1r ,\.re1i110 rifrri,rP 11111, in1 cli Ell'o11ora Conza"u ritrai
la da TiLiano. Cfr. infra. . i .2. r
2:>-t ( ... ] poich_r_c-ol t 1011 11 lodi d1; l!it'i ,piriti. d1"oggid , i,ano. a lei il Tempio hai fabhricato: rnl
uome. ,. ('(J menu drllr Jllll fllfl C'h omrid ahhia tutta Europu. voglio rlw Ili adorni r \l1arr dmt hai (I
locare_ il di' inu CIO\'\\\\: rhr qurstt lmagini -.aranno i frrgi
1
wrpt'1 ui. <' Ire la faranno risplen
dtn: .' 1010,,1. dw lr rolomw. 1111' la 11rn111rrra11110: r l"tl!rna ba>i . .,
11
la quale rr.,Hr foudarn r
Qu1-,1e 1111111agu11. rlw 1111omo rei in11a11zi al 'illO alt11rr ;;a n111110 lom1r. qu1.,tr qurll e s(lranno chr pi1
n:?Uarclnole In rrndera11no. ( ... ] (B1.n-. .1 15:>6. p. 20).
2:):) hi. p. 121.
2.)6 ' ono lr rauzoni lii- '\Il dt'll1 /ii111r ( 15:) 1) clrl \luzio (.\lt 1.10 1997 r 2007). quali rfr. \"1.c111 I 981J.
236
1cnlativi. li a figura intera: la prima canzone (lll)
r i11tnam ntr co tru1ta hull un po&. 1h1hta dC'lla de.crizione r r ultima ( II) rcr1i. tra
un rn11 ap vole fall irnC'n lo:
c. 111a11rando111i l"artr e le parole
da ritrar lri di(' l"alma mi clipi11111. (lii.' ._ 11-12)
[ ... ]
Quinci la mae:it dc I" ampia frontr ( v. 29)
[ .. . ]
Ec('() apparir doppia fidata -.corta:
lr illanti al111c luci di' inc (\'V. :35-36)
[ ... ]
Che dcbl>"io dir de ramoro-.e uotc (Y. -+3)
[ ... ]
urgr a novella lode
il b<'I collo. cl" \mor, ra rolomia.
\la qual fin lodi mai. che conve1111a
a la hrlt drl grazio o oggrtto
in rni \irn meno ogni umru10?
Dico dcl dilirato acro p lto. (n. :-:- -60)
( ... ]
E qual -.ar cl1 la mndida mano
lod< mortai 11ia111ai l aguagliar i? (vY. 63-6-t )
[ ... ]
bia'>lllO 111('. rarclir mio. lo C l'arte
ch 11' ntai di ritrarre in briC'\i cari
la gran I citate ond"ogni ba-. o ingegno
poria d'ogni sua parte
prend r materia ad ogni ampio cli-.cauo. (n. ?-t-78)
Yoluto ho internrn 111 e far di ' "110
di belli: \Oluto ho. a parte a parie.
tentar se rne' per me forse ,'ado111bra:
ma 1 dir 1 cor m"ingombra
mi mostra poi cl1' inara110 umano od ari<'
non pu ritrarre in carlc
un tale e tanto e co, ehiar ggctlo
eh<' , 11011 eh.altro. ma abbaglia lo ' n1rll<1to. (:\Il.'' 21 -28)
La s mbianza ind rivibil i m1 011 li fronte. occhi. g t . collo. p tto e mano.
h lh zze la ui < J parizionc' int rY::lllala la mani rate aff ttazioni di modestia <lalla
domancJa f('( ll' a ( V . ,) , 6' ) all'autoa li ' H ( \'. 7-t). Il ritra.rr C collocato nr]
pa uto ma com te11tativ pitt eh on1c alto compiuto (tentai di ritrarr ).nel
momento t '. > in cui si ccl hra110 1 potenzialit rratiYe del 110 ogg tto: la bel-
Iczza della donna ' tale hc anch un inueun m .di crr potr bb t:rarn da o 11i uo
frammento i pirazione e aru m nto p r tm urand cdi 17110 >.
Cna br v in ur ion nei t rritori d l pr im t:r la ui toria O' (caaia quella
d Ila ]irica ( daJla l'ila noca a O'li A alani) e in ro ia qu Ila dcl ritratto po tico (dal-
la omedia delle ninfe fiorentine alr. l111orosa pra). porta nf rm iunificative
alla orri pondenza ( ra della d rizi n e m tafor pittorich : il rapporto
tra uuardo. de id ri descriptio ntral in que ta tradizi n , ull fond d l-
la ort e d i raaionam nti d' amor . . lr morosa opra (1 O -1:-0 ) di Ci vanni
:\luzzarelli in ontriamo tr orti11iani ill un ont topa t ral : il narrator ' chiama-
to a 11iudi ar qual ia pi bella O'a l donn antat daO'li altri due J a aliere
trn du ritratti cdi par le> tra due rpi umani eh non ved . Il u ' un giudizio
di Parid enza guardo uza orpr a. p r h' egli a gi he i du ri ali parlano
della t a donna n condivide la pa i n ma ta , ompia nd i di a lta-
r parole e er i in lod d IJ'amata
257
L'eff tt della diffu a t rminoloaia pittorica
( combre1111iar . cd riY r >. cdi erna..re, cdiping r > ). u ata in rifcrim nt al-
rimpo ibilit di r nder il modello. ' rafforzato dal parall l be i p ti-amanti.
a cinaendo i a cantar . i titui ono tra e t i e miti i pittori anti hi (Timante
Proto11ene
258
). Il ccanon > m r11 oprattutto n i ver i m ntr il l metap tico
onc ntra nelle pr eh li introdu ono
2
.;Q:
[ ... ] O non ta b LI zza pi mai. chi t vor b n descril'ere? O opra cel ti m di.
citi ve vor b n con parole imitare? O leggiadria nza fine, !ti te vor ritrare? [ ... ]
Diventino tutti ali u mini Om ri , facciau i tutti ergili. h non ba taranno pi[1 a
e lebrar la mia donna. che fa e un fanciullin ap na nato a d criver i fatti d I
oroccio o chili o d"il piet o nea. ( moro a Opra, \')
[ ... ) ai mi cont nto pur un'ombra dise nar d le u bellezz pur ti.Il
eroo <limo trar d le u lod . (hi. 111)
[ ] megli h Y potr depingervi. o pi pr to dissegnarvi anzi ombreggiarvi. ad una
ad una con le mie parole qu li poche bel! zz eh I animo mjo, pien di que to ardente
de io. mi p tr far i primere [ ... ]dal capo pigliar prin ipio (ivi, 111)
25 l:l ntir a uomini di grand in
11
<'gno com' rano que ti , bastanti a tanta impre a, celebrar Jr lode di e lei
che tuL11 tre amavamo l amamo: il che mai non m'era ba.staro l'animo di fare, an r eh emprc ne fu i uto
mo?o o[ .. . ] 1982 [Amorosa opra], I ): cE i mi ridu vano co hrn a m moria le
pm <l !!1l altre bellezzr d l'unica imperatri de no ai cori et a 1)i bi d l' anima le mi
a part a parte, eh 1 le vedevo apertamcnl tutte (ivi, XX.Xl ). ull'Amorosa Opra in rapporto ugli Asolani cfr.
2000.
258 .Amorosa Opra. XXVI (lillantc) e XXIX {Protogcne); entrambi i riferimenti rompaiono a proposito druli
occhi r C!?llono argomentazioni parali I . fr. and1 L I (ali ro cxemplum di T11nantc, ripre o in LVIII).
2:-9 M.a cfr. ivi, X, vv. 1-8 ( 'io pote si , amanti./ ritrar pcrf ttarnente ron parol</ una donna cele t , un vivo
sol .I' hr .tanipata nrl cormi tiene morej o dimo trar in parte/ alm n cli la belt r' ho nel pen ro./ e narrar
non p les i a part a part I tutto quel ,.-ho nel core).
238
[ ... ] il volto d la rcuina d l'anima mia ho gi ron molte parole poco men eh
ritratto. cond che l' inu uno 'I tempo, amm ndui pochi imi. m"hanno lasciato
fare.[ .. . ] (ivi , L)
L rganizzazione d l t t i r gg ull alt rnanza di I di. parallele p r oaget:ti
per rn tri n lla forma di 1tn d ppio an ne br ve
260
: la e mpetizi ne tra b Il zze
tra forma o in una fittizia aara tra ritratti p lici- uara 'di ndo grado'. artifi-
cio a lirica - all'in r ci tra amor gr to, al7nizion per verba innamoram nto
per fama.
no tant la pot nte r t ri a d lr t rnizzazione. la \1.ttoria dell parol ul
temp pe meno n olant di qu Ila pi Iraail umana. ott nuta dalla pittu-
ra. li ricordo pu rinunciare alla oc aJ movirn nto. ma mo tra uno traordinario
atta am nto all mbianz i ibili. alla po ibilit di e Il uare un olto a un nom .
Que to ar tanto pi ero p r un amor nato n l ilenzio nel il nzio rima to, com
qu Ilo immaginato da Robert Br wni.na n l po metto The tatue and the Bust. eh
narra della pa ione non on umata tra il granduca Ferdinando I e la po a di un
nobiluomo fior ntino: on ap oli eh il loro an1ore non trover mai compimento.
m ntr , in un ' att a int mlinabil ana. il loro a petto mut r. 11li amanti decidono
di annuJlar il tempo tra f rmando i' in oper d. arte. La donna fa porr il proprio
bu to in ten-acotta (mod Uat dai Della Robbia) al po t della fin tra alla qual era
olita affac iar i p r o rvar l'amato Ferdinando fa ollo ar una -tatua eh l
ritra a cavallo u piazza dell Annunziata, di fr nt a palazzo Ri ardi. I du ritratti
fi ranno co p r l'et rnit l irco tanze d I prim in onn , quando lei lo ,1.d
pa ar otto I u fin tr . P r quanto Ja rim v I romanze a, la le
11
a nda non '
inumm dall di tinzioni di g n r h biamo tracciat . La d nna re ta all'inter-
no d I palazz n 1 qual il marit lo la ti n rinchiu a. appar aff et mo ol
attrav r o la orni della fin tra (e in quanto tal ' ia in pot nza un ritratto a
m zza fO'lU'a) mentr il grandu a i muo e in w1 luogo ap rt al enno d ila ' 1.ta
pubblica civil , om tal i fa rinarr .
260 Dttll'nlto al ba la ra e!!lla d Il parti compr ndc: . !!uardo t preme 'u gt'nerale. chiome. ll!bO, occhi. goH>.
b0<ca, fossttte, rollo, prtto
C.\PITOLO Ql \R'I O
IL HJTH 'l ,OC \IE OPER\ ff .\RTE
-+.1 al co11siulio al pittore
, ' he could '><'<' it ali "o cleark . o commanclingh. when h looked: it
"as '' h1 n ,,hr took her brnsl; in hand 1ha1 the th:inO' chanO'rd.
\'ircrinia \foolf. To lhe Liuhthouse
,\ fronte dell"1110rme diffu io11r del on tto ul ritratto in ace zion encomia tica.
cosa resta. in poP ia. della riH<' . ion ul ritrarre come perazion delrmie? E in
e ' U. chr ruolo hanno gli echi dcl Yiagaio ttrat rr no di 'imon .\ qu to
punto del percorso. la do111anda che ci iamo po. ti p r il xr ecolo - quando
il uprnn mum e,a i primi pa">. i e pr nd \'a una fonna .,13bile - d Y ten r onto cli
collClizioni 1111mc: una uniformit lin11ui tica. 11na pi ampia rnriet di
imrnzioni retoriche e !-iopraltutto una eh I" a e n ape' olezza torica e teorica. che
in!lurnza la poesia e a rnlta 11 'inllu nzata
1
.
In que lo quadro. rif rimenti al larnr d Irarti tao alri pirazione eh . in ieme
ali' artr t' ali' in11 uno. ne gui<la la man . i trornno sia in testi che celebrano
ritratti gi compiuti. :.ia in . on tti dedicati a effi11i 1 uram nte immaginari .. on
pari natural ezza il poeta- pettator pu affermare di tr nn- i in pr enza di un ri-
tratto pptfft' fing re. nono. ta11t una lidascalia h affrnna il e ntrario (e: opra il
ritratto ... ), r it i' J'immagin non i, ta ancora. e di pensare improbabili ni
La rontarn inazione dcl sonetto ul ritratto con il modello del consi
11
lio
al pi I tor in t ro luc uno arto e miderernl ri pel to alla f rma nsacrata da
P trnrrn, Br lllh DelJa Ca a. \ un'imma11inr compiuta. rpo. o sp cchio e alter-
ego prr una [HH' ' a he m dita sui propri limiti. si affianca mi"inuna
11
ine ipotctirn.
anc ra la fan>. h on la u. in nsist nza muta i e n11ini cl l confr nto tra pit-
tore r po ta.
1 Lu 1 rnl1a1 i,1 icu. ud <'o<' Illpio, rirorr<' ni , t'r,i eomt urgomt>nli di cli111ll>tnltio111'.
2 Lu 11011 ro111raddiziom tru i-1ru7io11i (' tfliirir 1'0111piutn r <r nt'il'ode lht' tHIOHlllll'J'l'Oll1il'U ritnlllO dell't1llllllll
(Carmina l11ac1wmt1a 198-f. 16). du ,i d1i.1d1 co11 il d1e i11urromp1' l'nnbta. intent a dipi11!!l'rl', ptrrhr
I opt'l'H ,1111hra pr111dert' ,ita.
T I ditti op trar h co ( fr. 1.-) I in ontro con Laura dipinta apparten va
a un pre nte indefinito. di abitudin . e la r azi ne era oli cata nel pa ato (eia
ritra e in art >: uando !ri.un ... > ). La tradizion uc e iva, pc i cinqu n-
tc a, t nd a m difi ar il rapporto tra tempi d Ila poe ia e tempi del ritratto: il
colloquio on rimmagine. e n uetudin ra ntata datre t rn in fom1a indir tta.
i onYcrte in apo trof . in monolo o me o in ena nel t t ; J' e cuzion viene
in,e e po ti ipata in un futuro impre i ato ( on tm annun io o una richie ta)
0
Yi ne olta n 1 uo rnl!!m nto, davanti al qual il po ta reaai e int rvi ne dir t-
tament . ue to proc o tra forma l'op ra e mpiuta in una rnplic po ibilit d l
pre ente-futuro. di arti olando il n o qua i id ntitario he in P trar a i primeya
attraver o un ae to preci o: il e on tto>, a n m d l po ta, e n anava al pittor
lo trwn nto con r to della ua art (a mio nome ali po e in man lo til e> ). La
rottura del leaame p r onal tra p ta e pitt r i a ompaana al tra colorare del
critrnrr > dalla lett ra alla metafora. eIDo di un 'appr priazion empr pi clu-
irn del I i o f
11
urativo da part d I di cor o metapo tico. fino alla qua i compi ta
cancellazion delrarti ta. Fi ura emblemati a di qu t pa a1111io qu I cP trarca-
pittore gi ern ato nei Ritratti di Tri mo. o hiamato in cau a in un onetto
del opp tta:
Qual tem raria mano imitar vuole
la pi b lJ' opra che :Natura t a
mai fabbri ca e e non potria . nze a
riformar pi r al te bellezze o] ?
hi la luct' ritrar d I mio b I ole.
e lunge abba11lia e trugu chi appre a?
Amor eh rha dentro al mio core impre a.
or ne va icco e del uo ardir i duol .
Ritornerebbe al ecol no tro indarno.
per trarn empio. di Zcu i l"ingeuno
on gli aJtri ch.ebber fama di quell'arte:
olo il pittor eh rga onora d Amo.
dal ciel di e o. ne ritras e in carte
eque la Laura e quella in w1 di egno:J.
'hiunque ia il pittore eh intend ritraJT la donna la ua mano t m raria
i di a o tenere una fida che n' la atura. rifa endo t a ( non
potna [ .. ] riformar). n Amore
1
imprim ndola n 1 uor (or ne va i o>) n' i
3
CoPPE.TI\
1912
LXX Ili. li soneuo fa part cli una ri e in lodr di Laura della 'ornia nipot di papa Giulio lll.
242
piti ti ( p tr bbero enza Jl'im-
po ibiJ1ta iperl lica eh . domma il on tto, <lall tncLptl lllt rroaativo al vcr o 11_.
i ottrac ol cil pittor eh r a onora d Arno> - cio' P trarca, a norma di una
diffu a pcrifra i? O piutto to imon Yfartini. di ce o> dal ci lo dopo av r vi to la
vera immaainc di Laura aruwnciato. n ila m moria d l l ttor . daali caltri ch'eb-
ber fama di quell'arte ( cfr. Rv/L IL v. 2)? ' imon e Petrarca. o mealio imon -
Petrar a: nell id ntifi azi one tra il po ta il pittor n IJ'u o an ipite di ritrarr
in arte, l'a e zione p trarch ca d Ua formula (di anar ) e il uo reimpieao in-
queccntc co (dc ri ere in parole) i fondono, in un'ambiguit intenzional mentre
cLaura> d Ila omia i riflette n Ila ua illu tr omonima.
Me o da parte rarti ta, il I ta ri ntra in e na parlando di ' come di un artis-
ta. Con perfett a oer nza ri p tto a que te pr m e, la fa e del pro creati o
eh i rimatori pi vol nti ri o erYan n i ritratti ti qu Ila che e i te i. in quanto
poeti. cono cono e perim ntaoo: 1 op razione m ntal h precede !' e ecuzione pra-
tica J U'opera:>. 1\ei onetti eh la de rivono. la ,;. ion le te di imon :\Iartini
riemera nella forma di un"intuizion int rior . ulla lin a indi ata da alcuni com-
mentatori, come Ge ualdo e Dani 110
6
. P r int ndere lo arto tra Petrarca e i u i
lettori cinqu nt e chi ' e enzial con id rar il pas aa io, m diato dall' Orator di
Cicerone, da una on zione m tafi i a dell'Id a (r cyd a di Rtf LL'\.) a una intel-
lettual (di ' rappre entazione mental ), h a ua volta pre uppon un movimento
inver o: l'elevazione d Il' 01111etto d ll' art dalla r alt mpirica alla forma di una
con zion arti ti a
7
. que ta diff r nza i aagiung la di parit, ben ril vata da
Panof ky, tra la nozion ago tiniana di un Dio p r onale. p r cui !' arti ta ' mediator
tra il mondo rnat rial I Id nella m nt divina, la rivalutazion rina cimenta!
dell imitazione d Ila natura eh appr da alla eone zion , hiara in Ya rui. delridra
com ri ultato d 11 l orazion di dati n ibili
8
. om rtdea cend daJJ1iperurani
alla e ienza co il pittor t rna ulla t rra, arti ta-di nel quale il
rov , eia il olar topos del dells artife:r:. Da anti ali' cademia fiorentma. ne
17
l1
te i anni in ui G ili r titui e a R1f L Vll la ua ompon nte plat nica
9
la
' nf t 1 011etto Q1mlfiiil pillor s tememrio e
.. La pre rnza di , 1 10. 1 drrn 1111 comuni oli " err 't' un co ron o con 1 s . .
stollo (TF.BW>EO 1989- 1992 fl/ l 91). citato supra. 2.3. li dato pi[1 rile1ante mi mbra la .1
1
:
.. ' I ' d I t la chiusa riwndicando la p(bs1bilita di
nell a 111 entrambi 1 dell a onda tcrzma a rr 10 e compommcn o. ' ' . . d'
1
( I 1 ) I p t ( olo il pirtor) "-'fa carico 1 eone u
un rrtrnll o autentico nHpettJvamente al 'cuore o o 1 ror nuo e '.l oc a s ,
ioni che, pur volH' in modi molto diversi, depon110110 prr la poe 1a l' a favore dell artr. .
1 fil fil fi ' d Ila poe ia ul ritratto cono-ce un mdLdl-
5 qur ta una delle rarrioni p r cui nel ,niquecento l ne 1 O o l' .
1
9
B)
bio viluppo, pur non u crnd dall a po izione minoritaria hr abbiamo riscontrato per
1
Quattrocento .
6
' d' fi - i ire prima ima!!inata la cosa, eh r"h
Vogliono i Platoni ci eh 1 me nella mente 1 ciascuno art 1c e l'
1 1
1 "'
desidera di fare, os nrlla divina ment ( .. . ) 1541, r. 62r) . .Cr. supra. 2.7.
7 PANOF. .. " 1996, p. 9.
8 Cfr. ivi , pp. I 9, 35, 38.
I 1
..
1
, , he
0
Lia rnent qudla irua!!inc e
9 An li e elli rriv , eh im n dopo aver contcmp ato < ea .. . (LP ) S)
quel i111ulncro tanto bello e tanto perfetto di h , h' rrli ha di poi m s-o e dipmto Ul cartr 'P -
... -t3
concilia e n .\ri to1cl . BcM I tto \'archi fa d l concrtto l'argom nlo di una bio-
ne. n I 1; -t . poi c:Ura in i m alla ua Le::.done. opra la maggiorwi::.a
delle ar/1 (1 -!9). cornm ntanclo n n Perrar a ma un poeta in arad cli intrnrnin a
pirno titolo n !la - !'arti- ta livino p r eccrll nza. ,\lichcla11crclo' o, aulorr
del nett .Yon ha lollno artista alcun conce/lo:
.\on ha 1"011 imo anbta alcun eone tto
c"un marmo olo in 'non circon rirn
e I uo rehio. r . olo a quello arrirn
la man che ubhidisec alf intrllrtto
11
.
La pre enza de] con ett , 11 l blor o di marmo la po ibilit di Jib rarlo.
p con crui?a cl ll'intelJ uo. i -piccrano on le nozioni ari toteli he di potenza
e c:U atto. \ h.i In qu t luocro i piglia e ncetto dal no, tro poeta p r
qu Ilo he_?1, mm d1 opra hiamar i da' Cr i idea. da Latini e.remplar. da noi
modello: CIO e per qu Jla forma o imrnaO'i11e. detta da alcuni int rizionc. che memo
d nella fanta ia di qu Ilo h int ndiarn c:U ,. Jere
0
fare
0
dirr1:!_, ap<rr
c1_1e /\11 approvo qu ta lettura non i impedi, ce di o: rvarr eh ranali i
di \ 1 entra opratlutro ulla prima quartina. I roprio orn il commento di
lh X'1IJ (.dr. 1..-). La J arazi ne di primi quattro eri dal corpo del
te to mette rn rnbra il I ro I cram on il ,ero terna d I n tto. la natura analocrica
d 1 n o tra l du quartin :
!1 mal eh.io fu ago. e 1 ben eh "io mi prometto.
111 te. donna I gg-iadra. alt ra e di\ a.
tal i na conci : e prrcl1 "io pi non viva.
C'Onlraria ho rane al eff ttorn.
fn un implirito. il ronretto latente nella pirtra e rri. ponci alle di-
\'er e forze mot1ve p t nzial n t 11 1
r ne p1 enti ne amata;_ e I aU alllanlP "he
vanam nte e rea di ottenern t C I
1r a. om m a trr te tr di f1 helancrcJo. 1111 oprrn-
I O ulla Jcoria ari i. tifa di \ardii rfr. \]
1
,
01
I. ,
198
., f\. .., .
<rrafia \ella le--ione i fa rif P: I)
0
p" - ""\ IC K 198 r B11toc c.111 19<J8. pp. 7 -/H. ro11 bthfao
-- 11111,nto a 11m1 etrana \!olza JI I \ I I . 1 I
opi-r1 rf"anr rfr l\\TtlU 1 ?QO' \ fC)
9
Q e . 'li (' nmr I" H' are Il 'lf'"O I C'utc'o 111 11111>11 t' Il
- -r. LBO.\JC.O r , llJQJ)Q :2007.
11 BL0\1RROTI 1998. 1.)1. \\. I+ Il pii \alerrtr cl "r . . I . .
in un tutir!J blocrn di marrao r . ,, I Il r"
1
ta
11
''' 1111 ro11rc110 lw 11011 posoa s111rr n11d1111>io
. rrc 0111ato1 a q111 a 11111t1n1 <be e Il '' - f
10. a elargii con i 1rnza hf n il 1
1
' up<'r lla mp11w 11 Cb o:,. a natizzarr 'flll.' corrcct
1
) \" , li
1
' rttcr hfJ 1a1110 una rnano rh ia guidata cfolrirrtrll<'lto (Rr,idori [fbl. ]).
- \RC111 19?:3. p. J:BO.
13 f310"\\RROTI 1998. 151. \V . ).8.
1-t ' i traila di liii fig11ra11te i1111wrf11to. 1101<1 Fc1tDH1 ' 19 - 7' ' . . . .
fora rwllu pne. ia di \lidwlan,.rlo l'fr. lk IDORJ :200-t.c
1
.:i. P .1. I er llll 1wu111 nll!'ii,10111' >ull nnr comi' 11u111-
2+t
ziont' arlistica diventa fiaurant di tm contcnuto C'roti o .piritualr. la pr ci ion
ron cui ,irn dc. critt tr ttarnrntr lr
11
ata a qur ta funziom'. Co nri madri11ali,
come per leNzr, donna, si pone ( 152). , 011 pur d'argento o d'oro ( 1:-3) e ,Vegli anni
molti e nelle 1110/te pmoce (2-t I) <' nel 011rtto e ben roncello ltaLla dil'ina parl<'
(236 ). Qu sto dato non toalie va lor:< lrttura cli \'archi. d w riflrtt. r
0
izionr doppiam nt anomala d1 M1rhcla11crelo: la ua cnttura lmca. -r1ttura d1
arfr,ra-porta. non i ri . 1)('rchia nella scultura p r parlar drlr art<' od Ila p e ia .
1113 per dar corpo a desidl'ri amoro. i an ie La pe o orpr
dente della lingua lo a\ \'ici11a a Dant . <011H' era v1d ntr cr1a per 1 contemp rane1.
mentr I<' tor ioni drlla inta. i <' re tr ma den it onc ttual lo appar ntan a una
delle pir alte rilll'ssioni -;ulrimmagine comr incrann e in il di
Lorenzo dr' .\1rdici (c fr. s 2.8). \nchr i11 \-lichelancr lo l oprra d arte e ontolo!!l. a-
mrntr j 11 frrior all"fdca. ma quc. (ultima. com ha notato Panof non Ya inte a in
s no strettam<'1tlr neoplatonico:
.\!olio dil r 11 a al intt'ro .,ano
ropra della prirn"artr. rhr n"a:-. ('lllhra
i ,olti r !.!li atti . '' co11 pi1 \'ve rn mbra.
di rt'ra terra o pietra. tlll corp. umano.
, 't> po 1 tempo a-.pro (' 'illano
la rompe o :-.tor('e o del tulto dism mbra.
la lwh che pri111 rra , i rimC'mhra
e . rha a miglior lo<'o il piacer \H110
1
;.
La noia av cr ione <li liclu lancrclo p r il ritratto trO\a conf rma nella i
ass nza. tra I u rime. di te. ti eh lrhrin l"i111itazion di una figura umana
. 1 ( l i co ic tto haIJa li,ina {la11e/ 11
d1ndualr, -;e non com tcrn1111 e 1 paragon r > r I e , .
I I
. 1 I
1
11 / l lo ('On br ,. Yi1 modello/ da nta a
HJ lor g 1 atti e a <'un. po oi quc o e I pio va 1 .
' )'' O l li d e r111 0111mt ntI j) r la \lan-
a 1. 11011 f rza d arte u. )O z1 rn
1
u. . ,..,
17
. 1 e di
1111
fficr1 non e
11
t11ta ( l. -1. 8)
c111 1. quasi e tori 1 a parzia 1111 n az1011 . . .
1 \ r I ( )3C) 9-tO) e uno leali ep1taff1
i ver i fon:; clrdi!'ati a un ntratt e 1 1tt na ,o on11a . , .
l
. . , 1 ll"ll to funebre I u de
p r , ('('ltin Bracci. del qual arti ta pr g t1o 1 monur ' . .
. . I . l 11 I . ., cru" h morte I 1>0 eh tal opia
Rrarc1, (' s ritra1lo pnvo (e a ma. I rn . u e '
ha 1 I cni11na ort I d"entnu dipinto o' i n n pote rno (202). . . d.
. . Il tt lr (o' r ro lr du noz1om
La 'i.'ione oltr mondana e il cc n tto mte e ua . . . ...
f
1 . ;, , 01 Sf)J["llUUl e - Il I Ccl I
elci a) l<'11do110 a coinriderr - nella rma 01 un 1111lllzt
1
'
15 Bt o-; 11111011 19')8. 2:l?. "'' 1 8.
lii hi, 2:1u. \\. I+
17 Per i 1r,1i e prr l'epioodio rf r. Boi.tO\I 2008. pp. 197- t 9Q.
m 'ui. per tatuto, il ritrarre non i pu f ndar u dati en ibili, ad :empio
nei le ti h ri!ruarda110 in11na<ru -acr . i pu' imitar<> Llll m dello in carne O' a
1
cr rappr , ntare G - Dio incarnato in wia fO'ura umana - ma id .alm 11t un
ritratto> di G non ' pcn abile, p r h' non i d un a o mim li o alla uc1
rappre entazionc, e m <limo Iran 1 I O'aend dell ic n a h ropit . E emplare
in qu to n o ' rn1 on Il ta iano dedi ato un pillore per l'immaaze di Ges
bambino io-nudo:
\on da ran di z li i oppur d' p<'ll '
o d'altra che 1 crute orni e c lori.
ha tratto q11e to runor d'eterni amori
il lecr!!'iadro fattor d'opre novelle.
ma dal pittor che di er n t ile
pi varia il cielo, e puri almi plendori
nude form in qu e le ti ori
al pen ier rivel pi ard nti e bell .
Dunque al i I fu rapito. e 1 chiaro e empio
\ a lui fu mo trat o n lui di ce
maravicrlio amente il .\fa tro eterno;
e f ne l' alma il imula r interno.
poi la dotta man eiru ndo il pre
dal proprio cor. quasi da \1vo t mpio
18
.
Per il uo Ge in fa . il pittor ( fattor d opr n velie>) n n i i pirato
all"arte umana, di Z u i o di p ile, ma alla pittura divina. Di te o. ar h tipico
pittor > fa tro. ali ha riv lato in i lo il chiaro empio (l id a nel cn o
di exemplar) oppure ha format in lui un imula ro> int rior (il con tto) h
la dotta mano> ha poi pr o dal uor come da un tempi vi nt 19 La alita d 1
p nsier> ai cel ti cori e n I luogo d ile pure id e d li anim incorpor e ( nud
forme>) rip te indubbiament qu ila p trar h ca di imon (ivi> ' il luogo d Ila
vi ion enza error do aU anima tr umanata vi n m trato il mod ilo prrf t-
to ). ma i compi n i domini di un iperuranio piu int n am nte ri tianizzato. h il
pittore ia tato rapito in ci lo. o he il iclo ia o in luj I' p rienza en ibil non
un pr uppo to deJJ intuizione intelJ ltual eh i e tradotta n ll'op ra dipinta.
18 RT 16:30; il sonetto apparti nr allnime compo te tra il 1586 e il 1595.
19 ' ull'immagine rll'I tempio dcl cuore cfr. CAJJ,1 ARO 1999. propo ito di uo aluo sog
11
r t10
arro. Maria Molza si chiedi e l'artista per diping ria ia tato in cirlo:
1
0
fu pur in '.aradiso./ ed 1vt dentro a' uoi color ti t e (Giovane Donna, rhe drgli occhifo111i, vv. 9-1 O):
n >onrtto l le"g in ALBRECHTBOTI' 1976 (p. 54 ), rhe propone altri e empi di testi liriri IJ o getti reli11iosi, ed e
commentato in 2008. p. 300.
246
d
un on tto di Anl ni All gr tti. proprio una conver ion piritual '
tan o a e 1 'I . di . l ' d. . . F t.
t h
P
mi o al miniator 1u io OVIO ntrarre a 1vma au ma
I' vento ir a
fan in.i:
Qual m ra\iglia, ol \o
don Cl LIO n I trrre:tr . ov e1 gia a.
non p te tr fonnar la bella i<l a.
l'idea del ben d I ciel pi raro p !mo?
E. la dotta man nza o t crno
d' alto<' pur inteli tto non ap a
il b<'I \'i ritrar <li qu<' ta D<'a.
ch"o!mi arte avanza, e vine ogni di egno?
Meraviulia fu b n, dapoi che 'l cor
ave' te pien <l ' int ra fed .
umtl torna te a l'opera gentile
h 'I d le ri o, ove 'annida Amore
11 1 v de:
mo tri lei \' iva mort O!ml uom, e
. 201
0 O\Ta uli altn avventmo o til
Il rom onim nto fa I a ulla ripre a, rove ciata. di
al v. 1 e ahermativa al v. 921) e ri olnqduil ta attrttav(r
. . l f . n m nta con e o '
fcd di due atti r atlV1: a ormazl . . d Il t un rinnova.tu nto
. . d Il ' ( ,. -8) u1 rn pon ono. n e erzrn , .
z1on pral1 a e op ra ' . . ( , 12-1-t) La ituazione eh
1) l
f d l ntratt compiuto ""
interiore (vv. 9-1 a P r. zwn. d condizioni limitanti: in t rra (nel terr -
tallo riev ata n li quartm d n u ?2 il t '"1 di un mt Il tto calto
, . l id a>- . nza o ''"
tr , ) l'inae<rno non puo on prre . . : D . , d m'illuminazion divi-
, d . t all piraz10ne Il\ ato a L
pur> la mano non aT ea':11
1
. a ar un pre uppoto e enzia-
na o da una m mona t rr na il mrnla r mt ta unmaO'ine u1t rmedia
. . I d Il . In man anza qu .
le p r l'e ccuz10n matena e e op
13
. . .
1
pittore arebb . al lim1t .
e della po ibilit di arqui i rla e
1
not'O oltrcpa ando il orp
o tr Lto ad attingerla da una m nt cli'
1
a. d . p r. , e er rimo o f ca-
1 h
ll fanta ia 1 po .n puo
he la ra chiudr: un o ta' o e,
11
a . . [ ]/ [ ]/lo or map e fu
l
' d l tt ( nd il p1tt r . ..
ment . attrav r o ap rtura p
. . 1 . rallo de la lfa11citw.fallo da lui. .
20 Rime 1565, c. 541', A Don Giulio mtntalore, opra I nl . I 'r e ude- o, ronferbC'C all'immam
. tic d('' r farlo 11 po1ere e H art
21 Il follim nlo di prima non dove a lllp1re, m
11
.
1
d'
. I d' r cluunque a auar I . . 1d
11 , p rch la figura mbra ,ha urei( e amo " . . . l()Cra
7
jonl' m male: qut 1 ea
, . . d il nrwmc1110 a un d Il' I
22 L' uso del v rbo e formar in rapporto ull idea
11111
c'.
1
e
1
. la tritura 111rdocim111ecen1csca e iuicl
. . . . d , nbinaz1onc 111 Ul 8 l on
non 1 nttingr o 1 v(tk, ma 1 ottiene a lUl.l coi ' '
dmo di Z w;i (cfr. infra, in que to paragrafo).
.A?
il cli cgno tolto/ natural comr lo f naiura
2
;
1
). o pi rcali stica11Hnt!' a11air lo dalla
parola. trarnitr la d scrizion ( \ irn 1 rrhastr ntro la \ ' O tra id a:/ , iwJ il
ritra r. r no 1 Yedra./ lo stil. eh 1 parlar \'O. tro cbb prr \ ei ai <'vocati
sonetti di iuliano Go lini -u un ritratt post mortem d I . rfim'nzione
poetica caturi 'ce proprio dalf id ntificazionr del modello eguito dall'urti la con
rurunaaine del bambino custodita Il .Ila memo1ia della madre:
Ben nr sali ti al ('irl. piuor urntile.
iYi il tuo chi11 la\Oro.
dw rrnclr di rnonr il poter ,ilr:
Piet tempr i colori. il !>UO le,oro
a1 er. r. e n "e \mor lo rile.
cha te d fama. altrui' iw eri toro
2
h.
Il dipilu ' tal r alizzato in ielo (i\i ) con l"aiu10 di Pi t. \[emoria r
pr1"oni1cate a eia cwrn <lellr quali \ien a-, 'e<Tnata u11 op razionr
aJ rnrarto P.ittorico: ri p ttirnmentr t mprare i colori (la pirta pro\'o-
e . i rnlti com le tele). offrire un rrp rtorio per
l (la memona cu tod1 ce un t oro di ri (H'Cli vi j,i) <' ostciwrc lo : tile
(I am_orr mat mo i pira r O'uida la mano drlrarti ta). Il mo,inH'nto che conduce
p1 col? e o al uo ritrntto attravec o urrnma<Ti rw mr111orialr (' un
. ritratto d I l I I ri .
. 1 r 1 a trn rnettr a 11ttor : rn qur. to percor-;o. la fiO'ura in carn
e_o_ '.l <lipmto eh I eone de una econda na cita ono 11010 i margini . roperli r
n 1foh di un 1unao proce . o interiorr.
X Irinterpretar il pa arrCTio dalrispirazion alroprra. la po sia del Cinqu crn-
lo lo colloca in uno rrnzio o ()e o l "t
. . ra mo r rnterno. tra trrTa e c1 lo. tra e rpo e
arnma: de cnYe11do que r li111bo )Jr"nat I I Il
.. , .. ' a< (P e1mnrnO'm1. 1 poef1 accent11anoora
I muta dcli idea che lartista p ' , . . , . l e
. . uo o SCI\ a1 r m c1e o o nrl cuor dc' ll amante. ora la
ua onrrme Jnj)O ita In l'Jl(J d 1 . .. . .
, . 1 onettI ( 1 raz10 . mazzoft1 , 11 tgnor Fabn:zto
... fer:;1fwuralor 111 cem l arti ta I d
. . , , . . . . l\. ora componrn o r ncornpon udo il ricordo d Ila
emlnanza fu10 a lih rare 11 pirazwne ( furor):
F.\BRIZIO. ritrar nr le
111
,. cartr
brami colri C'hr ili mi rii ra. ,. rnorr.
') 'l ( . ,-
- .is:o1.1 .)H. Libro primo. maclr . ' l I
nifou I' finf' Ira ll(J<'na '"' ('UOff' rapi . . I I . _ 1I('( Pr <fili' chP IU////ra (p. :3.j 1 ). '' .). 8. 'fru 111od('J10 -.ile-
li nura < r pr110 1 11 "'''"' JJ . I 1
a o la 1i io111 dint111 d1Jr. . ( r I' ,. lii ( Oll>Urto JH'r '>Oppnrn1n a lmrnrru l'lir Jlll(JC'( hl'('
') 111/(/f{llll' e r. \IGO\t t<J?i (' RO 200'J)
--+ Lo. El 1'' 1:;88 . .'enmda Par1r. CL\ \\Il. n .
6
_
8
.
2.i In. pp. 318<!19.
26 l1i.CL\\\J.\i .CJ- H.
2-t8
r darle q1wlla grazia e qurl 'alorr
di chu, I 1 cirl p<'r arri('chirla ogn.artc.
com icn che pria rimiri a partr a parte
le faltezzl'. il \'f'fitir. raria f' 1 colore:
p('l' 11011 mirar lwlt minorr
rallo ne ,adi in olitaria partr.
Qui' i fra Il' pur rirnlgrodo in 11wnte
l'oro, rrhano. i fior. ('la IH'VC.
i cri11. gli ocrhi. le "Uanrir. i lahri e il
rnmc i a lri presente.
1111n erti tal furor. chr dando in hrrve
opra a i l'olor. o&.,frrai mc a pirno
2
: .
Le i. lruzio11i dcl poeta ricono cono alr r ra d. art un oriO'in pi namem . en-
immer 'a nel!' e. p rirnza vi iYa. um ntano il mrccani mo d l ritrarre>
ndlr ue fa i principali: iunanzitutt ( P1ia} il pittor d \T o ervar a a
part :t r riainal . ('. amin nclo r a p ltO ( l ). r . ( <Y -
una omponentr d<lrtwbitus }. l'aria r il col re (ali cl m p1u.t_ecruc1}:
"li conven ritirar, i ubito in un luoO' i olat . per non ri ch1rue di imbatt r 1 m una
hrllczza mi11orr - llll accid nt <l gli occhi eh con dati.e
r impr visti il limpido ri ultat di wia pere' zion . Raccolt.o m
una litaria partr eh ricor la ceni dant hi lu glu d lla mem na. arll ta
ripen r al m dello e ar improwi ' aJnent di m1 furore he.
mettendo mano ai colori. e eguir un ritratto p rf tto. La piena odclisfaz10n per
l'opera compiuta i I ga alla funzi n h. aH il po (':
H ). CO com . ratto dell'art i ta h . in olitudm . nvolar !Il ll1 nt I_ bellezze
a imilabil a un yagheO'O'iarn nt di tip er tic . che rend <pr " nte I ?O'g t.to d I
d iderio (v. 12): alla m nte cl 1 pittor ( orn a quella d l p ta petrarclu ta} ti :or-
po <l Ua I mia ontrn1plata in a enza i pr , enta m una duplice
. . .
1
f 1,, to come 'Ottolinca la rt0'1da
m monal . rr1 rtorro do1 pw e pptamente o 1 rzza . . I:'
I 1 fi fi ( 10 11) Lolerazi n combmal na
rapportatw e 1 ore ma aurant1 1gurah '\. - r , . ,
I
. . . . d' d I I Il l ua riproduzionr mat nal e
e 1 111trrv1cnc tra la v1 10nc 1 retta e moc e o e a
I
. . . .. , .
1
Il ( t
0
) h '1tti1wendo al te-
mo to 'rema all att1\'tta fanta t1ca e a m nt<> 1111ag111a ' <
soro della memoria, co, trni eri lahora u11 , imulacro interiore:
Ella [L'imuia!!inazionr] eia la mt moria, ow niccolto
Dr' , 0:1 ri fregi i11 tant crui :;parsi
\'ol il te oro unio,
Himl' Li'>9, p. :3o:t
Tracrn talor le belle luci. e 'I \'Olt ,
Le Yoci, e (fii atti , le bellezz ond'ar i
o membrando voi me te --o oblio.
E -or<Te indi il de io
28
L arti ta pro ede om ali amanti lontani. per i quali frarnm nti i ricordi, r _
cuperati e riuniti. mitiaan l'a nza ria n rano il d ideri . Il ]oro t oro ' un
r p rtorio di b il zz . ma, attraYer o i fiauranti d I an ne> pre i alla lettera, pu
tramutar i in un forzi re di pi tre pr zio e:
Ben ch'io ' 'iva lontano,
pur rbo interam nte.
Donna, il t or ovrano
di tua belt. ne l'arca de La m nte:
e ben di i t oro.
de I tue labbra endo"i i rubini
e le perle d d nti. e L'or d 'crini
29
.
on empre. per. il di!!iuno \: ivo i azia i pr pri fanta mi interiori. ondo
un topo pr ent !!i in a aJcanti in ino. ondannato da Dante
30
, in a nza
dell amata ramante la e r a in aJtr donne. Ilo t o modo, in un on tto del
Go elini l'immaainazion i alim nta di b llezz div r cono ciute p r produrre
un t oro emanticament ambiouo n 1 qual i m olano amata' ' rep rtorio
rie h zze:
Quando di yaah donn letta chi ra
veagio. e non lei. ch'ava:nti gli o chi ho mpr .
acci che n de iando non i t mpr
l'alma. e enza il uo b n lanruisca pera.
il bel rimiro. ond'' ia una alt ra:
qual pittor. ch'a l'opra ua contempr
vari colori. io de le vari t mpre
formo al de io l'imagin ua era.
h i pregi eh natura i11 mille par e,
n la mia donna accol e fe' 'I lavoro
28 P1c:;xn.Lu 1996 LX Cm 1. ( /la l
2009. pp.
274
_
275
_' '
1
zonr cn:a J e ontananza della sua Donna]. . 67-73, 11llA qual cfr. E1.1.rno
2
: Careggianunlo poetfco 1611. c. 1:l5r. Il madrigale, iglato T '. , i pu attribuir a To111ma o tigliani ulla
ha e d1lla sua pr en7.11 in ICLL\,'\'"f 1623, p. 88.
3
~ Peri il rdilativo scambio_ <li. son lii tra Danll' e Cino rinvio a R I 07- 108. Il v. 14 della rrplj a di Cino recita: (eh<]
111 mo tr onne partr nu dilr11i.
C'h per mira I novo in terra appar e:
C'O . rarC'oltr an h io dole ri toro
d' art uentil , belt lontane e spar e.
du vicin mi vagheggio il mio te oro:! i.
Quando il u auard incontra UIL amppo di b Il e donn . I' amant coali il
meglio di ia cuna ( . 5) forma un.immagine mentale dell'amata un imuJa ro
veridico h offr al d id rio p r op ravvi, r all a nza f i a di lei
32
. Que ta ope-
razion ' paraaonata a quella del pittor eh me cola i olori ('" 6-7) e i pieaa
attrav r il parai! lo tra la Tatura l'amant . in un vinco! rafforzato dalla forura
etimoloaica ( ac l >-ra colt >) e dalla rima quivo a par >: ome la , atura
lta unit nell'amata i pregi di i i tra mill donne, o i il p eta ha ra colto bell zz
e par , per comporn una ola. ec ndo un fortunato topos d Ir lo!!io pidittico.
al momento della na cita la donna ha ri vut un dono. nella forma di una dote
fi ica o int riore da eia una divinit
33
la ua venuta ulla terra i e verificata in
una onaiunzione a tral po itiva ha pr dotto il rit rno cl lle 'irt una nuova et
dell'oro. o B iardo nel primo d gli morum Libri interpretava. via Petrarca. temi
~ nziali d Ilo tilno o e di ogni p ia d Ila I d >:
tto.
'on I i ritorna qu Lia antica vita
h con lo eff tto il nome de oro avia
e con I i in me al i l tornar 1,ita
34
Com ha 011 lin ato Pan f'k la rifl i ne anti a rina ' Cim nta1e ull'arte
non ha un att aaiam nto univo n i onrr nti cieli imitazi n d ila natura
35
: Z u i
31 Go llll\l I 88, Prinrn parte, L\.1111. . . .
32
1 , 1 .. 1 I alia soitolinea I op1>0-1z1on lonta-
Lamata e bl'mpre 1>r ente a li O<'t'hi della rnrllte ma non a1 Cll5I. ul
1
rl tu.e ' - d
1
-
1
.
1
l
o/
. . (C' ' d I . . e pi mlte belle= e a tre< o1111e
n 1wrno, a enza/prcscnza clw cml'rgc n I finale dcl ollrtto 1ze e e iane
la suufomw.ndo, se la/a di lontana propinqua [Ibid.]} .
:13 CCr. DE I UD . 1989-90.
:H BotAKDO 2002, 4 (Ordito atea J atura il degno effeuo ). 1Y. - -1 t Jr. R1f \ \
1
' "
6
I
66
t Rif L l \
~ . - prodo11i "li aneddoti del pa -
,,5 PAI,OFSKY 19% pp. 7-8 e -8 (e [ . ., l ('011 lo te o entus1as1no con Clii \'Cng llO n . e- ' . t' ranrdcloto
d I
' . , . orre fon.e anc ir pm 01 Cli t
. crue rnvallo r<l pportunamcntt' intrtrrati r li pm re enu t"tmp1. rn '
diZeui[ ... ]).
2 1
r il pittore cl ll'm a he inO'ann i pa:s ti e insieme l'autor dc I mitico ritratto combi-
nai rio di 1 ... 1 na. r il mac tro d trillu:.ionc (' Jll d l uperam nto della prrfetta
ripr duzionc della ,' OllliO')ianza . \11 nl\'CI" O la ua fiaura. un mito di cTeat i' it umana
' i proi tta ulla t --a: di una bellezza naturale ' i parla come di una artifi-
ciale. di una donna come di tm.oprra d'artr. di un 'r Yiwntc om di un ritratto.
ome o:. , rrnrn Holand Bai1hes n lla ua lrtt ura di 'arrasine. il orpo reale (dato
come tal dalla fnzion ) ' la repli a li u11 mod Ilo artic lato dal codice d Ile aiti.
in mani ra che il coq o l i --natural . qu li d lla Rambouill lh<' I ambina. non
ni nf altr he la prome sa del codi e arti ti o da cui derivato in antici1 0,:
10
ln
un onetto di arlo Riccio. il t ma n n ' appunto la bell zza eco11 la tra. po ta
di un ffiO'ie. ma quella oriofoal impar crgiabil di un mod llo in carnt> e a. la
donna alla qual il te to i rivolere:
Zeu i gi quando a 'rotoniati pitN'
la beUa greca. prima veder ml
tulle I b Il . e ol di inqu 1 I e
I de!!ne parti. ond La Yera ,in e:
e natura alor eh "ella,; cin e
d Ila po2lia monal. doruia ritobe
r alta belt eh in mille , ol accol e
e n ,. i bella g ntil tutte lt' trin:ic.
Tal hc fra tutte rip rtat il 'anto.
di quant al m ndo f ur. ono. e aranuo
di ci. eh altrui puon dar art e natura .
\ ' ro che b Ila are ti altrrtanto
e i almen pirt d'ogni mio affanno.
o dole drl mio cor o te!!Do r rurar.
Zeu i pu diY ntar w1 'er I ropri paradirnia cr ati op r il poC'la-amante
ta. per !J' l"an dcJoto di ui pr tagoni fa(. Wl mito di pillura
m i mc d1 ut ptctura ed al uor <lrl parallelo rhtori o-picturah (Lecrrcl r
18
In quanto e:rernplum tra . , i prr ta a ill 11 trar innumrr oli frnonwni. dai
prore i cono citivi aire prriC'nza amoro a. dalrimrna inazi nr alla descriptio ome
ritratto di paroJt>'.!''. 111 w1a pro a pi tolare con epita a . tr uo contai 10 con i ' r i
:J(J B\RTllb 19?:3. p. 55.
:p liiuw 1.)60. l'P 1.>8-1.)9. \Ila
:J8 'ul ruolo di Zrusi 1wlla rill1
rapitolo\' <lclla "'ronda pat'IP.
1ew1 don11a ri1<>ho il "m!'llo prrC('drmc (Qual 1-i"di<1, qual /,ippo, o qual !Iprite) .
io111 s1ill"irnitazion<' ('fr. al11u110 \BB\Tl"iO 1997 ,. \lorn 2QO:l . in pur1irolarr il
:-19 [ ... ] ('()1111' Z<-uxi 1111and1> ""'(' Ila ,., I . I . e . . di . [ ] e . . I
' " rmp10 r f' .ro10111u11 p111;,r ... e> 1 nuchor 10 q11r;,11 oprr< r rll<'
'r _:)_
della !3ella Donna. Girolalllo luzio d .crive la rn truzionr m ntalP di una donna
ccompiutam ntc> hc Ila. la sola chr i d bha amar<':
L' huorno aclunq11e ania11do et <lowndo la prrfrtta lirll1zza amarP. nr in una ritro-
' auclola. la dm rr fra moltr ami, r riC'ercanclo. in quella guii,a rlrr gi f e<r Zeu i.
( .. . ]: et rolni . IW\C'rHlol<' tuttr ignudi. 11c tra.,.,e fuori cinque bellis inw. dalle
quali appn.,.,o. cl1lle pir <'<Trlle11ti bellezze cli eia cuna fa endo ritratto. e nr fece
qurlla nobili ima ta' ola dr Ila imain <li 1IPlr11a. non men C'I peranrntura
non nHn bella d1lla \era 1 lelena. Co. . dico. cimer fan cwni uentilr pirito. ch e"li
raffi"urt'r in 1111a gli occlri . in altra la bocca ct in altr' altrr belle parti. di maniera
rhe. nrlla menti' 1ua..,i di una nUO\ art pi1 bella I lelena la effiuie di 2nando et
color!'nclo. egli :o.i trmer una cornpiutament!' l)('lla donna amare. ( ... ]il
1
Prr la lirica. all'orizzonte di Zru i e"' empr Elena. la pi b Ila cl 11 morta-
li. controfigura pi o nwno e plicita di tant cl nn cantat . o addirittura \' n re.
e La D a rhe ' ipri onora (' r iperbolico termin di paraflOlle Yocato p r il ritratto
clrtramata ( fimagin .li mia ,ita) in un nett he i uliano e ' lini ri,olcr ad
\ntonfrauce co Raineri:
Po eia dw gli orrhi tu i 'agl cl'altrzza
Ratto l'imagin di 111ia ,ita.
Chr tal appar. qual ,irn rlla m' imita
1w,,..,o ad alta ineffabilr doleezz .
RiniPr. tu narra altrui com<' bellezza
' par,,a in pi1 corpi. e ... da te rrradita.
,\llor 'edc ti in u11 sol C'Orpo w1ita.
E pit1 rara che 'lual altra . apprezza.
Tu btesso di' clr<' quellr membra indarno
Le pi h11lr si irnavi. e eh<' ol qu
Degn<' rra11 dr la clra di<' cipri onora.
Indi !->nivi di lei forma
E cli farna r cli gloria auclrarn1 an ora
,\ paro \dda r 'lhin co11 .'orga l't \ rno"
1
I I l
I I , I 1 I 1 L .. 011,1111 1olt' uiun11ir11 d1e -a111ra11110.
'u a natura a 1 lllH' puro 1 <uro; t' qua 1 11npnram o e n t'tL\I. ron p111 t , , ->
furn11nou110 ri1r11110, il quale I\' p11rri t'\1elle111i di di qu'.t1 l111\er. [ ... ] (1Rt
1
'
0
JQ8J. P -
1
) ..
O I
. d Ile 11ro1m1 rune
i tlO 2000. I. l. I 9-21. I :11111on ro11sidcran1 q111,tr lt>lll'rt' unn,. rlll < 1J>
11
gazic
111
. t ,
1
.
1
\ I I I 11 d' , ...,.1 h1 cin multi IHl'-1t'anali11 t'
propo-110 < t' la <'rnnda ltttera d1l primo bhro la cun11m't' 1 <' r "'"' o--t
1
'
1
. 1
1
I. I r 11 1 \ mda ,niont' dd (';m10111tn ue
thmci-1 1 a n 1proca t'l'll r ru la co1111io:.izionr dell rnn p<'r 11 io < rugonit. su
1
. ,
\I . . [ . ti Il 11 1artt' dd ranzo111111. LOlll-
11z10, ( lu di fJlll"lC 11ri111l' lt' ll l'I'!'. I riftriiucnll Il l<'Sll con Ulll Jll li pnm I I r . ,.
I I
. . . f f.; 'l ' l . f .' . I I Il 11uesH' Jll'O' li 1111110111' I I
prN <' t 1111 ranzoni ti lln be/fu c/11111111. p1r 11 quali r r. upm .. .v.i tOll t 1
1
'
1
.
011
".11 r'fi I l 11 d" l I i111lil1l'1111 ntrllto Jell anton'
" ' Il( ll71011t' I' rnmp t'lllt'fllo I (' opt'nt J'lll'l l l'lf , I' I ('(),(11.IZIOlll ( I
il R1N.1t1200i , I/tre ri1111\ Sa.
2S3
Il p eta orta il oli aa- pcttator ad ri,er una vnon , traordinaria. qu Ila
a ui ha a i tito ammirand reffaie di tma donna dall'a p tlo in omparabi l : in
l i ha 1itr vat riunit l b 11 zze h va.nam nle ( indarno) ave a e n id rat le
mialiori n Il a loro f nna parata ( par a in pi orpi ). Com riv la l'Esposizione
in pro a che corr da i Cento sonetti d l Raineri. l"immagin in que ti n . pr babil-
m nt una medaalia r alizzata da Leon L oni , 1itrarYa lara AJbignana, la moglie
d l Go elini
12
. Gli iiwiti h mar an le partizioni della pro1 o ta (narra cdi :
e ri\i) d tta.no piutto to imp ri amente l ma della r pli a, h ne rip t
ampi eom nti (\ . 1 , 11 ):
li oc hi miei. h ai fur vaahi daltnza.
del cadu o fior di n tra \.ta,
Libaro allor (com'if di io al'invita)
'na ola ineffabil dol zza,
Qualor dal velo a,aro alta b Uezza.
par a in pi parti. dal i I !n'adita.
\id r coverta e 'n un Aol corpo unita
(:\liracol ,;rn, ond L on 'appr zza).
r di i aUor: bell membra indarno
Altr apelJe ritrar t ntava. e qu t
De!rrran de la d a h cipro onora:
E mand l'imagine el t
Per entro I cor. ch'a I ue lodi ancora
pero il in fermar. la orga
Lari po ta ' dilia nte n l rievo ar al pa a.to la vi i ne della ublim b ll zza
ri.tratta; eh coincid on la rimozion del v lo h la opri a - mira lo di ui
h1 O!!lla e re grati all'arti ta. ei v r i eh ad ri con pi tr ttam nte alla pr -
po (vv. _9-11 )_ il rif rim nto a Yen r i amplifica attrav r o il ricordo, implicito
d li frod1t Anadyomene di pelle. Lidea h l'a p tto di un unica donna ec ezio-
nal avrebb potuto fornir un mod Ilo ade uato p r ritra.rr Ja d a d Ila b Uezza
-12 [ ... ) 8\t>ndo il . Giuliano Co elJ;n; [ ) fatto nt ar l b u 1 ' I Alb. D
di . uu r a e 1 ,,Lma e g nn 1. ;ima . ara Hmana. ua on-
.d
ccrllentr ulwre <' tatuario, Leon d' Ar zzo, vrnnc v duta quclrimagine a l'autore
1
., :.spostzione). ogio d:gli arti .ti non un p1 o econdario nella produzion drl o lini , come ro11frrma
un P
1
.a
0
del del signor Giuliano Coselini ( clw com par in Co ELINI I. 88 e . [7 c-101)): ci\011
vog 10 tacer dU< rrand uomm1 di no tra t' Il u I f ' d I
Go
"A
1
.
1
. .
1
C
1
.
1
a ecce entJ ne e oro pro Cl> ioni , che furono molto amati e. uma11 a
.,., 1110: uno e 1 ava ter one [Le! 1 !"alt A D
d
. . .
11
. : . , JJU IO gosto e 1 , qu Uo seult ffr e architf'tto di gran nome e qnr to
1vmo 1 uminaton e merav1 ho o ra > t d. I '
. ( [l
0
]) I prc rn atorr un vo to 111 rn1mma forma professione nellu <111alc eoh \ivr
enza pan c. r .
4;3 ltmTR1 2004. Altre rime. 5b.
254
rimanda al rov eia.mento teorizzato da go tino ifo nel De Pulchro (1.-31): [ ... )
neppur Z u i allor h, cl ci di dipinO" r il ritratt di El na. ar bbe andat pa.-
zient m nl alla rie rea, pre o i Cr toniati , di tant parti di giovin tte per rappre-
entar l' unica irnma
17
in di El n . qual ra a e a uto la f rtuna di a.minare la
ola b llezza dj o tei d. in e tig m 1 llenza H.
1 egli anni ttanta del inqu r nto, 'urzio Gonzaga ripropone r cquazion nco-
mi ti a eh . ifo a e a ri r at a io anna d Ara
11
ona la ombina on il ricordo
d I rolo' di im n 1artini, marcat da una ripr a molto id nt di Rvf LX VII:
Z u i eh gi con novo tudio tant
tanti lrggiadri i nudi mpi tol.
quando il divino imularro ol e
formar di lei, h . di b ll zza ha 1 vanto.
imilc al o tro a p tto alt ro e anto
non trov in terra. ond di que ta or I e,
or di qu U'altra il fiore, e ' n un ra ol e
p r appr ar i al ero o tanto o quanto.
Ma il B r an mio fu in Para o, e quivi
da ali angeli for le grazi e 'I lum
h gi infusero in voi rami he tclJ ;
n' p tea in altra gui a i hiari e divi
ragai mill'altr mcraviali b 11
vo tr adombrar, e n van altri il pre' un1e"'- .
La ntrappo izion tra Borgani Zeu i ulla quale il on tto co truito (8: ).
rinnova qu Ila tra imon Poli I to ma utw alla ontemplazi n d Irldea
la ra oha delle arazie d I lurn dca]i ana li, l qualit eh un i lo favor voi
ha con o alla donna. I p ta iipropon il n antiteti
in un altro on tto egnat da imp rtanti m mori a ian :
B n con 'io chr la tua n bil art
i pu' qurlla la iar di Zeu i a dietro;
anzi qualor I i mir a pari a pan
t ammir , p r tupor v nt imp tro
+I i'\ifo 19 I- 2, pp. 1646-16 O. Ln'altra wr ' i n p tira del motho ad e;. in Enea llirpino (Fin!!C'lldo le
lil'lle::ze alme, et dine, rit. in Tt.JR 111 1 Q72, p. H ). , .
4
:i GoNL.A 1:'>91 , L . Le edizioni 1. 85 e 1591 delle R111 tra mettono due wn.ion!.
ndl
z 150151 . . d' )' . pcc:ifit'O I md1Ct' e I "' IO. rmnct co
ionr o. 111r1p1l r Zeusi ilfiamoso che con st11 10 tanto t' nrn. ta, tom s ' . rebb di
- ( . p )008 (p 301) ,, m11te r 111\e e
U'Ollt c\1a 11 mio Lcon fu in Parodi -o e quhi [v. 9)); IC ' \Tfl - . . d . .
I Le '
10
tir al -er\'1710 e1 onzag.1 .
.('()ne on1. Il Borgan Fran Bor ani ( I 5 -162-l ), pittore uttivo a 111
1 1
gentll pittor. chi potrrbb in cart
chiuder gi mai con uman ' tile o metro
belt celestr. e l ch.almrno iu parte
r a i guardi. qual giacinto in wtro?
Fra gli angeli l uso iu Paradiso
doYe nacque ella. o ne la terza fera
dove pi ndc il di,in dcl uo bel vi o.
a ben ritrarla di poggiar forza era:
u batter ciulio. n pirar m
fea d'uopo. loda per aYerne intera-li>.
Davanti a un ritratto eh pme u ita la ua arnmirazione, il poeta non e ita a
chieder i quale pittore o quale poeta potr bb rappre entare in art una bel! zza
cele te. per renderla almeno in parte ac e ibile alla debol vi ta mnana. Per r.it rarre
pienamente la belt effiuiata arebbe tato nece ario alire al ielo (il Paradi o
dove fu concepita o il terzo cielo doveri iede). e, al limite, ottrar i ad oo-rri manifr-
ta:zione terrena (batter ciglio. pirar. fenomeni affini al prornr caldo et uielo)
al del mortai entiron gli occhi uoi u cui i chiudeva RlfL XVIl).
Alfattenzione della poe ia cinquecente ca per iJ con etto non corri ponde un
analogo intere e per i procedimenti concr ti che lo 1 ra pongono nella materia. I rif-
erimenti all'aspetto pratico cl ] ritTarre ono cons <mati qua i e clu ivamcnl alJa
forma del coniglio al pittore una equenza di istruzi ni che .il poeta impartisce
in merito aire ecuzione delfop ra. Si tratta di tma modalit quanto mai ambigua
perch non rievoca i geti d ll'arti ta. ma li prescrive, e non mo tra r.i che hanno
prodotto ulla tela o nel marmo. ma ci eh dol'rebbero produn : p eudode crizione
o ecfra i in \ritro l' advi e-to-a-painter pocm fonnula ill1 visibile purarnenle
ipotetico e tende a decifrarlo prima an ora che e i ta. una 1 tturn cl ll 'irnmagi.J1
che pr cede l'immagine te a e al ontempo la trasc nde interpretando colori e at-
tributi ome egni di qualit invi ibili
17
. fo que to en o. il consiglio al pittore
non meno lontano dalla ritratti tica come pra i effettiva di quanto lo si.ano i viaggi
ccle ti attribuiti agli arti ti: nelle due odi p eudoanacr nti he eh ne co tit ui cono il
modello antico 16-17), formato da una equenza di verbi e orlativi
o imperatjvi. che introducono altr ttante i truzioni. eia cuna d ile quali i compone
di un frammento del canone corredato di una alificazione (di norma w1 rpit to.
Go 1997. 84. i; esordio concen1rato ulla ('Ontrmplazione dcll'op!'ra piltorira ( cB('n
c 10) e 11 hru co movuncnto awcroativo chi potrebb1) riech!'""iano riopcttivamcnlc ri11ripil I' il' 9 rii
flf)C XXXI II , mentre in carte/ chiudf'r rinvi11 al V. 9 di .IW(' XXXI 1r rime A Il e, inc:atenal.c cou1e ne hr
bella Grera (/Wf'XXXVI). cfr. Rv/LXXVll . Cfr. anch1 RA1-;f.111 200'+. XX.
-+? 'ulla que tionP toro1r nei paragraf u1wssivi.
256
una mc tu fora , p rifra i o _un para?oM rnit_ol?crico). Nel madrigale [f Castelficar-
do ne nproduce, al n11cro cop10
1
una t1p1ca equenza:
Dipingimi il embiante.
CASTEL, drl gran CASTELLO
1u ch'a gloria ovrana alzi il pennrllo.
Fa' di crnrr la veste.
cencr. ch'a conde in foco
Fa rhr ruvida corda il fianco cinua,
corJa. il cui santo groppo a Dio lo trinua.
Da grazia al volto. e gra,iwte a l'alto.
Tanto basti al ritratto.
Pii:1 non tentar. se pur non i bastante
a dipingere il fulmine tona11te"
8
.
[;imitazione dei due te ti anacreonlici, r i noti dall'edizione curata da Henri
E tienne (155-t). in g nere i in archit ttwe ampie come odi e canzoni.
ma riechcgofa anch JteUe form br vi. fronte di grandi interpreti tranieri come
e Belleau-+'\ tra gli italiani pie a l'in tancabile Go elini. he Anacreonte
imitando, cuoprc le bellezze eccellenti della ua fiamma
50
in una canzone (XVIII):
nelle u otto trofe:>
1
, il nucleo del con iulio ( trofe 3-6) i pre nta incorniciato
dai ver i che pi e plicitamente rifl ttono ulla rappre entazione ( trofe 1-2, 7-8):
aggio pittor, vuoi,
e pur tanf alto aspiri.
i8 \l\Rl\O 1979. Oratori e Pn>dicatori, [. ]. p. 118.
P1r le risC'rillurc di Ho1nml e per In traduzione di Brlleau rinvio a O'BRIF'< 199.i.
50 Go>F.U\I 1'.)88, Prima parli\ dida calia alla <'ll1170llc \\1Il. La canz nr preceduta dal -onctto L\\\\111: che
annuncia 111111 duplil'c operazione celebrativ11. diotingucndo arti ti (novo Fidia e nmo c,\pdlc) 1 (
),
_>rnlpir/rilrur e chiuder in rime (a sua 1olta doppiato al "enizio di due ogg ui da etrrnart'. lr don di lei e
I amor!' di lui ).
51 Le 8 trofi. di l:l \'l'rsi (abCuLCcdrrDff) pi1 orJO'edo (di 3 vrroi) comprendono: introduzione, in un
il poeta prendr auo dell'imcnzione dcl oi cfo.ponc a ron ialiurlo (I): 111odcll_o. che
I l'(llll'to nova Dea, 1101110 alla finr della trofo precedente (2); i,1ruzioni 1crr r propne (3b): ambiguo
clic un iruilc rilraltu si po a rsrguirc (. ): appello dirmi o e pi[1 animalo (8): apt'.to.
ranwne P r il ritratto dl'I D'An1lo> (i,;,, C'eondn Partt'. pp. 200-'.W:3. cfr. supra.:... '.l.6.2) e e m
dc( lehlO, 1113 lo hehrrna di rime lo SlC SO t' rincipit. !'im Ot'll?.iOllC finale allr \!11,e e la dlSJlOSlllO >OllO muh.
Un hrcve confronto 1 rn le due canzoni mostra che le cliffrrenzc :;0110 invece legate al r ul ruolo
poeta. l:effigir di Franr\'.,('0 Frrdinando da1a com ai ('SC!!llirn. \' rauenzione ,i spo,ta uhito sulle don
ri
0
11 1 ' 1
1
'I d "11 " , li 111t"r1,11i 11 1dell"1r1i,m1' 11e uno 1111
"'
1
poe H s1 m1pena a t'opnmrre 1 ntratto e amata e ancorn ne e ' ' . .
iurrilli coinvolti ha nomf' 1 11n' iderli,i1. al di lii delln rnolzzazioue st('f't'otipa 'poi1aanwntC'.
1
Ladllo\'" I I I b li . l ll'amiti1111li ..l1CNl la medmz1onc te
1etnrnno111en11t'1111pre c rlC'I D Ani o:;. s1 scoprono e e czzC' ! t ' . , . ,
di r I ,
1
l 1 , b. i te,tJ I nrusm e 111111 h"'nta
nroo p.lllorc cun<r111rando i sul rresto dl'll arie e 11011 su rJbll ltlto. u entram
1
- . , "<l .I
di Cl '( r . , o I . . . 1 t . de\'(' llllC'"i'<ll'C I opnl e
11
a. unz1011ale 11 liti di cor o della po ia su e stessa. ma ne pnmo a
0 1
pm
11
0
[Il .d .
Camp ' 1 r . . . . ,. I I I I . r1. COlllt' H I urti\ l'r>ll tu no )/ .. n . 1
con una< 1wr,a rnnua rii rt rrnzzaz1on ("' orre1 a lr r Ut ate opn '
1
. . . .
1
;
1011]) I ) . . . . . .
1
.,, . 1 f
110 1
Mrtun 1111 ntrutlo <li p1tro (
'
1
1e c1ou1 o 1 1111pcutl a 1 tn11rr .11 p11tore - <' lC 1g111nn1, t t a ,
2 7
l'id lo mio ritrarne a part a part
'b '
entro a eali o d uoi
rac ndi i tuoi d iri:
fin eana Amor Ja t mpra l'art i
md 1 la eia in dj parte
quanto "ede ti ma.i.
P rch' la rim m.branza
di qual eh altra embianza
non ti faccia mirar pi ba 0 as ai .
h a qu ta nova Dea
forma comien i. e nova idea. (, .
1
_1
3
)
.11 rili vo he l'epit to in incipit embra on d .
ub1to ridi.men ionato daJl'ipot . ( . ) re al pittore ( aggio) viene
I' id lo d l po ta rarti ta d - 'I. e \1101 : davv r i pr pon di ritrarre
d
O\ ra imparar da Amo d d
onna. perch qu ta lezione ia f6 ] . d , gu r an o n ali oc hi della
dim
. cac a I ovra p01 m tt . d ('
o ntI are mornentaneament ) tutt . h h . .
1
a parte naelare
). p r h i ri ordi non i m a n to P1:1ma di l i ( quant Yedeti
rrurar inevitabilmente p', b per ez1 n ' tra fonuand la in un
lU a O Il mt r t di
volontaria eh lib ra la tavola d ll . d n en o can llazi n o Ull amne ia
a ment all tra di al .
va. con un proc dirnento affin il . m tra penenza ,i i-
Ir . . e a qu o u g nto dal . 1
a artJ ta di non ovrapporr altr . . . a azzott1. i rac omandava
b lt minore). In entramb . . u:1Pr ion.1 a qu Ila d I mod Ilo ( p r n n mirar
di . .
1 1
e 1 1 tratta d1 prot ag 1 fr il li .
una 10n traordinruia d Il" f . . re
1
ag 1111 o mtenore
Q
a mt r r nza di un , d
u ta pr auzion i giu tifi r . . ma fil pr ntJ ucc ive.
impon all'art uno forzo. n e ez1onalit d l m d Ilo ( n a Dea>) . che
. ul me to una no a fo
n tato un nuovo con etto D I cl n_na una no a id a,.s2, un nuovo
io che atri ne alla per.e ?P
0
(ail purazrnn vi i a n e aria per rappre-
h
ez1011 orno) alJ' rti . . hi d
tra nda le b t" ' a ta 1 ne un 'intuizion
m ianz p r raffi O'urar cio he ra chiudono (l 'anima):
L_e cru me d'or fulgente.
d alab tro la fronte.
di zaffr gli occL' l' al .
"" 1 tn preui tau
on come fa i p nte,
po te on raltre onte
bellezze u ' on doti umane frali.
on oper monaJj:
ch otto ruman velo
belt di ina pl ndr
52 Quete forrnulc insirmn ali' 'd I 1 I
<0 'cl ' ' <I O O 1 e v 3
l'a-1 ca M>mbra rir hra . I' . ' nnl'lano al dittiro rasian ,
nella m ntc dell 'tl ...;, .
1
.. c-"giaic c1m1olo11ia 1-dia li ri.fia . Jl "o orme n ve; nov 11rt1 ), mr111J1 la rna
,...,1a e 111noiazi nmrnro a idra 1 aJJ r tb' .
oue fllU COO..,i<,tcmc che jJ C J' . . O S10rzO COIT lll fllOl'IO che ha luogo
0
ru introdur nrlJo srli emn pocrico del ron;iglio.
258
non b 11 i ('Ornprendc
da rhi n n .,; alza contcmpland al ci lo:
al ci!'I , chr raro dona
quei raggi 011d' cll a ola oggi ha corona. (vv. 14-26)
nnun iato dal dimo trativo que La (v. 12) , l'ingr o della Dea nel te to i
ri lve in una vi ion f laorant ma ffim ra. h i con urna pre to e dall.int rn .
o'curata dallr bell zz na co t otto il v lo d I orpo. . no tante uno pi nd nt
cru cio metaforico (Or fulg nt , alba tro. zaffir ). le chiorn . la front .
11
li
cocchi e crli altri pr ai :. f i i no ai ielli enza luce. fragili e mortali ri petto alle
virt int riori. P r e r compre a e. a maaP-ior raQ'ion . p r e r rappr ntata.
la divina part richi d un rapim nto contemplativo a quel ielo eh raram nt
eone cl le d ti di cui la donna i fr Q'ia (ha e r na) . .\el cuor del on i ali o> i
di tinguono tre fa i: la ra olta di rnat riali par i per l'imitazi n elettiva ( . 3).
l adozion di modelli utili a ricomporli ( . -l ) e la ripr dnzion di ffetti ull'o errn-
tor ( . 5-6). ila e lta ( pr ndi >) nella m olanza ( contempra>) d i mate-
riali, il codic di colori e m taf or che la lirica u a per cl criYer la donna div nta la
ta ol zza p r diping r una e ncreta mbianza ulla t la:
Dunque dc l' alba i fiori ,
lr bianche le vermi11lie
ro.' r . on(f apparc et rnament ad rna.
i bei vari colori ,
n l'altr m ravigli .
ond"Tri l'arco uo dipin11 orna:
r <l I sol quando torna
pi '1 \'a ao al u l rnnt .
' I cli pi:1 chiaro adduce.
pr ndi il moto e la lu e
ond a I' rbe d vita a le piante
tutto qu to in i mc
e nt cmpra far raltr bell zze e trcm . (n '. 2 -39)
O\ h 1iv ndo "pr ndi i e lori d ll"alba . non. ad - mpi :
on que t e lor ' il po ta intr due un filtr forte ktt rru:io. he ha I dfett
ali ntanarc il t to dall orbita d l vi ibilc. La m Jiazi ne i accentua al m m nto d1
ug11 ri:r d i mod ili attrawr o i quali e nf rir una f nna alla e ncr ri di I m nti
attinti alla natura ( olori moto luc '):
D 1 tT Grazie b Il
forma qucHt' un:i aJJ ra
li ' ignucl t rna11 da' b i font i I ro:
1m atto hr fa" Ile
i vegai, iu I i, qlialora
) 9
i contempli il mirahil tuo larnro:
e com 'or io rad ro
perch la
oani altro. in \ ista ::-ia
o
d ke. beniITT1a e pia.
come quando il mio amor par che gradi,.,ca.
ia la bellezza
pt'ccbio Jeal de la ua luce interna.
Per I eh-e uccint a
e n" va leaaiadra diYa.
C'C'
fer cacciando. ha pregio non ,ile:
fa che co t i dipinta
ancor e me 'iva.
faccia de i cori altrni pr da g ntil :
cr. \ mor I" e a e 1 focile
cela ne uoi bcgli occhi.
onde a la ,i. ta
piacer eh ralme inc n<la.
com 1 f co 1 nri. e J :eia 1 tocchi .
Da luna il bacio fi<le
I lahr bel. che di dole zza ancid . ( n . i0-65)
La I ropo ta d i m delli ic no!ITafi i" ' affidala a dur medaali ni mitoloairi in
cima di trofa. le Grazi ( \'Y. -!0--L) e. appena in fili ara na. Diana cacciat ri ce ( w. '.)3-
:-;J). cui corri. pondono ri p ttivament la nudit e una Yr. tr uccinta. la bellezza
en uaJ e la ca tit. Pr pri Diana era raffi aura la. ad r. empio . . ul l'erso di una me-
daaiia. donata a Pietro Ar tino n i 1-:-1. in ui Lronc Leoni avrva ritratto fppolita.
fialia di Ferrante G
Il pa aa!lio dall"imp ralivo al e naiunti\ introduc lo
auardo deUo prttatorr. PN cui rogO' tt d Ile i. tn1zioni non pi1 cmpli crmrntc
i' h ar rappr entato. ma ci chr si l'edr 11 l dipinto: l"illu ione !ella parola
( i V aaia> ). l" e pre i ne benevola (in vi:ta . ia> )
5
"'. la corri pondenza tra e"t rtlO
ed intrrno (' . - 1-. 2). u La prematura intrusi n di ipotrtiei os ervatori in realt
na conde un lii i: il mom nto della pura \'i . ionr. drll"inrnntro ron i dati vi i\i. r
pa at otto nello pazio tra la mat eria infor111e r la r<'azio1H' hc con cruc
alla Y. ta. Il u irn ritorno al!" a ci el con i al io ormai in rparabile dallo , tudio
deali f'ffrtti. La forza attiva prrt a dall"immaainr . i formula affiancane! alle Gra-
zie il modello di Diana a ciatricr: p r h' la caccia lrttrralc. i tramuti in cacC' ia me-
taforica la donna rffimata abbia I u vittime. i] pittorr do\T nasrondcrlr r e ca
:;:3 l na '"lwda rl'lativa alla 11wdagli a in CRFCOR1 1985. p. :n6.
:;-+ \11 rif'hirdr rc !'he l'i111111agi 11e s1111 bri parlare e abbia 1111 ao1H'ttO bt'nrvolo (p!' r ci11 1 ista. cfr. ll1f \ 'lii. 1
7
). "'""'"quando i r1Jndi,c'!11d1ntr i11 amon. il 11,to ablii111t i dul' .. tementi pi1 frN
1
11111tP111rn1e riftrili al ritrailo
d!'lramata.
260
cl" \lllorr n
11
li ocehi . La. prtto dipinto d vr u citar n llr cpo1rnz > nri n i>
1 quattro pa ioni fo11damrntali (dolore. piac r . prranza e p n ieri no-
bili e dr idrri lumino i r onr ti:
\ I!' potC'nzr. a i rn. i
porga doglia 1 dilr1to.
'>prmr e timor. chr li t' frrni:
pr11si11 cli gloria aC'crnsi
mhcru1 dal diYO a;.petto.
1 eia i hl'i lu111i di I< tizia pieni
1bir dolci r er ni.
\l ostri 1 11a. conda al fini'
ro. ata r amra w. ta.
,011il11H11te rnllte ta.
l'alt< e rare fattczzr. e p<'llr!!rine:
la man candida e 1 pird1
Ili' riwli il candor che non wde. (n. 66-?8)
La lunaa de crizionr prr intcrpo ta commi ione i chitl(l (al fin >) con un ri-
frrim nto aJr abito. eh<' do\Ta coprir na, nd re l a nerich fattezz > (eh no
l'unico clrmrnto pura.meni fi ico nell"intera canzone). mentrr la mano e il piede ua-
a riranno il candorr dellf' parti imi ibili.>o. Jl corpo anolto nella \"e ta> a ua rnlra
\ elo> rh na con<l le b li zz intrri ri. supcrfi i che. nel quadr . do\Tebb rifletterle
f drlnwnte ( 1..' ia la I cll rzza (''terna/ prcchio leal d la ua luce interna [ w. 51-;)2]);
la centralit drlr anima. chr illumina dalrint rno un corpo in pento. d Lirn p r
drfinir la po: izion del p ria. chr in idia il primato dell" arti la figtu-atiYo puntando al
cuore trs. o d1lla :;ua tma rapacit e un modo di ,ed re:
O sr <'Oli gli occhi miei
tu pot1ssi mirarla.
ctHnr a11dre:iti de J'opra altero r raro!
Pl'r dH' n mirar lci
rwl cor rrri parla
.\mor. di .io 11011 ;.o dir. st ben l'impiuo:
forn pdl e 111 1'n chi aro.
Zru i. 1 nun
Campaspe. r in Crot nr
Elena.!' meli Ciunonr.
<' 'allrn il 111011do ha pir mirahil cosu.
111 n Jr brllezze di\I'.
e chi lr ,,idc- ignude. e wre c vi,r. (" 79-91 )
.);) Le <pmrtro p11"'io11i fondn11wnta li ,tcomlo la jhi1olor:iu pla1011iri1 l' -toka. mu ron la -p1nu11a al po-10 dt'I
d1,idrrio (l'fr. infm. -t .:3).
:l6 I.a \l'.,tc ' "it nrl modrllo i.rrro (C'11r11111111 l11arreo11f1'11 JQ8-t. lb. ' :IO).
> C"
26 1
il pittore pote"e uuardarc on uli chi d I poeta. realizzer bbe un ritratto
eh up r r bb i pi c I bri arti ' ti antichi , per h a lt rebb in prima pt>r ona
I' parole di .\mor . parol d tt n l uor . he la po ia te a uon a primer .
L' intcrpo izion <lell'i -amant ha l ff tto di far rimbalzare u di lui il confron-
to Yittorio o con ali antichi. in' i m al rif rimento a Paride. mitico o ervatorc e
giudi di b ll zz ( hi 1 vid ... ). Il pa aa!rio interm dio tra , rvazion del
Ili d Ilo (mirarla) r aJizzazion d ll'op ra ( opra) \i ne tra ur l . mar mi -
ione colmata dal ri ordo cli e I bri op) ic arti ta-mod li (Z u i I na, Ap llc
e ampa p [Pan a pe ]). n I quale i ria umono i pr e dim nti illu tra ti ali trof
(rimitazion el ttiva e il rapporto aff ttiY e pa i nal on il m dell P. La
domanda ai ' r. 9_-9-i in hioda il pittor a una dip nd nza e a un in1po ibilit.
rimandand alla ituazion de ritta in apertura:
Che p n i ornai? non o i.
ed a cotanta imprea
pa,enti. che pur dianzi rri auclacr?
o pur t 'han ali a.moro i
pirti la ment ac e a.
h"avventa runa e raitra arclent fare?
Or. e puoi. tatti in pa e.
Euterpe. Crania 'lio.
clat voi Diw ffetto
a raJt mio oucetto.
con eh appr o talor gli ang li e Dio:
n' p r col p n iero
I i firuro mai bella a par del,. ro.
\la qual tiJ . qual p nna. o qual pu canto
far imiJ ua beltat
cl I corpo al ol. cl l'alma a la bontatc? (n. 92-10
. di enir apo ITofato e i truito dal po ta (dianzi ) !'arti ta di mo tra a
un audacia h mbra aver p rduto. intimorito dalralt zza cl Jrimpr a for e in-
namorato d ha imprud ntem nt O'Uardato negli o lii .
1
l e ndo
. 1taz10ne cl nv rebb proprio dalla vi ta che cl eva nutrirn il d ide-
no r I 1 plraz1onf'_ ( . 4-5). ila ca e ortazion a de i t r dalrimpre a ( tatti in
pa.r ) gu . un o trionfo cl ile parol . Invocando tre Mu e (Euterpe, rania
n petti nt al flauto. all'a tronomia alla toria) i1 po ta i riappro-
p1 namentr d lh pirnzion e d I ompito di qu to novo ritratto. La lunga
finz1on d I con iglio uli ha infatti p rm o cli compirrlo in prima p r ona, di
5_7 li Ci11nonr t't,'llito dalla cousuela chiuNura 'ap ria cli qur ti el1n hi (v. 89) fa da ponlt', dopo
bl1"11a. prr I allu ione al giudizio di Purid!'.
262
dar ceff tto al proprio alt [ ... ] concetto. hiud ndo in rim le qualit d Ila
donna la propria pa ion ( o tr alt doti la mia fiamma int rnai
8
). e ondo il
mod Ilo i to in B mbo in a tiglion :;
9
. Il olo cfiuurar ui il po ta po a attin-
u r ' quello menta] il p n i ro che n n in grado di ritrarr pi nam nte I" amata.
eppur la ua i pirazion lo avvi ina talvolta alle r ature cele ti.
La grand fortuna d l n iulio al pitt re i l ua in prima i tanza aU'int n ifi-
cazione di un me ani mo che. in modi piu o meno ott rranei, agi ce ocrniqualvolta
la poe ia rimanda all arti d 1 di gno: l m tafor pittorich i riferimenti al larnro
deU' arti ta valorizzano il ruolo d J po ta in quant artifex efictor. m ttcndo l'a e u-
to ui proc dimcnti artifi iali delrimitazion anzi h uUa pr unta natural zza del-
la no-lianza
1
i0. un nel ll\' Il o. la finzion didas alica eh ha per cl tinatario
!'arti ta pcrm tte al po ta di pa ar in ras erna di mett r alla prova p nnclli
e colori d lla propria art : un 'immat riale tavolozza di firuranti. epit ti. parau ni
mitoloo-i i. Il,. ro cut r d l ritratto ' chi criv . non il pittor cui i ri\olue. ma
re plicitazion metafori a dei m zzi r t rici li a imila ai g ti d ta ? ti ne
co una riil ion d lla p ia u t a compiuta ul campo rn or'o d op ra.
li con ig1io al pittor ' per natura pr di po to a lib rar imrnauini io
laborate, purament ip t ti h , ma p o vien adottato p r d.1 ntrattl
finiti. n una i t a forzatura he. m abbiamo vi to. non imp n ien c affatto 1
po ti. Per h' ai loro oc hi il punto un altr : n n importa . -i di un"imma-
uin h i ha davanti auli o hi o di un 'immaain h non i t : 10 h nta. P r
chi ompone er i e per ali v ntuali c mmittenti. ' il modo in ui ..
on tti di iu 'epp Lea iadro alani raccolti n I Libro ter=o de dc .dll-ersi
nobilissimi et eccellentis imi autori (1- "'O) plorano que ta
una doppia pro p ttiva ullo te o ritratto, al quale da div _n punti
n l t mpo: un pre ent h attrav r o I par l riYolt al p1ttor . i affa Cla ul fu-
turo in cui r pera p tr \bb r r alizzata. un altro pr . nte _eh . e lloca la
te a realizzazione n 1 pa ato. a fa atura tra le du dim n 1om temporali_- tra
d li
' Il e nel le lCO
incompiut zza mpiut zza. ' rafforzata a e contmwta ne e 1 illl . . . . .
dalla lta di inquadrar du volte lo t o pr i _mom nto Uo u'. cm '. '
pr nd in mano lo e ti I m ntr r chi o o, er\'a il m dell il P n.
1
ro e mm
ari laborarlo. Po iam immauinar un pittor aJ avalletto. darnntI all.a l1l
I h' tanza intento a ne tnur
po a, com pnma pote amo p n ar e m o rn una . , .
I
1 d j .. 'e ordio del pmno on tto. he 1-
0 tlvar 1 n or o 01 un 1mpr - . . .
li
. . d ta l azione ed e uz1011 e (formai e )
r comp to ( w1 urne pen pre n ,
i ont mporan i:
58 Co EU I 1988, Prima pori<'. LJ '' vm.
39 Cfr. supra, , , 3. 1 e , . , (J
. . . . . . , . . .. I eia pr&.inre du rnodele :u1,,tr11ut... Ol
60 In que to trpo dr romp n11nen11 il lrl lo I ' rdro
111
<'.
11
no m
to . ))' cacti' it d J'nrti,tr (/bici. ).
' KY 1991 , p. (>I) il 1rsto non i limita n mostrore, 11111 riflette ' ttll nn en11om "u
26
\lentr ron rocchi intento e col pr11_iero
a r alta O\'C I I rlrtto.
agaio pittor. miri lr guanrie r 1 prllo.
e la frontr d"Amor lrggiadro imp ro.
s chr per troppa affez'ion dal wro
la do Ila man n n torca. nde difetto
alctm "in 011 i m I di' in a. petto.
e riaJ)bi a crir d"immortal I cli altiero.
Cr na il I i . . alnm ti punae
il core o calda. r con ardente nrra
forma di qu Ila ogni ben fatta partr
ben. che non cedendo a la natura
rane i uoi pr ai. e la natura a rane,
non appia alctuia in lei cealier !:le t s-a"
1
Il po ta al pitt r di evitar un e ' \' coinvolaim nto ( fr ria>) .
t nend? a la lTa 1mante aff zion>. he p trebb produne un.immaainc difrt-
t a e CI a. lontana da} \' f - .0110 tant rint Il it i ri chi rmotivi di qur-
lO rmrare. le h cadono otto I guarcl d ll"arti ta ono ome rmpre
?n lat nella norm.naz10ne (\ '- 3--): !!llancir. petto e fronte (che l'epiteto
rmp r_o nta anc ra una volta com r ano. come . pazio in cui una fi(J'ura
all (1 l d 1Il n ri ultalo ottenuto al pr zzo del dominio u11 pr pric
emoz10rn attravcr o un uzion maniacale (con arei ntr ma/ forma [ . .. ] oani
[ ... ]pan>) appr der bb alla qua i-identit di ritrauo e oriofoal . eh il final
formula radd ppiand il o tteto Lo d 11 1 1 ili. ' cli
_ . . . . . e mc t tmru1 l ta natura e arte (' .
12 duplicazione_ 1 n_fl_ tt n I chiamo intattic (a la natura/ rarl [ .. . ] e la
a al art ) e_ np t1z1011 . rafforzata dall. allit l razione in s al v. 14 lalf eco
d1bn>(v.11)1111bn(v12) di I '
fi
.
1
, . . - co e cap avoro natural nell opera d arte m
en. ropno la on!liunzione di natura art tahi1
1
cc la t" "t' 1 d
h
. . . . 11 mu1 a con 1 con o
on tto. c
1
nfcn e al ritratto ai eauit ma rn tte a fuoco l o mom nto:
Quando per aiunrrrr la natura a r art
tol e a la bella impre a iu man lo tilr
colui che per ritrar. raro e grmilc.
le maraviuli lcI . 110 increuno ha pa.rtr.
r o'.chio _riterC"ando a part a parte
il bel "' o. d more ca e fori le.
61 Rime 1;;;0. p. 40.
264
quanto ha di 'ago r di l<'ggiadro \prilr
trmi raccolto j, i i11 ripoi. ta parte:
onde di puri . vivi r bei ('Olori
fonna11do qurl nd primo a:-. p<' lto pose
Prima' era. le Grazie c i cl1i echi \mori.
c fra i ligu;. tri r lr
del Pil o . albergo cl C' i pi1 chi ari ardori.
cl"or 111ill c lacci e mili<' r<'ti
\cl racconto dr l porta. il pittor pa. a dalla conda alla terza p r- na il
ritrarre arretra in un trn1po ri vocato. pre rdente (Quando[ ... ]/ tol e ). Pa-
rallclarnrntr. )" accr11lo si po ta u] ne o tra du Primav r . qu lla o rvata
nel vi so d Ila donna (\'Y. -8) e quella hr appar nel quadro. o pc a tra I ttera
<'metafora (n . 9-11 ). Larti la \in colt nei g ti aia j.., lati nel primo . on tto
(in1pug11arr lo tilc. portare ..,ul modello uno cruard attent e compl - jy ).
ma il mod Ilo i tra forma tra I . ur mani. tra critto in pr -enz che non clip n-
dono da una somialianza diretta : il ,olto i muta in una Primav ra. cir ondata
dal! Grazi e r da un cortruuio di amorini. mcntr il no candido ro ato di, nta
un' irresihtibile trappola d' amor <>:i _ Formare> (Y. 10) ' i
17
nifi a o . in virt d Ila
nalura metaforica dr! uo oaactto della ua azion pitt ri a, non tanto riprodur-
re una s<mhianza quanto e nao, ond r 1 m nti ( po e>/ a co e). in
una resa all egorica ed ellll lcmatica. L , ibizion il na condim mo una
corri. ponci nza neali epit ti in idio i che rr ciano le due bellezze mquadrat
eia] dipinto: il Yolto r acciarino e pi tra focaia. il eno de deU pi
pa ioui . ma e la lac i r ti >. Attribu ndo all"arti:ta un ere t dutnv t1p1co
di \more (, . 1- ). la fi11zion p etica affianca al con,enzional inganno del
conderr un arnbicr110 dipina re senza far ,. derr". con para lo " b n 1 tt rano
prr un piltor . . . . .
Ln analogo : doppiam nt di I iani t mp rali i ri c ntra in un tnh1 onett1
li Orazio \a, azzot1 i I Fabri:io fiaural rin cerah\ d ,. I azione cl l
(
" /b " / l 1 1 I 11 I . I 1 1111 11el -1111l'llo 1m11cleme. d11I ritorno di
>-< t< . , a ro11t111u11a r n 111< 11!1 t a 111np1t < u 't nnl.!ganua a 111 . .
( 1 \ ) 1 I 11allr rimt \ iu - ane t' B 111 - ile. ron
nnpn,a qmi-1 nell a -, rr" n po,11101u. 101111 < mor l' 1 1 OCl no l . .
1
.. . .
1
I
I I . I /I f I \\\lii 1>rr nlruni rnnanll t' pt'r 111n111
rom i111az1om 1 li' rn111rnda ul d1tt1ro p1trarc 11. ro. 111 p11111ro ,ue a t
Q
I
. J I ' I ,li dalh n1m-a que-to puo
uanilo ( ... ]/ [ ... ] in man lo ,., tilt'>, and11 'l' lu mr< 1HL1onr por111 rt'!O
1
't
11
' I :,
1
. .
<l
cntnzion< m I 111111 t' c10 t w hptm
'orpnu rri 111 un 1r,., 10 co111!' ntr11 0 ., ul pa"aucr10 Ira tl"t't' ,11.1om l
111
PI "' d (
1 ' " f ren lit"'lzom del mar un' cron
1 rurn110 ( di pt' r ,,; qnalro'n di 11m.ro,10, d1e pre,11ppo11t' 11110 or10 o 1111 m ' '
l\l('dtio rk1ntmdo a part 11 pam' ). , .
63
> I' I I Il ' zn lirrnrn 11H moltr b1/le e /fon !'111-
. I ou1 1979 oi ( chl' sto. rn11 111 "iuslfl prnd111111. se Hl oz1one l t' Il
1111
1. r .
1 1
l ,
"' I I L . , h. ionitmndr ,olo 1 ' to l' 11 pnrtr
q11c11111e,rl11 '>in legala alla for11111111n inq1111drnt11rn e r CHlllllH' lrt'\t.
1 1
>11prriorc d!'I bll',to.
6-t Rime 1399. pp.
26
ntar i ollo D. dnpprim, in un pre cnt h au pica armun ia i] ritratt
p 1 111 un pa ato al qual il po ta ripen a a po t rio1i p il itato on uo f lBRJ-
ZlO, se ritrar ne le tue cart\ in na la fa in cui I immacrin non e i t ma ,
cri ncll int nzioni dcJrarti ta (e m far t nti ):
li dipinger cl I ol ralto pi ndore.
de J"acqua i) COI" . e l'imp tO d . Yellti.
fi
0
urar toni fulmini caci nti.
e in un \'Olt ombr aaiar r pr del core
b n col rir giuven o o fiore.
dnaannati ne fan ali api ali arm nti;
formar la nott in m zzo a lumi ardenti
o !"aurora che 1 ciel o' raa!!i indore .
'
on d'ecceUenti ma tri opre e c Uenti,
TERZI. ma -e la luce mia. il mio ardore
figuri in era mai. come far tenti
'
non farai di quelli opra mag!!ore
ma eh un n mico uo l'altro -u t nti.
miracolo ara di te e d'Amore66.
., La .tI:uttura 8:6. eh i regcr ulla opula al . 9 ( on) , funzionai alla on-
tI appo lZJOlle tra un elenco di ougetti di cliffici]c e al l" "t . ib"l .
ne la d d uru imp 1 e e eruz10-
onna a ntrarr : r numerazion he mbr mb. . .
e mprend f nom ni tu r (
1
a e mare te er plm1an
(
" 5) netn
1
. na
1
' -3 -8L aff tti umani ( v. 1) animali e piante
a 11 m au 1 p tt t h
cl nna. eh la metonimia formulaa l: :nn (v. 6). _ntando la
uper r qu li
0
. . . ar or , cl I P ta il p1ttor n n
ili ieme fiamma e e : Ilr . pu1 1?a r alizz r il mira olo di t ner
r . mat IL w l aro ta . . . ali'" .
una fa il oc a iou di arcr . . . . .
1
r ugg n e uwentw
niti dipinuer fuurar uziab m n.tre l u
0
llllp r onal f' o tanti ato degli infi-
1
. . . ' . l . om recr(11ar , colorir formar lt
um ita d1, terzi ri p tto
1
. Il . . e a a. p r ontra to,
aa
1
e nt1 ma tru 1 f 1 f 1 d l
rappre entazion Ja iano 1 all . . . rzo n tto at1 le e la
. i po t a p icolog1a d JJ amante:
Quant'obligo. Fabrizio. a voi ma t. a
eh' . , nn '
a p1 ta. mo . o d I mio grave ardore.
forma te m vivo e uatural colo
hi d. . re
e amoro fiamm il cor rni cinge:
6:) I lo riportaro il on tto supra. a p. 248.
66 lii1111 1.)99. p. 304.
266
chr ben lalma ovunque \'UOI dipin e.
quel bel sol che dipinto anco ho nel cor .
l'occhio veder non 1 pu. s 'altrui di f uore
come fac te voi , non glielo fingr:
e11li dunqu p r voi l' amato oag tto
aode pr ' ente in atto tal , rii ernbra
pr metter pa e e ci ia n ra p tto.
Cos ne l' alma, ne ali or hi n I petto
l'ho ernpr , e non man altro a le u mcmbre
che lo pirto. per far he le ras. emhr
67
.
L n obbliao di gratitudine lega il poeta all arti ta, eh uli ha pro urato il ritratt .
con olazione per un ardore non pi m tonimi o ome ribad cc la p rifr i al
\'. -. [anima pu clipina f ramata dov quant Y01t YUOle. ma non per que tO
roc hio pu derla
68
: p r g d ria pr nte, c n tutto il p o d ila ensibilit.
ramant h la porta n l uor (v. 6) ha bi o.ano di una rappr mazion eh uli la
fincra all' t mo, cfuor . La 1.1 ner it delr arti ta Ul7l7 Ila o romlipr enza d Ila
d nna, meglio d i uoi imulacri. he aturano lo pazio mentale fi ico del po ta.
rirc ndandol dall'int mo dall'e t mo: immaaini proi ttate dalranirna. p rcepi-
t dagli o chi. clip1te nel petto .
Ca iazione cli pi t ti intorn al ritratto t nde a introdun- un mo,imento
nel temp a dilatar i crm nti d 1 pro cr ativo: dall' 1-Yazione del m dello
all 'immaainazion alla lta cli e 1 ri d e p di nti, ali' o tto compiuto e oltr ,
fino all r azioni d crli p ttatori. r 1 on iulio al pittor i pu' trac iare la pr i-
toria d I ritratt ra i h lo pr cl , 1 in orauaia o lo i pira. ma an h
mett r in e na il m mento d ll uzion ,, ra propria, alY luderne. pr Yedi-
bilm nt , la dimcn ione ncr ta. ln uno d i t ti opra il ritrallo d Ila ua Donna
Marino orta uli Amorini a o correr il icrino n Jl'impr a:
La ciate ipro qua v lat nori.
clov d 1 mio FI ,Ii O il chiaro ing gno
di Dea pi b ila ombrando alt di. eano
pr nd di Zcu i a uperar gli onori.
6 lbid.
rlle t rzine il oggetto pa a dal!' e hio ( ce,,li) all' io. P r la tripartizione al v. 12 cfr. \'1 0'\"11 1979. llL In
pictam ta/u.dlam (Il iel, Cupido e un depentore a pram, per cui cfr. upra,, 2.5). Lo 'carto era Prf"ente t' ptl
potrebbe rivelare una pit1 biara m moria cl I ditti o pt'trurch co. ccondo tLOO s1-hem11 pre eme: t'Onternplazionc
drll'immaginc' (per cprometter pa C cfr. R1ifL/ \1TI , \ , 8), 'pa .ato: e oi:e .. 111'. Lii.di
alma, .r petto proba! ilmente i pie"l1 n il fatto che l'anima e lo facolta dw d1p11we I 11nm1mne O\ nnqm. il
petto e il luogo dow dipinta.
Parte a la tela. O\'ei pinga l' colori.
faccia de rare e de la man o. t ano.
Pane il p nnel gli riga: r I rnn I d "Il
Ji a la arlta onde piagatr i 'Ori.
\Itri a la rotr. u a a temprar gli trali.
tempri i colori: altri il mbianl altero
lllO\'a ancor fr CO ad iug;u l'Oli raJi.
tu. ignor. c'hai O\Ta gli altri impero.
de le ue forme ana lirh immortali
1116 rraali nel mio e J' r s mpi vero(llJ.
Dopo una breYe introduzione (' . 1--i) l'imit diYenta un circo. tanziato co11 iglio
a ali Amori'. he come legaiadri aiutanti di botteaa i dO\ ranno patiire c mpiti dC'finiti
n auenti (-o-t nere la tela: ealier il p nn I>: temprar i colori: a. ciuaar il
dipinto ancora fre- o). Ci cuna azione on creta ha un ref ren t r ale nel mondo dC'lla
pittura ma ac ompa()'nata da un 00'0' tto chr la mat riaJjzza. per metafora o prr
p tamento: ali archi l mani faranno da ca,aJI tto. la fr eia da pennello. la pirtra
u ata per fonriar O'li d'amore enir per la,orar i colori. le ali per i
colori app na te i. La c nql1i ta dei m zzi della pittura aJ dominio del traslato e lei
le1t rario culmina n ll'identifi azion della :fiaura nel uore del p ta omr mod llo
p ifetto I er l'opera ( cr e empio vero). ln un madrigal di Enra J lirpil1o. le prrcau-
zioni di norma uau rit dal po ta Y JlO'Ono propo te C' me e in atto per iniziatfra
delrarti ta te. o. eh prend la parola n I t to: condo la ftnzion . il pitt re Ale .. an-
dr Araldi. a ingendo i a ritrru-re \.lanuna da 'orreO'!!O. le d 1i rd' ili volgere ali occhi
in p rfilo,, o di tenrrli chiu. i per n n ten r i pirti miei con fu i> :-o.
En llirpin? e i \'an Batti ta Iarino. che crivono a qua i w1 e olo di di-
tanza I uno dall altro. ri reano ntrambi una ituazionc lirica entr un racconto che
re enza .'ilupp . ri tabil 11do le conilizioni p r una rittura in I rima per ona
all rno .<li una cornice J l nzialm nt narrati a. I ,o te:so pro dimento a cri-
c 111 mamera datante nell tanz di Gandolfo Porrino in lod , ili Li ia Colonna
(D?nna del terzo ciel madre d' lmorer
1
La definizion< cli limiti pot ri delrarl '
aff1dat_a a una voce lw irr rnpr dalralto in una riunio11<' di pittori int nti a ritrarre
la - wrn vo e mi t rio a e autoreYol . eh potr bb coi11 id r eon qu Ila
drll artefir di,foo:
69 197<J. Rellicosr,,. lrtuose. (9<;] (, opra il ritrailo rif'//a sua IJ01111a. Id l111hrogio Figino) . p. 2-t7.
I h'.IPr\O (', il IHl rolto. (' / qu<'i bi'' lumi, V. 9. per cui cfr. ' llJRClll 1972. p. -t5. e l11 m11111 r 13('11
tni1 da Corrcg,,10. 111ogl1r d1 \1coh art\ ' 11111< \ " 11' ( 1-'60 1 "'18) 1 ff ' I
1 (
.. " . ' 1 a r 1 -, J ca. "w <' autor<' r 1 a r<-.d 11 nell ap111l1'11111wn1 0 dello 111
<""a .1orn1111a l'iannza 111'1 eominto <li J> I I' 1 aU
1111 ao o a .inna. m iactnll , a cdt'brc camt'ru affrc,,ca111 da Corrcggm.
7
1 Pou111\0 1:).)1. cc . . -?r-.)81'.
268
Di pi1 . aggi pittor f a111osa sl'hiera.
per il ' r con bei rol ri.
ta\a dintorno a quella 111ia gucrrera.
a cui mini tra Venere e gli Amori.
quando ud eia la celeste -.pera
, ore ch'usci"a da mille
e cli ;.se. scesa in quel chiaro drnpello:
e \l intl<' in qur-,ta. rom il rirl b<'llo.
Ben pol<'lr ritrar le mani. e 1 ,.i o.
ma non ui mai di quei btt1li occhi i f'a"<Yi:
cha formarli fur . lanchi in Paracli. o
lutti i pi degni ;,pini. accorti e saggi.
Dunqu!' a ragion \.' tal poter pr<'<'i..,o.
chr 'irgulto non giunge tcccbi farrrri.
e s potes:en riti le \ ' O I re scole.
potrr..,te auco rifar di HO\'O il olr
tenza . uJla pluralit (chi ra: hiaro drap li : l o tre cole: I
lingue e I mru1) riv la la portata mtiv r aie d I <li or . h muov dal tal nto cl i
pittori pre enti ( agO'i srcondo la definizion ta iana) p r tra ciru una br v
poetica toria drlrarte prn;ta otto il egno ili P trarca (con ali altri ch'ebb r fama
di quell'arte >):
Quanti al mondo ebber fama di qur;. ta arte.
empre han cercalo up<'r, r natura.
ma qu sta bella tanto in orrni parte
che ' I poter lor con lei 11on mi ura:
. altre,. lte fatto han nr le lor rart<'
mera' iglia. o per o prr ' cn1ura.
non rrn tutt in una il l'irl infu. o:
e prr non li danno. anzi li cu ...o.
lcu11 ne' suoi color fu s po. rntc.
cht non soJ fe parer ra..,petto \'Cl'O.
ma f ne gli occhi di. coprir la n11' 1H .
ne la f'rnnl e CO!>I urne. artr 1wnsiero;
111a 'inrr di \'irt ult' anlentr
o<Y11 .infi11ito nobil magi t ro:
ondr qual di saper l'alma pi:1 ingombra,
po o 11011 fa . pu' lipin<Y r ro111hra.
'> I o -
8
. f .
1
. il " I
0 11 .,.,11 1aliur il \l'r. il d1' i1tiro
- '1. r<'. ,) 1. ) ' " ,\1111 tradizione che ti e ormai 111 111 iare rn1' 11mo "
1 1
-e 'r
1
..
1
I
r I ) 1, rimr 111 -11r1r e - uni. 1p<' r lo t
n mto a mod1'llo ( c\lir111 iu que,rn; cma q11c.u1 ' lwlln: ma \ ' llll'l' t(ll ,111 1 .
( p 111-, 11 a neo rifar di 11 ovo il ,oli). il purnllelo tnt ari i d1'1la paroln !'dr! di . ( l
111
1f
11
l' e
1111111
).
269
e omr a le vaah , r pell arinr
membra "appre a I incr !!llO o tile.
mo tras e d'ogni b Il il fm .
eh "alberaa dentrn a !"anima a ntil
ar bbon quell r que Lo
e tropp al r del ciel co a unile:
ma 1 hrnrue I man on piar mut
a ' 'olem mo nar tanta virtute>
7
J.
Gli h
( [ a.n]n fo , empr . a pirato .ad natm:a, talvolta con ucc o
. . . ". . par r I a P tto ' ro> ), ma Lma co t1tui un m d U
r'.01: ru loro forzi. m quruuo con ntra in tutt I doti d l ci lo ( o . o upr.-
ne m no he capa it. qui
( u.auerire la rnent > neuli e tenor nvelando I mteiiori n J vi ibil
ibil , co ti.une. art e p n I ro> n Ila front ) t
po la upr ma bell zza d lrru1ima, il ritratto . bb ' . .e
na. Pul Jmor m terri nulla tabella for t>. a.i un opera d1V1-
-i.- Mores animumque
parole di Mark Rothko. la v ra e enza d ll . . .
pi ri ied nello confinato m t d ll' . a grand ntra.tt:I tJ ca di tutti i tem-
re e e a.ii:I ta pe J fi .
p r i ntim nti _ . r a rura umana per 11 cruattere
m omma per il dra.inma um 4 E .
poeti. 1in dall'antichit il orpo d fini a.n_o> . ppure, d1a.ino a colto a.i
non i po ono pin.aer Ulla . e ?ulia oltre la qual I arti fi .aurative
il eureto dell'animo Il eleb ie m r ra.VIglio a en ihil cli tro cui r ta elato
. rnmo voto lOrmulato d 1 l ( Ar .
ammumque effinger po t./ Pul hri . . a arzia e utrnam mores
Ulla piccola variante nel 1488. tab .for t )75 i riaffa eia,
dipmta. da Dom nico hirlanda.i 1
6
1
P e di b ili Ima figura fenuninile
Gio degli Alhizzi Torna.bu:ni,
11
:a.fiuadro a Madrid (CoH zio? Thy n).
ne n ila ntratti tica co va. Ma , . . . gurata ?i ond la Vl uale ornu-
e propno
111
quegh anru negli critti di Alb rti77 nel
3 hi. c. 58r-v.
74 Homxo 2006. p. 46.
5 fr. supra. 1.1.
76 ln un ritratto d I
Coli ri . e pittore ene* NProcrio de Landi (1 .
. E, \i 'r,goEnTo que t parole. che &i devono ca., at.ional CaUery of rt, Wid ner
i . , , , ". A EQ R. AHTE:/ 1 IL A e aun u1t c all arti ta: Q ANT M . J . FA
e oucncre. io ottengo LI . LOR . AHTE . O O (e Tutto i che
. con la rrna arte competo con gli dei ). Cfr.
008
[Eppure) non i ungo a 11ulla: percl1 '
77 i elDep1rtura iaffcrmal'inipo"' . d" l , cat.6.3, pp. 191 -192, fgg.36-37.
ira dol di
1
aJlza 'rendere con al .
. ore, gau o e timore, de iclerio e simili altri (D rwu movimenti d'animo d rti affezione come
ep1ctura, IJ , 43. p. 74). '
270
pcn iero e nell 'art di Lconrudo che i moti dell'animo trovano ace
0
al i ibil
<lipu1to. attra er o Ia fondamenta.I inv nzion eh porta dal profilo alla po a cli tr
quarli e frontale: una . ra rivoluzion ' probab,ilm ntc la olta pi i11nifi ativa
nella I unga vicenda d lr art rina im nta.l
8
. il mira olo immaginato da Lor n-
zo d ' Medici nel on tto IX d 1 uo canzoni re, un ritratto d I volto e d U'anirna
( cvirt he in lei i informa) . un trionfo in grado di O\ rtir 1 g rar bi d li" art .
dr 1inando a un icuro oblio gli arti ti antichi ( Phidia. Policl to Praxitl , ):
Qual pi propri a ha potuto il ma!!i t ro
trar cl ll a viva natural ua f m1a.
tal ora qui: ol manca eh.ella anel !
la e coliti chr expre e il volto vero
mo tra i la virtL1 che in lei i inf o mi a.
he Phidia. Policleto e Praxitl f
9
All'et del .Marnifico appart nuon al uni ritratti eh violano il confine tra 01p
e anima attraver i m zzi di un vi ibil dallo ta1uto inc rto h comunica pi di
quant mo tri tra nd t o n ila mi ma in ui richied Ulla decifrazion .
Pen o ad e mpio al ritratto di imon tta. \'e puc i, la d nna a.inata da iuliano
de dici. attribuit o a Botti Ui (1480 ca., Fra.n ofort . tad l eh Kun tin ti-
tut. Cemiild galeri ) e a quello post mortem dipinto da Pi ro di o imo (1-t90 ca ..
ha.ntilly 1u , e Con<l): in entrambi la ca.iatt rizzazione del ouu tto' completata
da ogg tti e acce, ori , ri pettivamente una plac h tta be riproduc una u mma
d lla ollezione m dic a. d v il tema della punizione d'amore alta la \rt della
ca tit, e il < rp nt -aetemitas. eh ' i contrappon al pae aggio lillo fond com
la b ll ezza ideal alla adu it
80
.
0110 tant e il gra.nd prO!ff O rappre entato, per r pre ione della vita int -
rior d i ouu tti, dal up ram nto d 1 ritratto di pr filo. in molti ca i la r a dell
qualit imi. ibili de e ricorrer ad attributi e tran i al volt , om a ad va ul
l'erso d Ile rn dauli
11 1
: embl mi e o u tti imbolici ' Ono indi azioni upplem ntari
<love ra petto refer nzial e qn Ilo m tafori o i m olano dove iJ vi ibile' impu-
8 01.1.ARf. rA p. I 36.
79 \lm1c 1 t 99 1. I\, V\. 9- 1-t. ,\ propo ilo drl ' 12. Zanato (lbid .. p 394) pecifiea t h nella prima vt' n-.ione
011 11 0 ll On c'rruno dubhi Mli 'O/:(<>"CtlO (quef f"url Sta: e fos (' in grado di t,pr_iwre )e beJle
7
.ze
dell a donna, non uvn' hl w pllri )-, mrntr n Il a ,uri11nle ri ono;,tiuta comt' ;, urr -s1va co/111 potrcbb.c unche mtrn-
cio O io'. t' dunqu : e i Il \' ,. pobto dinanzi alla fonua l'rro della tfom1a. non c1 arebbe , tato
uru;,ta 111 grado di riprodurl a.
80 Cfr. '1FR1 \h 199'+. pp. 13- 15. con riproduzioni dcll t du immagi11i a pp. 18 t' 19, e l:fr. funzione drlln
plucclwtta rnn il profil o di Faustina nel doppio ritratto fr 11111l c di Lotto cirnto fla OU. \Rl.A 2003.
8J . ui ritratti 11111plifirnti o completati da una dt' ll'animo o delle nella
di
uni mrraphor,, or auribut . di un 1trso dipinto o di un ccopeno ron motn o tmblemi. tfr . . BRO\\ -00
1
introduzione, p. 12 r Po11M1 E11 2003, p. 79. uirimprr' R rome 1itnu10 ddf'nnim11 rfr . .\RBIZZO\I 2003.
271
ro. iunifi a -emprc ' e . tt"SO e altro. Lo t L 011ardo, eh inYita a fuuui r i pro-
fili fonda la :;up riorit cl ila pittura ulla . ua imnwdiat zza imultanea,' autore
di ritratti eh i c1Youo dclri.JHrarazionc mblcmatica. in chia\'c onorna ti a
0
di
ritratto mora I . Il ritratto di in vra dc Ben i ( cfr. , 3. 1) tcstirn nia l"u o earat-
1 rizzante del r ve cio dipint (come, negli t ', i anni, i ritratti dei durhi cr rbino
dipinti da Pier della Fran e-ca). ma anch . in i 111 aJla Dama dell'Ermelli110. la
miarazion dca]j I menti imbolici dal rerso al recto. Il pr cr o di riunilicazione
d IJo pazio pittorico non impedi e hc. ul recto. 111 ti particolari onti11uino a
collocar-i in luoahi fi icamente cl finiti. non eparati lai ritratto \'Cro proprio:
ul parapetto he pu e upar la fa eia inferior d I dipinto82 u un tavolo o
un ripiano. in una nicchia. Oltr a Gioraione. il pittore h piu ha fr que11tato
quc t forme e for e Lotto. con quella di ponibilit norditaliana' alrcniama rhc i
intreccia on la pratica impr . i ti as:
1
: ricordo il operto p r il ritratto dcl ve covo
Brrnaro dc Ro i (1505. \fa hinaton. \ati nal Callery e \a1 oli, :\lu. o di apo-
di.Jnont ). r ffiaie di Lucina Brembati (F 18 ca .. Brruamo. ,\ cadcrnia Carrara [ili.
12)). il ritratto di un uomo di 37 anni (1:- -t2 a .. Roma. all ria Doria Pamphilij ).
Come n l ritratto di Lucr zia raJi r (15. 3. Londra. \ational alJ ry [ili. 13)). le
parole. nella forma di iniziali. m tti r i rizioni. offrono un \1lt ri re annotazione.
do tm1 ntaria o moral , alla em.bianza
8
-1: ritte ullo f 11do Iipinto. u cartiirli.
e poi u libri e I tter . ornunicano il nom del p r onaugio effofato. la 11a et. i
uoi p n i ri le ue int nzioni. la ua e mplarit. In \'irtli drlla loro collocazionr
mar!li.nal o comunqu di tinta e I1 orni iata . potnnuuo inten<lerlr. al limit .
come trema riduzi ne piurammatira di un componimento u ritratto o. "i \rr-
a. com uo nucleo rio-inario. 'imiJi f enomrni cli ibridazion non fug ono alla
po ia. che ad e i ri rrn un"attenzion nien(affat10 di int r ata.
La po ibilit di attra\'er are la oulia tra la ernbianza e il mondo int rior
pr o m a in qu tion dai po ti. hr di norma ri\' ndicano a la ola lnrnaain
il ritratto del corpo e drlraniina . .\ri modi pur comenzionali di q11e ta
u . 1011 . lirica illumina la uatura cl ppiam nt m di. ta di uni tentali,o cli
' '
1
I int riorit in un ffigi dipinta o colpita: seuno il olto. un filtro . ul
quale
1
di anano martif tazioni mi 11rabili d lri11t riorit. e a mauaior racrione
i irnboli. h lo accompar1nano. in quanto rin iano a siunificati non vi i-
lnli e nchiedono un int rpr tazi n . La on ap voi zza dri po ti part ic larm nt
8:! Pcr il rapporto del ritrailo con parap1t10 COll la lradiziorw drlle icone foudamcntalr r Rr .. 1986.
8:J li nmfmmo ron i ritratti fi"1rr111 ' . I 6 li 1
. ,., ' '
1
JlllO e 'rrr panico arr11e111r 5!"111 rnt110 qu1111do 'I nl<rnno para 1 1 cmi
Mrullurc e111h!Pmat1ch1 comi 1111 ,.. ' . 1 " . . J
, .1 I . J .1 : ao ui g
1
impresa portrcuts. 111 Rerrnis. a111r lf-fn.,Ji1011mg.w 1rn
111uJ 111111w < Na1 "are 11ll'lud1cl in dw rt , I I
11
. po ra11 111 orr rr to proiecr a puhlic irmwc of tlw ,,11b1cC'f. Tlur arl' strrct )
1111 > 111iat1c \\ hrri as so oftrn r h I " I
I
1
. 1 . . e l<On is
11
r 0111pa111c1 h1 11 uxt or 1110110 cxprc's!>ill" a parlwulur 1>ohtwa or u 10 01r1r11 1111 a111 111 wh I I ' ' "
,.. '" rt
1
r1c a. pirat1011 or mora! i111cntio11 of 1111' ,iltcr i. dl'fi1ml (H1: l:.LL 1995. p. 10).
84 D11un11. ri pura111e1111 d0<11111c Il' [ ) 1 , I
1 1
I . [ J .
/
arro. N'rtzronr puo ru,,u111crc il l'alo re di com11111110 dtI prnmnaggw t' Il'
' o li \lrnr '11nrno da 1111 epian1111111a o d11 1111 1110110 [ ... J (Crrnr \H 199-+, p. 19).
2 2
I I
I'<> a) i>iltorr firlO'ClldO di i truirr I' arti ta C po -
I
I ca o ( (' COll!,tg I e I I
rricrntciH < [ . ., ata oluzioni icono1Trafichr reali. ma c1cranrou
1 . I I onr fil ouna . lldlll e O' - 8) d' e 1
sibt e rrc a > ' 1 . . I a onda 1>a:rtr d ll Rime ( 1. 8 ' IU iano
concett ua l <' rf'lot t 1. _,
i , . di ci onetti iii cui il ritratto di nta u11 pr te to
I
. 1 >rende una rnr
Co -e 11u con 1 . . .. !Ot'" aostino Drrio (mera icrlio o rapprc en1ator
I I artista ti 01 irna ' d'd 1
prr e ogiare .. ' . , )11:;
11
. te to (LX ' XJX). h rcond la 1 a ca 1a
. lt 1 mim111a fo1111,P
1
1 runo .
rl un v o Il . d.\ l Orcio ill11minat r eccellenti . imo>. e pnrn mcra\1-
cCommc!lda l artr .' ugu. f? . 1 a " '"uuito rivelando la natura fittizia delle
- o ntratto emrnm1 r ui ' ' . . ff' .
glia p 1: llll JlCIH . a -calichr. JI )!'(' ntr in ui rio pr nel . atto d li e l.O'l
. uc rs ' tV<' cmque cbd , . I , I , to cl Ile t rzin . eh ffron una p1e11a-
f r' .. '( e ntrappone cl pa cl fun .
apo tro a a1t1:; a I . r l'r j lenza di un pera CO tupefac nt : pro
ziou drl tutto con\'enz10uale p . . . li!IU mal' i [)razion ( I" alta id a>) e il
, I e sono stati i malena ,
fayoJo i e eo on esot1c1 n . . . . Lillu ione ubita dalrio- P ttato-
11 . t 1 conce s1 da Amore lll pet ona. . . ( .
penne o :;ono s a t. , , l Jr udito ( \'iYa ben YCram nt . e parla. pira.> '
re fa appello alla \ ' l ta ma clllC 1r a . ta al ri no cimento <l l ogaett
. I nore eh \na 'reonte. por ..., .
1]8') . r. m un cr cene o nH
1
. , ,
1
. [ , 2]) I oneuo uc e no
(
1 , ua o I a colto. r cl<' a. t> ' - . . l
raffi1111rato IO a \Cr io. t . , , fatto a odato. lll i oppone a
(XC) la non riproducibilit h, I ff ;;;1 mediante il paraaon ( .\l
ihilit di rappre entarl. u e rb l; ::eo d Ila ua Donna p r ali ff tti. l fiaun
rie. imo. chr non porendo !iourar
per imilit11dine ):
L alta brlt dw r11iri t'
Dtcio. lw11 piC'riol ' dc I
l dow occhio monal gi rnttrna,
n(. tanto uman 1wn. irr olt ra tende.
.\la sr dipinger . ai co111'rlla incmd
1 I
. Jt 'lll. f('CtO(' trQ\"('rlU\,
C'Ollle (' YO" 1C a I o
I .
com or lr pari rd or lP g111 rrr a tcr na.
rei offende
p 1onw 1 con m un gul\ a
fl<'t' ali C'ff l'tt i ritrar potrai
prrfrt ta la belt che n -.rolora. . .
qurl rhc ncs w1 pcnnrl "rpp crw111a1;
rita) \uo,tino
I
. . [ 1 Or] (<"lrlll 11011 111um ,..
11 ". Ci11/ia110 Gos1'111t, '- ' . (1-8-+) I \l rnp.
83 CO%Ll\I 1588. ''0111111c11io della nla <e tg/11/1/1'. , <f >//a pillum coltura et ., l,,. ni:1tort'
I I L . I Talla/o te or <'
1
. ,
1
I' ,I di , a,0111; 1 1 '
Dtcm r me111101111to < u omaz.i:o ne " 1
1
iitrRttO d1 C.nr o .
. . I I 1 , / ) ('0111r 111ton 1 1 w I , ub1to 11n111a t
LI (('01110.1izro11e d1 nlrarTe e a m1 111
11
e .' . Il J' it di un l1111)lO t' ('111 11 e'
J S 11 compnre .i ''
11
' che ru al . tryizio di Rodolfo d \,hnrgo t' { t'I' il\ o '' .
I Il
"79) E' colon-/ (Lo,111zo 1'17:3- 197-+, 10. , p.
1
. rllo I con 1
11
Ji td ,ntrcl\
1
'
1
. . .I r inie('\ a11ror l umro nug .. ' . "/ r dii ti dit; Il lii S('
86 Trm1Jrnoli a darlt h1ur10 urah1 odor i , oru .
1
. . , --lii e ali llcdn, t' I um e 1
li I rlil'J>H,rl'"Jlllttt
ma l'ultn iclru. ma q1wl diYin pcnnr o,
011
' \l\ n . 9- H).
\mor fu qtlf'llo? (CostLINI 1:-88.: conda parte, L. X '
87 Cfr. /l/J('\\\111, " 1--+.
no. dipin11i una rgemc aurora.
e Lucif ro in en. eh co' be rai
di mill alme \'rt l"arm inJora
88
.
L impo ibilit di v d re (o hi mortai [ ... ] n n 'int rna) n epir ( n
( ... ] uman p r [ ... ] i t nde) la bell zza int d Ila d molto upcrior
a qu ila pm plend nt eh il pittor o rva (v. 1). oJo pr canam nt att nuata
dalra\ r ativa al v. -. eh uaa ri mmprobabil ondizion di riu cita (
dipin.aer ai ... >): p r ritrarr in modo ompleto ( perf t1a) la bellezza che tramor-
ti e fa innamorar (v. 10) ali dovr bb ap rn rappr ntar aJi ff tti. un
come (in anafora ai w. - - ) non una cosa, m1 az1 n non un a p .tl . La Jda
ar bbe quella di rendere in un ogaetto tati o mat rial qualco a di dinami o e in
prui im ibile (rin ndio d"runore, il pot r ulla voi nt d li amanti. l'alt rna11-
za di ben volenza rud lt. la !rioia il dol r prov ati dalla ferita amoro a)89.
r ll"impo ibilit di r alizzare un ritratto on ntrat tille con eau nze prod tt
da olei he d ve rappre entar . l'arti ta potr' ricorr r alla imilitudin (dipingi
una ora m urora>) cio' alla tra rizion i dati reali in un figurante, h m-
bra allud r al nom della d nna elebrata n li Rime ( fora lbignana. rnoalie dcl
po ta). , Ton olo la p r onifi azion mitoloai a e il para on no p <lienti che
la po ia impieaa omun rn nte ma li aff tti u itati dalla donna nell'runa11tc
ono foa etto pr ipuo della lirica. come an i e la trattati ti a ontemp ranea90.
Il doppio po tam nto. parti i ano dal ampo cl ila pit1 ura a quello della poe ia i fa
ancora pi operto quando il poeta ri olge al m1iator una nu ari hi ta ( I) ,
pi 1 tteraria he mai (Al mede imo. h temperando i colori con le laarim di lui ,
dipinaa pi to a la Donna ua> )
91
La pr ahi ra muo e dalla on, tatazion di ci he
il pittore ed della cl nna ( 11i O. cri O>. crud lt). con id rato in . 'e in r lazi -
n alla condizione emotiva d Iramant (v. i ): u que t ba i rarti ta ' invitato a
ritrarr la donna con una te nica in olita (in di u ata fougia ). t mprando i colori
88 Co tux1 1."88. econda pan , C.
89 1a d Lia dtata canzone X\ ITI {rfr. supra, p. 2.>3). il pi11ore era i11vitato. pi nali ticamcutr.
a. realizzare un mrano che produces e gli te i effrtti . uscitati dalla don11
11
, 11011 a rappr entarli direuamr11tt.
Lrffwo della brllrzza di cui i parla nrl 011 tto Cl non ' i11vecr a po teriori, ri1111ova10 da wia 111i111csi p rfrlla
(comr nella cauzom), ma viene coinvolto nrl rreativo tabili n una onti11ui1 anrora pi fortr tra
arti la. p0<:ta-amante e modrllo.
90 I ondamemalc ' innamituuo il Trullalo della poesia lirica di Pomponio Tor lii d!'bitamrntc edito com111cu-
tato in ToREw 2008. '
91 pittore-o r_ei. che 1 gioro e 1 riso/ dentro a b "li ocrhi r 11e la front alloggia./ o com da pietate ' I
e drl a pioggia:/ per tu. dipingrudo il uo bel vi. o,! ovr lo tanro !nio peu ier
rol tn. 10 piamo,_ ond 10 quasi anciso./ me ci i olori i11 foggio;/ for e averra !'hr la un
bella imago./ temprala col 11110 duol. cli ell a non Trd1./ pieto a nnda I' mpia sua b luur./ Misero me. che par
lo? ella, che wde/ lo I.Tazio mio. aha rmpre il CfJr pi vago./ e n l"ima,,.i11 ua cerco pictare (Co rw11 1588.
tronda parte. XCI).
2 4
I I , ta provoca ( . 5-8). ' un diping r p r ali ffettj> om
1 ianlo (' 1 ama e .
con,' P lt alla lett ra p rch' i dovr bb omp1 r . concr tamente,
. X. ma qu ta o a . (l . . d. 1 . h
111
' r n"" fi ica di una r azion m tl a. a p1ogg1a 1 acnm e
do la ma111 e taz10 ' .
1
11
an . . ) La debol . peranza eh que to ntratto. l tt ralrn nt co
e e dal < u01 . cl . to a la donna ( . 9-11 ). i con urna pre to m un finale
d 1 JlO a r n 1 e p1 .
0
or '
1
, l da anti alla off r nza I' mpia [ ... ] b ltat r ta 1mper-
lamento o, pere ic
1
. d
1
Al p ta-amante n n r ta allora h e rcare
b
1 <llVl n p1u cm
tLLrba t anz11'1 n con la qual P n ava di commu veda (" . 12-14). La
olaz1 n n immag1 . d ali . l'
e. n '., e i va ( 'li ) affila le armi del paragone pr nv n a a
elida cahc1_ u . lit re 11 nza pr lu a all"imma!!.n . il talento p neo
raffi!!llraz1on cli 1 d"pint r l"int lii enza prendo. he ha
e lllll ical ( 'ontinua ammc . trar J l '
la ua Donna di po ia di mu i a):
Que ta che n ) enti r del , ol. .
p ria 1 mondo illu . uo b. i lunu.
astro ma11uior. e cli ntrar pr - umi.
dipinm un altro sol, eh arda e on l
\fa rinu uno, i prn i ri I parole. .
p chi de r alma, e i uoi dol i
ond che dol em nte un or con unu
ond'orni alto int Uetto appagar uol '
come pcn i ritrar, Dccio? Parn o
le pingi a cant ' 'nt rno al a r f nte
tar i Apollo cantando e I or LI :
eh' Ua a le Di,e d al ,a talio va 0
!'acque la ul ria a cr ' i fiori '
e ' l numero r la luce anco a le t 11 -.
. . li al qual rri p ndono du livelli
TI on tto ffr al pittor un clopp10 e_ n ia lo d li d vr dipinu r un altro
cli difficolt: e vu 1 r nd r l'a P tto (i, ico d e '
1
. r Q3. int nde ri-
. ili" d. 11rr nta p r m
oh, ec ndo la t ni a d ila mi tu m . u ai chio dell'anima don
., cl ., h ' Linmat n P e .
trarr an he cio 11011 i v
10
arl altre immaaini. L"inae11n . 1 pen-
fruttar lo paz1 rntorn alla fi
17
ura, a
1
al. ali ali miali mbrano
. al. , . llettu i e m t .., .
ieri le par 1 i o tum1. qu_ ita rnt . . tti ament 1 runmiraz10n
corri pond r a chia rn gli ff t Ll he. u citru)
1
'
11
p ffclati a un i onoarala ac-
dell m ,nti ( v. ) la pa i n d i uon ( 7 ' no a
92 lvi, Il . . di .lnra rrova onfemrn nelle inunaaini
3 , . . . . tor io al nome lunun o )
9 Ladd nsar i di una co tcllaz100 tcmauca
111
.' da cluce, tcllt'>
h
( 11 lt11111 Il LrO> car ' r e apro110 h1udon il son tto t u trar>, '
e 'Oria: una e na con .\pollo e 1 . dipinta a a11fo alla donna ,
un fondale. Led ti po ti li musicali indicafr dal P . 'com un
panrehbero daJJa fi ionomia, dall"abi1 o clalrattc'O'O'i , arna, n "tra-
rollat rale. e iern alla mbianza per quant lllcll da ekmento
p1fril O'iata che
0
lini nccd a q . . .
1
. ne _quac ro. Lattcnzionr
I
.
1 1
uc, ll part1 o an. o1:ipc
1
Ira \'i 1 .
1
. . .
)I tra et1cra e m tafora (con tutto raz a d 1 Il . I )I (' 111ns1-
I . z
1
o e 111t n-a o circo I I
O'J o tra fiaurant e figurato). dipende dalla loro . r . . , . 1 . la nc alto
' t . d li e ( 11101 nnta COll il luto' . I
-; ratc0'1e a poe ia. ma e rtam nte eali ha in m nt il mod Il ]' . .l'
fJ Parna o. ad empio. compare in icm ll'EJ" I e r un111aa1111 r ali.
eh ritrae Barbara Borrom o a orni) la d /cona u l'erso di una mrdaalia
\" \TO:. (ill 1 I ) . . aana a a m tto \ \. \"LU. OB\iOXJ \
. , -fa eau11a p r 1 u nozze ( 1.).).-) Il
dr No"ellara rarti ta , il fio
1
. p p l e
11
,ami o Gonzacra. ronte
r
11
mo rer ao o alcotti \1
1
il no tro po ta ara di ca aQi Il . ma iamo a i ano. dore
'
11
ora a a L mbard I
rora:. eh i" de ul rerso c1 I 1 d' .rn . pacrno a c1 nporta 1' u-
d 'fr . . i una rnec aa ia I Ipf lita onzacra .. d' J
.a J zzo de egwta mtorno al r 2-r.-3 (ill - . o . ra. i acopo
ntratto d ila nobildonna clip' t d B . d ab e u 1sp1raz1onc di un
. . m o a rna1 in amp19., I 1 . . .
1 an rte an h in un
tto (XLII)
1
. . .. eco e 1 ntratt1 e 1 tenti
1 lletti Rota. ancora
011
il oin '. Ju"
1
adippartien_e a una eri per rittoria Ca-
' o rn1ento \ O'O trno De io:
)lJJ. \'UO} J"aft.re prruiar. dtan preofo e \alltO
_ta b !tate. ondr fan JT i cori.
mm, DECIO. i. hr i tuoi rolori
r nd pi b i col uo bel , i.
0
samo.
ritrarla a pirno. ornale il mam
d mn_tte palme r tri"onfali allori:
\'Of ubil rota di lr<>'aiadri amori
ca.rea r di fiamme. a I i dipirwi a <'anro.
la qnal !tiri One tatr eh 1
. 1 r 111 cuna
otto molga pi f lir a
jJ
.
r <'' i rl <>'ia e11 Ili' la pa I .
re ima:
qu la cr rnor la rota >. (' noi .
1
f" sru.
<' "J amrulfi or ahba a <'cl or ul 1
ne <
1
I . . 1 una.
rur ar u1 uno . tato mai %.
Cfr. e \A.vNEI. 2000. lll. n. l."" " .
l 1hullo (Uirrie li i ..,
9
) r >09. p. ->08. do\I' .,1 errwd I I . .
Pani
1
v,
0
C'Oli
0
1
-
1
t.
11
nma
11
i11r ,uJ TCJ\e'>lio i . , J '_a '
1
pr<1Jabil< d1mazio11r d!'lri,rrizi11111 da
pra e ut Jr'JCH' . e o. 1 e e cn11a D ' I I p
tcs. o arti In raffi11r11 Pc '. n acce i. A oiniblra. p gaso in eh . llf o11.lrl11ta < r rndo. I r il
(i, i. n. 150:' "0"
7
) g ..
0
'>lii ier-.ro di una medaul' I . _r fo ca rurlf'(. la 1'orgr111r fppocrc11c . Lo
). fi .) . ,,. lii ( IC mnu ti f)O 'I . \I
9
- ('( . < a H11rz111no ureo .\nronio \111gno
.J ' r. GRtWR1 198.), Pfl .3;)
6
.:j;J
7
J .
96 p '
0
'' M fo <'rnno a11d
rr un 1111111nento 111 oncHo
1
, f>Pr l . . w a
1111
onr1to riferito al dipinlo dl'I Curnpi
a pnnr1pale hiblirw f 1 (' . . .
..,ru a u ,o,rluu nm io a BoLZo-.1 2008. pp. 227-'.BO.
2 6
Per realizzare Llll ritratto compi 'l ( p r ritrarla a pi no). il pittor dovrebbe
alcuni parti olar-i. che emhrano allud rr al nom al co11nome d ila
il porla propon '.na11to ia d co_rato di palm di allori (Vittoria)
r che Yirin alla figura ia dlJ mta la ru ta d Amore (Rota). La celta di qu t at-
tribut finalizzata al rebus d ll' inteCTrazione onoma. tica. ma aagiung indicazioni
uppl mentari . ui ('O, turni imp ccabili d Ila donna: chi (Tira la ruota he innalza
0
ahba . a CTU amauti 11011 Amor ma ne t. La po . ia C()O' I ie un procedimento ron-
rrrto cl Ila pittura. man !ratto di ugaerirnr l'appli azi n lo dilata fino a o urnr il
ritrailo stc o: per visualizzare que t fen rn 110 di po tamento. inunacriniamo o a
arcadnbbe . r. cane I late I cmbianze, comunqu imprendibili p r 1 parole. della
Cinecra de' Benci di r ,conardo o cl ila CO iddetta Laura di Gior(f'ione re t er olo
il ginepro e la pianta di all ro. I a collo azione d ll'el m nto mblematico a fianco
(ca cauto) del sogcr<'l lo ricorda la cornpo izion di reni ritratti. come il Giol'ane con
lucerna ca .. \ ienna. Kun thi toris h um [ili. 1 ]) di ott o un Ritratto
di gentiluomo confondo di marina di Cio,anai ariani B rcramo. A ade-
mia Carrara)'P. don' al fian o della fiaura. ad mpio in uno cl ali an()'oli uperiori.
cli tro una tenda costata o nella rornjcc di una fine tra, ' i ,. cl un oaa tto o un pae-
aagi con 'id nt fur12i n in1h li a. La pr nza di un lrappo oll rnto ac entua
l'rffcuo cli qua(lro n l quadro' rimpr ion di troYar i di front a un ritratto del
c01v ma anche d lranima. alla rual .i a d attraY r o quelrap rtura.
J meccani. mi ' ugaeriti al mi1ator D io trO\ano una pr ci ari p nd nza in
poe ia. t t rr no della o, tituzione. e n la imilitudine o on Ja metafora (.\uro-
ra, 'ol ). O u qucllo dPll amplificazione. on l' pitct o la perifrasi ( Parna O,
palme> callori . r ta > t
8
. L quilibrio tra m m ria dcli immaai11i e trat me
della parola si costruisce a11 hr attrawr. la equ nza d i onetlil)<l, eh formano una
oria di lw1cra ra11zon s am ntata da elida cali : la di p 'izion d i quallr te ti
centrali alterna ccl! iconoarafich immaginari ma t ricamente att tate topoi
amoro. i. he a lor po no alrint mo dei -,onetti. 11 rap-
porto l l'l i \'l'I'. i di pini i p lllllll'l' O lll llll doppi rep rtori tll taforil' . che tende
una rt't' intorn alla pura ,.i ion e. attrav t"O le tratifi azioni l ttrrali e figurate
d<I te!to. costringc la upcrficic vi ibil u un fondo tr ppo scuro e r m to per hr
97 Riprodotto in Ro s1 I <J%. pp.
98 rs('lllpi di q1w,1t 1ra1tgir uri con ii:lio al pilton oono in 1101.1 \:\DLR (C)Q- , PP.
il romp 11imt11rn di Ben Jonon i111 itolato 711e Pictun' o/ I ft.r Body, do1e il potu1 ug!!t' rhCC al pi li ore di
dipingcn llll'lafon I' mr1 11imir.
9Q Lo seri!' rhiusa dai sonr11i \Clii - \Cllll. \t'I primo il pOt'lll 'Pir"n al pitiore rlw \011 f'llOle
la sua .Oouua .ii111ile al 1wo, perch 'egli non /'abbi" a teuwn dipinta. rome fa rim.
in rHHnc dt'llu propria tranquillit. \ 11 ,11onclo 1111 m101 n rlogio dd ritratto t' llnto
fii1tanu1111 dal "l'olo ,olt1111r con n1i 11li strumrnli d1I pittore ' '1'11"0110 s1H-rn1i . 1mm
111
un tt'mpio, nlla
opera pi1 riu reff ti( drlranuua d1I poeia (Clw con.meri il I' i rotori a/f'imagiru della .ma Doww
rome a s1u1 maggior gloria).
2.7
lo auardo lo pos a raggiuno-ere. ll filo onduttore di qu ta e cli altre erie dato
dalle i truzioni per un ritratto, ma e orclio ed epilogo lodano tUl opera finita: com-
mendare e i truir ono due att o-!liamenti apparentemente contraddittori ma
proprio il loro intreccio enunciativo concettual che p rmett ai poeti di parlare di
manten una po izion . Il d.iscor o poetico he i viluppa
mtorno al ha. bi ogno una conn?parte reale ma piuttosto
della ua posstbdtta, di rn; unmagme potenziale, eh puo omigliar o meno a iin-
magi1 vi te e iicordate. E pi difficile c1ivere cli un 1itratto compiuto che di un
ritratto ipotetico: per d un f'fgie che non e ist la poe ia pu co trui rla a
propria e omiglianza. tra formando i dati vi ibili in oggetti e figure he
cono ce e ha o-ia unparato a nommar . Per que to i appoggia a elementi acces ori e
dall? ivo incerto: attributi. u:avestimenti mitologici, dettao-Ji che po
000
farsi b:amite d1 un ritratto moral .
.un dedicato al ritratto delrequivo a amante di un gentiluomo della
famiglia auli Antonfrance CO Raineri prend npunto da unge to visibile nel dipin-
to (tender la ovrun va. o d'oro) per viluppare un paragone tra la donna
e Pandora. La relanva annotazione identifica il d tinatario e fornis e coordinate
(un ritratto dal naturale, un quadro grande)
100
mentre nei ver i il
particolare del vaso d oro viene interpretato in quanto i ricono e appropriato alla
natura inaffidabile del oggetto:
hmagin. igaor, che v innamora
Il va o d'or convien i ove la mano
tenda colei. che 'n bel embiante umano
irena i cori intorno accheta e vora
101
.
Nel onetto di Ta o ov1a l t t d l d h
b
. a s a ua e a stgnora uc essa dt Parma ali attn-
un guerre chi della donna r"tr tt : all ' . . ' . .
. i a a uggenscono o ervatore idenaficaz10m che
f una, dopo ,1 altra. ( Que ta e ha 1 a ta in mano e l'elmo in testa,/
, di. 'e P
1
P
0
ta non e, non e Canulla/ od altra in arme forte in gonna one ta:/ figlia
e aro[ ])102 e ' d . li . '
0 1
avantr ag occhi del lettore pa a un'effimera galleria di
tatue ombre evocate dall ' h
.
1
,. d . . a poesia pm c e dalla cultura. La poe ia coglie o sugge-
n ce mtro uzwne di un dettagli all d
alit
, al o per u ere a un dato invisibile ad e empio una
qu amor e a sua volta il d tta li d
e g o pro uce identificazioni multiple, condo un
100 diretto al ( ... ] gentiluomo auli sovr' .
quadro grande, ov"ella i vedca stend
1
. un dal naturale della sopradeua amata ua, dipinta in un
in quel loco il nome di lei velatament:: ovr UJl va o .d'.oro: e l'assimiglia l'autore a Pandora, e primendo
2008, pp. 231-234.
2
004 Espos1zwne [ CI]). Per un commento al te to cfr. Bo1,zoN1
101 fu1sau 2004. XCl. vv. 1-4
102 RT 640, vv. 1. 3-5.
278
odello iterativo eh incontrer 'IUO ancora in Tas o e in 1arino
103
. Il con eguente
)i garsj per neg,tzione, delle possibili identit, genera un caleidoscopio di para-
0
di :ma chere encomia tiche. In modo analogo funziona il terzo onetto che il
toselini dedica a m1 po ibil ritratto di ittoria Rota:
e i11 man fingi a costei, DEClO, la cetra,
eh con quella di lei b n ' a orda
voce g nlil, che qual d' Amor pi orda
alma pi de ta e le pi ciolte impeua,
ca ta Talia fan; e la faretra
le app ncli e l'arco, ond quell'empia e lorda
belva fu anci a gi. se ti ricorda,
che nvan ' a enta a lui da lui 'an tra,
farai l' arcier eh plende, ' a la gom1a
rliugni l'anne e 'I coturno al vago piede,
al capo I elmo e l'a ta a I man b ile
farai Pallade ardita, e la tua donna
direro Febo, Talia, Palla e che cede
al tuo penne] lo tile ancor d'Ap li
104
.
L'attributo della cetra, adottato per rinviare al talento icale. dell.a ignora, in-
durrebbe o-li p ttatori a ricono cer nel rinatto una raffigurazione di musa.
commedia e della po ia l'ar o la faretra li avvicin rebbero piutto to all 'unmagme cli
' Il' lm aira ta uagerir bbe-
Apollo cacciatore mentre 1 armi e i oturm, ms1eme a e o o .
ro un tena. ono tante il framle legrune con il te to pre edent ( L'
05
) la rapida
0 ) I 1 b"lit' t tta letteraria
quenza di ipot tiche ( e fingi appendi gmnm. ve a a 1 a u . . '_
d
dal t f ' il v.o,bo eh de ima 1 succ ivi effetti
e11Tave t1mentr uagentl poe a aia1 .,...
0
.t a] dello el citato
della rappre entazione le identit che o-li attributi c01uenranno mo . . . .
1 d 1 f i : fis-o mutavano le identi.ficaz1om,
e empio ta 1ai10 i . ettag 10 . oca izzato nman a . , .
. . d di d tita apparenti.
mentre qui al ucced r i degli a ihun Offl pon e 1rna ne 1 en
103 Cfr. infm, 4 . .
-- ---...
10't GoSEJ.1N1 1-88, e onda Parte, / ' I, p. 222. .
1 1
.
l
. d d v ttoria ha nome I cos tu e uaxo i-o e
105 Come il fior di b !tat e a !'altre ha tolto/ qu . ta C""
18
ra, on e , . . . dcl bel volto/ embianza
chiome/ cli lei pincrl'udo, oan.i altrui pn'gio hai olto./ Ma perche
10
nun qudi al eh ' io bramo e non
., I
0
lm h l' te 11"ha dome I cantan o non ' . J
viva, 10 gia non v gg10 come tant a e a v1J1t omai, fil i
1
; \
11
. e i imi rlia/ a i rai Juc na, a
l'a oll o./ Fall ' dunque in rnan DECIO ancor la lira./ non d'Orfeo, ma e
1
po o,
3
.'u
1
. I pirlo a Ja tua anzi ua
I ' f / co 1 oua a11 per mera,'la 1a '
cnn e orato e vago:/ e dara orse 1.I Dio per cui r pira O"ll
1
t 1 o . d
1
.. t" .
0 1
cui Vittoria ha ,'edotto
b li
( . L) L ' 0 1 1enJe 1! fase mo rnn o e
1
.
!' a unago lVl, . a rnpprescntaz10ne e vwa ma n 1 '
1
. U pittore allora iiMtato
tnmc anim (per quanto io miri ... non vcggio ), un oggetto para do aie P r a tra la dormll una
I a . l 1 ( "' d ) l ].. cl<' porta a una nuova ns rmi""" . ' . .
ne a0a1unger' un 1cttag10 1' alJ e unq111". .. , a na,
1
.
1
fo ._, 1 i tratto potr nnunnr 1.
divinit: polJo-.'ol , il dio per ui ogr osa vive ( r pira) e grazie nl qua
1
r
279
J more d I ocrgerro tr nmo C\' j)r ione ,.i!->ibilc in abiti. atrributi r arn'cli.
zon parate'tuali' rii,,p lto alla fcrura umana\' ra e propria. i cui trarti .
0110
ora
mcdiam nt r ali ti i ora marcatam nt idealizzati. la. e il volto ' iruinaaiuci
d ll"auima ( c,\am ut imag e t animi rnltu ._ ic indir<' CLili 'h) , il
pu e' ere decifrato anche n<'lla na nudir. La co trnzi ne r la con e<rurnr e in-
teq r razione (ri I cni,am ntc immi ion decifrazion cli e gni ) cl Jla .em-
bianza dipinta pu r cruidata. ad e mpio. dai pr cetti cJclla fi io<rnomica e
dall"interpr razione d i ere tiw-. o meno tccnicament - dalle metafore eia una
pazializzazi ne ipo tatica del rnlto e del corpo. Pietro Arrtino il riconosciuto
campione di mm \ j,it he tra ende -e ste-. a. di uno auardo rhe i afferma
in una d crizion accurata e cn ibile e in iem :-i u pera con la e fanta ia ( rfr.
.3.6.:...). in una traordina1ia op razione celebrativa e autoc I bratirn. doYe lr
parole completano il tri nfo dcl color di Tiziano. I 11 una letr rra clcll'ottohrc 15.")2
ad Antonio Gicrante. crr tari d I B adelli. allora legato pontificio a renrzia.
Ar tino 1 ue ambizi ni un pa o pili l\a11ti. impegnanrlo i in un rero ('
proprio .ritratto . piritual :
-"el ,. der il mirabili . imo ritratto di \fon i"nore ro. 0011 mi .,ono pohuo a-tr-
n re di non ri1rarc an lo n n la faccia lllu.,tre di ..,ua .'i"noria, ma la -,pmhianzu
del di lui animo cgreuio. Onde p r frclr di ci. rcrn chr ,-e l;rnando in :.orntto. Crnn
'.che come duo Carli Quinti i wugono al mondo. uno di mano de la 1rn111r11. e
I altro de lo tilr di Tiziano. co mede:>imamrnf P p<'r opra cli qurlla e di qur.,to dur
Beccatelli appari,cano. [ ... ]
Chi mai non "iddr. e ,edcr rnol. r altera
Indo! d"ocrni re!!ia
In le Yi cere il cor dc
11 pensi r pio d" wia ment in era:
Chi 11on romwendc la embianza \'C'ra
Dr la wrt1 r de r umanitade.
La t<nerena cl la cruitade.
Come lddio . runa.<' qual in lui i :.pera.
.\firi il ohnnr e 'acro Beccatello.
E ' edr grazi tali in lor fi"11ra.
Dal olo 'fJrc di Tizian p nn Ilo.
r dipinto il C'Ontempla la wtttua
rrrde11dol , ivo: cQue to ' i'uello
Chr de la mia innocenzia ha in ' la curn 108_
106 Co, Cinro11r uclr(}ra/or [C1 196 J . . .
11r so110 rrli intnrprnt ) . r . e 'f 60 ( l11fa11i COlllC il vi.,o ' lo '>prcchio clrll'a11iJ110. cos 11lt ocd11
r ' '
1
<on n1cnmcnto ali"
11
I 11 (' f . . .
fro111ali ( -+-+)i I I .
1
. \' . , > r< 1onr <e oratore. , r. uifra. il rappor10 Ira prnna pcr.m111 r po,11
. . a ' llrra < J rro111C'a h11 neo a 1 ntOrf'tto ( . -+ 3)
10
7
Prr 'I , '
. li< su 1r1111 rmv10 a BoLZO\J 199"> 1 "- 186
( - . . . pp. J -
l08 u \f.1.J2. pp.1-t9-1.i0.
280
au{'lldo un impul o i11contr11ibile. retino a r bbe ritratto Lodovico Brrca-
drlli.
ronrc11trand i ulla drll" ull' a .petto r
1
rr danw prova mancia al uo chr ha m d1 i
al ritratto di un .\Jon iw1ore, I. alla vi. non.r.icruarda l 1mmagm m
, la v ra r IHopria incarnazione cU doti munat nalr cbr 1 m 011tra o rvandola.
<' ma < ' ( 2 6 7) f'
QO'a ttO dell'ipotetico \'Cdrre capll'C llO \'lftll illl non \''\'. --t, \'Y. - . e p l' tnO
la
0
":i
11
iglianza fisica <:prc: a attravcr o lo tu1;or d Ila vien: ri.p nata a ima
l
t' .
1
tratta la C'll todia di un 'alor ( w. 1.3-1-t ). In que t ca. o l azione del I oeta
qua 1 a e . . . . . . . . .
f . ula. eccrzionalme11tr prr Arrw10. m tenruru d1 ntrare. non di cantar o dire
. I Oll11 b 1 d 1' . . 'b'f' . ibiJm
10'1 peicl1 pr due una ra1>pre entazion ver a g 1 inl'lSl 1 ta v1 ente
e opra . .. .
incarnati nella srrnhianza dipinta. comun ment . la ra.ppr . ntazion d li. mteno-
. I olto i>a a dalla potrnza all atto attrawr o la de 1frazion eh ne fa il p ta-
nta , u ' . . e minili dall
prtiatorc, guidato dai prrcetti e. per. 1 1em . e
cri taUizzazioni paziali d Ila po tica a P .trar. a a B_
La lettera di Aretino a YcrornC'a Cambara ui ntrattl d.uch1 d _r
l
. I' > \la
1
1
a della Rowr El on ra onzacra (1 36-1. 3 .. F1renz . U-
nno. ' rane . , . . . .
fizi ). di fatto si sofferma(\ clu irnmcnt ul primo. : lando l allu i m a
incarichi militari diplomatici n i quali il du a ha la !!rand zza d arnrno
che j lrgge n I uo a p tto valoroso:
lo. donna ele"antr, vi manclo il 01Jetto che' i mantr to. e ch"_io ho creato
con la p r cagione del pem1 Uo di Tiziano. P . 1 l'Ome non potern
' I I ' I affati"ar I ll"em10 per ntratto m no
ritrar Pnnnpe fHU Ol ato, co 1 10 non< O\C\a ..
onorato. [o nel \'rderlo chiama i in te:.timonio es;.a natura. facc.ndole l'onf ar.
I E 1 ' f e edenza ocr111 ua niua. ogm uo
l"artt' l> era ('011\"Cr.,a lii e1 pr pna. (I CIO a r C: cl [
prlo. ocrni bllO !>egno. E i colori ('he l'han dipirno non trano. l e_ a
carne. . coprano la, irilit d r animo. E nel lucido dr I anm eh gli ha
11
r'
0
b
0
. I li I 1 I' per ornamento om an en
si il wnnrglto dc \"(' uto a< attO" I ( 1eLrO e . I forbit
l"rffcuo i p nnacchi de la eelata. appariti ,i,am nte con le lor r fic;.,i_om ne
1
.
I
.. I al de i '>ttOi rreneralall , on natura i.
de la corazza di cota11to Duce. mo a ,. rb l , . t> I . f I cl la ua
l
. \' . altro co 1 fionta c 1e per ec e '
111a sirnamcnt quella < 1 eul ura. nou per f .:1 I , ,
. . . , . 1 . . ' h crucrra che re aYuire ,t nt
rrl<1n1 dw com11u10 a 1 1 aggi et ' t ltt ne ' e:- F'
' '
0
. ' . , 1 I . , .. " e 1orem:a non
(
'I . 1 _. I . ba t li i eh <rii d1e tn mau a , uesa, llH zia. .
, 11 11011 t 11 ta e 1 1 r-
1
.
10
chr rendr nw
d'ariemoY Quanto odi che de P rtar la moru a( ro d . Bolomla
I 11
1 . t cli C sarc quan o 111 e
IP rren(i r lt e ella uccide'. B 11 o con > >e a mele!> .' : cl .. "Iler cui
r-> li' . , b , , le nttonr e r t n 101111
v duta;.i ,;"a n la pittura :.e n 11u1ra' iu piu (e - I eti'i di
. I O 1 I l n 1hro appr ,.,o, p01 ns '
pu . empnandani1'ncalr1eo. r eggetto.c ' u. '1 D I' " cl'Llrbino rnondi
, I ,. I d' . I b 1 ti Duea r u uc
11
co111mr11dar la ,oloota e 110 10 1 cr r r,
1
. . .
1
. ' ID ,. \XYll.
. o \" . 1 \ li cli ownwll .\ . . \. ..
lodar lo ::it il <' di ('O;, debiti ,. r. 1.
1
mrzia
1
Pietro .\ re1ino
. . (F' ' zc l rlizi) N'!!llito dn "lzinn ( "u la miu
109 'fr . .' :l.o.2. Ptr liii 1r-,10 del Beccadl'lli :-111 propno n!rauo ITTll "':3-"'-+
f!P111111, rn111r nl rostro stile} rfr. Cot. 1. 1Yt1 190:t p. :l82 t' ' c.11tt>ifl lll8 .. PP
_8 1
e 'I chiaro Apelle con la man de I. arte
mpl andro il YOlto e 'I petto,
Non fin <na d1 pellecrrin ubietto
che l'anima comparte.
fa f man. che dal cielo ha macrcrior parte
Fuor mo"tra ocr1ti invi ibile eone tto
Per 1 gran Duca nl dipinto a
copr I.e palm entro aJ uo ore parte.
E_gh ha il terror fra l'uno e l'altro ciulio
in occhi , e ralrerezza in
e! CUI paz10 I onor iede. e 1 con i crlio
Nlb o
i e u to armato, e ne le braccia pronte
Ard.e il valor, che cruarda dal periglio '
Italia, a 'ra a ue virtuti conte.
L'union de i colori, che Io tile
Di Tiziano ha di te i. esprime fora
La concordia che regcre m Li
. onora
Le del pirito gentile.
eco mode tia in atto umi! '
Onesta nel uo abito dimora.
Vercrogna il pett . I
L o, e J cnn e vela e onora
e . . cr_cre Amore il guardo signori! . '
Pudic1Z1a e belt, nimiche etero
te spazian nel embiante, e fra ciglia
trono de le grazie i di cem
Prudenza il v8!or uo guarda :con i crlia
- el bel tacer. l'altre virtutJ." . t
L' m erne
omon la fronte d ocrni meravicrlial IO.
Il confronto tra Je imma . .
1
retorica dei onetti . . illumm a lgllldis . a a della lettera e la sofi ti.cala
di a tinzione di fu
. vergent1 delle due figure ritratte L , nziom tra pro a ver i e i caratteri
mterpreta con grande preci io . a pro_sa e fedele al ritratto eh de crive e
cgm d 1 ne, mentre i ver l tras . . d .
e po.tere a favore d Ile quali ' . . . cm ano 1 ettagh dell aspetto e i
ne tra ta mtenon em lifi d 1
. nu dittico in ver i potremm di P can ? a iterazio-
le_ quali1a morali ricono ciute nel o re la. pro uruta il corpo la poe ia
lettera 1 acco ta alla embianza d" . corpo. ignficat.ivamente, pero, anche la
ipmta attraver o rr ]" di
ieccamsm1 e .1 stanziamento e
110LAt222 3.
174 ' '. . ' pp .. 14-316. Peru:n co
.. Qu 1:1 ntratti dei duchi d' Urb' nunento dettagliato alla lettera e . . . . .
Woods-Marsden sono ccl b . mo, che saranno o11gerto di t . _a.1 on rmvro a BoLZO r 2008, pp. 168-
da due le ti di clorri di Fc rati anche da Ago tino B azian . mo specifico cap1rolo del prossimo libro di Joannll
( f
o-O rance co M E o, m un componi f'
r. Docr.10 1993 p.
106
) ' ana e ' leonora, con entr . . . . . mento s1gru icativamentr. preceduto
' au nspetlrvam nte 111Je doti rnilitari e ullo virt
282
mediazione: la messa a fuoco dei particolari filtrata dall eff tto ullo pettator e
dall illu ione ( om fan ben l'eff tt .. Y Chi non diria ... ),e il dettaglio materia-
], la eia tra parir e ma.nife ta i meriti in i ihili (non per altro co i che per
fede de la sua crloria ... ). La descrizione tessa i con entra u un elemento dell'ha-
bitus, 1 armatura di per o peso tra visibil, e invisibile, in quanto inclica un ruolo
e comporta una connotazion
111
. i el ver o fuor mo tra ogni in i ihile concetto
(v. 6) i mi ura co non olo lo ruto che rende Tiziano uperiore al grande
roa an he il en o dell ispirazion aretiniana da anti al ritratto. AJl art viene rico-
no ciuto il potere di mo trare all'esterno fuori, ci he non i pu vedere, potere
che spi ga il rili vo conferito ai dati fi ici non vi to o ma uperiore a quello che i
ri contra in altri poeti; il poeta-spettator ha il compito cli decrittar i che visibile
collocando 1 doti morali n Ha geografia del volto. a sociando parti del corpo e qua-
lit interiori: dop uno ouardo generale (nel dipinto a p tto) individua il terrore
fra l'uno l' altro iglio, l'animo in gli o chi, l'alterezza ulla <fronte (dove
iedono l onore e la aggezza) il valore nel busto (<armato, come nel quadro e
come i ricorda nella pro a) e nelle bra eia. ono qualit atti.v , cli combattente e cli
uovemante rutt.e proiettate all e terno all interv nto.
La l nera non fa parola d l ritrntto di Eleonora Gonzacra, e il relativo onetto
Yiene allegato enza clamor e quasi distrattam nte (" on un altro appres o); come
i conviene a un' immagine in sordina i cui colori chiari e tenui embrano comparire
di fronte alle tinte me e igoro e dell fficri di France o :Maria. Un annuncio i-
lenzio o p r una f17ura controllata e evera, dalla condotta impeccabile. L equilibrio
interiore d Ila duche sa trova e pr ion nell unione dei colori ccli t i dallo" tile
di lziano112, che riflette 1 armonia dell virt l concordi mini rre del uo pirito.
La natura pas iva di queste doti int riori i ri pecchia n ila qualit tari.ca dei Yerbi
eh ne definiscono la pre enza vi ibil ( ied e dimora; Yela e onora): il debole
movimento implicito jn pa.zian ' incorniciato dal embiante i p <men Ila
tabilit del trono d ile grazie, vi ibile fra le iglia. Il volto di Eleonora bello
e pudico, oprattutto il nzio o, come on iglia la prudenza come
p rfino la ua uhalternit grarnmatical (la du hes a non mai le vrrtu
la abitano pre enza inerte remi i a la inducono a orvecrliar i propn compor:
tamcnti pi che a parlare e ad agir . Per cop rt ragioni encomia tiche,
anche nel caso de.Ila Ma ola e della l3arozza, il t to concede alla dmma
privil gio di un identit, ma a1 la comparsa d l nome nel te to non i accompagna il
ricordo di fatti not oli.
111
r " I di . . .
1
Il f{'tt. . " triilit ncll'i1111lr sa mimet ica di
. Lii ce ta vn.lonzzarc qu 1 o delt aglio com ' pone e a a ua e
1
' a l cn . rod
'I" l atufll perdte la np u-
izumo e nelle intenzioni d I committente, che aveva maJ1dnlo al p11.torc a propna urm '
e e fcdelmcnt .
112 [
l
, . . h .
1 1
ll' m
1
maginozione dello pettatore
. : e 011 mezzi propri 11lla tt'cnica cl 1 pittore be 'T'i.:wmo a mvc no a
la v1t1t mteriorc dci uoi p rsonagg.i ( PoMMIEI\ 2003, p. 89).
283
-
\d \r('{jn i d ,. n P I . I . . .
. f oc 11 a ln 1 ,' u n t rati i fenu .Jj .
ta rea larment qualit int rimi T I , . 111m . nr1 quali l'a. prll
m .\ la ola. la nobildonna Yen ziana ccl. h. ' t;I ritratto di Eli. ab tta Quiri-
prr rntazi ne di un ,.i ( ur ' to, ) I la cl em >o e Odia ,a a i 1.1_ il gc lo di
a una nperfi ic da crua1cl,11": e ... > li l r la complicit drllo pettatore davarlli
Questo l'aureo. il hello. e il acro ,olt
De la ola . .
0
. . r sacra, e aurea. e bella
Chr I mira wdr qu Ila ,....az Il '
Cl . ;:;< r.1. que a
E
l da gl.1 anaeli il cirl I er ciarle ha wlto.
-Cc "Ili eru1 " . al
. ' oarn ,.. or racrolt
Tra I alni" e 1
CJ < , gran era ra. con eh Ila
k
1
:
0
le sue tienJa , ua tella)
La il ecol_ d ogai al ben oprar ri,olto.
I
a rllu tr . e l'animo reale.
P
en rer "<' il
. cor :.incero.
E lo pino <li lei <ho e fatale.
1 r 'enrbianza nel uo from alt
Ritratto ha 1 . ero
,, l I il mano. u mo unmortale
ia e ie di ,
pmto r non men \'CT chr il ,rro'H.
:\'on appena di' .
. . 'enta oaa tlo d llo cru . , ..
additato aJJ ammirazion .. .
1
. ru:do ( Clu l mira ,. d ) 1 . 1
re daff . .. 'm a embianza> cli . . . . . . : . qur \O to
. . e terno all mtcrno, attra, r il fr . . <O. un ubr lt. e I occhio tra cor-
al
m b1erne pirituale. II lraam d ittico (Qacrilr flltro d Ila grazia , qualir fi . ica e
) andonato n u . u to>: I:.cco) 1 .
1: ..
1
" t rzme. rhe el
11
ano le . . , d' , . rn corpo e anima ,iene
uu ta (w '1-11) . . v11t11 J Eli ab t . f
d ll
.. . '. - 10" ciandol l)Q nuo,rui t
11
. ' e la ill orma a tratta e
mlllaz1one (] l
1
n a t m
. a or mbianza [ ]I R' o. m quanto vero o<rnrtt
maa!no 15-+8 El - ... Itratto h T M
P
iJ .. a ena Barozza. Ar tino fa .-r . a iziano ... >). bi una l<>tt ra del
1 uontratto 11
1
. JHe1m1 nto a , " 1
J
. e. ne e O!narla com" I ' r I rie awva COlllf)Oslo
a petto
0
n r .... creatura m J .
1 e mam e tazioJJ e
1
r
1
0
. li . P ru:e. rntn ia la nozione del-
1 e l>'razia ..
'" " "'
011
un mv nzionc vi. ira:
f: .. J Altro uon ha fatro. il . .. .
eia cuno di < , I' suJ)J[o eh ro v1 viddi in . . .
P
ri: [ J \J 1
11
1 rhC' m.olro intendano I ia prttrrra. nrordarr11i il comr
... a chi rio
1
'
1
ato a onorar, 1 I
J
. 11 ' '<'" iarehbe f
1
,
11
1
ron g l lllC' 1io tri pro
non e 1ro la \'rra . > mte tto prr re 1 f
colore . '"tra s rnhianza. rorn < lH' izo c H' li . !>. rontemplando
da un <::
111
_1m: mano di AprlJr di r\i .
6 l:rr, ' ' Cli ma la finta irr
oiorc 10 raccndano.rnr>o l:"'I r. c>1tord.1e:.1comeinfini1il11mi
auo r ahn d .
"
1
co f urnr ''da lr" J1f ilezzr
I t:3 Cfr. supra 3
1
., ,
,\\\I\') . 1 . . . . . r .,.2. Il cnufro111 I
. 1111 ca due in1
1
irl' , . .
0
ron ' uc >011('fti 1a,i f .
(
l,l'>l(Jll(' d11l'irnmaginc. lllJ A:,:l17o'Oll1 _d11c-rge111i della rorma ON '.J1d1c111i nlla 'lt''Sll efficric (/W(' \ \ \111 -
,a-a '>li i rii 1110 &1 co111rn1 , Il ' to Ml rii rallo'. ,. .. I ..
rimo ronw rapolan>ro r1 . r,i r doli drl ,
0
"/.(!'lto ff'
11111111
' H 1 po11i m11ovo110 dalla
11-1 LI. 111. .38. p. 60. J un urti' di11r,a dulia ra <' .,111l'ahilir1 d I pillon'. l)pfla
28-t
datevi da la natura e da Dio. arcrc;.c1n in te'. . e gC'ntil<'zza ero 1ur11P. Di YOi
diro. clw etl' C 11!'1 front C' Il<' laria. per <rrinamentr adorna di e di rrrazia. j
f ormarr I.a rn '.' tH'I di lei rivc>r o r t r la IJ<'ll<'zza. C'ongionte
a d1 Crrmnr. con I Urre che pnmmo I allo d!'I rnirarolo a i d no. tri
i1.l(' r<'dihile .. C:l!t ci> fac!'ndosi , quelle' dc i Cc ari. con lr imprc e loro aprr
0
_
la cornr gemme anello .. o eh la prudrnzia dt' la ua mode tia
propria ritirn<' il di voi C'onsortr. he e ci non fu: r. il compendio de i
reali Imperadori pigliaria qualit eia la condizione dr l'r :ier ,. tro. [ ... )11;;
La combinazione di brll zza e \irt eh onora la de tinataria' eloaiata
aumrr o r1' \ ' cazi ne ili t111a medacrlia. un ou11 tt doppio h cind ci eh nel
ritratto dipinto era unito. ' ul rerto ' i pone rcffi ie. h aw la fronte r <aria pi n
di cli grazia .. ul river:.o una duplic inunacrin imi lica: I p(ronifica-
zioni drll'One:ta e della Beli zza. unite come i m Ili ac ompaanat da un motto
che ribadir ru11ione upr< mament rara di que tr due qualit. il miracolo della
loro compre. enza a i d no. tri . 'm, ul cerso . i ra Id ppia qu l inol p re!rrino
incarnato dalla rne la11lia te . a. le cui due facc n c m il corp e r anima. );el-
la lettera .\retino allud al dipint e. c!!uito da \'a ari. ma n n dim('nrica quello di
Tiziano. piegando che la rauion rhr l ha indotto a riY r non preci amcnt il
ritratto ( lo e rmpio che 'i dimo tra \'\'a ) . ma r obbliao di onorare la Bar zza eh
caturit al olo \ ed rla in pittura. li componim nto L - itato dalla ernbianza
finta allegato alla lettrra al \'a' ari del 29 ltwlio 1. -2:
Ecco' i il 'emetto chr i lllerit i dr la gc>ntil<lomia e i prieghi rnstri m'hanno tratto dr
lo ir11ellet10, con tmrta ,olont dr pi non -.i potrebbe dire. lmpcroch io non ho
mai 'i-.to , olto , i' o che mi abbi rno..,:.o a upirnr. f'ome il suo dipimo.
dli' la grazia de gli OC'f'hi. fa 11131' ! dc la sembianza. ' \' aJr rezza de la fronte.
uni ...rnno 1alment1' in::.ieme. rhr fann di lor mia rompo-.izionc> cli bellezza
pili to ... to rc> le. ll' rhc tl'rrena: (' quel ch pi ammiro. r dw niun pu auardar rotak
imaginc con de-.ir la-.ri\o. \la son u cito fuor di mr nel mo
pen11ello vostro. che far io 10-.t rhr io lo \'CIY"il ne la ' 'ila ,ua? Di \'inezia il.
Di Luglio \\\\li.
Larte fatta '\atura. r chi noi eredr
l'esempio altt'r che Ciorgi) ha tolto
Dr la Ba rozza. mI ui TO 'olto
L' indole che hanno gli \ngeli si ' de.
Lo spirto de lo -.til. clu al Y< r non r de.
'tas, i tra i color ,i\ in sr rarcolt .
\ qu<'ll grazi . a qu lii onori ,olto.
Pietro .\retino
I IS LI . I\'. -t8?. p. :102. Co111r chstn a \\ooos-r-. hnsm.s 2001. cin th1' or(1h1 rd111iH'I) ft\\ J fimalnuhjt't'l'.
liii' fl'\l'N' lllll"e l'\ ll' IHI'> IO for11' Oli dli' f 1111iliur I ht>lllt'' of ht'llllrl or , -jrfUl' (p. 8'.!).
" . .
285
-
. he In trna la fa e r il .icl I, diede.
intanto il auardo uo beato
L1 noi. h umilem 11lr il contrmpliamo.
a to r nde il pen iero innam rato.
Tal he olo inchinar le ideriamo
La belli ima Donna. Ido! d I Fato
i\e la qual par che no11 pe Aclam
11 6
La natmal zza deffimitazion va ariana (' 1) ' ubito I gata ali' pre ion
d lf indol ana lica (pi t to J t eh terr na) della Bar zza. La virt d Jla
donna embra nobilitare lo tile d l pitl re (lo pirt d l til> ). che la ritrar n
a luta preci i n (al " r non e d ), ali p ttatori (contempliamo). il ui
pen iero potenzialm nte in1purn i fa a t . In quanto fitta tar ia di topoi, la lettera
qua i tm onetto in pro a. con llll tipi o finale piaramruati o o P''- o (eh
far io ... ). o una orta di parafra i del onett : n ll 'a petl d lla Barozza (rom-
po izion di b U zza) indi,idua qualit !!i riv lte alrinterno (grazia: mae t:
alter zza ). com ribadi la natura non la iva d i d id ti eh i ' pirano.
. ano tant i riferimenti ai p ien alranimo, i eh Aretino , cii e di que ti
ritratti f mminili riruarda enzialmente virt morali trad tte in OillJ ortamenti
(r ttitudine. prud nza. aener it e .): nzores. non aff tti, ulla linea di qu ll'ammJ-
lamento della per onalita eh ali tudi uender hanno ri ono iuto in m lti profil f m-
minili. fi ari in una po a eh n utralizza lo guardo d 1 ogaetto afferma il po e o
da paiie di un padr di un marito
117
. rena Milano om nella Fir nz del Quattro-
cento, il ritratto di profilo ra il pi adatto p r rappr ntare rtzabilus. la I llezza e
lo tato o iale. the on tru ted b haviour. th virtu u onduct f th e id ali. d
women
118
. Per r nder i moti> d H"animu . vi t i o imper etti.bili il pittor dovr
inv ce far volg r il oggetto vero Jo p ttatore. Ritrarr f anima. r int rna ( lta
Ca a) o la divina> (P trar a) part , ' un ompito eh il po ta te o a mne dubito-
am nt perch' il baglior d Il bellezze int riori una luce che fug11 al olor alto
calpello alla parola b n pi radicalment del t oro> orpor o:
gi men bel de lo splendor interno
qurl ln oi di r rno
di Cuor. perir. rubini. a\'Orio d or
116 !.... L 11. -t21. pp. -t 19-420.
117 Cfr. 1992 e \ n1c1rr 2000.
118 \CU 1997. p. 79. i !'cn,i ad empio al ritratto di Ciovarrna d "li Albizzi d I .hirlaudaio (1488. Madrid,
Tl1y o a qu1llo di Bianra Maria for.lll dipinto da Ambrogio d Pndi. (144:3 rn ..
a \lat1onal Calle'.y of \Vidcner Coli ction), do\e i v<'de w
1
gioi Ilo chr rappr ntu l'impr sa di
Lodov1 o il Moro, fo""." d1l tipo n1l. qual Carad . so i pr ializzi (Ww;
11
1995, pp. 2-t3-244 ); oppure aJ ritrntto,
opera drlJo L<s o artista, <"h mff1gura u11a don11a C'he una cintura on Jr iniziali d I Moro ( 1490 a.,
Londra. Satioual Callery).
286
parte in bianca {' vi a ne .
' n cl I pazio e breve
di natura r d' amor gloria e t oro:
ma fhi dipinge quel ch'io denlro onoro?
[ .. . ] . )
B 0 i potrian I dar (non f or e a p1 no
gli occhi e ' I volto_
ma in de riv r eh 01 l mterna parle
,. . . l rte119
vinti arian al ma gru e nata a .
, '" . anz n h e 1 bra El nora de dici Gonzaua, prin ipe -
o i 1a o, m una e . . l" iblt' cl' 'trarr l virt>
di Manto a, ff nna in forma rnt IT011at1va, impo t 1 a In . ' .....
a_ uni I Ha d ma120. Al ntempo r interna part tend a I lil
i o tl di .. d" doti o di fa olt121 ar par nt mente enza pa wni. Lo on-
un r ge to 11101 es
1
. ili d di a all b ll zz int riori
f rma, ad e mpio; lo trambotto he p mporn or
d ll'an1ata:
i unta e 11 leagiadria fr dda hon tat ,
Rara in cor aiovanil canuta mente.
Infinita b nt. omma behate,
D d"hon r he l'altrr voglie ha pent
Oltr"oani human p 11 i r alta hurniltate,
obil anauc, alma di vinute ard nt
In v i ra c lte, come aemme in auro t"
voi gloria, a me clan pena e re tauro --
. 1 o ta il t rico d ali aff tti>. t:ra-
Dunqu p rfino il P rduto Tnnommato, p . d' . ali D ll'am, ta ritratta
. . . ,
1
Il d un I n o d1 attitu 1m m r
f rma I inten nta a nna . il otum _una fredd zza bru iant - e
gi B mbo ev ca,'a non l mozi l1l d : t . t art >) a front delle pro-
( al I b ll zza ]eaITTa na. na . . f .
l virt - nno. v r
0
1
- n tta parzi ne d i attl
. . . ( . a r t ma e I or ) . na . . d
pn pa 1om p m ' PI< . . _ . i Da una part . l'id nti6 azione -
rll'anima impli a due pr uppo n ma t op1 .
. . . rii/ CO O n . 30-36. --i8.
119 RT 13i 8 Quando nJardo a nu ' pe11 ie . I . d rii I qu lle \ in1 di rui !!i, t( ad r-
l I I de no"a nt rnr e"gia ro . . r a/
I
10 Quai aranno i colori l' I mli\' t' , 111111. n r-1 1 I 11a cremi! ? I o 'lilla. du. ti - me e P ' l htllnl
- . il alcun p<> .;3 rn or t a 1 , ..
na?/ o pi tra in cui olpire t ti ur Ioni t' (ibid .. w. 37-H). .
q
ut'I cht' man dotta ad ma./ (' n \ll P . . Il 1 , e Lo "nl(e.,.no e lt' allf( don e
I I o11110>1z1011r a e qua ita . . , lla
1? 1 I o tr o f nom no 'i o,,,rna, nr e so . . lO di d1'11irrurrt' la beUeza dd corpo r non que
- ' ' . 'och 8\llltllO lt'llt3
\in dcli animo non r 1 fanno lllt' trrn. pert'1
dell' animo [ .. . ) (FIRf'\ZIOI 1977, P 89). li ' . d1' comronimrnti, il onetto 76:
I . I ,d alo ne a slt's:a erte I . I
1' 1? 'loREI Ll 9008 Rime 8:t \Ile bellezze de corpo t'\t e ic a I P"r 1110 trar ua ricd1ezza al m ndo e uara/
-- - . n/ O I' an mwa fi\'ar ' I 11ra
Quanto thrsor tn1 i t'a\i 11101111 cr l no ocr , I . < urrt'l 1/ Phebo cl homai da voi ar ucc nnp ..
Tutt posto i;1 voi, do111111, u noi 'ornlll'fino vt'la (\ " Per un'anali'i pit1 anuruta i
I
. . I , n1a / I'.: s1nu-o < o. u-o i n
Vi fan perle <' ru lilli u lrru t r . . P >01 Ob
. . d' p 'l r lii nm 10 a 1 11 -
qmsti di ahn 1c 11 1 1111 1110
28.
gli affetti com oaa tto el tliYo d Ila lirica in quanto crnt clclr .
9.()a it d. l e io. 111 quant ,. >e
- e I pnm r a Y1ta moti' a< he la po ia n n riconO'rc alla 11
tr . com. abbiamo ,.i to. le attribui e qual he fa oh n. e .p'. ura., m n-
unn 'Orn pondenza tra il mon I intNi re dell'amante cii e11 i' altra.
alla cl m1a- t or ,. fatta di beli - d' .. , t rn nt1. 11cgat1 invee
dal ritratto co . zz
1
\Jrtu-a meu h naturalm ntc. non cca
mm 1 a cn,ere.
-l.3 Per una.fenomeno/ouia poetica dell'anima L'isibile
I mores. inte i om mial't' I d .
. :
1
a
1 1 tra uc no m azi ni e attcuuiam . . .
a cedono al la uperfi J pitl rica attrnv r 1 , l 1 . L>l:'.'. nt1 eone iet1.
L pre ion di em zi ni aff tti e : to, I ."<' to. I habttus. gli attributi.
prer inalienabil . tto 1 I lllY . n: ndicata dalla p ia com
l
mc 1 a ne 1 tta d1 cntratt" ]' .- .
. ,
13 ra oho una eri d. di h . <
1 111
,,.
1
anann Koo
i pmtl e ntra""Oil O"getti ma I T . . .
tazioni e pen ieri malin oni i - d . l d. . . e Il J immrrM m mrcJi-
. 0' lat arumo 1 traduce
"e t1. ad e mpio qu llo di abba l f . m e pr . 10111 e m
cuor . non nza ie o di 0"" ttJ. are. r nte di portare la mano alf altezza del
a n - tra a Itri 1
attribuito a iornione o al Po d (1-0 I a . I wmne con d ILbro rerde
r enon . ca a11 F . F.
ewn [ill. 1 ] ) il 'dd B . .. ranci o. me rt
, . o l tt rocardo di I vanni .. . ( r 10 B
z pmii" z ti 1uz um) 1 .
/ 1
ai iam a.. udapr 1.
.\"e'" York. Frick Coli C. J) 'wrnne G rosso di Tiziano (1. 11-12 ca ..
c ion . . 'on on rndiv1du1 tr fl . . . , l
chi ano lo auardo la co . d Il
0
L. attm. a a Burckhardt
nver az1011
0
1
ettato . . . . '
m ndo int rior n 1 qual 1
1
.
1
npi gat1 u un invi ibile
ad ntrare. 'h ian crentil tL pe .. ap rt ul Ilo ul p llo. i invitano
dei loro ritratti i intu o u o _u .. m ri:im luo"O . on amanti . al cuor
"en ral in tri nfo h dntJ prn _md fmiti di qu Ili di un ovrano di un
. pa1 no ntr d crranit' . d .
t:Jmor . no tal cri a. afft'lti privati d I I J o1 mo ' mores: p ranza.
ni. att tat in parti lare eJ -_. o a Kooi, la o t ruzio11r di qu te inlJna"i-
dalJ
. . n pumo mqu 1110 en t . 1.1. d. .
a poe rn d amor conte .
1
. . o. ruruu m mia pro1 no
d
. mp ran a. 1e i voalia 0 d l
1 ritratto liri o. J'ipol di d . . m no a ottare a definizione
. .
1
una envaz1one fonda 1m . .
to tipo ntratti tico co trin"e "il m nla r11t po llca d1 qu -
1
, a n ett r u alcuni fate d. 1
cron ogica e pazial on I .
1
. . . .
1 1
n 1 \ ' O: una coincidenza
d
a a<T1onr 111 u1 p eia "t tl . , . . .
prova ei te ti. :ia n J eneto d. . .
11
ra o prn 1 e vvwrnano. alla
i 10r11wn e po d. T . .
te. nella Roma di Raffaello o a F n-ar . r '. IZlano ia. pur di\'Cr amen-
B mbo: una t ndenzial o .. a. lutl1 luo"hi t ccati dal fortunalo a tr li
. \Tappo 1z10n tra I < . . l . .
a com umcarc (
0
alm
11
m t . d.
1
> a !0111 m cm a p1U urn n cr
d
. .
0 1
a
1
vo cr comunicar ) 1 1 1
me iaz1 m imboli h <' ali azi d Ha . . e ammo e e o.CYrr llo se11::.a
p , po
13
' rnt a om e pre: i ne diretta dc"li
1''3 Koo '>006 ('f
- - . ' r arwhe lhu1R1.\' 198:1r\lu.ou2007.
'...88
alfrtti. Prr 111oblrar<' l'anima. la pittur::1. una ,olla di pi1. 11011 p11 fare a 111eno clrlla
parola. o JJH' <rlio di un detrn11i11ato modo e::-pre i\O rh ha apprr o d, Ila p r. ia.
in parti cola rr da Pet rare a. A rigore. anche qucstr i rmnaai ni ricorr no a 111f'diazioni
p r portare r i11t rno all'c-. trrno. ma :;rruardi. <T(' li ('po. ('. in c1uanlo man ife tazioni
intcgrntr nrlla fiaura C'lli appari ngo110. ono (' prdicnti m no difformi dalla pura
rmhia11za di quanto lo iano. ad c. empio. altributi . imboli i impre
lua i-
mile I ndenza appare conforme alla natura drll'intro:.przione lirirn nei u i a. p 1ti
pili piani e ('Hlltabili . lontani dalla den a ,;..,i, itit dell<' ipo ta i ti I no' i tirhe.
Il ritralto liril'o co tit uir bbe una .,orta di doppio al ma Thile dcI ritratto
drlla bella donna>. offrr11do una pirga1:ione parallela t' -.immctrira ri petto a quella
proposta molti anni fo da Elizahrth Croppcr per le Belle cinquer nt eh
Paral-
ltla prr il mecranis1110 dell'ic;,pirazionr. che maturebb<' a ronfronto con le due firrur
liri"he principali. il poeta-amant la clonua amata: ... irnmetri a perch alla di . tin-
zione Ira i generi ses uali corri pondono due erir complementari ( OP-grtto/o"getto.
intrrno/e-.t rno ). eu tramh codificate: eia un lato r atl gcriament d lla lll ditazione.
del languor<' e !ella co11f ione. eh apr allo pcttatore e al l ttore un mondo cn-
zialm nte iuteriore. dall'altro re ihizion en ualr o piritualizzata di una bellezza
eh .. ulla clrl canone> hrew e lunao . .,i pr enta i.n forme ernpr U"uali e
idralizzate. eh te11douo. pie tonicamente. alla B ll zza. E emplar in que-.to . n o
potrrhbe e, I" acco. tame11to tra du opere di Palma il Yec hio, il o icldctto Poeta
della -atio11al ,all (1 16 ca. [ili. 18]) e la Bella d I \Iu o Thy n-Bornemi. za
(1318-1320 [ili. 19])
1
:.!u. Qu .... 10 . p cific clwma binario att nua alcun 111 op-
po: izioni rhr abbiamo rie no-.ciuto tra ritratti ma hili ritratti femminili. in I arti-
colar<" quella tra identit d ll't1omo anonima! lella d ima e 1u ila tra condizion
attiva del poeta<' pa \it drll"amata. In \rt"1 della lor d minant liri a, quc-,te
immagini 11011 hanno bi "110 di nomi. ma olo cli ruoli o cli YO i (un i un lll). p r-
chr , i riferi con a una .- toria intima e al cont rnpo a un paracli"ma modellizzante.
La posizionr ul rdi11ata d Ila domk pu e cn on rrtita dal uo ruol aacrre ivo.
implicito n ll'att uuiam nto di qu -ti amru1ti dolenti(' pri"i ni. ri. raffaurati in po-
, izi n di drholrzza. feriti r torturati dall'amore.
.\ condo \ll>t'rti ci 11101i dt'll'1111imo ,i tomHom1 dni moti dd nirpo ( ... ]> (/)e pirturo. Il il. p. 71 ). \i
11101i ;. drdin11n t11tlo il otto11do librn dtI citato '/-(lf/alo (1:i!H) tiri Lomnno. Per qm"li rifrri111tnti e per In pi
tnrd11 odifr11zinr11 dell'artt dti cmni l"fr. Bouo..,1 ICJCJ:i. pp. lbh. Pou1 Jl}<Jbh t' Po'1HI ''ou ."ulla
fu11zio11t' d1i 1,ti an h1 mlrid111tilra1iom ,imholi1a o ,rnrirn 1l1i >ll!!!!t'lli : 1fr. C1tR.1 H I <><>-t y._ eht rita il
i1 t'' oruto Uitmtto di L11cn=i11 I alier. di Lotto (ili . t:l]: nd quadro. pmlmh1lrurntt dipinto nt'I l.l.U. 111 01ta,'.ont'
d1llt s11t nozzt' . la do1111n iiulirn l' i11111111"llc drlln ''"' 0111011i111t1 r,1111plarl' : il cnniliu ,ul tarnlo. t'UllH' una duln-
'rnlia al <lbr1-:11o. nti1u c\EC l LL.\ l\O'l DIC.\ Ll CHETI \L \ l\'KI' ., lt ultinw paml1 di L11m1ia
,pcorulu Li,i;1 ( lb urbe conclita. 1.:ill).
I 2:i Cfr. supra. ,'
l'.lh I d11r ri11111ti ,011o -,t
11
ti ,ig11ilr11ti\'1t111t111r \''l1thti 11no 11t1w110 all'altro nt'lln fl.'t"t'llll' lwes.
I w1 l ;H"k to '/ti(/11 (Londra. \111ionul 1." 1111ohn :WOR- 18 gt111111io 200<l). \1l r1la1110 nirnl1
1
!!<> w1n
/'are.1 :W08) lt 1-htd 1orrispondmti ,0110 lt llll . hh-b-:' . pp.
'.289
fa quali 0110 ali m 'Cnim nti eh i volu no n !l ' anima, Jo e nari i.nt n re
p e ia pittura i contendono? L'alt mar i dcli pa ioni l'in orabil r i l<'n-
za o la rapida on unzion di erti tati danim : l'att a. la paura, il d id rio, l' ira,
la di perazi ne. qu ta alt zza. impo iliil tabilir una di tinzione preci a tra
m ti. affetti pc i ni. tra mozioni inaolari f nom ni int ri ri ri ndu ibili a
h mi anali ti i di 01iain anti a. Qu to tanto pi v r ri ono ciain la di ' tanza
tra 1' pr ion mod rna d Ila oaa ttivit qu ila propria del p trai l mo. che i
ba a ' U un rep rtori d fnit di ituazioni p ibilit motiv , dov ani p cifi a
variante pie a u uno fond omog n o l'intr duzion di un moto nuo o pu
aff rmar i in una data ar a a O!!ra6 a o pr una uola di po ti ( mbl matico
il a o della fortuna m ridional ' d I tema d Ha " I ia). Il ambito di qu ta
odifi.cazion , le m tafor i ti wnono w1 ruolo fondamentale. La rapa it di
:finaere o!mi affetto on il rnimeti m proprio cl ll' attor ( . aa!!iung r i, del p ta-
Yentriloquo di infiniti io) , vin attribuita al pittore Ja op Tint r tto (1518-1594)
in Wla lettera di Veroni a Fran o:
I non po o, -ignor ntoretto. entir rti , li quali all volte lodano tanto "li
anti hi tempi e bia imano i no tri [ ... ) lo ho ntito dir a aaJantuomini non
poco ,-er ati n lrantichit. e di que t"art intend nti imi . h ono tari ne no
tri tempi.. ono og
11
idi , pittori e ultori i quali non olo pareg11iare ma anco
pr porre 1 d ono agli antichi. come ono tati helang lo Rafaello. Tiziano ed
aJ?"i. e? ora 'te voi .. _'on dico ci per lu ingarYi , ,. dete. p rch que. to ' publico
gndo. il qual e a voi pare eh tal non ia, av ien perch' errate )'or echi e alle
vo tre . non curat aper in che eone tto iat degli uomini. come o liono
fare
11
li altn della \' O tra art di qual ivoglia altra. Il h credo io avv nire
percioch, endo \'O pervenuto al ommo di qu Ila e ap ndo non e ere niuno
pa ato innaJlZi, ome chi degna aver p r auida d lla ua trada chi per
quella non altra volta andato, dell ' altrui !!iudizio non curate o loda o bia imo
che ' 'i rechi. tutto iat intento in quante mani re i pu d' imitar , anzi di u-
p rar la natura non olo nelle o in ui Ila ' imitabile, ome n 1 formar fiaure
o ve . dand l colori. ombre. profili. fattezz . mu oli. m vim nti atti ,
po 1ture . . p1e
11
hc. e dj ,Po. izioni a quella onformi, ma fattament prim ndo
ancora gh aff ctt1 d li animo he non cr do gli ap co fincrcre Ro cio in c -
na, ome li fincre il vo tr miracolo o ed immortal p nncllo in in rnur in
tela od in altra o a. '
! 'i prometto che quando ho veduto il mio ritratto. op ra d !Ja v tra divina mano
tO ?no tata_ un i11 for e rei fo e pittura o pur fantasima innanzi a me com-
panta per tn
11
anno non mica per farmi iru1amorare di m t sa. come
a a l\;ar i o. lddio grazia non mi t ngo b Ila h io tcnrn di av r
marnare dell propn b Il zz ma p r aJ un altr fine, hc o io ... 011d i o
U: .. tel a certa. hr a ndo ralma natura v duro quanto f li m nte
voi 1 mutat , anzi_ l avanzate. p rcb voi con l'op r o tre imm rtali quanto a voi
cr?. , te tan10 a lei . di onore, non o cr mai di dare agli uomini d Jl a nostra
eta 1 alto P llegru10 inge!mo eh po i a pi no piegar l e llenza cl Ila vo tra
290
artr, perrhr rlla non re ti cl in fatto ed in parole vrrgocrnata in tult I' t eh r-
rann . Ed io. certa di non riu ir a tanta irnpre a. p n o cri la penna vi pr 11 da
\ostro ignorc Dio folicit
127
.
La po t a atta a i t nitori drali hi. ri end.i ando enza itazion
upcriorit di Mi h lang lo, Raffa Ilo e T1z1an . Il uo mterl utor ancora pm
anunir ol , p r h' n n i cura d I giudizio d ali altri. a rbito nelr ezi nale
forzo di imitar di uperar la natura: non lo n l ritrarr c: figur . orpi. n
I loro carattrri tich anatomich e con movimenti po e convenienti a ia un
og rtl . ma an he n ll' primer egli affetti d Ir con un:abilit di mim_ i
int .riore up riore a quella del e l br attor Ro c10. cl1f o da iceron n lla,
11
10-
vanilr orazion Pro Quinto Roscio comoedo (for e cl 1 6 a. ) . Il para O'On tra
l'attore e il p nnello. tra la ena il upport d l dipinto. i du ampi in cui i due
ma tri i e rcitano e producono l I ro finzioni moti . lmpli ito ' il rif erim nto
all'actio. la partizion della r t rica antica pi frequ ntata dalla trattati tica rina-
rim ntal ull arti
128
: gli p di nti della u tualit. ali att O'giam nti del volto
e le intonazioni d lla voce, nelr attor com nell'ora tor , p rm ttono di up rar
i limiti e pr ivi d ll'irnrnagin . a' inand la ai p t ri d Ila voc . at_traver o la
qual la tra mi ion d gli aff tti i r alizza in modo pi diato
12
1) . propri _a
qu to punto d lla I tt ra h la po t ari vo a lo trano incontro on il propno
ritratto mi t rio o d ppio ulla ui v ra natura ha dubitat a lunao: pittura
o fanta ima appar a in virt di qualch diabolic inganno o per qualch fin
ianoto. clu o con fal a e di rtita mode tia, qu ll di pr vo ai un innam -
ramento narci i tico. Di qu , to p ibil in ant im la ortiaiana n ta aria
ome e fo e un nto ordinario, cd ' una mpli oincid nza h n 1 1580 i
di I
. . 130
ia dovuta dif nd r propri da un a u a prati 1 up r ttz1
127 I1.1'co 1998, XXI. pp. 68- O. Tintorrll anch autor di un rirrano del poeta Lui!ri .roto d rto il .i co
d' dria (prr la ua le11 ra al pittore dr. 2008, p. -3).
128 1301.zo. 1 1995 (pp. 176- 179) rgnula anch il paraaone albcrliano trn la rnpprc cl! mo
accl'ntunti e gli rcccs i cl gli iwioni (p. 168): ( ... ]odono quellr imrnnrini molt parer \"IW quali i;n?lc. g. umo
O"ni 'iuo m mbro. e per que 10 in lor 6gur frum parerle hermidori r i trioui cuza alcwia cl !!11Jta di pmurn
[ ... ](De pictura, Il H , pp. 7 - 9).
129 cl Traila/o della poesia lirica Pomponio Tordli o scrYa che( ... ] non niega '.\ri rotei che la Pillura co' l
db>c!!l10 i co tumi non e prima, hc per que.:.ta cau.a non :,ia differenza tra Wl Pnt .re wi altro, ma non
infonde a qu I modo i pen trand ranimo on ranim I aff tto con la pao ione. Que to modo ('_Pro-
prio dcll11 voce, es cudo rlmrmonia proprio in trumrnto a i, non p teudo il Pitt r dar quell alla
ehr p il canton alla voce. ('h ' instrurnl'tllo pi(1 '' ivo pi animato. [ ... ] gli aff t ... ] ono molto ptu propmqm
alla 1oc h dal! arterie, dallo pirito dnl ror pr ed che al penello arpello. m munemo e muco e fml lo
(Trai/a/o della poe ia lirica, in ToREW w008, p. 628). Recitazion e p :,ia ono trenarneme !errate nel oncno
prorn1iulc delle rime di I ahclla Andreini ( vv. 9-14 ): E come uri teani or donna ed ora/ rnpp'.-e rntando
in vario stile/ quant volle iwrgnar Nnturu e t ,/ o la tella mia "li ndo an ora,/ di furrn11t1a ctn ud verd
pril1./ vrrgai ron vario til b n millr n1rt (cit. da L\ HL'\O 2001 p. 53 ).
130 L'episodio' tato tudiato dn 1tLA1'1 1985.
291
\ on p tendo can cllarl' !"eccezionale ialento dcl suo rimi Tiniorrito. la
intendr almeno imp lire h ia n-Iebrato tla u11 poeta di pari 'alo re. 11rgand alla
:;ua poca un autore d ano d lla :;ua art .
cnza u ir lal < ircolo " ncziano al quale afferisce la ' t<:" 1:>a Ycronira Franco.
il terna dcU.imitazionc d Jl'anima com limite!' pietra filo ofale della pittura i in-
contra n Ila orri:.pondrnza in wr i tra . lio \lagno. rsat1 iu tinau <' omcnico
y nier:H. In a ' nza di e lio. la . ola con:.olazi 11 d IJ"amico Or atto(' 1111 mirabile
ritratt dipintorn:"!, un mira lo di omiglianza r Ycrit. h rl' terl'hlw
e non amm ttendo h !"arti ta abbia aagiu11to anima e ' I ino al quadro:
\Ientrr eh in "trana c trm partr
\'ivi. e lio. da me lungi e
b n non ho qui e non quanto maffi o
n rimaginr tua dipinta in carte
in cui panni talor 'j, o mirart .
parlar la lin!rlla r mowr crli occhi il \i:.o
!ice incranno). e L'alma ho iJ1 paraJi o
tanto rocchio e 1 Je io m'appacra rarte.
.\ miracolo tal formar potea
l'indu 1rr man. cha talllopra accin:.r.
anima e pirto ancor 11011 le giungra.
Il mio buon Danan. quando ti pin r.
copr d l'artr ua la \rra idea
e nattua agguacrli. r pur non'
Dipi11<1rndo il ritratt cu Crlio. il pittor ha e p rto la wra cidea d1lla ua art .
cio' r .., nza a luta cl ffartf' d Il imma11ini nrlla ua forma perfrua. clw 'l(' lllhl'a
oincidrrr on il dono delranima al ritra110. La rapacit di eone dcre vita. parola
e m vimrnto a u11 imulacro (procluc ndo una orta cli automa o, appunto. di fan-
1:31 . 111la C'l'rd1i11 l'h<' ,i riu11in1 intorno a Oonwnil'O \eni1r(fr. l\ooi:o 197-t. Fuo\11\ 1991 r llo, 1'\11111.1CJ<J2.
pp. 89-102.
Indur ,one11i del \hwnn a Domf'11iC'o Ti111orrtto e a l rnnr<''<'o Brrnho (\11<;\0 1997. t(>() - 161 ) 1'111110n
drl ritrailo 1dl'111ilirahill' ron il falio di Jaropo Tinwr<llo. Do11wnico (efr. \I 11z 1 Rou. 1111 200 t ): 1H'llo -r11111
hio rii 'fJIH'lli 1011 Do111P11icn \111i1r (Cn 11'1" 1998 CL.\ \ -CL.\ \'I ). 1om i11 qur lln (' Oli \,n 111i o Pigna1tlli
(P1c,u1.u.1 I C)!J(J . \pp. Il. \\\Il-\ \.\lii ). 11011 ,i fauno 110111i. 111a 11 id111unir111< il rif1ri11111110 i allo 'Il'''"
ritrallo cl.i ('_lii ,i parla in C11 '11\I \\ 1998. 111-CL\ I\. C'OllH' nHJ>trauo I( rimr < l"iwipil rii CL.\\' (. l11ch "io.
mP11/re r11111ro ).
1:n (,11 '1"11' 1998. Cl.Xlii. l:rdizionr dw ra 10/!li( 11 rinH' drl Ciu,1i11i1111 r d!'I .\lagno fu pulililirnta 11rl
1600 .(\f'll('':ia \lthl'hio) . Il rifrrinH'mo al di11im pPtrarrlu,m 1111i rhrl1110 dallr 0Hi1 rinu in -ari!' <' in - i'n
1
dall r-1111 111111 dl'!di a1re11ni 1 dri pnlit\ i IP"i(ali. dw 1111go110 ri10111r,1ualina1i (ad (' purudi,o) ronu i
ro11n11i (ad t . r idf'a d(I,
1a:;rna) lihrra ]'ari r dalla . ua po:; izio11c ubordi nata alla nal ura. L artificio. a rPpl ica
lrl \1aan illu tra lr ragioni di una illu ion :
.'pc..,so pcr ti ' goder da 11w . i partr
lalma. O\ I' al rnrpo 01' ( 1 n11nin prCC'i..,O.
r qua11do al 111io ..,11nhiantr il guardo hai fi .-o
i\ i ..,j lorn <' .,ua 'irt 1 rnmpart .
Quinci io 11011 nwn rwl dolce inganno ho parte'.
111e111rr 11H' ..,corgrr 'iH> in lui d, a\ i.., o
,. lwnrhr lungi. a te ' iC"i110 a . .,i o.
pa.,ro il di giuno e 1 rnr ron.,olo in parn>.
o for ..r a11rn da lr r r rror ... i crea
pcrehr df'.,io. d1.og11' or di nr<' li s1ri11..,1.
dipinto a gli orrhi luoi rn"tl\,irn e bea.
rhr ancor a mi r i propria fin.,!'
amor 1 ua imago. m unqur li n-1
che lri prr 'rra ad ahbracnar llll .
Lapparente animazion del ritratt (dolce inaann : lTo_r ) _a.r hb rnta
al tra.,frrimento drll alma di Celio nelrop ra. f nom no he 1 '" nf1ca ogrn '" lta
che Or:;atto la fi , a int<'nhamrnte (il v. 3 coni I onde. p r immcn,ia. al v. 3 d Ha pro-
po. ta). \n hc colui clw f. ritratto gode e pari ci1 ad Jrillusion . aziando il liai11110
<lrlra .. rnza. pecularmcnte. con 4uruito l'anima attin
11
n J .,u \iaagi (' . '?-8). L
terzine :.uacreri.,rono una pirc1azione alt rnati\ a. e pi nnnzi nal . attribuendo il
mira(rnio animazionr al drsidrrio che Or atto ha <l Ila pr s nza di C li . Comr
la quartina mrtte\'H in parallelo J" peri IlZa dcl tu con quella d trio (io
non lllf'll ). co la ..,econda t rzina . piega il concetto pr o. ri!!uardo a rsat10. ai
' . 9-11 . fac udo rifrriment> a quanto Celi t o ha pr Yato: anch ai ..,uoi
(occhi tuoi [ ... ]/ [ ... ] miri ) ramo re - che corri ponci al d -i dl'I ,._ 1 O - ha frn-
to ov111u
1
ur l'imacro di Orsatto. ,\ un'impos..,ibil t oria dell'arte mc imitazione
'
perfrtta. fondat< liii principio intellettual r intrin o. i ontrappone co i una
pit1 ica f nomrnologia delr errore \i:,,iYo. che ri onduc re ito ahis. imo e ap-
pare11trmrnt in. 1 i1gahile delri1111nacrinr alrespcricnza di una ricezione
int n. ificata dal coin\'olainwnto dl'llo prttator . guc una proposta d1 DonH'lllCO
Veni r. eh riprr11cle lr trsse rime e akuni rimanti. part 'cipando con rlrO'anza a una
omrrsazione porti ca come ..,t' rn dm 'ano 'olcr r nel :.110 -alotto w1wziano:
nrh'io. 111r11trr ri111iro a parte a J>Hrll'
pinta r(ffgr lua ('Qlll u11ri fio.
13-t hi. CL.\I\' (l'fr. \I, .'\o J<J<J7. t81 ).
corger la ,irn imacrin propria avi o
, ben opmr lo , ti] epfH' in ritrarle:
pi m 'ammir a ai n 1 imicrliane.
che de gli occhi altrui 'inganna il vi so
h 1 fa" llar le ia tolto r i o
'in parlar l'udi i anco imitane.
E talor fu ch' io lei tac r credea
perch 'ocr lia a pru-Ja r n n la on trin e
non eh 1 poter parlar le i tocrliea.
tuoi te , i lor pi tiire
verament il penne] hi ti pincr a
e d'ocrn altr pittor la crloria e rin e
135
La ontinmta la condivi ion d lraraom nto ono e\id nti n Jr ordio ( n-
h'io) h rimanda inunediatam nte ad altri t ri ad altr peri nz tradotte in
ver i, n I onte to di un elo!!io a piu oci (com altri>). L int rpretazion d l enier
m tt racc nto u1 ilenzio d lrinllllagine. a ordando il nu l eo di Rif L \1Il u
rim di L X\ 11. p r approdar a uno Yolgim nto fati o parado al : il ta r di
un ritratto co omiali ant cau a pi meraviglia di quanta ne u iter bbc il fatto <li
udirlo prufare (cio' imitare eli anche nel parlar) . ina lar ' an h l' idea che
il iJ nzio po a clip nd r da una lta del ritrat1 non dalr a enza di una facolt
( n . 9-11 ). h ioni.fi h r bb rimp rf zion cl Il art . Ila r plica. il faan oali
il uga rim nto e lo viluppa attra er o il riferim nto a Piarnalione, appli ando un
moti o r tico in un onte to di ami izia:
n r e Martr
a oti altrui da trano amor conqui o
d' un corpo umano in dwo avorio inci o
le membra fur di novo pirto parte
perch mia pinta effigi . ond appagart
a pien non puoi mentr' l' cchio cleri o.
far i viva 11011 vedi ed irnprovi o
formar par 1 di tupor oLnarte?
Ch tando or qui lontan p r orte rea
ivi al valor. h'a te que l'alma avin
vicin ervir potrei qual cri . ol a.
1r hi. CL \ '.
294
Ma, e ' l merlo di mille .in t ri trin ,
miUe ru1 or ' lij il ciel fonnru dovea
p r l'aff ett acrguagliar che ' I or mi in
136
Lallu ione al mito (vv. 1-4) auida il pa agaio dall eloai pittorica
alla pr t ta per il u il nzio ( . . -8). l'immaITT.n p t e re pirar prula-
re. lj pur tando lontan (qui >) potr bb rvir i' ami O ( V >) Offi ol \'3.
Que to m ti o aura er o iJ rif rirn nto alla vi inanza fi i a. riech agia quello i
viluppato dal Magno n Ilari p ta al Giu tinian. ma la hiu a pi arauta: an h
e il iel ave e on o al ritratt di animar i . a\Tebb dovuto formar > mill
, lij > p r erua liar<' l"affett d I poeta p r ranli o un p r ci un dei mili
m riti ra hiu in I ni r.
11 ritratto dj un 1 ttcrato h fr quenta un alotto o un accademia oprattut10
uno ca ione di e rcizio po ti cli gru d'ina mo p r i uoi odali. ma. com ab-
biamo 'i t . pu m bilitar m rivi <l ila p ia d. amor . In particolar . la capacit
di e prim r gli aff tti ( peranza, d iderio. paura) tend a onfonder i con quella di
e prim r l anima tout court: 1 ffiai prend vita !ll'azie al de iderio di hi la guruda
grazie al oinvol!!i.m nto emoti o d 1 011a tto dipinto. Ri no iamo qui la traccia di
al uni topoi quattr nt chi. l aati all'impulso ad animar il ritratto n la propria
pa i 1L o ad affidargli om a una lettera d' amore, la manif tazion dei propri
s ntime11ri
137
Du ingolari on tti di Ca para tampa e a p rano qu t po ibilit.
alJ t nd una rappr ntazion i ibile d ll'int riorit ad us dei 1 tt ri- p ttat ri:
\'oi che ' n mam1i, in 1 ri , in bronzo. in cera
imitate vin et la natura
fonnando que ta quelraltra ficrura.
che poi omigli a la ua f rma ,era.
venite tutti in ITTazi:o. a , hiera
a formar la pi bella creatura,
che fa e e criamai la prima ura,
poi che n le u mru1 f la prin ra.
Ritraggele il rnio cont . a\ i a m nt
qual ' d ntro ritrar! , e qual fore;
eh a tanta opra n n manchi n:ient .
Fat gli lanwntc d ppi il
come v drete h'egli ha ramente
il uo 1 mi che cr.li ha donalo more.
136 lvi, .L \\'I (cfr. o 199 , 182).
137 'fr. s11prn, 2.52. 7.
Hitra2gete poi llll da l'altra parti'.
conu \C'drctc l'Ido in effetto:
5enza cor nel pr110
pt r miracol 11 \mor raro e llO\ art(':
naw !'he \ada ,,enza sartr.
timon. nza n'lt- l' trinch('ltO.
mirando al lume benecll'ttO
d(' la :.ua tramontana. onmque parte.
Ed a\ertite che ia 'I mio cmhiantr
da la parte ::.ini. tra aftlin e
e <la la Jc..,tra allegr e tr'ionfantr:
il mio ..,rato f elie rnol dir questo.
or che mi trorn il mio :ignor clcn ante:
quello. il timor che <laltra pr
In una finzione che ri cheagia il djtti l eu-archc co attrawr o memorie di Bembo
e D Ila Casa. wruamo fr nt aaiar i du mnanti uniti da tm amor non reciprorn. o
omunque 11 11 ped ttament ricambiato: un anomalo dittico n ." nu_zialf' . rh:
te la propria truttura d ppia n ila t sil1lra minutarncnt binaria dei 28 ven'. Daglt
arti-,ti che chiama a ra 'colta la p te a i atten I uii"imma!!ine completa. un ntratt
delr anima d l corpo (qual r dentro e qual ' f re). ma non :. ugaeri e concrrta-
ment omc tt n re qu to tutl tondo fi i e pirituale. ottintend ndo dH il mondo
int rior dO\T tr parir nella ernbianza. Ci sorprende. p r contr . con un .impron-i. a
riv lazion di i he ' fi i am ntc imi ibilf': l"itll mo cl l pett . dove r a do\'r
rappr entarr clu cuori. p rch' 'oliali.in po . ie I an 'h qucll di ,a: para. E w1 dato
dj fatto. dj tu i ott lin a la,. rit o tanzial (com wd t : romr wclrete) eh
i oppon con tutta la ua evidenza motiva alla natura p'trado sali' r aut i11at mali. tira
d ffironoITTafia: la raffiuurazione doppia cli un pa11icolarr imi. ihile (perchr nascosto
nel petto). h rove eiailfwtod !cuor narratodaPetrnrcainRLf/Xlll (' . 72-7:))
1
:
1
<J.
Que ta celta icono!!rafira annuncia la clef rmazion lett raria dcl ritratto clic si accen-
tua n I econclo on tto. Il doppio cuore trova il . uo r iJ r con l p tt vuoto della poc-
tc . a. c ndjzion h la r nd I tleralme11te imilr a un ritratto: in olucr senza anima.
rhC' . Pmbra ,;,.o. enza vita.\ n olo. il uo rnlto clow apparir cli,iso. eia u11 lato triste
dalr altr !!i io o. 011 clue espre ioni eh la 011cla trrzina drci fra nrlla loro fi . it di
1 :33 . 1111r1 191 :i. I.\ -1.\ I. dw ('ito per arroglif'mlo gli interwmi di .'t fn110 Bianf'lii in Poete.m rfi.I C'inq11ece11to.
PI' I :39-1-+0. " ri111 iundo ullt 111ir annota1io11i in Bo1.10'1 2008. pp. 99-10:3.
1:31) I .a rl'la1i1a i11fi,io11t 1111 Petrcmha rrdirirns (Pudma. Paol!J Framhoui. 163.")) di Cinrn1110 1-ilippo To111a,i11i
1110,lla Laura 1wlr allo di tt111rf' ron !:1 >inistra il polo 1l1s1 rodi Fram(,<o 1 di pnndrrl(li il < uon dal pr11u. L;if.
lu,trnzimw i ripro1lo1ta in \le L1Lc111.1' t l\\IZZA p. 199.
_96
( \'llOI dir). 111 qu<' to rnmpimrnto di111idiato <'anamorfico culmina la co. trttzio-
n;di una figura rii!' parte da mod11li ,i-.ihili rcali (i l ritratto doppio<' il clittiro di po. i)
per giungere. cmi !"ausilio di mctaforf' r topoi pn'hi alla l t1cra. a 1u1 esi10 impos. ibil .
di iperr!'ali mo p:-.icologico. di 'i-.11alizzazio11r (k:li aff tti nello . pazio (la condizio11e
fantas111atica e rnC'lmnorfira di chi e inrnunorato). La onclu ione implicita in que ta
in\'CHZiOll mnorosa r clw 11011 r pO!> i IJj le rappre mt are la \'i lH i11trriorc C'OD i lllC'ZZ ('Ofl-
. ueti cl Ila pittura: per introdurre le \cr11d1 dell'anima 1wlrinuna11ine n ihilf' ' nc-
er::Mrio ...cm1an o -,uperan la'< ro'>inuglianza. nwttcrc' in cri i le e I1czz della 'i ion .
Il l'anta. del volto di Ca'ipara !cerato a due pa .. ioni. la 11i ia
t' la paura. '>lati ('llloti,i riferiti ri .prtti,amcnte al prc ent e al futuro egnati la
C'Onnotalioni oppo. te. Lo ..,bilanciamento drllo :-.rl1crna quadripartito dellr pa ioni
un pre eutr f< licr attnnc1 .. ato dal timore per un futuro in idiato da una po :i-
bile ri,alr. ::ii ria..,-,r:-.ta. sul la linl'a cl I tempo. in un madriaal di Enea Hirpino:
Chi h<11 ro111 111pla in 111<' <1uamlo la prnw
\rha fuor del pe1to la paura "pinta.
\"it a gioi'o ... a ndevi dipinta:
Quando.I timor alla p<'ranza
Ch.int<'lllO allltor 111i mira.
Gioia duhhio ... a \ ('{lrmi 11C'l ,iso.
Et quando hor I' 11110. !t or l'altro . c<nde. rt :-al,
Chi gl'occl1i ,pr mr gira
Ritro\a lllC da lii<' lll('ZZO di,i o:
.\Ja chi mi ne l'a f)<'tlO fi.,o.
Quando la dal timor r \ inta
\1orte mi wde ...ol nr gl'occhi finta
1
"
0
.
' ul rnlto d J poC'la-amantC' i dipinao110. clalritlt mo. I ombr di tma p icomachin
in quattro t mpi tra la 'P<'ranza <'la pama. eh i contendono l'anima ome un t ni-
torio: la perauza e tronwt te la pama dal I tto: le due pa. :.i ni e miYon in parit
i altrrnirno vcrtigino mrn11te: il timor sronfigg la spf'ranza. Il madri ale or fow fan-
dam 11to cicHco dello ' (' mtro c me su un quadra11t<'. ma le ;,ue fa i non ::.i u cd n
in una r4uet1Za fis a <'po..,:, no mf'r dmatr nu-iahili. A ia;.cuna l Ile nnbinazi nj
intern corri, 1 01Hle. all"!':-1< rno. 1111a cliY ca masch ra m tiva. atleO'!!iata a tma forma
di aioia o ili di perazi IH'. La mute voi tl nnentata ,ita int riore del! ammlt i mani-
fo ta com un\'olto rac 11110:.toorarumiliat ( m qu Ilo di a para tampa)1-1
1
.
dovt' all ' r tremo ddla aioia vitak si C ntrnppo11 r ffillUlllattH'LltO 'h oit1cide COll la
1-10 11111111\o 1 S20. t'. 211'.
I t.t
1
9 rit h g"ia Hif 'C,\Cll. ' :3. \tI n111zonit'rt' dtlrl I irpino efr. n11rlw il ::onrtt l 11 timor ctrto. et 1111a
'ubbt<i (I l11tPl\O I :>20. tT. I 91-20r). , ' 111 rapp rto ira scriu 11ra. , olto (' nffrtti dr. i ,3,,gi rnreolti in Po:-.'TRE
llOll 200.1 r \1 ml.Hl OTII 200().
2
m rtr. ll tea:o d il pa ioni ha bi gno di un prttator , pu' formular i lo attra-
'" -
0
lari l ta di tm !!uard ( hi ben ntempJa:o; h'intent ( ... ] mi mira>
,hj al" C l yer rn aira; ) Tl auarda>) ' ffi Il ff anam rfo i, Il aDO h
ro rvat re i po ti n ilo pazio p r veder l'imrna!rin n lla ua f01ma rr tta: tanlo
il v lto (in Hirpin ) q1mnto il uo doppio, rit:ratt (n lla tampa) , i offr no ome u-
p rficie da de ifrar , apparenza d f nnata h .un nt nuto non vi ..
inaolrum nte \' ina al i lo m tamorf h i di m1a ul volto il llirpmo
la p ]i -ernia alternata he 1 in1pr ' ri ator B rnardo lti dando la pru la alla
du he a Eli ab tta onzaaa, attiibui ce al ai i ilo in forma di da 1 i indo ato:
Per !mo del mio amor n I fronte p rto
un . qual dinota o!m.i mio rato.
eco varia il uo ignifi ato
come rnrio iJ martir. come il onforto.
Quando on poi fra 1 danno la alut .
o petto m tra al mi viv r inderoo.
oluto tr tto e ciolto in ervituteH
2
.
Qui un e emo> indo ato a um igni6 ati diver i mpr imp r rutabili per
lo p ttator . a e onda dello tato d' animo d Ila duch a innamorata ondizioni
di pirit o pe e tra il tormento (martin) la on olazion ( confort ) det rmi-
nat da mutamenti t rni (un tradirn nto una p ranza). La rittura in persona di
( fr. .' 2.2-2.3). eh p rmett di far parlar li abetta in prin1a per ona a e ntua
il aratt r di ogg tto lirico del gioi ilo. eh , om un i rnografo dell anim r ai tra
e tradu e in ruiazioru di irnilcato le o cillazioni emoti ,: liri o p r h' I.a poe ia
d. am r ' il codice di que ta e pr ione i] manual di rif rimcnto p r d cifrrula,
p r h' la ' una l ttera d ll'alfabeto l'iniziale di un I n p t nzialm nte
infinit di parole. P r que to e la parola torna al po ta-amant , lo t o gn
puo enir interpr tato ome manif tazione a lui ri olta, d ila bene ol nza od IJa
H2 li 1r (. in di che haveua in fronte la , ig. ra Duchessa d rbino) ' edito, con
reue. IO d 1 man -nm r vananu m nota, 1n Morr 2004, p. 452. La zion d I m . Ro iano 680 eh compm1cl
lr rime 1l1ll'Accolti (la zione per Elisab lllJ ' ai ff. 93u-98u e 109r-v) tata tudiata da M s Acc111 1996.
298
rud lt d Ila duche: a nei uoi co11f ronti:
'on enti, o mar di bellrzza 'irtute.
eh io, srno tuo ia cl' un gran dubbio . ciolto,
se lo ' che porti nel candido volto
. ignifica mio trnto o mia salute.
<limo tra ccor o o s rvitute.
bOspetto o curt. rcrcto o tolto.
sp mc o trido, e al o o .,epolto.
se le at ne mir .,tr tte o olutr.
li ' io tempo fort che 0011 mo. tri C"llO
de uperbia, o pir, evrritatr,
slratio, angue, udor, uplici e de11no.
e loco ha la pura 'eritatr.
qur to dirno tra con non poco in11e!!Tlo
un ol olo in bellezza e ' 11 rrudeltat ?"
3
.
Cimpr ndibile p li mia d l . m1 > m qu o deriva dalrin rt zza delrin-
terpr tazi n , guidata dai timori e dalle peranz delramrulte. h ontrapponaono
una erj di antite i ( . 4-8) agli cl nchi ornogen i propo ti dalla ducbe a. ambia
il punto cli vi ta, dal mittent al d tinatario d l m aaaio. ma in en:runbi i onetti
la e > la m diazion attraver o la quale i omuni ano alr t mo i entim nti e lati
dietro i] olto. ignifi ativam nt il aioi ilo vi n indo ato lilla front >. i ' nell
pazio eh tanti po ti leag no e m p ibile h rmo o paJ ni o d li a ioni:
in qu ta ede non neutra, il p ndent o titui e , on la ua immota ambi!!U.it. I
e. pre ioni he muo 0110 t:rasfiaurano i tratti di altri an1fil1ti. L.ipot i eh la >
fo un p nd nte donato alla du h a dal uo ammirator 'a tialion . in i me alla
to1ia dei ,on tti del I ccchio au h'e a Jeaata alla mi i ne londin d l 1 O ,
ug
11
erir bbe la po ibilit di id ntificar il d tinatario d l m ag!!io ifrato proprio
nell'autor d l ortegiano. In a nza di pr rt non t111 , a rif i non a e n-
dar que ta ri o truzione p r h' la mplic mbinazion cl i uoi I m nti ci im-
mett i11 un cortocir uito di p r ' affa, cinant : il aioi llo. il ritratt dipinto da Raffael-
lo il ori criano. le impr vvi azi ni cieli ' olti i onet1i d I p eh.io appartenaono
a una te a ultura d 11 fi!!ur ed Il impr d v le m taf r i topoi d Ila po ia
d'amor tr fil10 una vita mat rial n ali a tti (I p hi il 1inatto. il aioi Ilo) il
con.fin tra e rpo anima me cp1ell tra inunagini . pruol , i fa in rt i rid fini-
rn a.nt ment in tma ompl a dial tti a di -ibizi n na ondim nto.
H3 fr. 2004, pp. 4 .. 1--+ 4, che !'!mala un he un al1ro orwtto , ul gi icll latina la IC'llera che porti).
_99
-t. -t Le parole come coce e come anima
li pe.,o chr i porti attribui cono alla ricezione. agli effetti delle opere ul ogartto.
d n\trione alle, olidr argom 'Illazioni di 'hearman till"arl<' rina cimcutalc 0111r
grandr arte tran.itirn. a1 erta e ll"interazione con lo Iettatore, espre sa nrlla . ua
forma pi1 eplicita dal ritratto frontale. l'hapiro ha paracronato lo ::,rarto trn la I o. n
r ntalc qudla di profilo a qu<'llo tra la narrazione in prima p r ona <' quella in
trrza
1
H: un rafticrurato frontalm nte i ri\'olge allo pettat r in modo di-
rctt . com in un pitaffio al riandante o in un 'i Trizi ne ul pi di tali di liii bu to
colpito. Darnnti alla Dama col 111a::;::;o/i110 ( H?:- -1-80. Firenze. \lu eo azionale
d l Bargello) di _\_ndrea del \' rr chio. pre nza 'fra e mobil<' . potremmo qua i
immaginarla sul punto di premi re la parola attraver::.o uno deali epigrammi latini
compo ti nella cer hia laurenziana: del re to. in anni non lontani . crli t .. i lrtterati
. perim<'ntarnno que to u. o rille. ::,o d Ila scrittura in prima per:.ona dando \'Ocr.
in pitaffi. ad .\lbiera cl gli _\Jbizzi. la fortunata ui vanr amata da ,' icri.,mornlo
cl lla .'tufaH:;_ .\i piedi di un epitaffio dc ,.e il cl funto Cecehin Bracci prendi' la
parola (r fui de Bracci ... ) 1 am1ota: oct la l<' ta. che parli Hh_
In molti ritratti rina imentali il oag tto i di po11 alra .... colto <'a una conversa-
zione> con r o lTator<'. L imuizione di ' heannan particolarmente COI!\ incrntr
nel ca o dei ritratti di arniciH
7
. che rano ffettiYarnenl<' oacrctto di uno . cambio
ammirato n . o. p ano di affetto e di memoria: le dficri itn-iate r riccnrt
potenino re c lebrat in ver. i accompagnate da , emetti con la funzione di
I tt r o biali tti.
\nch in poc ia i trorn tTac'ia cli qur t pratiche d Ila rirnluzione comunica-
tiYa rappre ntata dal grande ritratto cinqu cent<' . co. L umani -1a .lanu. Pannoniu .
in procint di tornar nella natia Cnah ria ( J-t:-8). dedica un carm latin e liii
doppio ritrau dipinto da :\fant gna. rh lo rafficrura eo11 ramie Galeotto \Jarzio
da .\arui1-1
8
. \ l 1516. alla ,jcrilia della part nza di ndrea \'avacrero da Roma. Raf-
faello lo ritrae in i In<' alramico <' c Ileo-a 1\a tino B aziano: lr du fiaure onori-
\Olt wr. o chi guarda. probabilmente a famr di 11110 p ttatore <lcrcczione. Pi tro
.. comun_e al qual<' !"opera rra dr. !inala. I fortunato tipo clrl ritratto
d1 a1111c1 i po :ono nc-ondwTr anch il ritrallo Ludocisi ( 1'." 02 ca .. R ma. Palazzo
Y n zia) attriJ uito a ioraione r il Doppio ritralfo di Pontormo d Ila Coll<zio11r Ciui
(1.-22-2-t ca .. V nezia (i li. 20]). Il ca ci iTlt re sa prn1t11tto quando i . oggetti
1 H . 11 \PIRO 1992. p. --1:;.
H.) Cfr. J,,rn 1970.
1-+6 Bi o ..... 11rno11 19'18. 219. 1101< u p. J+:;.
1-+7 Cfr LOJURH\ 200:3. p. 139.
1-+8 li rarmc- ,j l1gw in l\.R0.,11. P\HR011 t<J79. PI' :12:i-32:>.
:300
coirl\'olli 0110 dri lettrrati. <'in particolare dei poeti chr i dimo trano en ibili al
ritrailo 1 ro11 ap 'oli drllf' su funzioni. drllf' uc po .. ihilit dei uoi limiti. I n al
di l di 1111a frpqurntaziorw epi odica del tema. :'\ayaaero . <ri. . 1111 epiararnma ul
proprio ritratto inviato alramata. il fecr del ritratto cdi parole l'i pirazi -
nr principale d<lla propria po -.ia d encomio. Bemho cri .... r ul ritratto dcli" amata
1
affid la propria inunagi11<' alla pitturai-I". Abbiamo gi avnto modo di ricono r
una ,<ra o. sr..,. ion prr il critrarrr > come trma portico in un altro protaa ni ta di
quri giorni ro111a11i. \ntonio TehaldPo. a ua volta effiaiato da Raffa Ilo (1:-16). che
ri11grazw in un so11rt10
1
"
10
\ una fa.,<' prrcedente appartiene un uo componimento
che .,i pn erlta 1..,plicitam nte eomr im iato in if'mr a un-immaain
Dapoi rhe la mia ortr ad\'l'rsa r dura
non \OI rhe tero cum il rnrpo io ..,tia.
maudoti . Ti111otl1eo. JAfigi< mia .
u qurlla dir m.i f1; atura.
\fa 1wrrh rosa muta la pirtura.
mi 011 sforzato trovar modo e 'ia
cli far che al' ero pit1 propinqua ia.
agiong111do la 'ocr a la figura :
alligato ho cun1 lri certi fnwmr111 i
rhe prr fla,ia gi . cri .... sospirando.
ari liii' n<li r rhe pmfar me -cuti .
. ' che di que..,to don dw hora ti mando
prego. Timotlwo mio. l 11 1t COIH<'IJI
.,in ch"o ritorno a te. che 11011 .,rio q11m1do
1
:;
1
Poid1r la lontananza. d<' tinata a durnr<' per 1111 tempo imprrcisato. ali impedi
di star<' 'i<'in ali" amico 1 imoteo (B111clrdri ) on la pre. euza fi ira ( cmn il e rp ).
il po ta <rii im ia la propria cefligie colli' so tituto: un 'immaainr somial iante. ma
per nndrrla anC'ora pi'1 \'era deC'id li farla parlar '. 11aturalml'11le in wn.i: co,
('ert(' rimt' r amor rittr per l la\ ia. ali< gat alla figura muta. 11 dfrc11tano la
vocr. Il sonetto mett<' i11 relazion una cri di, r i (certi frncrrn nti con 1111
1-19 _Per l"q1igrn11111w di \an1gero (I.usus [ \\ \CLRO I :;:lO]. ,\.\ \ 111 ) rim io u BOLLO'\ I 2008. PP I :li-n:l. di
lkaz11111n 1 llr111ho 111i '0110 l{i ool'fl'rntala ili prrcrclr11n1 (cfr. ;l.6.:l r 2.1 ).
1:)0 l-.s1111to 1989- 19<J1. 111/1. -+:>8. Il pm111 f1rrurr,1 fu H'ni-i111il111m1t' ri1rn110 ancht dal pi11on l' inci-on
11
-rone,1 C1rol11mo \londrlla. al qualr ,,0110 ril'olti i ,011wi h t' Hb r 1111 rnrn11 In tino (f liero11y1110 pictori. in
PISQL IZI 1%6. p. LI\).
l'.il 'lu11oro ICJ89-tlJ92, ll/1.11Cl.damra111101moi11Ro1.1o';i:2008.pp.1-+:2H-.
1
:)2 Pl'r In dPti11i?io1w delle ri1111 t'Olll1' cfrng111t'11li dr. Co\180\I 200:3 (p. ::l). rhr tm tt,10 di .\ntonio
Corna1.u110 dow il ltn11i11r co111parl' proprio q111111do il porta, ri,olgr11tki,;i 11 u11 ctr10 Teodoro. t,plidrn rimcnzio1w
01
ritratt . ma -i pon o te o impli itamcnt , in r lazi n con w1 altr ritratto.
r effigie doppia formala da qu i ,. r i da quell'immacrin ' in qu lo m do ad -
n pi nam nt alla pr pria naturn di l tt ra di bran di un cartecrcrio po
Lo cambio pi tolarr la corri pondenza in vcr i ono f orm di onv r azion
a tli tanza h po n ont nd re al kecp akc portrait il primato 11 li' fficacia
-o titutfra. Xelle Rime di Annibal ua col lctter ri ernt dalramata dfr ntano il
ritratt pi prezio o di colei h 1 ha ritt . p r h n primono la Y rit profon-
da, eh r ta preclu a all inunacrini t:;
4
: meno b ati d 1 p ta ono ali amanti eh
o tentan le immacrini d ile amate ome tr f i, m n b ato ' Pi malione. la cui
f licit dipende dalla b nernlenza di \ nere. m n b at ar bb tato ali t o e
aye ott nuto un f6crie dipinta non una I tt ra i.5.'>.
La a rar hia tra ritratti ritti e ritratti dipinti di c nd da quella tra anima
orpo. cio' dall'ecc li nza dei r lati vi oggetti imitati. Il iudizio di val or implicito
in que ta po izion ' omoaen o a qu ilo eh ontrappon la cultura alla pittura il
ritratto n I cuore al ritratto materia] . chierati ri p ttivam nt con r er e n
il parer t
56
- con r nte polarizzazione d Il m tafor n i t ti, he t ndono ad
a o ia:r i firuranti pla tici all'immagine m ntale. La po ia ta dalla part della
cultura perch ta dalla part d u anima. d li e enza n n della rza. come
dimo trano 1 olid architettur di parole alle tit dai 1 tt rati tra Quattr inque-
cento: p r dirla con tm p ta h ha fr quentato qu ti antieri celebrativi: Comr
han dal i lo i corpi d natura/ r alma, u da gli po ti anti/ quei de metal di mar-
mo d pi tura ts
7
, Partecipando alla di puta animata da ar hi, Ben enu to ellini
crive eh da pittura non altr eh o albero o u mo o altra o a che i p chi in un
fonte t
53
valutando il mito alb rtiano di . ar i o in entor d ila pittura ed il ruolo
ordinare I proprie liricb : B Ul\i per virt vo. rre r mr>so/ fra dolri appa ionati miri fragm oti/ eh
d una Angiola ,;,.a ordino ad . l>O o 1997. XLI. n . 9-11 ).
1 ;-3 U dei con il onetto La mia, 11011 la tua sorte;. at'l'ersa e dura, riportato in P. QL z1 1966, pp.
XLfll-XLI\. Per il tema d Ua rappr entaziou delranima nel ritratto nella rittura cfr. anch la rorri ponden
za tra Era mo e Pieter Cilli. u cui rifleue, 11\trIT 2006.
15-t Ct' co 1581, V-L' ' 1111. ben quaranta onetti cbe ccl brano le lettere imi111r alla donna e da lei rice-
.,.".1te. la (ivi. P 10) 1:au1ore aveva mandato calcune u lrtterc e rim p r un er)
a una dol.endo.1 con lei cl Ila ,ua ab nza; ed era gi iato molti giorni on urandi:,sin10
drs1d no a I ntorno dr o Ebr o. J)('r aver lert r da lei. in ri po ta drlle b11e; le quali ndo lnal-
' 'enute. gli il cuore di mi. urata dolcezza, r gli r corono infini1a mara iglia e 1upore ( .. . ] ..
onrtto LXI (IVI. p. 4.3) 1 d. Ile I tterr come di immagini: cln quest fai ima!rini, eh vere/ ( 'io non
nt to .LO h.an da mo. tran,1./ un allr1rrezza misurata tro,o:/ e col piac!'r hirnaginando provoj di doppiar
cerro I \WJ mio piacere:/ w diletto infinito pu doppiar-i(' . 9-li).
hi._ LI (Altri talor ne porta al rollo appeso). XLJI (ILfamoso scultor di C'pro vago) XL (Gi desi'a.i d'ater
ntralle 111 carte). ' '
1-6 "Ila toria del P.aragone tra pillura e cultura qucs1a oppo. izione adomhrata in Alberti e i11 Leonardo,
molto fonc nrl Cortegtano e rfe,tinaui a ri mrrgcr nella cli puta varch.iana ( fr. OIJ..ARETA 1988, p. 573).
1'." Tmtnt0 1989-1992. 11/1. 229. vv. 12-14.
138 La l111rra di Cellini .i legI' in appendici a ARCllJ 1960, p. 81.
302
e cmplar eh L onard atnibui. e allo p hi
159
. iamo fuori da qu Il quilibrio
ccell nt rappr nlat dal odalizi Ar tino- iziano, un vi
11
ro o ntauro di po
ia pittura h co ri heacria n l Dialogo di amore (1542) di p roni:
Lo Aretino non 1itra11ue le co men bene in paro! he Tiziano in colori ; e ho vedulo
d ' uoi on lti fatti da lui d'alcuni ritratti di Tiziano non facil il giudicar
li onetti on nati dalli ritratti o li ritratti da loro: e rt ambidui in ieme. cio il
onetto e il rit rallo, on o a perf tta: qu to d vo e al ritratto, queUo all'incontro
di carn d'o a te il on tto
160
.
Aff rm ta rimpo ibilit di t ilir al di l d l m ro dato material . la pr
denza r n 1 erica e di i pirazion tra i ritratti i on tti, n l dialocro Tullia d. agona
ottolinea la p rfezion h e i comp ngono in i m . Int razione re iproca non
a()'oni ti a, inolo enza difetto di oc corp ritratto parlant parola rive tita di
carn ed o a. con formula vi ina al v r o final di un on tto ar tiniano in lod di
Tizian : c\1a p rch' il m to ' n l mplo finto./ Dir pu i ' atura. h n 1 art il
miri./ "Lo pirto t\ in lui do a cam cinto .
161
La i urezza on u:i la po ia i attribui ce il ompito di dar vo ali immaITTn:i
d riva da una pr m a important : la parola ' p r cell nza il mezzo attraver o cui
ranima i prim ' la rn diazion pi pecif a d ff int ri rit emoti a con ttua-
le dalrintrmo ali" t mo. La compr nza di o e e int Il tto>, dir bb Giovan
Batti ta Cclii ' i eh ontraddi tingu gli u rruni dagli altri animali la prima
prime con tti e pen i ri d 1 on o. P r qu to non ' ra luzion di ontinu-
it tra la Tittura poeti a la rifl ion teori a di uno d i pr t cronisti d 1 paragone
tra le arti: B nedetto Var hi l'animai r di qu Ilo traordinario p' odio di onfronto
tra arti ti e letterati rappr entato dal1a di puta della maggioranza delle arti {edita
com ec n a d li Due lezzioni soira la pittura e la scultura, Fi:r nz , rr ntino.
1549). ' na di cu i n ul primat tra pittura ultura h i chiud in parit, ma
anche - d ' qu to ra p tt e ntr n 1 no t:ro di cor o - una trattazion di arcro-
mento arti tico onc pita pronun iata in un conte to fondam ntalm nt 1 tterari
(nel 1 47 da anti all adcmia G r ntina) eh ulmina pr prio nel onfronto tra
poeti pitt ri
162
. Molti armi latini di ar hi i rif ri ono ad o d art
163
tra
159 OLl.ARETA 1988. p. 573.
1?0 PERO\! 19 5, pp. 54 -5-!8. 1nal "8 parit i rii van Lia citata I zi ne d1 iornn Baui ta Celti dedica
81
netti 'ul ri1rarto di Laura: Ond qw.' "li . on chiamati aaliori e pi e ell nti p ti i qua.li .anno m ofio
rappr entar con le parol negli animi no tri tutto quello he v gliono; e quegli i mialiori pi p rti pittori. eh
>anno meglio rnpprr entnr coi olori dinanzi ai nostri occl qu I che de iderono (LP p. 229).
161 LA, VI, 312, p. 287. t'I onetto allegato alla l<'tt cra, dl'I nov mbrc 1553 (!ri1 ci1ata supra, t; 3.6.2) .i leaae
811
he che[ ... ] Ti1iano/ Il cn od I o e ha 11el p nncllo (\ . 3-4).
l62 Tra i nobili precedenti rh giu 1ificavan in de I n raria. una di puca ul paraaone tra pittura e cultura.
OLI Rf.TA 2007 (p. 17 ) ricorda il De remediis di Petrarca, il ortegiano, le del 1 lza.
l63 I te ti i lrgono il1 R 111 19 )9.
03
,ollarrta ha rimarca10 la tra quelli intitolati ' uh iniacrinr
[ alicuiu:] <' qu Ili In ffgiem [ alicuiu ] o Dr ( aliquo] picto o cfo to: <rii i
presrntano rmnr epigrafi. nrlla forma d tre pi!ITanrnw cli qual
ver i.
comr se dows cro effctti,m1unte accompagnare un"immao-iuc ( ' uh ... )
1
M: nli altri
on '1 terza p r ona. e lcbrati'i e. mrno . o. decrit1i\ i. ,\11retta11t
' eh i prni non mrnzionino !"autore drll"oprra. ther amrnte dai secondi: In tipica
proporzione Ul\' r a eh<' tende a . tabiliri tra !"importanza. ru1 he retorica. confrrita
alrop ra e il rili vo dato _\.I rcond tipo i alJinrano. pn ,. clihilnwnt . .,li
urnm r Yoli onrtti in rnlaare h 'arhi ri\ l
1
1r ad arti ti
11
':;: tra <rii altri.
hclm1gel . Pontormo. L onc L oni. \I !te drll pi!rra6- pitafli dc Ila racc lta lati-
i rif ii -e no proprio a tiffatli: non nza lllerrs' e allora onf'r rJUff qu ti testi
di ac ompaanamento. non l11porta ' C .fittizi o n'ali. con r ito dC'lla Terza e ulli111a
di.spu_ta Ila e onda l zi ne. donnata dall"ut pictura. Quj i leacrr che i
1
orti imi-
il di n_iro principaLnem . cio i onc tti r I pa i ni d li" animo e i pittori
llllltano pnncrpalment il di fuori. cio' i corpi e lr fatt zze di tutt Il' e r 1t.1'. Laddove
I ani d l di e!m ha11110 ome 0
1
rcretto d Ila propria m:i . i ne mim tica re trriorit
.. le :Uti d par la ?rurno l"int rn . che corri ponci ai concetti (prn i ri.
1 piraz1 !11 e imma!rull concep1t n la mrnte) alle cpa i011i> delr animo. un oaartto
JU mt il ttuale d motfro. econdo qu Ila e n rzi nr fica <l Ila po . ia cara
ali Accademia fiorentina.
to_ i alcuni d i I i cel bri ritratti dipinti da un iilferlo u-
tor di \ar hi. 11 po ta-p1t1orr .\gnolo di ' imo detto il Bronzino
111
-. Alcune effiai
raffi urano per onacrgi appruteoenti alla cerchia drl lettrrato fiorenti110. eh ne fu ii
(' 110!.l i] Yero ' proprio e mmitt nte. I iitratti cli Lorf'llZ L n-
Zl -1. a trll forzr.'c ) e di L aolino lii ( i.-36-1 ;)3. ca.,
Berlino. taathche en) ontencron i Triziolli ,.i ibili a occhio m1do. che drYono
ere I tte p r comprenclere di I
. , . p1r11amrnt 1 p111t1 ai <prn i a1 par1 naon - hanllo
c1oe una fm1z1 n imi] a quella cl li t1 1 I b l. J
17
a 11 )Ut1 e e r1 ' IJll 1 u cerso o sul recto di
Lma ta,ola. ul libro che il Lenzi. crioranr ami e protetto cl I Yar hi. t ir11r ap rto
con la mano d stra i leO'aono d11 o (
0
1 1> ( . r .
t'l n t 1. uno e 1 r1rarca con n nm nto laura110
al nome. d I Lorenzo) e uno dello 1e so ami r maei;tro168. rl quadro
h raffiaura d aio an uman t \f 11 1 l:L
o
1
a ai<' J 1 wJro co titllJ rr una . orta di ritratto
16-+ \ prop<hitn dt"
1
li L1ogia rlP,,li uomini 11" arme ihl I" I e - ,
,./orriumnn11pipn1Nluto1lal d 11" I . IH I0\1onel l.J.J1 . ma \Jafft'10' !'l"\achec )rlll
formula Rllb effivip ,<.,,
11
1
l" dil
10
nomcl r .
0
hriai(o\lal nornmauio. comr nel 1olunw drrlicato ai lt'ttrru1i. ma dall11
_ "'" " u ' 1 111r a gi-111u10 1H1:1 :WOt. P 2:16).
16.> Pcr 11110 tudio 011i. 'onrlli ( 1;)33) di \art'lri rim' , T .,
00
, , . . .
d in Cor I 2007 d . ' '" r . IO d . \_\'TI'lll - i e a C111000 200 . l Il 1)111111 d1>glt anhll
166
\i ,
11
para ona
111 1
<mc dei onr1t1 a una 01111 rii e pi>tolario 11r1i,1i('O> (p. 176).
7 1960. p. ,JoJ. 1 er "" co111m nto a 'JllP tO p!lh.,O ifr. B111occ;111 1998. p.; i.
16 . Cfr. 1 (.\/ lOTT\ I 998 t 1\111.. I Il 2000.
168 crr. Bnoct.. 2002. DOGLIO 2006. pp .. )?-.)8 (' \l.o\<OI I 2007.
cintell<'ttualc drl sog"<' I to. 101 n<' in molti ritratti con I ihro . cJow la pr Pnza di un
,olumr ap<rto o chi11 o o di un pelmrc/1i110 allude allo status d 1 p r:onaaaio. rollo
lettore
0
dilrttante di poe..,ia. wdioso o lrtwrat o
1
"" fn alcuni i qut to tipo ritrat-
tisiiro i sovrappoue a q11Pllo studiato <la ,\lmi.arnH' Koos, in quanto il libro indica la
,ia d"arrr :.o all"iuteriorit cl l . ogg<'rto effigiato. Co ac adr in un altro capolaYoro
cli Bronzillo. il mi-.trrio. o <' g<'lido ritratto di Laura Battifrrri (1:)60 ca .. Firenzr.
Palazzo \'re hio ). p<'r il quale> cli.,poniamo dr Ila ddla donna ritratta,
clrl pittorr cli altri lrtt<1ati. che ci m trano dal 'i' o come ' imili ritle ioni ian
impliratr nPll'origirIC' nella ricezione' di q11e. tr immacrini. Gli critti della po t a
urbinate. 1;p a iu rrondr nozze clelJo cu I tor architrtto fiorentin Bart lom o
\mmannati . nacqurro a contatto con accad mir 1 tterari come qu Lia deO'li A or-
diti di l rliino r dccrli l11tro11ati cli 'i na. naturalmente> con l' ccadernia fi r nti-
na. e furono raccolti. 11w11torr lo . t s o \ 'archi. n I Primo libro delle operP toscane
(Firenze. Giunti. 1;)60). Consacratr all"e11r >mio lcI duca Co m1 cl . dici d Ila
ronsortr Eleonora di Tolrdo. qu 't rim o ... pitano un buon numero li on tti di cor-
ri. pondrnza con lcttrrati <darti. ti. tra i quali il La ca e il \'archi. B nYenuto .ellini
e Bro11zino
1
:
0
fl tc:ito Ile la Battif erri dedica al pr prio ritratto non ' c mpr nella
raccolta data ali -.tampe ( e condo al uni perch. rnm il dipinto. ar bb da rif rir
ad una data di poco ' uccc :iiYa alr u cita clrl Primo libro) i Ieaa inYect>. in iem
alla replica dr! pittore. nrl mano critto eh raccocrli l rim del Br nzino
1
"'
1
:
111'1 mito ril11r<'lllt' ('vago
la pa. lorrlla lua. chiaro CRI , EHO,
quanto brama il tuo cor ca. to e
ci mo ... 1 ri aprrto. <' ... ii rn11t111to r pago.
comr la propria mia no,ella imacro.
della tua dotta 111a11 la\ oro altero.
ogni 111io affet10 ogni
quantunque il rnr ... ia di relnrlo rngo.
E ('OS r urbon-1. eh ' ami rntanto.
deano rin1l r1 \pollo. in fino al ciclo
rnlto da tr. mai wnle , errru.
l6CJ _i:o:,1rvn1io1w '"I ritrailo di l guliuo \Janrlli ,j d1n a :RoPPr R l<l8.1. I riinrni con liliro .,ono al 'entro ddlo
'Indio d1 \hc.ou 200 . ma .. rr. u1l!'h1' 11:.or
170 I 11 ti i- i I O'>ono ligger(' . in !'dizi one 1110 l1rn11 . in 811111 . RRI '.!000. ma dr. \I 1\T\\ 1R1 :.wo-
171 I..( rirnr prtra.n-ht,dw drl Bnm1ino ,0110 dn 1111 111atHNTil10 lion'111in degli 111111i r- ulta dd Cin
<illl't'<nto. Bihlio1t'rn \nzionale Ce111rnl1' , nh. \lnglinlwrhiano l:'io:JJ),
nimiero" 1Col1di101Ti-;pond<117,a sc11111hin1i rru i kllern1i lprrnti 11Jl"Arrndcmia f1onn1 11111. talrnlta dedwat1 n ntra1u
nulizzati dnl piuon ,11,o (dr. Pu1101r\ 1 <)!)8): un 1rruppn di -,mwtt i di Benl'd 110 \'ardii. del L11.,l'll (. l111{elo <' "er
d
1
'
1
'1'a, .11 11011 che im1110 ). <li Clwrnnlo e dell; ''l'' 0 Bronzino ,i riferi,rc nJl'eflgit' <li Laurn R1111ifr1Ti . L
'>t'ambi111ru In p(wlr ,a<' il pi11on' l'hc i lrAAr alle rr. :>81-:>CJr. rn11111111111110 in BolJ0"\1 20 8. PP I:.
; 0;)
Pur in Ltn dettato fati o o cnpt1 o - h l'u o d i nomi-tra tim n1 ri er
e Dafne 1iporta ali ambi nt e al odi e accad mi o - i di tinau la ntralit d J
t ma d lr pr ion . t ma 'i ibilc. di aff tti pen i ri hiu i n U-animo: la
poete a auaura al pittor h la ua pa tor Ila . probabihn nte un'innamorata
nza nom
173
mo tri n J volto> i che il cuor di lui agogna, io la i tra parir
il proprio amor o ]a pr I ria ben vol nza. h di qu to ali i ac nt nti . L"au-
picata mani! tazion d I mondo int rior a]f t mo troYa un termin di paraaon
nel ritratto cl ila p t a appena dipinto dal Bronzino (la propria mia no ella
imago>) eh copr tutti gli aff tti e i pen i ri di ol i h raffigura p r quanto
il uore d ideri n onderh. La po te a attribui il pot r di comuni ar I int -
riorit al volto amabil , ap rto ' I agibile d ila pa tor lla, ma lo confronta on il
meccani mo di Yelam nto eh a!ri in un ritratto dal ontemo del tutto oppo to:
un profilo impenetrabil on cui la fi ura dipinta embra chivare e ten r a di-
tanza ro ervatore. La contraddizion che i pr du e nel pa aggio dal! imma!rin
alla po ia he la riguarda olo apparente. e. mai. dimo tra quant il dipinto
ia fedel all araom ntazioni di Var bi. alla olar opini n dei po ti : pa ioni
e concetti ono gh oga tti cl ll imitazione propria d ila poe ia non dell arti vi ive.
Alla pittura allora non r ta che appropriar i cl ila poe ia ac oaJierla oncr tamen-
t . come tma icatri e o una frattura ianificant n 1 proprio corpo vi ibil . Il di-
tacco della firura chiu a in e te a i ontrappon al e to d ile mani h r a ono
un hbro aperto, ovv r i mo trano ranima eh il uor alt r di Laura vorr bbe
e lare. Le lunahe dita i invitano alla l ttura di du onetti tra ritti ulla uperfi ie
rivolta ver o di noi ri ono ibili com Rvf LXIV XL: du t ti non on utivi
n 1 Canzoniere. il ui a o tam nto impone all p ttator -I ttor un t ntati o di
decifrazion . Nel on tto LXIV eh i apr ui g ti di una Laura derno a fug-
g nte (turbati egnj binar gli o bi; pieghar la te ta t re ndo ']vi o) il
po ta invita l amata a di pr zzrufo mai, da lei rifiutato la an eller d I pr prio
uore: in ' XL. am.m n ndo di av r eduto. e lp ohnente. alla tentazi n della
ua b llezza. la prega di re pieto a. In du po ibili ituazioru di colpa (I blio
la cl bol zza) l'amant invo a da Laura due oppo t reazioni i] rigore la com-
pr n ione: Ja ondizion d Il amant prime o . indir ttam nt , I att giam nto
1 2 1;-65. c. 58v.
.173 La pa torclla,, talvo!ta i?entificata 011 la a poet a, che n i primi quattro ver i parlerebbe di r
m terza P r ona: l 1poLC 1 non 1 puo eludere, per he valorizz r bb1 il parali lo on il uo ritrauo nella se onda
quartina. ma l'e ordio pone qualche difficolt. , ulle po ibili con. cguenz cloloro d Ila ri,e]azionr d i C'ntim nti
df'lla donna ali' e temo cfr. Brn RROT11998. 173-174.
06
Il . dell"omonima donna ritratta. li aff tti e
le intcuzioni dell ' amata, , perhal u ion ' a o ti n lla razza piramidal del uo
. . i h la po t a orr >e tener n . . . . . al-
1, v lano. in m d obliquo (attraver o la vrappo 1z1 ne di un li
corpo . 1 ) 11 . l di un altro po ta l'amat Petrar a. tra cntt a p nne
tra Laura ne e pa 1 ,
B
. 17-1
del po ta-pittore r uz1110 .
r Ile Risposta d Il arti ta, I auardo -Laura.
. t ll pr l'anima e la quint nza di I t (ti ver ).
pm o. .
fari tr parire, d 11 a qua calma eh un laao:
La ca la e bella, ov'io mi sano e
. D I \I' o b Ila e ca ta O F;\ . il vero
nua '
piu hiaro cuopre: il vj ,o e n ro
girando, h bel pie tranquillo lauo.
Ed io eh 11 lei . com l'alato
nwL on canuiaco, altr n n veu!!io o chero
c'hone tate beltade. onde l'intero
corger for. c potei vo tr'almo, e ago;
e non pur gl'occhi, ov rnor hiaro e
rema, f rmar n I fortunato ,elo.
c'ha d' honorr e virt1 rint ra veraa:
auto
ma qur ta man inI nna, oim. di tanto
e m, del ' er che p r vera rna il e
. aat a
e temo Lete uni u oprar mero .
laendo i e me nel di-
ri ulta pi limpido. n l
. . . a di intuir Lawa n lla ua int r zza nobil
il poeta-pittor -amant ha ti pnv1J 10 u . Il Il CO tr tt a fermar
, . [ ] al ) n 1 corp e n anuna. .
pr f nda (1 mt r m > ili . t alla uperfi j del Y lo>. pur lil -
ali o hi t o, retti da un amor pur um1afna . lo d Ila Laura P trarche a
d' (il ID 1 fl 0 V
guagliabil perb llezza ret11tu m ldi into) .Eppurelo
in i m il lo indo ato da qu ta n l P h dovr bb tradurr l mtu-
f cl l
i' t tra il V r a mano c
Piritual ' I orz ru . d . 1 ritratto. v rO'oan am nr
. . . . 'b'l tal da mdurlo a na n er i . di h'
lZ10ne rn opera v1 1 i c. . . d lla ua art . I arti ta e 1ara
inad auato a t m re l'obli P .r tutte l unp1
Il
. l retazi ni dell'imrna"ine
li cl' Dante - e' ara nr e
111
erp izonicr
1 -l La mi"lianza drl profilo ritrau n queUo B:ttif rri "a. lettrire ma anche.
(ad e. da KrnKHAM 19 8) - potrebhr a. a aainata da ellir in un a lei moho \TTI
unll nobile ibrida Lllura-Prtrar a, come qur
3
imm "'
[ , Via] v. 11 ). fr. Doc1.ro 2006, PP 48fi
4
.
75 B 1565
. . . 1 ')00 pp 83-84:
1 , 110 ZINO , c. .)
/
.
1
tt d I citato ID \COL\ - , ?.
/
B
'b ' t 1 Br nzmo n o . . trito e li -o eato
176 Qu to guardo cc\zional e Rl In u1 , tato p ter nuu nrrurare in r . 9 19)
. . ' I ,- 0 /occhio terrcn a.na
1
. Il f tura" ntc (n . - -
cComc gli oc lu . crcru I.' '
1
' la lll'llI di Paradi:.o/ far conta e e uara a a u
oi, cui solo il t I consente/ il senno
o.
una " onfitta di manirra. chr si ri\ la talr in delJa visione i11teriore
(n .. -10) che preccd il firmi 11rgativo. r nella propo. ta drlla Battifrrri. che. comr
abbiamo 'i ' to. mett<' l"arcenlo proprio ullo . ' lam nto eh< 11 n ha potuto impcdin.
e ' impo. ibil a chi Hlda attrihuita la e lta dei i r la d ci ione di
nel dipinto. ' indubbio che nella relazione tra questo ritrai 10 <' lo sca111hio
poetico che ipira :,i un nodo teori od ci"ivo. al cuorr lelparagonp tra pit-
ttU"a I o ia: i due on tti petrarch :,chi danno alla firrura una rnrr> (p r quanto
non ua. ua olo per emulazione). atcrawr;-.o la quale i man ife ta nn anima> in
cui ..,i com ndon . e' rit ben 'olcnza. JJ contrasto tra di tolro e pnrolr
o. t ntate. tra cuor e lato e cuor . uo malarado. \i ibile. rralizza la 'ocazionc d1lla
parola a fari. anch nrlf . ,oc dctranima.
li ... 10 epi:odio mbra analorm rip tesi ciel ritratto lirico> e -t .. '3). almrno
p r ra..,p tto he ci rirruarda. Le:;pr ion d lranima e po..,..,ibile olo attraver..,o la
mediazion deirarl ,. rbale. eh ia implicita com nei ritralli wneti tudiati dal-
la K ) ... o in po izi nr \i co a e trionfai comr tra I mani di Laura Battiferri. La
p ia mia manife tazione delranima alranima e de..,tinala: mie qurcrli ono
chiamati migliori pili cc Henti po ti. i quali rn crlio rappre rntar con le
par I neu/i animi no.tri tl.mo quello he rnaliono> i--. La di tinzion tra terno rd
inr m rigumda l'ogeetto delrimitazion (e rpo r anima). lo tarut reciproco cl Ile
ani le fi..,p tti, dr tinazioni ud che un po tao un pirlor canta fingr./ !"uno
a r chi interior. r altro d fuori> i-8) . Il m tirn ron a rato da .\Iarzial< percorre
on in lllr ' tat li ce o la tra lizione
1
- q e. h Il oltrr rau..,picio r latirn alla pittura
( . .\r ... utinmn .. .> ). apr uno pazio di aut lefini1ione e affermazionr p r i po ti . Il
limit d ll'inattingibil p r rart figuratfra ( mor animumque>) lihrra un ruolo e
un n.. p r la parola. che pu attrilmir i i] pri,il aio eh 11 ga alla <'"prinw-
re qualit imi ihili di una figura umana.
-f .. ) I po ti daranti al ritralto
. ell paro], d i poeti. la ., !!!!<'Zie nf' d I !ore alla l mola par( nena e irrirn liabilP
ri!!uar f affanirua alla 11a imerio1 . La t ... a dt b I zza. mutata di.., gno. aflliag
I_ I .. n di nnara daHmti aH ml1iauzr unrnn uri I r a .. prtto . n-
11 Il di nnun nam 11t dalla oglia clt'I , j.,iLilr. t mi "tlt zion p r
I di - u __ m J er le ani della par l.1. rl Rina .. im mo la
I
. l e _. 1\'rr< le imnuvrini in modo anche molto preci o. ma non pu
\ ca1>'lCC ( I ( ('S I !"' l'al . . d
prosa< l , I l {" ti11u1amcnte. un dNtarrho dopo , tro. nnun ian o
r I eh Jll('f 1('11( o(' a UOC'O 11
ai o. I . della 1>it1ura. Co111r crive Lf'onardo.
alla t cllH I a
il )Orta) hi rnoll' <'q11iparar<' al pitlorr. ma non '>i lr ue
[ ... ) [
1
J Ile 111,. 111 1Jri di tal hell<'Zza. il tempo I!' d1,1d I una ria I altia.
I f.ir lllt'llZIOIH' I (' ' . I" '
"'.. r'- ttr r obli\ ioru. (' di\ idr I!' proporzioni. le quali ('flz:qrran "" n n
\ I . F !1011 )()(('fl( lol< llOlllJJare. ('S (J 11011 puJ rompom I armonica
;111al1 di di\ irH' proporzioni . E pcr lo un m d,c
pm z1011c1 '1' . . I .. I . dr la 1wrulazio11r di una hellrzza dipmta. non puo are
ll'lllflO llC <(lld ( .., llH liti
( ) HIO
una hrllf' zza ..
, :. "<me dihtrndr il ritratto nel tempo e framm !Ila in rn o lin. are rim-
:;;; , itiil>i lr.
111
.ocli lica
1
ndo .la.
rhr I<' lH'llf'ZzC' d1 una < cl. 11111. . . to> rar ono tant
. . . I _ I . lcr<'ra prn il aru< 1 at r mnam01a
hgun: Yedra '"' <O\<' a :at ura . C" .- I lro a int n amente d -
i potrri d1ll"e11wgeia. I impre s1?n < que ton n t ali
. . , I . . ,, lw iwnnwn tramo e a\ ctnU a l . .
smltl\/l 11011 (' a (CS..,cl ( .. , f" l b" . .. ttam Il((' iJ t to alt immaam
rhc ahbiamo una buona probab1l1ta <i a) coni L t o non i accadreb-
. , " 11. \ ('lllllalr COITI p ll( enza. s..,
di ricorHN.:Pr con ..,ICUH 7Ztl li , d. 1 1 11 loaiato
l . I ' . . mo a lh anar 1 n ra
hr lrggt'rHlo 1111 o un ma< riga e.'<' .. tf o) trac iarr un'effiui
da tu1 ptw1a ci rlovrrmrno fermarr a poch1ss11111 i a i. I I . . lt. Alle difGcolta
. . . . f' . I . . I r "l tant quant ono I on I. '
generica. s11111l e a Ili 1111tr a lie. a
11111
. .
1
<l. una codifi azion
I I a per la p ra. 1 P o 1
trulturali d1'I m zzo ' '<'r w e sr -,omrn .
1
, I .. ib"l p<'rch. per
. . . I . lr IlfO}Jne recrol anc H a '1 1
molto rwula. Il pctraH 11'>1110 tmporw ' . 1 I ' r' d ll'e p rirnza en-
la 1>i1 autentica i. pirazionr. 11011 puo accorrlwr lit. mo t( : on lt1cihili a tipi.
. f' . t 1 ute\ o P r qu.t11 o r1
ibile. la \ ariet di mhianze Hl llUtamcn e J I u I I alla uulimazi n
. . . I an I tendon a 1c ra r.
Pu aniri11ar i m volti ai corpi
qu li
11
1 1
:
1
tiatti f nuninili
I
. I lar n('r a an 1111 <
dell cliffcrmze. com<' acn11 f
111
moc ..,emi e r:, e> l . : e a farci y -
I . 1c di c10 che a po , lcl ne
dri quali abbiamo parlato. l na cot1s1< "' azt 1
der lo rnnferma co11 cxid nza. . . I
1
.
1
11 z ritratt e di I ell z-
1 1 t 11 'ZZt l t'r I ar ar 1 )<' ez
li pt'lrarc 11 . mo 1111p1 gag J , e
1 1
' ' . I t all.inunaain . he
' I t on re un ' fil e 1r I
01 1
ze in arnr o . ..,a. n n puo o non' u .
1
( . . I "" miliari (n lla
I
. . t w d1 corpi :,11rm1 '
la i'oli a una ice conhtd azwr . . {' l
11
rnte rii ro lucibil .
) I
. . 1 un ,, Irma 111 u11 ai
b llrzza r nrlla bruttezza . < a sCOll ljHH I r
11
ra l .. natura. ma
. .
1
!tanto non urn u
Com ha . critto Cion111nr Pozzi . H P e ia
11 1
! . . . ' d pniam nH'
. . . Ul"' l .. l'I' . '. . . l li irnma O'U] fl('I \ 1 I r
Il mmeno lllllla la prttura -. cHUll I (
180 Lf.O\ 11100 I CJ9.i. p. l 8.
181 hi. p. Il
182 Pom t<J IJ. p. 22.
:309
illw rio. p rch i d ttagli \ ' O ati p non appart naono, aramma1i alm nt . al
ritrall . ma al mod llo, e an h quand fam10 part d lrefGaie ( 0110 cio pr enta-
ti om dipinti. olpiti, in i i . ) n cancellati dalJ pe or moloO'ante d I
codi . Il 1 t in aener i limita a n minare alcun parti d I vi o (piu rararn nt
d I oq o) e. non co tando i dal ri aput I ico del anon . pr du una
01
1a di
tautoloaia de rittirn. una ri tallizzata mm iazion di parti h n n hanno forma
e color al di fuori di relazi ni prc\i t dilcat . a i tiamo a un tentativo
di d rizion indfridualizzant , h a piri a r nder la p ificit di un'immaaine.
ma a una nominazion in un linauaagi a priori che, in quanto tale. non fa che
ribadir l'in i ibilit. i che i pu dir ' ci he i pu v dcr , e vi ever a. Con-
temp rancamente. lo aurudo le r azioni d Ilo p ttator -amant (gli eff tti ) iJ
rapporto na rpo e anima. tra t rno d interno. oraanizzan qu ti brevi di or i
attrav r o i verbi-filtro mo trar >. prire> di oprir , h riv lano quanto
poco la uperfi i vi ibil conti in t a, quanto rapidru11ente da il p to a ci
eh ra chiud . Tei tratti del rnlto dipint . indfriduati odo an ioni ricorr nti.
la po ia r ai tra il tr parir di qualit int riori , he il O'aono ul i o e attraver
0
la pagina: una li ta di virt cui i er i r titui cono la pre i ione di un nome a volte
di un eone tto. e ondo un odic a ua olta tabilito
1
8.3 .
Le empio di Giovi.o indurr bb a pi aru la po rt d ll I rn nto de critti,,
nella po ia t ritratto con la ua funzi n di dida calia ri p tto ali relativ effi!!i.
p:r altr a ompaanate. nel ca o d ali Elo ia. da una pro a alm n in part cfra-
nca
184
: ar bb pleon tico o omunqu non nece ario t ntar di "i ualizzare ci
che i" ,d . in i o opra il te t . In a nza di immagini la t , a funzione on-
volta dal deittico eh m tt in ampo i h ' altro dal testo: una
finz10n .. di pr. enza. un unogato r torico d li immagin in quanto tale e enta
com .l 1mmagm . propria. da ulteriori de crizioni. Da anti al riLratto. il poeta
e ordi e pe o mdi ando I op ra di ui parler invitando ad o rvarla un a to
lo funzione u idiaria al t mpo t o lo lib ra da altre r pon abi-
lita ? ntu_v ti ono indubbiarn nt importanti ma non ba tano a
are cita , o largam nt intenzional . della po ia. I p ti mbra-
no lil eO'ulf la fama d l ntratto vitando di fidarlo ul pian d Ua vi ualizzazione,
terreno do .ar ro per forza p rd nti: il loro river di immagini gi eguit
0
nt ipotetiche, .i .radi a da un lato in abitudini mondane ortigianerie
pe1 rn nt a tratt on it.J eh t ndo I li f
. . . no a n o vcr I ne a propna unzion prat1ca e
cel hrauva dall 'altro m un inint rrotto di or o u ci h non i <l non i pu
vedere ulle ri or e pecifche della p ia per lodare e cu todir la m m ria. Per
183 Penso non :.olo ali associazione n . . . . .
alle ortili cli iinzioni daJ on tropi'? ng?ro. a m qu 11 te ti. Ira do1 i morali parti drl 'i o, ma anche
zia-, clru11iadria icc) Cf . tr .t
1
<:'1 cmqu rcnt sca uJla bellezza ull ' amorc r . ulla donna ( gra-
" r.
1
attau racco u 111 ZoYrA 191.3.
18-! Cfr. supra, 3.6 e 4.2.
310
entramb le ragi ni la clc crizione vi ualizzant embra n n rientrar tra le ri or e e
gli int r i di chi ornpon ver i u ritratt n' tra 1 atte o l pr o upazioni di hi
li commi iona. Una prima ripro a ' off 1ia da un dato tati ti o: quando il oggetto
ritratto e l br il t to i on ntra u pi odi eh on l ati al . u nom nella
memoria oU tti a, m ntre ' an nimo la co i nza dell immaain l u impli-
cazioni lert rari r tori he hanno m d i di pi aar i un po pi lib rament . In
ltri t rmini, la rappr ntazion (pur mpr irrigidita dal anon > da modalit
fnit di d ifrazion ) tende a pr val re ull'id ntita o vi r a
185
ullo fondo cl Ila tradizion . i on Ui di Ar tino appai n fu ri m dia per la
grande attenzion h ri rvano a.ll' e p ri nza d 1 v der . .e . cono pro-
prio dalla e n inzi n h la poe ia non p a n n d bba o tltmr 1 all
do la p ti a d ll'evidentia. i hi rano ii lutam nte dalla part ? ll 1Ilvenz10n
poetica, m ntr la traduzion d i dati vi ivi in parole r. ta pr r a d Ila pro a
epi tolar (cfr. . .2) . . el campo liri o il I run con 1 tto p 1 t ..
dato dalla dida calia ma il poeta i a um prattutto il ruolo di loITTar 1 co_m-
mittenti
0
di fanta ticar ul ritratto. ll introduzione alla t rza part dell Rtme
(1614) di 1arin critta in una fa in ui I in i .ioni
ancora un prog tto r alizzabile, iJ rapporto he l a I er i a1 n p tll':
definito dalla mpli formula opra> il loro aratter l gg ro gi o o 1 pn-
me n J verbo h rzar >:
Tra i Ritraili ntrano i imula ri di div r i u mini illu tri in armi e m in lettere.
tant moderni quanto anti hi tal h f rmano a ruisa d'tm lu o. opra ia c:a
imaginc i hcrza con qual h bizarTia e ondo 1 azioni d I. entato. .e!rul-
tanto in i lo tile che tennero tra' Latini Fau to ab o 1u110 are aliaero
h n , la iarono molti epiaranuni, e tra' oluari r nico olti et il conte Balda -
ar a tiglior, de' quali n vcaaono al un poch ottave
18
b.
La cbizania p ti a n n i i pira ali a p tto non muO\' lla rappr
zion . ma da ti fatti ( ond I azioni d l rappr ntato>)
18
'. r una Yero
mile onfluenza di raaioni t cni h di gen r : da un lato i narrabili tll quanto tali
po ono o tituir Wla div r a vi ivit, mponibil protratta n l t a
tatica h mbra pr lu a al di or p tico: dall' altro pr prio 1 az1 ru co lltm-
1
0 15 d' . Il b' (' fr Jc !'om.id razi ni di 01a .\laffei
o. ull mtere e p r la fi sionomia nelle rarcolte 1 ntrattJ e 11e e 10gra 1e
in Cm,10 1999 e 1 1 200-t.
186 Q
, . . aU d Il R' ( 161-l) do'e \!arino elenca le parti-
li to pa o <' ompre nell 1mrodUZ1one a tcr1a parte e ime
il
18
. . d ll G . ' 200 TI 38 39 mc ena \Rl o .t. qui poc
z1om a a lena, e ora i puo I<> crere in PP ?
1
-
39
Il Il ro iae d Ho
fa riferimento arli Epiurammatum libn' quinque (1 d I abeo e aab !/eroe ( ) e tt e e
11
aligero; p r I' olti e ,fl stigli n fr. M 1x1 A 111 I 9-. , .
I nurc e o n-
187 [ ... ]nei "ritratti " la fa ola o l'i toria eh offriva il cl tro allR macch
1
tta dpi. ,
1
d 11' ' .
1
. I 6 . - [ ] (P1 n lntro uz1one a ARL'\O
twrn n aneddoto[ .. . ) quru1do non da wrn orta d1u1c1er )t gra co 111 \er
1
...
1979, pp. XLI- LII ).
11
no il cuore dcll"rlogio epidit1ico . li spazi a11111111ciati dai 1erba tidendi
po:,,0110 assrrnhrarc impre 'e. cariche e lllrriti familiari. trnccr di 1111a personalit
con tul nonH' una st iia. ma "rnza un corpo. I o netti rc,,ta 110 un ca taloa irrime-
diahiJmrnt 'uoto I r r hio. unc..,po izion ontcmplata a porte chiu e>11111. La
luce non a' ola n colpisce q11 "ti dcp rihili manichini di parole (Pi ri ). perrh.
aggiungo. n ' gumdo lito' a li rag
11
iunae. for 11011 <"- 11i nt eia '" cl re.
i!!nificatinunente. le unichr cc zi ni alla ancellazionr po tica d I vi ibil
11011
riQ1.1ardm10 l fattezz . ma rlzabitus.
11
li altrihuti e i trnvestimenti mi1 loaici. Qualche
irnlizi . per quanto d bol . -ulle carattc1i tiche dell"immaginc si trova proprio quando
i carall ri delr fligiato non ' Ono indi,iduali, ma O'i tra' lati cd c. cmplari. come nei
ritratti in reste di: in qu ti ca i. I cr la natura delfinm1aaine. chi . criw de,e e ncen-
trm i u cl mrnti predefiniti e n n ri onducibili ad una fl ionomia ingoiar : attributi.
po- e col ri di rim.inanti p r indicar un.identit mitica o . torica eh uJJa tda . i
a ocia a quella d I oO'aetto. L1 mo lo w1i onoarafia O'i ,i. ta e pre tabilita i
' O\Tappon alra p t1 da ritrnrrc. oU 'mHlo la po ia dal rnmpito di rendere i tratti
indfricluali. li eff t1i di que ta e mhinazione non ono per neces. ariamente ,.i ua-
lizzanti. per h, un in i tito rif rim nto a una figura nliti 'a pu funzionare come una
emplic irnilit11dine o . er coim lto in clinarni he te. tuali che tendono a toalier e
non a r tituir e ncr tezza . . -el n tto Il Prencipe Tomaso di al'oia applica
in mocl piu i. t mari o un pro edim nto ruialoO'o a quello eh al biamo inc ntrato n I
ian Ol'ra la statua de la siunora duches a di Parma
1119
:
Qur to. rh Fabro al 'irn inri"r
,ionctto auerriero in \irn pi tra.
e ch'anror fiuto. in feroci rr11i
pira pavento. onde ,;1 uo111 arr!'t ra.
il nipote non del !!rande \11d1i . r.
eh' "li armrriano il fianco arco. <' faretra.
\011 rJ lebrro che 1 fier Cirrante 11eci .
cll\ rrhb ne la mano o fionda. o cetra.
E r fu "e il Carzon che nac-qur in Pella
O'>lt'ITf'bhe ]o Cl't I ro: (' LCrra I
. e fu il tuo fi gliuol. Tlwtidr bella.
TO.\I \.'O . eh gli ag!maglia: e e ront ra ta
ron l"antiro ,aJor !"et nowlla.
drl "ra11 CARLO " nnoglio. e tanto ba ta 1'10.
188 hi. p. \LI.
189 RT6-i0. Ur. supra.: -i .2.
190 \hmo 1979. / t (":l'3) 0
ue. fl 291. anno1a10 i11 Rouo\J 2008. pp.
312
A ciasruno chi 111odrlli cvorati prr paragonr vicnc a ociato un allrihuto di tinti-
,.0 (arco e faretra : fionda o crtra: S<"<' l tro: a la) che>. ma11cando nrl ritratto.
la corri pondentr iclrntificaziorw ( \..,canio. David . \le..,:.andro \launo. \rhil-
le): un e pedienl<' retorico macchino o e contrario alla vi ualizzazionr. in <ruanto parla
di ci chr f/Ofl d Jl('I quadro. di ci) clw il quadro 11011 re non rappr enta. Del O'ornne
lirr]io di :arlo Emanuele di , 'ayoia. che aggrraglia que ti co<'lanei roi b llico i. ap-
prendiamo olo (('lllilJiJc (' '. ri p ( an-
cor Jinto [ ... ] fl'roci gur:-.e) e alla (111c ( I 0\1 \ O e ... ) . La rnza dr un particolare
della semhianzu o cl I ro,, t mnc pu offrire il prC't<' to per un mani rato rimpr ,ero
alrarii 1a. couw ru' I sonetto in cui \1arino, da,anti all"effiCTie di Eli. abetta d"lnO'hilter-
ra. e prime una condanna morale della , O\ rana . uggerendo i mo lelli ai quali il pittar
ambb dovuto j..,pirar"i (Chi di qur. ta sacrilecra e profana/ .\nO'lica I zabel form
runacro/ [ ... ]/ darle \Olto dcwa di Ti!!r llircana/ [ ... )/ ritrar Pr O'Jl(' cnid I. o cilla
\nnicla./oCirc .o {inO' [ ... )>)
1
!)
1
.lnca:,i i-
mili. il rifrrimento al mito. pw- m11m endo da caratteri del quacLo. cliwnta unari or-a
lettrraria a tutti gli effrtti. Il de. crittirn . i ro,r eia e ' i tra f rma dati.interno. come
accade quando il p<wta in\'ita r artista a "crgli cre un oO'g tt in ai11 e o a come
modello per una rapprr:ieutazione !ilori a o mitologica. Ta o ma. hrra una mplice
e nazion a ritrarre \'inrc11zo Gonzaaa pr pon ndol come forma t rr na> ade![ua-
ta a cfigurm > bellezze di,ine (. 1l 110r ur:;io . trdi::.io preO'andolo a ritrar il siwzor
di .llantom in quante uuise. e lo imnuwza):
, .. a fa\Olo..,i dei forma terrena
fi"uri . \rdizio. <' 1-!io\'inet to \111on
fingi . a rni :-.parga il mento il primo fiore
i11crrto s d1t' ... ia \'eduto a pena:
o Febo. ch"or Piroo nel cielo affrena.
or rarriato r dt'I ciPI mao pa::.tort' :
o rrli altri. a cui la guancia il li L uore
di "im inezza fa ::.rmpre . err11a:
il tuo ..,ig11or ri:-.guar<la e dal I <I 'i.,o
che ci11go11 ro1:i biondr r molli piunH
togli. ondr piaccia. ogni tua belh1 imago.
\ "{-,l'ha Frho ron"ien i. un hiarn !urne:
d>. rh ' i11 1\mor loda. un dolci' ri-.o:
"' I I ' 1 I . . ' it
2
' t que e Il' puo ne a 1 a tn pw n1cro .
l!J I hi. Belle /111p11diclte ,, , 'nlerate. (1 p. (Dis11bt'llC1 R1gi11a cflngltilterm. '
1
1-:.! .. - 8- I O).
19"R""' .. -- . . l" ' I ("(' "(cfr.i1i.-:'8ll), 11111
- 7 .8?. C.urz10 \rd1110 ( 1.i.l0- lh06). po<'tll <' 11111on'. fu ntralll-lll t 1.> 11.nl,\ "
111111 11
. ',
1101
1>11ppian10 u11rlw rilrnlti di \l11n11zo ;.<emulo I 111\llll formulnto d,i 1'
1
''
0
1izo i ter infa1:1 a in amru pollo ( , 12), Amo: ( . 13) e quan-
to cli pm bello e 111 altr g1ovam bcllezz ( . 11), per h ba flu nt1 hiome biond
doti che i nYcnuono a qu tf' ( lum ; ri O). er tino a u ha eriu ta-
ment parlato di ritratto mbl mati o> p r que to on tt p r il uo g meU
0
,193
dov l'imito dir tto a rappr ntar il onzaera formuJat a prutir dalle peri nza
d I po ta (io nello tile ardito>):
" nte. Ardizio. l'ar o la farerra
fauro al bel Yinceuzo e 1 fino-o Amor .
che que ti traJj impiombi quelli indore
e li t raa d a auzzi a dura pietra;
onrra \'iobe. che p r du I -"imp tra.
or Febo arei ro il formo d or r ttor
d 1 CaITO de la lu e ed or pastor .
or col plettro in Parna o con la cetra:
o coturni alati con la v raa
talor per l'aria il me aa!rier volant ,
col rir o talor Bacco fiorito:
ma in quante !?lii e io n Uo ti! ardito
l'omo d rivo. il tuo rad mi in lant .
di pi bei color le cere p raa 19i.
. La. rittura come operazion qua i pla ti a domina il t to attraver o una
e
1
:
1
( cfiauro; e.fingo; formo: orno e d ri o>) on il riferim nto
all.abi.tudrn ( ov nte) di antar il Gonzaga con uli t i attributi uggerili
all arti .ta ( o far tra: arei ro> arro>. plettro>. tra>; oturni. cv r-
ua> tlr o>
19
.>) La f 1
. . : . upre a. lll unz10ne n p1 ogau a. d Il pr ion in quante
. . al pittor . onf rma che I gui > ug rit airArdizio ono
tJ immaginati dal po ta non dall arti ta. u t d t rmina ltna
p ulanta tra 1 du componlill t I .
. n 1. a pittura 1 1 ptra a una cr atura t rrena p r
dar u10vane divinit. m ntre la parola impi ga il rif rimento a qu Ila
te a d1 m1ta per e 1 brar un Al d. 1' d Il l I
,
1
I umano. I a og1 onvcnz10na e
e noto e 1 ra pra i omun ritrarr d. f d I
ovraru ignon m veste t am mito
193 LI
11
cnerc drl onrt10-impre a i dcrlin . [ . . . __
. pecir d I ritratLO cmhlcm ti . . .
1
a nel ?
11
1'llo ul carro de la mente rumga s1ed1 (RT .">3)] nella
iconografico con C!!llaf() Cno .,ara. a. cnvrr ad C empio, i) on llO 787 ( ... )V ro -prO!IT8111Dl8"
Gonzaga) in quante gui e [' I uni zi? Ard
1
7:
1
0 pr gandolo a ritrar il ignor pri11C"ipc di 1antova (\'incenzo
. asso e o tmmag111a " (C1 lJ 1999)
194 RT 88. Nel medesimo aPomento.
195 LI' G ure ri pctlivarncmc Atr1or', U
' po o. \1eJ'(urio, Bacco.
314
0
della toria, oppur dar ai p rsonaagi di una cena all gorica l fattezz degli
alti mrmbri della rnrtc
196
Quando i rif ri cc a que to tipo di imma ini. la poe ia
prcod att di un ma nto eh . alla ! tt ra. fa part del quadro. ma e n
di co ta travolrr ndol o remventandol 11b rament . com a ad n I onetto
rnarinian La marchesa L ia Turca Pia, in abito di Pallade
197
Lineranno p eudo-
de crittiYO ordito dalla poe ia ai danni della pittura i ba a ullo te o m cani-
mo di di trazion di clu ione eh abbiamo ricono iuto p r id tta li
198
. parti-
re da un ma imo li concretezza appar nt , l'i olam nto po ti o di un particolare
ri ivo di fauo rnat rializza l'effaie in quanto ri n alla digr i n o mette in
rili YO con tti importanti per una I ttura r t ri a delrimmagin pi h p runa
ua de crizion ica tica.
tac e del ritratto a un di e r liric r tto da forti im n nzioni em-
bra impli ar un lii i o una di tor ion . un m tamorfo il ata alrimpo ibilit
di dir una fi ionomia umana in un odi h i fonda uHa ripetizion ulla
riduzion ad unum di infiniti po ibili corpi ( anim ) e ulr clu i n di parol
cateuorie e tran a un di ibil po ti pr ritto. li ritratto r ta fu ri dal te to.
bloccato da anti alla tr ttoia r tori a e linrrui ti a del p trar hi m ali r
11
ole
non critte cli un u nere, ma la di tribuzi n dei po hi d tta li up rtiti rivela
come la opravvivenza o la cancellazi n d lrimmagin dipendano an he da ul-
teriori e pi prr i e c lt letterarie. Le uni h re i tenze d l Yi ibil ira olgono
infatti in luoghi t tuali f rtem nt caran rizzati . per lo tatuto in rto liminar
(il parat to) o p r la pi inten a fieruralita (ornatus) . Pro di omm nto o di
raccordo. p izioni , dida calie o 1 tt r in virt d Ila loro natura " traliri a .
acce oria o do um ntaria, po ono u t dir 1 tracce d ll'r p ri nza tratt nen-
do. come le ma li i una rete i che non ha acce o al te to lir.i o. ltr que ta
oulia. uli hi dell'immagine t ndono a c in idere on li adden am nti cl llelo-
cutio con l o a, i ni in ui la parola impi era I propri trat erie c n parti olar
con ape olezza ( imilitudin m taf ra, i teti, p ri fra i, rif rim 11ti mit lo!!ici )
Tal corri ponci nza ri ela he i p ti leron di mo trar ol qu llo h o_no
in urado cli m trar , i e i con ntran u i' h , d 1 ritratto dipinto. il codice
po tico pu illu trar (d ttaerli. attributi, tre ve tin1 nti ), p r lun
11
a
i m cani mi d ll 'eloui d Il'amplificatio. Per la liri a, ouli r qu l m ntl
fiuurati i ignifica Iarn e raddoppiarn il meccani mo loeric r 1 ne , dllll -
que di fatto tra, e nd rii renderli in n i t nti ridi p rderli n l proprio t , uto
imrnat rial . La p ia non ol a imp 1T al i ibile 1 propri r eroi , ma a frufo
continuando a parlar di ' .
196 Ri: UJ, 2002 ri cordo i tra"e timenti mitolorrici dei re di Fn111ria, limitati alla forma d I
0
in
>"quc Q I di hr 11 arazzi malli t' t' ntrac rea 1.
' nzr narrative. ucst ' munarr1n1 s1 1rovano non o 111 pmtl, ma anc - ,
19 1979, Belle Casi<' e Magnanime, [ I Q), p. 228.
198 Cfr. supra, 4.2.
31
Lindi,iduazionl' drll zone di rort ocircui10 tra lirica pillura e 111porta r,i-
<l liti con egu nze ml'tocl I 11iclw. Pt>r comprr11d r e nrnp rar . alm tlO in pan<.
il rapporto tra te .... ti r ritratti nel -,uo caratt re pi[1 auttntic e -,1 ricallwnt<' vi\o.
llt'l"I' ....ario combillan !"indairin l'archi,io. in inY ntari e docum 11ti.
on 11lla "JJfrifica ricoaniziorH d i luoahi I tiri in rni i ra<'coglie la m moria.
non mc ,, ... ariament<' c..,plicita. delle in1maaini: luoahi fort m 11t carattnizzati .
come abbiamo ,-i to. che richit do110 un 'analisi attenta al funzionamento d Il e
m tafor e alla t ria d Ila topica. La pittura 1 u pr>nd<'r aJla lett ra i figuranti
d Jla pc ia" la p ia pu tra. form re il dato pittorirn in m rafora o ricu-,rruire
ci h ,-ede ... condo topoi. Qui n n f. iu gioco olo una I u ... ibil rrat<'!!ia di me-
diazi n a ... rrana. formai . ma un.int <'razionc concr<'ta di p ritnza mat rialc <'
m t for : un inrr ccio emanti or funzionalr <'h -,ra alla ha... d lla r 1 trnzione
di .!!! ni ri>ali. ci aiuta a piegarli e a pi gar i t -.ti h n hann m moria.
Pin ri p rti -.embrano p :-o guardar allo -,t .., r pr.nori . ma ia .... iu.rta
propna prinripia. incontrando i nelr idcazionr. o n Ila ,ira materiale cli ' r i '
imn ::ini. D umenti omi epi tolari a mite p rmettono di rie -. truir la ,.i n-
Ja d -.radi tr e intorn a llll ritratto. mentre rin rim nto di tir li e di da calie
-.wla l"intenzion poetica di tabilir un 'in olo tra i H'r"'i r un dar anenim Ilio.
indipendentem nte dal uo p o eff ttirn n lri pirazion < n Ila fonna del te-,to.
In qu e pro e. cli <'nizio o PsplicatiY ma pc o non prin di ambizionr I ltr-
raria. gra,itan pi. odi cli tatuto ambiguo. a meta tra c ... p ri nza <' finzion . cJ
p trarchi mo i eh d rirn da conY nzic ni. u<' . ti abitudini di una . c1r1a -,oa-
uetto a un a . imilazionr qua..,i e m1 l ta: ad e. <'mpio. r.rto eh amat e amanti
i cambiarnn J tter . Ioni ritratti. ma il modo in cui i 'er. i n parlano non ha
a he wdere con una ing la ..,ituazion . pr i a datahilc. mc con qwlla te a
ituazione div nma partr <li una modalit e pre . iva <' ociale <'tmdiYi-.a. m ti\ o e
ritual he la p :,a a1tinae a un repertorio !li c difirato. P r corff r.,o. il I< aamr
tra prri nza e si rin al da ll<'lla pra i pn cui i t :,l i . te i vi ,ono una orta
<u conda vita. po t-l<'ttrraria r con r ta. iwllr occa ioni d Ila co11 r accanto
aali oaa tti eh arcompaanano.
P r quanto limitate e precarie. I re1ii tcnzr chI \ ' ihilr formano un bagliore li
fondo. una luce diffu a chP aHolge in iem i tP-,ti ('i ritratti. Per rintracciarlr d b-
hiamo . forzarri di J1lP1Hlcr il rapporto tra la poe ia le arti fia11ratiH. ('.ancora
prima. tra la rralt r la letteratura. in tutta la ua <'ompl . it. e cercar cli rico. trui -
rc la trama ac idPmata d I loro in ontro. 11 llr oprrr e nel I , itP d gli 11 mini. Qu to
ignifica anche avvi i11ar i a u110 . prrifiro mod di co1Jrrpire ali og(fetti. l irnma-
r le par le. in partirolare la loro part cipazion alla vita alla costnrzio11c
deiridrnlita individuale(' colletfi\a. rn modo che a rnlt r l ntani simo dal nostro.
u volte ci appare a sol11tamente familiare. Ricordando l"imp
11
1. o da cui nacque il s110
'hakPS/H'arr'w1 Segotiatio11s. il chidrrio di ''ria Toltan lr voci dri contemporanei
di. 'hah pear. ' teph(f) Creenblatt cri\P: Jf I \\ant d to hear onr [voicr). I had
:316
I
, . tlic 111 a11 y voicc: of thc d ad. And if I wanted to hear the voir<' of the othcr. I
to 1rc11 . . . . . . 1
I 11
hrar 111 , 0 " n ,oicr
1
'
1
'
1
PPr r<' t1t111rc una voce a1 ritratti r un rn to a1 sonetti
iac
0
. 11 I 1 I
iuno chP di iJOITi ali" osservazio11c' e a a co to. acenf o att nzi n . a non
non po.s'
IH'rdrrc il no' 1 ro sguardo e la 110 tra v re>.
l(IC) LRll\UI lii l(J88. p :!O.
:31.
lLL TRAZI Nl
..
r m1r.lr pol1dcto iprou1
on gl1alrn hi.;hbcr d1 quelltr
tnt I nn1 non ucdnan I. minor pane 1-
dell.l bt 'a eh m'lue 1lcor conqu1io
m' cerco 1ltnto f1mon fu 1mparld1fo
onde que(b gcnril onru ftpartc
tut l:l u 1de et l.1C1tra<fc mclrtc
per far fede qua g1u dcl fuo bel u1
L opra fu ben di q elle che nclc1do
[1 ponno imagtnar nonqu1 tr noi
ouc membr.1 fa.nno ali.alma udo
cortcfta fc ne J. pote.t far poi
che ti.a d1fce[o aprou.u e.ti do et g:r
et dcl mortai fcntnon g11occh1 [u 1
ndo giunfeaf1mon 1 lto concct
mio n megltp fc in man lo!hle _
f:udfc d.tto allo ci. gentile
cbon uftgura uocc et Hl tcllcto
1 fofpir moltt m1fgombrJua 11 peo
che cio ch1ltrt a ptu c.iro amc fan utlc
pero chcn uifu. clb fimo!lra hum1lc
prome,m:n om1 pace nclafpcto
Ma poi ch1 ucngo aragton. r chonlc1
bcn1gn. mente aCf: 1 par che m' fcol
fc nfpondcr fap <fc detti m1c1
p1gm.11ton qu.mto l u r1 1
del1.11m gin e tu. fe 1mllc
.iudb 9u I ht Col un. u rr 1
1. Anton io ,rifo, , imone Marti11i (R1f L ' II - XVllT): Bre eia Bibliot a Qu riniana.
incunabolo V , f. 3 ,.
I
uo pcnfutclo ex nel pcnftr nia!falc
pieta f1 fortcd1 me ftdTo
che mi conduce f pdfo
adaltro lagrirru.r c&1 non folcw
che ucdcll;do ogni giorno 11 fin piu pte!fo
mille fute o ch1cftc dio quellalc
cbollcqual dcl mortale
charcer noftro imelled:o al ciel ft 1ru.a
ma infin qui niente mi relcua
prt'go o of ptro o Llgtim r chi &cca .
e c f1 pt't ngton conu1en che fu
che chi poCfcndo fu.r c.addc fu uu
degno e cha mal fuo grado a ra ... - ... ..
quc:Ue b ccia
in chi m1fid gio apen e ora
Antonio Grifo, Laura visita il poeta t sogno (Rvf LI ); Br eia Bibliot 'Ca Qu riniana,
in unabolo G V . f. 124r.
3
Antonio Grifo. Laum-se1pente (Rvf CL f ): Br eia. Bibliot eca Queriniana. in unabolo
G \ V. f. 132r.
Il
Actt non poifo 8' temo non adopre
ntrario effcl:o lamia lingl 1 core
che uoma far honorc
alafua donna che dalcicl
come p <fio fc nmt'in cgni amore
con parole morult aguagliar loptc
dmme 8' que che copr
alta bumtlttate infefic<U uccolu
n Ila bella prigione onde or e fctolt.i
poco l ftato ncor blma'gcnttlc
altcmpo che 1 i prima maccorf1
onde fub1to corft
chcr:i dcl lanno 8' d1mi cute aprile
coglier 1or1 m quc pr ti dintorno
fp ran o a lioccbt fuoi puccr ft domo
1 un cran d:tl ba ro cl t o doro
J uor fmcilr di ZJffiro
4. ntonio rifo. La bella pre ione del co1po (R1f
incu11aholo e xv f. 11 '"
lll
XY) Br ia Bibliotc a Queri.niana,
5. Pi an llo. Ritrailo di Leonello d'&le. 1441 : Brr amo. ccad mia arrara.
TV
6a e 6b. !latteo dr Pa ti . ledaglia di igismo11do Pandolfo J\falatcsto, H- 0-- I:
M dagli r f: t n e. rnt. n. 6 6.
a b. o I Pa ti . Medaa/ia di /sol/a deu/i Alti. H- : B r
11
amo. llczion priYata.
'
8. Giovanni ntonio B ltraffio. Ritratto di dama. fine d J
Born mi za.
VI
.: Madrid, Mu o Thy n-
9. Lyippu (attr. ) Medaglia on ritrai/o (aut ritratto d IJ'arti ta?), .fin cl I X
Briti h li um.
10. 11pido scoc a una freccia contro un suonatore di liuto; inci ione dal fr nt
z1on cn ziana dell e Opere d 111 bald ( enezia, do d rrato 1
Yl!
di un' di-
11 . Raffaello (attr.)i Ritratto di Elisabella Gonzagai 1504 a.- Firenze, Galleria degU ffizi .
lJJ
12. Lor uzo I olto, Ritrallo di Lucina Bre111bati, 1 18 ca. ; Berrramo Accad na Carrara.
IX
13. Lor nz Lotto Rilrallo di Lucrezia T'ali r, 1. 3.3: Londra. i ational Jallei .
X
14n l 4b. Pier Paolo Gal otti, Medaa/ia con il rilrallo di Barbara Borromeo, 1- - ; \\'a hina-
ton 'at i nal all ry of Art Kr Ile ti on.
1 a L b. Ja opo da Tr zzo, Jlledacr/ia di Ippolita Con::.aua. 1 :..- -3; Londra, \'ictoria and
Alhert 1u um.
' T
16. Lorenzo Lotto, Giovane con Lucerna 1508 ca. .
ienna, Kun thi tori che Mu eum.
Xli
17. ,iorO'i ne (. ) o Pordcnon ( ?). ,10vane on il libro 1wde, 150- ca.: an Franci e Fin
Art. 1u um .
' lll
18. Palma il cchjo. 1:-16 ca.: L ndra. 1 ati nal aller.
19. Palma il Ve hio. /M/a. 1 18-20; co hy u-B rn mi za.
X\
20. Pontonno. /Joppio ritralto. 1 22-24 ca.:
nezia. Fondazi n ini.
FOTOCR.\FI CI lE
Bn.,ria. Aibliotrra Qwri11ia11a. inrunaholo C \' \ . f. Bibliolcca Queri11iana.
-> Brr..,ria. BiblioH'ea Q11<'ri11i11na. i11c1Ulaholo C V \. f. I Biblioteca Qu riniana.
:i 13n--.. ria. Bibliotl'rn Q11eri11iana. incunal.mlo e y \ \ '. f. Biblioteca Queriniaoa.
i Bn:-.cia. BibliotC'Ca Q11eri11iarw. i11ru11abolo e \' \ '. f. 11 Sr. Biblioteca QLLeriniana .
1 Pi ... anello. Ritrallo di Leonello <rf;.te. 1-H 1: Bergamo. \ C'adcmia Carrara: \cca-
drmia Carrara.
ha r 6h .\latteo de Pa ... ti. Jledaglia di 'igis111ondu Pandolfo \/alatesi a. 1-+:-0-:> I: .\lodena.
\li dagliC'r1 J:,;, t('ll e. cat. 11. (>86: ,alleria. \Ju;,co e \ledagliC're c.
;a e -:'b. \lattro de Pa ... ti . \/11daf:{lio di Isotta deuli ltti. H:>:3: Bcruamo. collezione prinna.
8. Cima1111i \ntonio Boltraflio. Hitmtto di dama. fi11c <l I\\' -.cc.: .\la<lrid. \lu ro Tln...-
;,rn-B 1rnemi za: \lu. eo Th) ... .,en-Bornemi:--za. .
CJ. L) ... ipp11'> {attr. ). Jledrqr,lia co11 ritrailo (autoritratto cl trani;,ta?). fin del \ ' c.:
Lo11<lra. Briti;,h .\lu;,111111: Briti;.h \111 eum.
IO. Cupido scocca ww freccia contro 1111 .monalore di liuto: inri .. ione dal frome:.pizio li
un r<lizione 'rn ziana d!'lll' Opel'<' ci!' I Tchaldeo ( \' nrzia . .\lanfrrdo dc .\lonfrrraLO.
1 :)(}?): Biblioteca L ni' 1r itaria di .'a.;-.ari.
11. Raffaello {altr.). Jlitmllo di l\'lisnbetla Con:;a<ra. 1;10-+ ca.: Firenz . allcria cl gli
l f1izi : Ufizi.
Lorrnzo Lotto. Ritrallo di Hrembati. 1518 ca.: Brr!Zalll . \eca<lcmia Carrara:
\ e adcmia Carrara.
l:l. Lorruzo Lotto. Jlitmflo di L11cre::.ia lalier. 1:-;3:3: Londra. \atio11al Gallcry: \a-
tional Cali n .
li11 e I .+b. Pi rr Paolo Cale tti . lledaf!/ia con il rilmtlo di /1arbara Rorromeo. 13: :- : \\'ahhing-
ton. \ational ,nllen- of \ ;t. Kre::.. Collertion: \ational Calici: of \rt.
13a r l:>Li . Jacopo da Tn1z . liedaglia di Ippolita 1:>52-:3: L ndra. \'icwria and \ l-
bcrt \ ictoriu and \lb rt
16. Lorenzo Lotlo. Ciol'WI<' co11 l11cema. 1508 rn.: \ 'ienna. 1\:1111 thi::..tori,.,rhes \ lu,.,cum:
I..
18.
19.
20.
Kumthi
Ciorgionr (?) o Pordeno11 (?). con il libro t'erde. I :>O:!. rn.: 'an Fram j,.,('O.
1"i111' luh ' UJll t.: Fine Ar1-.
Pnlma il \'redi io, -Poeto-. 1:) I b ca.: L 11dra. atio11al Gollery: ntinnal Call
Palma il \'rrrhio. Rei/a. 1;: 18-20: \111.,eo Thys,e11-Bornemisza: (() \ hth('O
TI 1y::.1 11 -Ron1rm isza.
Po;11or1110. Doppio ritralfo. 1 \ enrzin. Fondazio1H' Ci11i: Fondazione Ci11i .
1 Df CE D I 'OMI
bradata. 232n
Accetto Torquato. I 8811
Accolti , Bcrnard . vd. ni o, Ar tino
Achill r. 206n. 238
chmato\"U. Anna. _99
damo. 286
fribo Andr a. 9211
(faml n. Ciornio. n. :32 n. 39. iO 11
gatard1idr. 22
Agcno, Franca Brarnbilla, 39 n
go ti , iovanni. 1 O n. 112n
(lo tino di lppona. 6-t11
Agrippa. Ciovambatti ta. 1-8
iace, 26
Alamanni, Lui(fi . 21
.\lberti, on 47. 69. 9 o. 101. 270.
28911 .. 302n
Albrrto da 1a a di 1ar mma iOn
Albi nana, larn, 218, _54 e n, 2 -t
Albizzi . lbi ra d crli , 10 n. 109 300
Albizzi Tornabuoni, iovanna degli. 2 . O.
28611
lb nico 'imo ne 1 O'fn, 107 n, 112 e n, l J: n,
12i+u, 129n, 16-n. 168n, 217n. 2Hn
lbr ht-B tt, 2i6n
Al hida 69
. 21 n. 3i+11. 95. 221.
.\lighieri. Dance, 3- n. -t0--t3. -t5. 52. 59-6'."".
0-?2. 11 n. i.-5n. 162. 1 n. 229. 2-Hn.
2-t . ro e n. 307n
\lleurerti. ntonio. 206. 208. 2i7
\Jp rs. vet!ana. 30 n
Ammanati. Bartolom o. 30-
Ana r onte. -8 e n, O- 1. r?. 2 3
nadyom n (Afrodit ). 1 . 19. 20. 2 -t
Anclse. 3 L
\ndreini. I ab Ha. 291 n
ngeli _, i e l. l'.""0
Anueriano Cir lamo. 128. 131 e n. 135n.
141-1H
.\n Ime. 1. 8n
nticrono I Mon ftalmo, 101 e n
t\ntio o. 22n
\ntipatro di idon . 1 n
uonclli, Rob rto. 3 . n
Antonio da 1 mp , 80
p li di oo, 15- 1 . 19-20, 23-2-t,34n. 811
6 I, 9-t 100-101. 1 H. l 0-131, 13:311
1 2; 18811. 196. 20 . 213. 233-23-t. 2-l6.
25211.25-t.2 . n. 261-262. - .9.:...82-28-t
Aphthonio. :...9n
Apollo, 8, 13311. I i-17., 189. 19 , -
2 6. - 9 n. 30 . 313-31-t e n
Apul io. Lucio. -tn
Aquilano, crafino ( rafi110 d iminrlli).
2611 11 1- 11 :3, 11 5, 12: n. 13- n, l -t l -
142 11t- lt , 1 O, 18
rago11a, Alf n. o I d'. 9-t
\ rau na, El 11 ra cl". 102 n
ragona, iova1111a cl", :23.'" 23.
\ rn!!ona. J ...ahella 11". 11:3
\ra!!ona. \!aria cL 9-tn
\ra!!ona. Tullia <L 22 n. 2.-:fo. :30:3
\raldi. \le ...an<lro. 26 n
\ rbizzoni. Guido. 2?1n
\rddia. 1-t.3
\nlizio. ( urzi . 211. 2:30 e n. :31 :i-:31-t
\n i. Giulio. 1 on
\Mino. Pi tro. 30. 1 :J:'-138. 1-:'2. 1-:'8n.
189n. 200. 211-21-:'. 22.i 2%n. 2o0. 280-
281. 28-+-286. o:3. :311
.\r2an. .iulio ari . 93n
\r!!ia. 51 n
\rianna. 21 n
Luclo,ic . t lOn. 1 r. 11 ?. t -:'2n. 2:36
\ ri ... totdr. -:-:3. 20-t e n. 2H. 291 n
\rmida. 313
_\ rqu . Ro end. 138n
\ rrighi. Ludo,ico drgli. 232n
\ burCTO. Eli ...abetta cl .. 192n
\ hurgo. Ciornnna cl .. 192
.hhurgo. cf. 222
\, burgo. Rodolfo c1. 2. 311
\..cani . 313
..\tanairi. Dionigi. 206
\ tena. 20. 80. 111. 2. 9 .. 315
\dante'. 222-22:3
\ tlante maao). H
\ 1ti. I otta def!li. 102
\ wrurlli . .\ urrlio. 2_. -228
\urora. 2. -t-2. :-
1 . n. 26n
\\ alo . \ lfon,o d". 226
. h alo . Lo tanza d". 150 e n
h alo.,. F1rdina11do Fran 'I' co 1r_ 218-?19
221. 257n -
h alo . Ciorn1rni d". 221
Barl'o. \Cl. Dioni o
Badini. CatC' rina. 9911
'rre1wll a. :;:- 11 .. )9n. 62n. 6-t
Bajardi. \ndrra. Hn
Baldacci. ()()n
Balduino. \nnando. l 8611
Ballarin. \lr ...andro. 288n
Baltnhaiti . .lurgi . 1-+0n
Baudelio. \lauro. 1 .
Baran. ki. !!11111111 G .. 61 n
Barbaro. Danit>lt. 199n
Barbaro. F ranc1 ...co. 228 - n
Barbi. \lidwlt. 6011
Bare l . .\liqtwl. -t:3. 8 t
Ba chi. Paola. --: r 11. 16811. 2Hn. :30-tn
Barolini. 1odolinda. 6211
Barozza. Elena. 28:3-286
Barthe .... Holand. 2.):2 r n
Bantbchat. Joha11ne ... . .56n. 3811
Ba ... ile. Brw10. t 9(rn. 20:311
Ba,,inio da Panna. 9+%. I 02 r 11. 122. 1:{.)
Bath. \lirluwl. 22-tn
Batillo. 28
Battjfrrri de.,li \mmannati. Laura. :30:;.:rns
Ba,andall. \licharl. ?-8. 1.i n. 20n .. )2 .. )811.
69n. 9:3 1 n. 96-99
B atricr .. -9-61. 65. 21 On. 229
B1aziano. \go,,t ino. 22211. 2"27 r n. 28211.
300<301
B ccari. \ntonio (\laeslro \11to11io da Frrrara).
-i.n
B r aclrlli. L dtl\ico. 21?. 280-281
B rc-uti. Franrr-,rn. \d. Copp tta
Bcw. \ larina. '...01n. 231-2:3-t
Bfff a \urini. \ntonio. 18:3 r n
Brllrau. Rr111\. 28. 2.3? 1 n
Brllincioni. Bcrnarclo. ?9. 8:3 e n. 1
u.-
Brllini. Gentili'. l-t6. H8-H9
Bdli11i. Ciornnni. 112. H6. H8- I -t9. I h. -
168. I ?O. 1 . 8
Bellini. Jacopo. 99. 1 -+6. 1 -+8-1 -t9. 16911
B1 ll oni. Ci110. 66 r 11. 6811
Brltramo (pitlorr ). 1. 1 r n
Brml o. B1rnardo. 7-+11. 169
Brmu . Fra1wr ro. 292n
Br111ho, Pii tro. ;3 I. :}:3-3-t. 66-68. 7-t11. 9:3.
108- 110. 112 r 11. I 13. H6 (' n. 1 ;)611.
1 ,0. 16. -180. 182. 18.-. 189 ,. 11. :n2-
2:t-. 2-t 1 .... 6:3. 281. 28-i. 28?-288. 296.
:rno-:rn1
Bt'11assi . lessa11dro. I 9711
Br11ci. Cine\Ta dr. 7-tn. I 69. 27 2. 277
B1 nd!'d1i . Ti1110110. 1 O. e 11. 11 O. :rn 1.:302
Beni11i. , 'andro. 81n
Br11ucri . \Jr sandra. 117
Ben11irr. \d. Camhara. I olla
Brrnart dr \'r11tadorn. ;35 e n
Brrtolani. Maria Cecilia. 20n. -+811. ;)6 r 11. .- 8-
59. (> 1. 6+6.). 7611
Brrto111 . Giorgio. '.) l n. S.=}-58. 6.)n. 7-t
Be 0111i. Ottm io. 19'ln
Br. -,i. Jfo.,,,rJla. 6611
Bettarini. Rosa1111a. 3111, 55, 58-.)9. 6311
Brtt ini. \la urizio. ? . 18 r n. 20. 59n. 11811
Betu.'>i. Ciu-,eppt'. 21711. 2.1:- -2%
Bianchi. Hn. 18111. 191 n
Bianchi . .'tefa110. 19011. 29611
Bihhie11a. Bernardo Dm izi da. :3;3
Biffi. Cimarmi. I 07 t' 11. 11:311
Boccarl'io. GiO\ a1111i. 18-19. :36 e 11. JC)n. -t8n
Bocraniazza. Cio' am1i \11g lo. 215
Bocrolari. Giorgio. I 02n. 10911
Bonio . 'ewrino. I . 2n
Boiardo. \latteo \laria. 8-tn. 1:-6 t' 11. 251 r n
Bold1. Cio\'anni. I-+<>
Bolorr1H'he. Franro. 61. 6:3
Boltraflio. Ciorn111i \111onio. I H-113. 12-t n
Bolzo11i . Lina. 18n. 2-tn. -+011. -t?n. JOOn.
10711. I l-+11. 1:rnn. 1-111. l-t-:'11. 1:><J11.
17211. 181n. 18+ 185. 18811. ( C).)11. 20?n.
22911. 2-t511 . 27611. 27811. 28011. 28211.
28911. 29111. 2%11. 1 n. 30.)11. 211
Bo11elli . lsab Ila. 19211
Bongrn11i. Paoh 8-tn. 10-tn
Bo11 si. Lt' li o. l l ?n
Borga11i. Fn111crsrn. 25:) e 11
Borgh<s1. rnr li11alt. \d. Caff ar lii. 'cipionr
Diomrcl I -t0-1 i1
Borgia. Lucrrzia. :n. 102. I 09. 11 ?
Bor O<>'lli. Clurardo. 1 6 t 11. 20-t. 217
Borra. LuiCTi I 82n
BorromC'o, Barbara. 276
Bo chetti. I alwll a. 112
Botti elli . .'andro. 2. 1
Bottrigari. Ercole. 180
\lr sandro. 106n. 169 o
Bra ci. Cmhi110 (Francesco). 2-+5. 300
Bramante. Donato (Donato di cio cL\ n-
tonio). 11:3rn
Brf'!!llO. nwnio. 1-i9
Brembati. L11('i11a. 2?2
Brork. :30-tn
Bronzini. Ciornnni Batti-.ta. 130n
Bronzino. \gnolo ( \gnolo di 30+:30?
Brown. Da\ id \ lan. 8:311. 109n. 2?1n
Browning. R liert. 11?. :n9
Bruni. France. co. 32n. :3611. :38n. 231n
Biid I. Q,car. 81 n
BuUock. lan. 189n
l311onaiToti. \l ichclangrlo. :3311. +tn.? I . 20911.
2-t-i-2-+5.290-291.300.30-t
Bur khardt . .lacob. 288
Burgio. E11g111io. t:r?n
Burg . canli11alr. vd. \lrndoza. dc
Butad. 1.
Caffar lii. 'cipion (cardinale). 223
Calandra. Cian Jacopo, 11 0 11
:elio. 26n. ?O. 100. I 03. l t O
Calliro . 2.)
:alm ta. \"inc< nzo. 8:3n. 11 2 (' n. 11 -
Cn mbi. \I Conso. ln
Camilla. 278
Camille. \ lidwcl. 7711. I J . r n
Campa pe. \ d. Panca pe
Campb Il. ' t phrn J.. I 1111
Ca mpi. Brrnardi110. 218-220. 22-n. 2;)'?11.
2.6 Il
\ ntonirtto da. I 12
Ca11ace. -t8n
Ca11ali. Luca, 21n
annata. 16 - n
apilupi. Leli . I 8
Cappello. Bernardo. -t2n
.appello. \'ince11zo. 212-21-t. 216
.apua. iulio are di. 202-20
.apua. \latteo di. :.03
,aracciolo. iulio e ar , :22
.arado o ( ri . toforo Foppa), 11 : n, 286n
Carbone. Lodo,ico. 99. 101n. 109
ardini. Hob rto. 6-tn
ariani. io\'3nni. 2 :. 288
Carit o (Ben detto areth). :-o
Carlo r 16. 13 .. 198. :213n. 222
e n. 2:2?
Carlo L\ di YaJoi . 192n
arrafa. Ferrante. 16n
Carrai. t fano. 6611. 1-t9-r O. 1. -t-1 . -. 1 . n
Caruso. 'arlo. 21 n. 198-199. 20-tn. 311 n
asini. Tomm o. -9n. 209n. 31111
a io de .\1 di i. Gir lamo. 102n. 108 e n.
11-t-115
a oandro. 9;-
as -ola. Lui!!i. 2-t8n
Ca celicardo (predi atore frane ru10 ). 2.
a B rnardo. 195n. 19 . 201. 205. 224.
_.) .
Ca telnuO\'O. Enri o. 59n. 89n. 99n
Ca-;telw1 ro. L do,ico. 6 .. 69- o .. 6 e n. 8.-
11
a ti
11
lionr. Balda . ar. 1 . -18. 30
11
110.
11
;-
n. 18 -185. 191. 229-230. 263, 299
311n
a toldi. \la imo. 107
11
o tino. 199-200, 222 e r1. ,314 r
11
'at rina d'Au tria. 193. 210
Caltanro. Federico, 110n
avalranfi. Guido. 2:-0
Cedi iano. -2
11
' lia. 128 r n
Crllini. Benvenuto. 302 11. 305, 30711
<I o. 23.)
Cr-11ri. Cial'onro. 206. 208
326
,ere ara. Pari dr. 8611, 111-112. 1-t3 e
11
, I ;)3
n
etina. Cuti rr dc. 129n
hapman. I [u110. 2:30n
ha t lain dc .ouci. 3 11
h . a. ihia. -6n. 6 11
hiabrera. abri Ilo, 19511
hiarn i Leonardi . Anna :\1aria. 6-
,hiodo. Domeni o. 2+tn. 304n
hiorboli , FJzi . 18611
hrtien de 3;)11
Ciardi. Roberto Pa lo. 19611
ia" I Ila. :\la, i111 :32n
iceron . :\larco Tullio. 22n. 20911. 2-t:3.
280n.291
i cuto. :\farcello. ;9ll
Cidipp . -t8n
ieri \'ia. laudia. 2 1-2 2. 289n
illenio. Giornnni Tr ta. 1-8-1 :-o
imabue. 16. 61. .
ino da Pi toia. -tO--t 1. -t.)n, 2;0 e n
'ire . 313
'laudia110. laudio. 1;- -tn
'lemente. John, 28
lio, 102n. 262n
lizia, 228
' lou
11
h. e<'il I I.. 18911
I "-io, Giulio. 173-1 . i. 206. 208 e n, 24
o le . Bartolorn o. 20011
ola anti. Arduino. f' n, 281n
ollaltino di ollalt . 296
olJar ta. Marco, 10611. 180n. 2. 111 .300.
302-.30-t
'ollarile. Luigi , 7911
olonna. Giovanni. 24, 46 e n
olonna, Livia, 2 8
olonna. ittoria, 12511. 2-t.
omani.o.i. Cr gorio, 20311
'omboni, ndr a. 1. 1 rr . 1 7n, 30ln
'onti, I andro. 61 n
onti. Giu to df' ', 104. 15; -156, 162. 1 211
ontile, Lu a, 218 e n
ontrn1, iu11fra11co, 33u, 38-40, 42 n. 59n
'oor, crtnrdf' M .. - 70n
oppetta (Fra11 .co B cuti), 16n, 185-186.
2-t2 e 11
oppina, 120
oppini, O natella, 6-tn
rd llier, Dominiqtr . 93-96. 9911, 122n
Cornaza110, Antoni . 1-1n 15- , 1.-7 n, 1 2.
228n, :301-' 02
ornia, Laura della 242-2'13
orradini, Elrna, 100-101
orradi11i. Lodovi o. 1-t9-1:-0
orr "gio (Ant nio Il uri). 268n
orr g11io. \larnma (B atric ) da, 2 8 n
orr ol' da. 1-n. 23 n. 1 O-t-10-.
JO'J-11-t, 12 n. 13111. 133 en. HOn, lH
H n, 15;3 e n, 1-7. 163, -28n, 308n
or o, nt nio, 17n
Co mico,
1
i ol Lelio. 79
Co a, Fran co del, 149 e n
o utta, Fabio, 6511, 80n
o ta. Lor nz , 11O-111
o tamagna. Philipp , 61 n
mrna o, 22 e n
Cox, ir11inia, 22 n
ri eida, 36
Cri. ero, vd. Bronz10
Crivelari, Bart I m o, 85
Criv lii Fran o, 31. 22_ e n
Cro . B n d li , 19011
Cropp r. lizab 1h. _Q , 231 n, 289. Q;)n
ruz, Juana I11z de la. 209n
upido,27-28 43n 8-.9, 111n, 129, 132n,
143, 26711
urtiu , Ern. t Roberi , 7 n, 101. 202 209 e n
urzi Lan ino, 107 e n, 109, 113-11-t, 124
D le andr , Fran ca, 180n
Dafn , 77-78
Daf11 , vd. Bnttiferri, Laura
Damianaki Hornano, hP' a 107-108 116 e
n, 1 1n
2
Danae. 190n
Dani le da Volterra (Dani I Ricriarclli ),
180n
Dani llo. Bernardin , 19n. 58n. 62n. 6. -68.
?On. 3. 2-t3 e n
Dati. Leonardo. 96
Davanzali. hiaJ"O. :33n
Davidr. 18011. 313
D Laude, ihia 3-i. 41n. 51n. 62n. 127n,
r3n. 2. 1n
O Predi . Ambrorri . 286n
D Roberti . Dom ni o. iOn 60n
Decembrio. An.,el . 30n. 99 e n
Decio, A"o tino, 18n, rin. 2. 3 e n. 2?:- -
2 . . 2.9en
Dedalo. 20
D lbouJ1e, hiJJ 28n
Della Ca a, GioYanni . 162 n. 16 . 16 -168.
1 2-182, 212, 22-tn, 22.n, 241, :....5611.
273n,284, 296
D Ila Rovere. Fran co Maria. 189n, 21 i .
Dehninio, Giulio a.mili . 23-tn
Demy. Ja qu .
D ucalione, 1 O
Di Benedetto. Arnaldo, 18211. 305n
Di Girolamo, o tanz . 35n
Di Rienzo. lina. l 18n
Diana, 1 33, 11L21 L 260
Didone. 21n. . , i .. 10311
Dilemmi. Cior.,io. 1 311, 18011. _38n
Diomed , 36
Dioni o, 22n. 2=-, 1-t e n
Dioni ottL arlo -t , 6611, l-t6n. 16 n, 168-
1 . 17911. 19911
Do.,lio, [aria Lui a. 22-n. n, 28211. 0-tn,
O.n
Dolce. Lodovico, 1 .. 21
D nati Lu rezia. 16011, 1
Donato. nica., . n, -911
Donnil. ndr a. -tn, 1 8n
Do i, Do o. 100
Dotti. U"o. 3 11 , i n
Drm -.hout. 'larti n. 2-t
Du J achim. 18.)n
Dii llwrg. \ ngelica. 1:38n
[ , . ?811
Ea,dak<'. Charb. 22 -2:30
Eg< ria. -t8n
Elrna (di Troia). 19. 5111. 1.-o. 18011. 209.
211. 2:3 1-232. 2.-:2-:253. r :- . 201-202
El iocl ora. 3-t
Eli-.ahwa I T udor. :3 1 :3 t' n
Ell rro. \(aria Pia. :20211. 2-t8n. :2;)011
Endimio11e. 33-3-t . :-o. 161
E11rH. :37. -t .. 238
Enri co lii <li Yaloi,. 189- 190
Equir la. 'lario. 111 11
Era mo da Rotterdam. :302n
Ercole. 20-21. 10 .. 220. 222-:2:2:3
rei... , c1. Cupido
E-. tr. \lberto .-\ zz cl". 100
E te. I d". 102
. Beairic d". 80. 83n. 10-t e 11. 111 - 11 2
11"?. 1:29
E te. Bor"o d". 66. 9-t. 100
E tr. Frcole Id". 9-t
Ila d". 31. 10.). 108-11 O. 18-t. 233-
2:3-t
E tr. L1011 Uo d". 9-t. 99. 10211
E. Il'. \ larfo.a d". . 1 n. 195
E t . \ irol fil d". 99- 100
E. t ic1111 c. 11 nri. 28. 25.
Eufn111orc. 100-101 . 2;3;fo
Eut rpt. 262
EHI. -t:3. 81
Fanizza. Fnu1ro. 30n
Farnwr. \ orman K .. 2-tn
Farn C'. \l r,, anrlro (<"a rdinalr). 1 :3. 206.
20811. 212
h1rnr 1. \lcs a11dro (1011dotti rro). 20:311
Farnr f'. Odoardo (c:a rdinalr). 223 c 11
i'arnc-. p. \'ittoria. 191
328
Farnetti. \I onica. <>:211
Fau,ti11a. 2? 111
f< ho. 'd .. \ pollo
Frdrri co 11 di , \ nia. 3 .
Fccli . Hoberto, :30;)11
Felclman. \ lardw. 29211
F1' li < iano. Feli ce. 1-t9n
Fr nzi . Enrico. ;).) -.)(>. (J.)n
Fco. \l ichclc. 8Clll
Fcraho,... Gima1111i \ndrea. 100
Ferrari . e' Prino. 28n
Frrri. F errurci o. I 02n
Ferroni. ,iulio. lMn
Felontr. ?O. 1 OOn
Fiammr tt a. 18- 19. :39
Fidia. 16. 20. 2"?. 0-t. 9911. lOln. 108. 128.
1:nn. 1-t9. 20-t. 21?n. 22:>n. 228. 2:>2n.
2.- :11. 2. 1
Figino. Gi o, anni \moro:rio. 19;}-1 %. 20:3-
203. :20 . n. :21 7. 26-:' -268. :2-:':3n
fil rlfo. Francr co. 06-6 ?. 69 r rL 80. 99
Filippo Il d. \ sln1rgo. 21 7-218. :22. -2:26
f ilossPno. \larcello. 79n. 11;)
Filo trato. 1 . n. 29-:30. :206 e 11 . 2:32 r n
Fiorio. Tr r 11 .)11. I :2-tn
Firr11zuola. \ g11olo. 235 r 11. :28711
Flarnini. Fra111Psco. 15 ln
Flm ia. 301
Flt'tchrr. J nnift'r. 16911
Flora. 1 :Bu. 2:31. 26.- 11
Fokhcllo di \farsiglia. ;37 e 11. 7711
Fontana. A1111ibalr. 220. 2:-33
Fon i. Giacolllo. 1 -8- I -t9
For111 11 io. Gi0Ht1111 i Franrrsro. 21611
Framhotti. Paolo. :29611
Frane . ca ( 'rnia r). 1:-0
F ranrc. co di Paola. , 'a11. 1.)0
Fnrnc eo I di \ 'aloi . 7911
Fra11 co . . \lic'rolb. 78
Franco. \' ron il'a. 189-191. 28011 . :290-292
Fra Gius<p1w. 79-80
Frati . Lodc)\irn. H 9n
Frrcd111 Ul, Luha. 811
Friedril'h. I lugo. 2811. :22:311. 2-t-t n
Fri1u. I ?
Froissart. .I ran. :3611. 1-tO r 11
Calui1lio. 70
Galani . CiusrppP . 2u:3
Cairota. I ra1He,..ro. I;)()
Caleotli. Pirr Paolo. :2 . 6
Gahot10 drl Carrrito. I t:3n
Calla11d-l P1 rri111. :)On
Callernni . Cecilia. 11 I. 113
Call i. i\ngc- lo. 9:3. 96-97. 99. 10 1.
11911. 1 :28. 13 1 n. 1-t I r n. 1-t611. l-t8. hO.
2:31 . :2:3:3 ( li
Callinaro. Ilaria. 2811. :2-t<>n
GaUo. Filrnio. l-t.)-1-t6
Ga111hara. Isotta. 189
Gamhara. \ eronica. 188-189. 217
Gargano. \ 11tonio. 12911
'
Caurico. Pomponio, :30n
Celt i. Ciovan Battista. ;) . . 61. 67 .. 1-74. 1:-?.
:2-t:3-2-t-t. ;30;3 (' 11. :)Q8n
Crntilc eia Fabriano. 97
C ntili . \ ugu to. 11911. H 3n
Crrolamo. ,' an, 9:311
Ce. ualdo. Ciornn \ 11dr a. 5?n. 66-70 . . :3 e IL
7() (' li . 79. :2-t:3
Chirla11claio. Dome11iro (Dom nico BiP'ordi }.
:2 11 1. :2 o. 28611
Ciar hi no. Lui r ll a. 29 111
Ciaromo da L ntini. :3? I' 11. -t011 . I :2()11
Ciga11 1<'. \11 to11 io. :...80
Pictc r. :30211
Giolil o dr Frrra ri . Cahrielr. 78. 1M>
Giorgio. , ' un .. -t11
i rgion . l-t6. 2 . 2. 27?. 288. :mo
Ci ott o. 16 61. (H . 97-98
Cio, a1111a regina di l\apoli ( io' anna I d'An-
gi o CiO\ anna Il cl ' \ ngi- Durazzo). 210
Gi ovunni i\11t onio da Pa\'l. -o
Ciovt'. vd. Zr u.
Ciovio. Paolo. 199-200. :202. '.20-tn. 20911 .
222-223. 22811. 30-t n. 310-311
Ciulio III (Gio,a1111i \laria Ciorrhi drl .\lo11t1 ).
2-t 2n
Ci 11l io Ca mill o. vd. Drlminio
Ci unta. Claudio. :>7n. 9111. 11 . n. i.- 1 n
Ci11 tin.ia11. L1orwnlo.
Citr..tinian. Nllto. 1'."6 r n. 18-:'n. 2 :. j' n.
29.5
Coff P11. Rona. 1 . 811
Golia. 18011. :3 12
Conzaua. Camilla. 108. 1::3- 1 . -t
Conzaga. Camil lo. 276
'
Conzaga. Curzio. 17211. l 78u. 18211. 25.) t' 11
Conzaga. Ell'onora. 19? n. 21 . n. 23611. 281-
:28:3
Conzaga. El onora de \l rdici. 19:3. 21011. 28.
>Onzaga. 11 5. 1-H. 171 n. 18:3. 298
Conzaua. Ferrant . 19:>. 222 e n. 260
Conzaua. Franrr-.co IL 111- 11 :2
Gonzaga. Gionmni. l 08
Conzaaa, Giul ia. 195. 20?11 . 2:3<>
Gonzaga. Ippolita. 21 . n. 2. 6
C nzaaa. riia. 31:311
Conzaaa. , ci11ion . 18811
"
Conzaua. \'incr nzo. :3 n-:31-t
Corni. Cuglirl1110. :3111. 60-o L 92-93. 11 ?11 .
1 ?0-17:2. I. 811. 186- 18-:-
Co-.elini. Giuliano. 31 11. H n. 1 %- 1 %.
217-21 . 22 1-22:2. :22;)_ 2-t8 t' 11. 2.- 0-2;; 1.
2:):3-2:>-t. 2;). -2:)8. 20: Il . :2 .; -27-. 27<> l'
I l. _79 (' Il
Co1tifredi. Rar1olornro. 120 e n
Crad nigo. Ciorcri . I 9"?
,rrcnhl att. .'tt'ph 11. :3 16-:{ l?
(, . ' 1" ""0 "
1
60 ) 6
.rrgon. ,\ ma. -- n. - n. - . n
Crifo. \n1011 io. :>?. 7211. ?9-8 .. 112-113
, ri !maJ. \Inria \ntonit Ila. 1-t:>n
Crillo . . \ ngtlo. 20.S
roto, Luigi {il Cieco d' Adria}, 29ln
Cualt rruzzi . Carlo. 1.3 n. I . n
Guarino da \erona. 9:3- 9-t. %. ()9-100
Guam lii. \l('s::.andr 20 . -20
\11nihale. 2-+, 192-193. 302e11
Guillaumc dc \larhaut. 36n
uisa. .arlo I di. :..11
uittone (L\xezz , :..O e n. 36-
Hacr::.trum. Jcan I loward .. 1 n
I lardi n. B nn rt. 2Ln
Tom. 2 On
I lcrdcr. J hann ttf ried, 228
IIill. G ora Fran i . 93-9-+. 1-+0n
llirdt. \\"illi. -9ll
l lirpino. Enea. 181 n. 25511. _68 e n. 2 -
298
l lollander. fohn. 206n. :.. .. n
11ui. ,\ndre\\. 18-n
llutton. Jame . 21 n. 26n. 10011
lanuale. Raffaella. 116n
Ili ino. B rnardo. 66 e n. 150
Ippolita. - 8
Isabella d".\,iz. 22.
I ab tta. 1;-5
I Ila. DanL . 12-+n
bible .. 1n
Jack on- top . Cerva e. . n
.lager. Erir. 32n. 3 n, -t3n
Jrzabel. 313
Jon on. B n, 2-+
Joulo, ky. Fra11oi . 263n
Kirkham. \'i toria. 30 11
Koo . \Iariann . -88 e 11. 30.-. 308
Kranz. hert. 8 e n. 9111. 202n
Kri gcr. \1urray. 22-tn
K1i . Ern t. 8 e n. 17n
Kru e. 'hri tian . 138n, 21411. 216-21
Kur.r,. Otto. 8 n. 1 . n
Lai'. Loui r.209
Lamo. le andro. 21811
LanC'rlot. 136-13
Land. \'ornian E .. 7-8
3 o
Landi d' , 2 On
Landino. ri toforo, I@ n
Laua dijk, Karla, 1 n
Lanao ca. Marah rita, 1 3
Laodantia. 18-19, 31 ,
Lai Girumi , iO e n
Laca ( Itonfrance r razzini ), 30 e
11
,
30 . n
Laura. 8. 19-20. 28n. -+3-H, 48-6 . 69-8
89, 93. 11111. 130, 150-l L 162, 16 .
169-1 o. 1 -1 6. 179-180. 182. 185-
186. 190n 210n. 22 2-t2-2-i3, 29611.
303n.30 .
Laurana, F ran co. 106-1 O .. 116n
Laur n . Pi rr . 20011
La,i11. In-in, 1 O u. 30011
L cercle. Fran i . 2:-2 n
Lenzi. Lorenz , 30-t
L onardis. Ja opo, 86
L nardo. da \'inci. 83 n. 113-1 H. 1 +t.
169. 231-233. 1-2 2, 2 7. 302-303.
309 e n
L oncia. 143
L one (Giornnni d J\1 dici ), 18- n
L one. Ambroaio. 106-107
L on.i. Giovan Fran o, 255n
L oni. Leon . 218. 22. n. 254 e n. 255n .
260.30-t
L onida di Taranto, 1 n, 22n
I onzio cola ti o .. O
L oprudi. Ciacorn . -31 n
L ing. Gotthold phraim, 206n
Lib rale da rona, 1 O
Liburnio. 'iccol, 146, 229 n
Licino, Giovan Batti ta, 196. 217
Li one. 21n
Li urgo. 21n
Lilia. 145 e 11
Li. ippo. 20-21 , 101 n. 10. 114.
22.-n 252n
Livio. Tito 289n
Lomazzo. iovan Paolo 7. 218, 273n, 289n
Lombardi Jf on o, 108
Loniliardo, Tullio, 106
Lonahi , llolwrto. 6:3
Lonahi ' ilvia, 1:31n, 17111
Lo1111iano, ba ' lia110 auto da. 66-6
Longoni. Cri stoforo. 109
Loredano. Giovan France o. 11811
Lotto. Lor nzo, 271-27 _, 2 . 28911
Lu a, a11 . 61 e n
Lucia ( 1onychina) , 12-t
Luciano di -2n. 29. 232-23-t
Lucrezia. 51 n. 103, 289n
Luiai Xl di \'aloi , 1 S0-151
Luiai , lll di Borbone 101n
Luiaini. Fedrrico, 23-t-- 3:-
Luti, Ginevra. 6611, 150
Luzio. le andro, 10 n, 109n, 111n
Ly ippu (medagli ta), 140
Ly i , 17811
\la la, l\ovclla. 288n, 30-t-30- . 307n
i\lacro. vd. Maar' . Vin enzo
1addal<'na, 2-t6
Maff i. onia. 199-200, 203-20-t, 2: -in,
30-tn 311
faggi , rmand , 19 n
faano, e fio 186-188. 292-295
Maano .\1arco Antonio. 2 6n
Maar, in nzo. 31 , 232-23-t
.\laira, Daniel 8- 9, -3 ln
MaJa pimt , 1dd a. 61
Jalat ta, France o, 111
1alat ta , igi mondo Pandolfo, 102-103
1alinv rni. 1a. . imo, 8ttn, 90 e n. 12-tn, t:3 rn
Malpiafi ' iccol, 151 n
aJvito Tomma o, 106
Mru1ra, Jo ph, 1 OOn
1an ini, Frane , 32n
Manf rl tti , , t fono 29 u
Manfrrdi Muzio, 193-194, -O Tl 21 On
Manfrrd dr lonf rrato, H3
'1
Mann. icl1ol a . 16n
Mantanari , Laura. 305n
Iantrroa. Andr a, l 02. 16-n. 300
Iar "Anto1tio da l'rbino (mu ico). 21:-
i\1arcband. Jean-Jacqu . HOn
i\lare,rotti. Gior"io. 195
i\Iaraherita. ama .. in
i\laria. 61-62. 80-81
Mariani Canova. iordana. - n. 80 e n. 82-
83. 95n
.\larino. Giovan Batt i:.ta. 21 n. 3311. 191. 196-
199. 201 e n, -0-+n. 20. n. 209-210. 222-
22-i. 25. e n. _6 . -268. 2 9. 31 1-313.
3rn
.\1armitta. Jac p . 191
.\larot. lmem. H
i\1ar1. 1-+9. 221.22-t. 29-+
Mart Ili. 1
\1artelli. Cgolino. 30-t-30-
.\fartelli. \"inc nzo. 1 n
.\farti . .\Iario. iOn
.\larna. Ferranl . 21:-
.\fartinelli, 13 rtolo. l 13n
\IarLini, imone. 8. 3-tn. +-6 .. -8- -9_ 61.
3.6.-69, .1-7 .. 78.80 82.85.87.92.
125, 1-18, i-0-151. 161-162. 16.-1.0.
1 6, 180-18 L 186n, :..0-t, 1, 2-t3 2-t6.
255
Marullo, i\fich I , 91 122- 12
larzial . .\larco \'alerio. 2:2-2-t. 2. O. 308
Marzio. Galeotto da 'arni. 300
i\fatraini. hiara. 181n
\fatt o di GiO\'Hlllli. 1;)0
i\fazza B azzi Brubara, 292n
.\kl auahlin, J\m1in, 61 n, 296n
n.:31'
I di i. Ale andr d . 61
dici. o imo I dt. 30.
ledici, Fcrdinand T d '. _. 9
.8. I in.
:3 n
.\lrlt'H"l'O. 2-:'. 35
\klitr. 2;)
\lenanclro rr1ore. 20 e n. :Nn
\lrnd<'bohn. Leatricr. 2+tn
.\ll'ndon1. Dirgo I lunado de. 129n. I :3?-138.
21:>-216
.\Jrncloza. Franci ro dr ( car<linall'). 21.)
.\ lrneghmi . .\Iaria 39n
\Jrntorr. I O l n
.\lrrnirio. :3 I -t11
.\fichirl. \larcantonio. 16Qn
.\licito. 2211
.\lilani. 2Q ln
.\linen a. nJ. \tena
.\linonzio. Franco. 199-200. 223. 22811
.\li110,,e. 3-t
.\linturno. 6611
.\lironr. 2-:'n. 2911
.\!olino. \iccol. 212
.\lolza. F ran e' o .\fa ria. 108. 195 e n. 207n.
2+t11.2-+6n.303n
.\londrlla. Girolamo. 12 . n. 13 . 301 n
.\lontaguan.i. 'ri-tina. H911
.\lo11talc. Eucrenio. 91. 231 n
.\lonteC ltro. Emilia Pia da. 115
.\.lontefrltro. Federico da. 9'.3. 9; n. 98. 100.
102-10:3
\lontrfcltro. Guidobaldo da. 11.-
.\Jorgain. 136
\loro. il. 'd. , 'forza. Lodovirn
\lortimer. Ruth. ?811
.\fotta. l l>l'rtO. 116 C 11. r2n. 298-299
.\lottola \lolfino. A.Jr . a11dro. 9-tn
ini . acd1i . .\!aria Pia. 91n. 106n. 116n.
121n.2:Dn.298n.31ln
\luzio. Girolamo. 19:3. 20.n. 21011. 226 ,. n.
2:30. 2:36 r n. 5:3 e 11
.\luzzanlli. iornnni. 11 O. 115. 2:33 ,. 11
\ani..,o. :12-:n 161. 302
\atalc'. \lauro. 9-tn. 1 -t9n
a' \ndrra. 2411. 301 e 11
332
\ il\ azzotti. Orazio. 2-t8. 2.)8. 2(>5
\egri . \nna \!aria.
\ er ro. Emilio. 11 On
\ <lii. I I 6n
;\ irol' , an. 1 19
\ifo. Ago tino. 2."";) r 11
\ iohe. 21. 26. :3 H
\oot. Ja11 ' an der. . 7 n
\ owri. B atrice de'. 106
\uti. Giulio. 1 <).)
\u,oloni. Filippo. 16211
O"Brie11. fohn. 28n. 2.3711
da Cubhio 61
limpo da 'a..,..,ofrrrato (Balda.,-.arr Olimpo
d crli ,\J ,..,andri ). 1-f3. H6 11. 2:31 e n
Omero. 16-17. 22. 29. 179- 180
Onoria. 229n
radino. Lucio. 21711
Orazio. 108. 1.):l 1 . 9n
rfro.:.. 79n
Orgilk I 18n
Orsini. Giaromo. 96
r ... ini. Latino. 20:3-20-t
\ 'ircrinio. 20. 188 e n
On . .Taro po. t 88
Onieto. Paolo. 160-161
o, idio \a one. Publio. 1-:'-19 ... 11
Padur1110. Guido. 2:>n. 2. n. :r
Paladini. Filippo. 19$
Pallade. vd. \te 11a
Palla, icino. Ferra11tr. 11811
Palrna il \ ecrhio (.lal"opo \igretti ). 2.'31 n. 28CJ
Pa11ca.,pe. 1 .. 61. 262
Pandora. 2 8 1 11
Panetti. Batti'>ta. 102
Pani arola. Francrsco. 196 e 11. 20:311
Panizza. Lct i zia. 29611
Panno11iu . Jan11 . . 300
P:wof .,k y. 2 11. 5:-. 2-+:3 r li . --+5. 2;) I
(' Il
Pantani . Ital o. 1S 1 n, lSSn. 15 li ,
Pantea di \hradata). :..:32 <' 11
Pantea. 2:)2 r n
Panurcio dl'I Ba"no. ;39 e n
Paride. 18011, 262 <' li
Park1r. DC'horah. :30-tn
Parra..,io. 17. 100-101. 2:3-tn
Pasqualigo. Luigi . 121 I' n. 169
Pasqnazi . , ' ikio. :10 1-:rn2
Pa..,quiPr. 1t 1i nne. 109
Pa..,ti . \lauro de". 102
Patillon. \lichel. 28n
Prdrrso11. Jill. l hn
Pecl ulli1. \11na \laria. 11811
Prga..,o. 2 . () r n
Prnt'lopr. 19 e n
Pl'retti Or,,ini . Flavia. 22? o
P1ri . imo. 8n
Perilli. Plinio. 930
Peri11i . CiO\anna. 217n
Perosa. A l1ssandro. 1 :Hn. 300n
Pc rugi110. Lautitio. 2:3211
Penwino (Pi etro \'annucci). 111
Petrarca. Frane e . 8. i.- -16. 19-20. 2-t e
11. 2811. :32. ;{5. ;3. Il. i2--t6. i9-;}2. ;)-t-5:J.
5 7-66. 70-7.), 78-82. 8S-87. 89-9:3. 1 I -
1 18. 128. 1-t8. t ;}0- 131. 1;) ?- 1 ;)8. 162-
16:3. 165-170. 17-t-175. 17()-180. 201.
208. 228-229. 23:3 e n. 2:3;. 2-t 1-2H.
2;) 1, 2h9. 281. 286. 289. 296.
:307 (' Il
Petteruti Pdlegri110. Pietro. 21811
Pfi,.terer. l lricli . 1-+0n
Pian11zn, Giovanna. 26811
Piatti . Piatti_110. 11-+
Picrnlo111ini. ,\l1,.sa11dro. 201
Pich. Federica. 60n. 28711
Pier cl!'lla \icrna. :3911
Pieri , Marzio. 20111, :H 1-:) 12
Pirro drllu Franc<'"ra 100. H8- H9. 272
Piero di Co..,im (Pirro di Lon nzo di :himen-
ti). 271
Pi"malionC'. 1 . -18. 32-:33. 48n. j7. 39. 69.
r-99. 107. 11811. 132 e Il. 1j7. 161. 17011.
207n. 22511. 29-t. :302
io,an 11811
Pi"11atclli. A ea11io. 17011. 25011. 29211
Pi<matti. Franco. 1 3n. 206n. 2-+611. 25511
Cl
Pincaro. Giornnni. 112
Pindaro. 17911
Pino. Paolo. 16 .
Pinluricchio (B<'rnarclino Betti ). 1-t 1-1 H
Pirirotelr. 16. 101erL2Tn
Piroo. 313
Pirra. 107
Pi anrllo ( \n1011io di Pu cio Pi ano). 93-100.
103. 122. H8
Pi.,ani Quirini. Chiara. 1 -:'811
Pi-,ano. GiO\ arrni. 62
Pi . ano. :'\icola. 62
Plalon . 3:'ln. 5:- ri. 68 .. :... 23-tn
Plazzotta. arol. 2:3011. 30-t-305
Plinio il \ ' cehio. 15-1 .. 22
Plotino. 27
Plutarco. 2211. 9;)n
Policleto. 19-21. 2;. 5-+. 5 .. 62. 69. 1O1 n.
1s:-. 1-7. 18011. r:-. 271
Polia11010 di Ta o. 26, 23-t11
('
Polk ena. 21 r n. Sin
Poliziuno. \11g1'lo. 15-tn. 16011
Pollar<l. raharn J.. 10911
Pommirr. 8 e 11. 1911. ;)9n. 61-62.
92-93. 10111, 1:3811. 162 Il . 17611, 198
11. 211 e li. 21 Clll. 2 ln. -8111
Pontani. Filippo \!aria. 21-2:..
Poman . Giorn1111i. 106
Pontormo (Jueopo Cani ci). 61 n, 300. 30-t
P nlr moli. \l ts,,andro. 28911. 29.n
Pop -llernws. John. 10 ln
Porr llio ( ' iorn11nanc nio d( Pandoni). C}-f e
11. 9)
Poni none (Cion11111i \11to11in de' 'ard1L ) .
22?11.288
P(frino. andol fu. 193. 268 t' 11
Porlo11nrio. \larco. 46
Pozon , \ngela, 6611
Pozzi. iova1mi. 8 e n, SO e n 16911. 231 e 11.
265n.289n. 09 n
Pras it le. 19. 2 -2 .. 69. 10111. 128. 131. 2. 1
Prete. Antonio. 120n
Primo. \lar o .\ntonio, :22-23
Pro li, Paolo 18-tn
Proco di Paolo. r
Pr un . 313
Prom teo. 96 n, 20-t
Prote ilao. 18 n. 31
Procoueoe. 1-. 238 n
Pulzone. cipion . 191-192
Quintiliano . .\lar o Fabio. 22n. 29. 209n
QuirinDI ola.Elisah rra. 1.2-lT, 1 8-179,
182. 196.283-28-t
Quirini. Girolamo. 1 . 9n
Quiviuer. Franoi . 2Hn
Quondam. Am deo 16. -166
Raffaello. vd. anzio. Raffa Ilo
Raimondi , \"in enzo. . n
Raineri. Antonfran eco, 201. 218. 222 e n,
253-25-!. 256n. 2 8 e n
Rama. Elena 11; 11
Reinach. dolph . 1. n
Re1er. Rod Uo. 105n. 109n. 111 n
Re idori . .\1att o. 2-t4n
Riccio. nt nio. vd. Bre!!Ilo. Antonio
Riccio arlo. 1611, 252
Rico, F ranci o. 6-i
Rilke. Rainer .\f aria. 229 e n
Rinaldi. e are, 126n
Rinaldo 11 O n
Ringbom. Lxten. 2 2n
Rivol tti. IU"i tian. 199n
Robin. Diana. 23511
Rouer . \lai). 208 e n
Roio. :\ico tta. 11 On
Romano. Gian Cri. toforo, 83n. 11 O, 112
334
Rom o i vanni , 10211
Ron ni Lu a, 119 e n
Ron ard. Piene d , '... 2E n
R and. D3\id. 195n
R ali. Gianpi r . 1811
Quinto. 2 0-291
R cnthal, Mmraret F., 19011, 29211
Ro nthaL Olivia 77n
Ro etti. Dant abri I, 61
Ro i. Antonio, 12111, 12411
Ro i. Bernardo de', 27 -
Ro i. Fran o.'... . n
R ta. Berardino. -8-i9. 123 128. 15111
R ta astelletti. \'ittoria. 2 6-- . . . 2. 9
R thk . .\fark. 2.0 e n
Houill'. Guillaum . n
Hou et. Jean. 39n
Ruffno. Ale andra. 201n
Hufino. 2-n
Ruozzi. Gin . -6n
Ru ll. Daniel .. _ 2n. 31 n
Rylands. Pllip. 23 ln
abbatino. Pa qual , 1 n, 25211
abeo. Fau to. 311 e n
ab tide, 2
adol to, Jacop 11 O, 115
almoneo. 26
annazaro. Jacopo 106. 1 -n
an O\'il10 (Ja opo Tatti ), 22 n
antauata. Mar o, -O. 4 n, i9n, 52n. 57-58.
6-i. 90 e n. 1 5n. 16'."' -1 6, 1Tn. 1. 811
anvitale. L onora, 198n
l an itale, i ola, 268n
'anzio. Raffaello 7. 108 116, 182-183.
288 2 1.301
a o. Panfilo 11 , 135-136 147 e n 1 1-
152
auli, famiglia 2 8 n
aund r, Ali on, 231n
a iozzo ( imon rdini da .. i na), 43n
arlo Emanu I f di 273n, 313
avoia, 'fomma di, 12-313
avorunan Maria, 168-170, 178. 182, 234n
t'l
calig ro, iulio ' ar , 11 n
11dola , tario, 2211. 2-in
carpa, 111a11uela, 176n
arpati. ' lauclio 281n
cve, Mauric , 9n
eh r, tephcn K. , 140n
cblo cr, Julius. 7 e n
chmitt . Lothru-, 302n
illa. 4811. 313
copa. 101 e n. li
colli. Angela, 1 n
cud' ry. rg de. 16. 3 e n, 10111
eba liano del Piombo ( ba;,tiano Luciani).
119cn,
econd , cilio, 23-2'i
eah zzi. nton Federico, 172n
enoclc, 22n
forza. Al an lr . 128 n
forza. Batti ta. 100. 102, 116 e n
forza. Bia.n a .\1aria. 10-l e n, 113. 129 n.
28611
forza, o tanza 120n
forza. Fran co, 96, 102. 151n
forza, Gian Caleazz , 113
forza. Lodovico, 9-80 104 n 112. 113
e o, 28611
hakepeare, \rilliam. 24. 20 n. 31
hapir . .\1 r r. 300 n
h arman John -8. 21n, 300
iddal , Elizabcth. 61
oeratc, 9.- r n, 2 -in
olario, Andr a 109
3
, oleni, Anael . 196n
ordello da Coito, 3 -36
or l. 'harl . 1 8n. 233n
parrow. John. 1 :} +n. 300n
' perandio da .\lant va, 10_. 109
p roni. peron . 303 n
pilimb ruo. Jrene da. 196-19
pinclli. IIetty. 99n
pini. Gh rardo. 30. n
pinola, AmLr "io. 224 e n
quarzafico. Girolam . 66n, 80
tampa. Ga para 18-n. 209. 29 e n. 29- -
29.
teinberu.L o,61n
t rzi. Fabrizio. -i8. _6- --66
tiglim. Tomrn o, 198 2 O e o
tiller . Rainer, 199n
toiclta, iclor L 1 n. 190. 119
trato1ce. 25
n lke. ari Brandon. 61n
trozzi. Ercol , 1 O . e n. 110.
nozzi. Tito \'e pa ian . 93-9-t. 96, 109. 134
n
tufa. igi mondo d Ila. 109. 300
wtee Vinrinia, 61 n
\' nbro. J p r. 30n
Tac one. Balda . arr. 113-lH
Ta Id o. Ed ardo. 292n
Ta !!i . Paolo. 113n
Taide. 1 -+ e 11
Tanturli. Giuliano. 1 3-1 . -+. 1. 6 n, 1 9n.
2Hn.30-ln
Tanzi, Fran e o, t 1' e 11
Ta o B marcio. 230. 236
a o. r ole, 19.n. 231n
a o, Torquato. :..O n. - n, 0-71, 120n.
L n, 165. 168. 18- e n. 18611. 188 e 11.
I 90-192, 19 -1 .. :201-:20-t. 206. 211 n.
1-2:...:... . 2- n. 230n. 2-t n, '.... 8-2
28 312-31-t
. aumar ta. 1
Trhald o. \11ro11io ( \ntonio Trhaldi). l (m.
20 r 11. 2-tn. 26. :Hn .. 9. l 0211. 106-108.
110-111. 12-:' t' n. 1:30-1 :3:3. e 11. H:3.
I 00. 13 . e n. 182. 18.). 2-+311. :rn 1-.302
Trmpr:>tini. \nchi:ie. J 7811
Teodora. 2+25
Teoclor . :30 In
TMg11eto. 2.)
Trti. :312
Theon. 28-29
Thoma. 59
Tho1won d ,rummond. l 9.)11
1hullo. 2'?6n
1ma11te. 100-101. :ns r n
Timomaco. :26n
Tina gli. Paola. 21 On. 28611
Ti11tor uo. Domenico. 1:3211
Ti111oretto. Jacopo. 190n. 28011. 290-292
Ti cmi Bem nuti. \ntonia. 10:-11
Tiziano Ye1ellio. 7. 16. 1:38. 16-:'. 1-:'2-176.
1.8 e n. 180. 212-21 .. 236n. 2-t6n. 280-
285. 288. 290-291. 303 e Il
Todrri. Giusrppe. 102n. 10911. 27611
Toledo. El onora di. 30.-
Tol:itoj. Le\. :31
Toma .. i. Franco. 9211. 166-16 .. 17-tn
Toma ini. Gia<'omo Filippo. 29611
Tomiri. 103 e n
Tor lii. lppolita. 229-230
Torelli. Pomponio. 1. O e 11. 191 r 11. 1 %11.
2. -+11. 28'?n. 291 e 11
Torre. Andrra. -Hrr. 50n. 711. 18111. 19111
Tourrw .. Jean dr .. 8- 9
Trapp. Jo eph Bwnev. +tu. 5. n. 5911 .. -t -79.
8.- Il. 151 n. 16911 .
Tm i.,an . .\larc',\ntonio. 21-t-216
Tnno. fa<'opo da (JaC'opo \izzola). '176
Tri ,i110. Giovan Giorofo. 29. ::l 1. 112. 18-t.
189. -2611. _:32-23.). 2-+2. 2:- .311
Tri. ta110. 3.)11 .. )9
'l-oi olo . .36
Trornto. Paolo. 66n. 166n
' lrra. 'o nrr. 134 Il
336
Turchi . \la rcello. 18111. 2:).)11. 26811
Turchi Pia. Li, ia. :3 J.)
Lnaldini. Brrnardi110 degli. 96
lbaldini. Otta,iano clrgli . %. 1();3
l 'nico. \rrti110 (B<'rnardo \rrolti ). 21. 11.).
11 (>n, 2;3:3_ 298 (' Il. 299. :311 (' 11
l rania. 262
\'alrrio \la;. imo. 2:3-tn
falirr. Lucrezia. 272. 289n
\ annrl. Fiorrnza. 10211. 10911. 2 . (rn
\'archi . Be1wdPtto. 61 n. 7211. 16 7. I %11. 21 . -
21 . 229n. 2+t-2-t:>. 302-:306
21:3-21;)
\ arrO!I('. \larro Tcnnzio. 199
\i ari. Giorgio. 7. I?. :30 .. )-te n. <>In. ?211.
7-t. 11.3. 167 ('Il. 208n. 2-t:3. 28.)-286
\'as allo. \hatl'. 21.3-2 J:-
Yrrr . Carlo. 1 1:311
\'cechi Calli. Paola. 1:31 n. l-t.3n. 229n
\ellutl'llo. \lt' 66-69. 73. '?9. 16.)
\ enafro . .'iln1110 <la. 6(>-67. ?On
\p1JCl0111e. \Ja1110 cli. 209
\' 11dra111i11i. Ciornnni. :218-219. 221
\(nrr. 16-1 .. 19-21. 2?. 69-70. 111. 1:32-
13:3. 178. 189. 20?. 211. 22:)11. 2:31 . 2:3:).
25-t. 2<>9. 29-t. :302
\rnier. DonwniC' . 292-:29:)
\ 'rnturi. Gianni . 6:211
\ Prde. 1 :;o
\ 'er!!inr. vd. Maria
\ rrh yrn. Ego11. 11111
\'ero. Lucio. 2:3211
\'P1T cchio. \mirra d1l (Andrea di Cio1w).
160n
\' pa ia110. Titt J la" io. 1611
\'r pucci .. 'imo1w11a. 271
\'ieker . . \ancy. 109n
Villa. Aie. andra. 111 -112
Villani. Giovanni. 9811
Vi llata. Edoardo. 115n
Vi11drli1io da . ' pira. 80
\ cli. 20911
\i ,..1ilio \laro1H'. Publio. l(>. 21t'11. 1'?911
i. Bianca ,\1aria. 102
\'i-.co11ti . Filippo \laria. ')-+
fo('Ollfi. Ca;,paro. 79 e Il . 8211. 10-t- l O:>. 1 n
t' 11. 11911. 1:2+ 12.). 129- 1:32. J:3:>n. 1'.39-
1-tO. l:>-t. 26711
\'i1tori110 dn Feltri' . 9+%
foaldi . \lirhrla11g,lo. 21?11
\ 11lca110. 221
\\ alclnian, Loui \lrxandPr. 1-tOn
\\alter. hl''rborg. l<>On. l<><>n . 19:)11
\r1hb. Buth I lrlc11 . 29-:30. 209 e 11
1i11rich. I la raid. :3:3n
\\ elch. 11 .' .. 28611
\\ ilkin.,. Ernr l 11.. ?-tn
. . \llan .\l. 12811
\fo'I -.\lar.,<lcn. .loanna. 98n. 1-t: 11. 217 n.
28211. 28:>11
Woolf. \ 'ir11i11ia. 2-t l
\'\ 'ri11ht. .\li.,011. 21011. 28611
h<'llf. .)9
Za111brreari Bo,i. Giulia. 193
Zanato. TiziH110. 2. 1 n
Zarw. Girolamo. 19? n
Zapprri. Rolwrto. 160n. 16911. 1 . 3n. 1 %11
Zarotto. \ntonio. 10-tn
Zeu . 20-21. 26-:2" 9611. 1 O?. 1:3511. 189-
1 C)O
Zethi. 10-1 <J -1. 6-i. 101 n. 11-t. 12?. 1:30-
1 :-l l. 1.>o. 201. 232_ :ns. 2-12. 2-+6-2-+7.
2:)1-253. 25.- 1' n. 261-262. 26.
Zonta. Ci11st'PI r. :31 On
Zoppin . Banolomro. '?8
Z ppino. \ircol d'.\ri totele .. 8. 23211
Zoppo. \laffo. 1-t8-1-t9
Zuliani. Luca. 65n
ABBREYIAZIO 1
en
moro a opra
AP
De pictura
Fam
Her
!nf
LA
Le Muse
LP
. \11
OF
Par
Purg
R
RB
RD
RT
Rif
ecretum
Trionfi
/'it,e 1550
f'ite 1568
T/\
Vi\1b
z
YiraiJio 1985
.\Iuzzar ili 1982
Antologia Palatina J 981
A1b rti 1960-19 3 [19?3]
Petrarca 19 . O
1989
Aliofoeri 199-i-199 [1994]
Ar ti no 1997 -2002
.\Jotwla \Iol.6no e Natale 1991
C Ui 1969
Plinio 1982-1988
A.rio to 199.
Alighieri 199-i-199 . [199 ]
Alighieri 199-t-199 [ 1 94 J
Aliuhi ri 2005
B mbo 1966
O Ua a a 2003
Ta o 1994
P trar a 1996a
Petrar a 1993
P trarca 1996b
\'a ari 1966-198. (d. 1- O)
Va ari 1966-198 ( d. 1 68)
Alig11i ri 1980
A.Jiuhi ri 1996
Petrarca 1756
338
;
RAFIA
TE TI
.\ e tto. rqualo
198 Rime. a cura dj .. \iur Torino. Einaudi .
A olri. B marcio
1-1 5 Opera ,Voca ;:;oe soneti capitoli, slramoti & una comedia. \' nezia .. -iccol e
in nzo di Paolo Zoppino.
Alh rti. Leon Batti ta
1960-1973 De piclura. in Opere l'olgari, a ura di C. Gray on, voi. Ill, Roma-Bari, La-
lrrza. pp. 5-107 [De piclura) .
Ali11hieri Dante
1980 fila nuorn, a ura di D. D Rob rti . .\filano- apoli. Ri iardi [T. 1-
199i-199 ommedia. con il comm nlO di \ . .\1. hiaYacci L onardi.
1995
1996
200
[f nf, Purcr. Par].
Rime, a cura di G. Contini Torin , Einaudi.
Vita nom, a cura di C. ,orni, Torino. Einaudi [T1 b].
Rime dizione e mment ta a cura di D. D Rob rti , Firenze, Edizi ni d l
,alluzz [ R].
nakreontos Teiou melie. nacreonti Teij Odae. b f-lmrico tephano luce
. latinitate nunc primwn donatae. Lut tia , , pud H mi um tephanmn.
Angerianu , I li cr nymu
1995 T/z e Erotopaegnion: a 'Thfli11g Book o/ Lol'e. a cura trad. di Wil on,
i uwk op, D raaf.
Antolo ia Palatino
1981 a ura di F.M. Pontarti. 1 rino 'inaudi [AP].
quilauo
189-i
rafin
/_,e Rime di erafino de' imi11elli dall1quila. a ura di I. M n"hj11i. Bolo-
gna Rornagnoli-Dall'A qun.
339
:200:2 l'trambotti. a cura di \. Ro- i. Panna. Cu:.111da.
:200.- , 'onetti e altre rime. a cura di .\. Ro si . Roma. Bulzoni.
.\retino. Pietro
1997-200:2 Lettere. a cura di P. Proca ci oli. Horna. a Irmo [ /; I].
.\rio;,to. Ludo,ico
199-:' Orlando F11rioso e Ci11q11e Canti. a cura di R. Ce:-.<' rani e . Za11 i. Torino. l irt.
Barbaro. France co
J C)J :- De re 11.roria li ber in parte duas. a cura di \. to. \t ti <' mrmo1ir drlla
R. .\ ccademia di , cirnze. L uere d .\rti in PadO\a. :32.
Ba inio da Parma
1 Q:23 Le poesie liriche di Basinio (lsollaeus. yms. carmina caria). a cura di f.
Frrri. Torino. C. 'Jamore.
Battiferri de!!li .\nunanna. Laura
"'
2000 li primo libro delle opere toscane. a cura di E..\I. Guidi. l rhi110. ccaderrria
Raffaello.
Beaziano. Ago tin
1551 le rime roluari et latine. Yenezia. Cabri I Ciolit o de Ferrari r fratelli .
B ccari . .\ntonio
1 le nme di .lfaeslro lntonio da Ferrara ( In ton io Beccan:. a cura di L Bellucri.
18-:-
Bol i?na. Patron.
_ ru. Antonio
fl, !!i hi torici di alcuni per. ona[!!!i del/a {runfrr/ia ( a. tiliona. .\lanto\'U.
F ran :-ru111a.
ni. Bem rio
Rim dt>/ arr!llto t'l_far.eto poeta Bmwrdo Be/in:one. \l ilano. E \tam !!azza.
Rim -.ui rini. ' Ili ndat e annoract> da P. ( anfani. Bolo-
!!rta. Homa!!uoli.
Bt'mho. PiPtro
1%b Jr . p
1111
"
111
rosP e rimP. a ura di :. Torino. L trt [ RH]. pp .. - 05-68-:' .
1987-1 C)CJ:3 I li I
-<' rre a cura r i : 'f1a\ , 1 (' t 1
. r.. ' . .,, ti. , mm f)<.'r r t -.r1 e 1 111g11a.
2002 ' .
La gmndr fiam111a: lrllerr 150:3- 15 r: a cura cli G. Raboni . \lilano. Arrhi11to.
2008 Le rime. a cura di \ . Donnini. Boma. , alerno.
B mari dc \r111adon1
l 'l 1) 1'1111' Ucd1'r. < ur;i di ( .. \p1 <'I. I l.11lt . i1nw' r.
Betussi. Ciw;rppr
1556 /,e imagini del tempio della sig11ora Do1111a GioN11111a !lragona. dialogo di ,\f.
Cimeppe R<
1
l 1tssi. I/la il/11. triss. s. Donna I illoria Colonna di Tolledo. Fir n-
zr. Lorrnzo Torr ntino.
Bibliogmphie der Tro11badours
19:3:3 a cura di 11. Car ten r \ . Pillet. I !alle. iemeyrr.
Bo caccio. GiO\anni
196-t Filostrato. in Tutte le opere. a eura di \'.Branca. \lil ano. voi. TI.
pp. 7-245.
198 . Elegia di \ladonna Fiammetta. a rura cli >LP. >Ius ini 'acchi . \1iJano. >lun.ia.
2000 !morosa I isione. a rnra di Y. Branca. >Iilano. \l ondadori.
Boiardo. \latl o
200:2 lmorwn libri tres. edizion critica a cura cli T. Zanato. Roma. Edizioni di
:, toria e lctteratura .
Borghe 'i. Diomrdr
1585 Rime amorose del siu. Diomede Boruhesi uenlillwomo sanese. et academico
intronalo, 11ocella111e11te poste in luce. con alcuni brieci aruomenti di Cesare
Perla. PadO\a. Lor nzo Pa:iquati.
Borra. Luigi
199-t L 'amorose rime. a <'lira <li '. Rahitti. Roma. La F nice.
Bracce-,i, i\ lr. :-iandro
19-+4 '1/e.ra11dri Bracci Cannw. a cura di A. Pero a. Firenz , Bibliopoli .
Bronzino [ \"n lo di .osi1110]
1-65 [ca. ] Rime del Bron::.ino Pili ore. libro Primo. m . .\ laaliabe h.iano ll.l.\.10 della
Bihliotrcn :\azionai<' Crntral di Firerl7e.
182:3 onelfi di 'In crio/o I/lori delfo il IJrondno ed allr<' rime inedite di pi iwiuni
poeti. a rnra cli D. \l orcni. Fin nz ' . \(aah ri.
Buonarroti. Mich langrlo
1998 lli111e. a cura di 1. Hes idnri . lilano . .\londadori.
Cal111rtn. \ 'ineenzo
1959 I ila di , 'em{i'no lquilano. in e lellere edite e inedite (con due appen-
dici di al1t{i11editi) , a cu ra di C. Grayson. B lognu .. ommi per i te ti di
lingua. pp. :19-7 . .
Capprllo. Brrnardo
199 Rime. inQuondam JC)Q?.
;Hl
armina Anacreontea
198-t ar111111a 1nacreontea. a cura di 1.L. \re t. L ipzitr, 1 ubncr .
. a i de \fedici. irolamo
1-2, (?] Libro intitulato ronica: Ol'e si tratta di epitaphii, di amore, e di 1irl11te, compo-
sto per il ma<rnifco asio Fdsineo cal'aliero. Bolorma (?] . inzio hillini (?].
a la. Luigi
J - -H .lladn"rra/i del ma<rnifco iunor carallier Luiui a sola piacentino. \' nezia.
Gabri I iolito de' Ferrari.
a teh-etro. Lodovi
1-32 Le rime del Petrarca brecemenle poste per Lodorico Casteil'elro. Ba ilra.
Pi Lro d edaboni .
tialion , Bald ar
1981 Il Libro del orteuiano. con inrroduzion di . uondam e not di , . Long .
jliJano. Garzanti.
200-i
Rime e giochi di corte. a cura di L Fantato pr m a di G. ,\1alacarne e G.
Pizzamialio, Canneto ulf Oulio. Euro!!raf.
ei. Fran
19 -l
CO
Il can::.oniere. a cura di .M. eci. Roma. Zauli.
r ara. Paride
200-i Rime. dizione critica a ura di A. roboni, Fir nz . l chki.
Ch t lain de Couci
196-t
attribues au. 'hastelain de ouci (fin du XII debut du Xlii sicle) ,
edJZion Titica a ura d1 A. Lerond. Pari . Pre uni,er itair d Fran .
hiabr ra. abriell
1998
Haniere, scherzi e can-:.onette morali, a ura di . Raboni, Parma. Guand11.
Cic ron . .\farco TuUio
196-t
L'orateur. Du mei!Leur genre d'orateurs. a cura e trad. di
Belle L ttr .
. Yon. Prui . L
olonna. \'ittoria
199.
Rime. in uondam 199 .
1982
Rime. a ura di BLlo k. Roma-Bari. Laterza.
omani11i. Gregorio
1960 flFigino Ol'erodelfnedeffapitlura (1.-91],in Trattati d'arte del
voi. 111. pp. .3 -3. 9.
342
inq11ecenlo,
onli, Giu. to dr'
1916 La bella mano. a cura di L. it tti. Lan iano. 'arabba.
ontil , Luca l
J552 Discorso del Conti/e cademico Fenicio sopra li cinque se:tsi del co1po ne
comento d'un sonello del signor Giuliano Gosellini, al ravalter Leone scultore
esareo. Milano. al ri e Girolam 1 da.
Coppetta Bee uti. rane co
1912 Rime. in C. Cuidiccioni e F. op tta Bee uti. Rime, a cura di E. 'hiorboli.
Bari. Lal rza. pp. 91-327.
Cornazano, ntonio
1997 Rime, in Quondam 199
1
i ol da orr ggio
1969 Rime. in ld .. Opere. a ura di A. l
ni B nvenuti. Bari. Lat rza. pp. 105--!6 ..
Curzio, Lancino
1:b d 'lil R o e Ambro!rio Da Yall .
1521 Lancini urtii Epiurammaton u n ecem. ano,
Dru ilo. B rnardin
1 -11 onetti. an;;oni e Triomphi di Me ser Francesco spositi.one .di
Bernardino Daniello da Lucca, n zia. Gio anni Antomo I 1 olini da abbio.
O Ara na, Tullia 1912
1912 Dia/ouo della ignora Tullia d' rauona deLrinfniL di amore. in Z nta
pp. 185-2-!8.
D embrio. Anuelo
diz
. ura di .\. h n. aur.
2002 De politia liueraria. 1on cnuca a
Della Ca a,
1978
1986
2001
2003
iovanni
Le Rime a cma di R. Fedi, Roma. al mo.
Corri pondenza Giol'anni Della a a- arlo (15:.. -19).
ura di O. 1oroni, Roma, Bibli te a po tolica \ aucana.
Rime a cura di anturli, Parma Guanda.
Rime, a ma di . . arrai , Tori110 inaudi [RD ].
Detto d'amore, Il
d. a
1983 Il Dello d more, in il Fiore e il Detto d more, a ura di Mar himi.
11
-
va Tilgh r, pp. 419-44: .
Dolr . L dovic
1960 Dia/ouo dello Pittura, intitolato/' retino. in Trallali d'arte del inquecento.
1, pp. 1-11--0 .
3-+3
f,>igra111111i erotici
J()89 lntolocria palatina. Epigrammi erotici: libro I e libro \li. i11troduziorH'. tra-
duzione e note rii ' Padua110. \lilano. Rizzoli. '
Firi no.
I Q87 El libro del/"amore. a rura cli,. \iccoli. Firrnzr.
Fi lelfo. Francesco
J con doi commenti ?opra li l\: can::.011e. El primo del we[!no-
1ss11110 m1s er Francesco L altro del sapientissimo 111isser lntonio
da Tempo 11ora111e11te addito. { . .}. \'enrzia. \Il H'rtino da L !-.Olla.
Filthtrato
I Q97
l111marii11i. trad. note di C. 'hilardi. introduzionr di F Fanizza. Lrrcr. \J'fro
1' .
\!!nolo Firrnzuola.
1977
Dialogo delle belle::.::.e delle donne intitolnto Crlso. in Id .. Opere. a t'ura di I)
Torino. l 1 r. pp. -:-n-:'89.
F olqurc de .\ Jar, ille
1999 le poesie di Folchetto di .lfarsif!lia. a cura di P . . 'qu.illat"icni. Pi!-.it. Parini.
Franco. \"eronira
19-+9 Lettere dall'unica edi::.ione del JJDL\ U. con proemio nota iconorafiC'a a
cura di 13. Cr ce. \ ap li. Ricciardi.
199.-
Rime. a cura di . Bianchi. .\! ila.no . . \for ia.
1998 Lettere. a eura di . Bianchi. Roma. , 'alrrno.
Jean
190:3
li . .\u!!t"Jo
Espinef/e amoureuse. a cura di \. F 011 rrirr. Pari . Klincbirck.
<'I dbat. . a cura di \. ourricr. ro11 in app ndice al u11C po
,ur aunw clr GrnH. Droz.
Can- nicrc. a< ura di (,_ onni. l rhino.
il' di
Cauriro. Pornponio
JC) .1 Ue smlplum. a c11rn di A. Cita tel R. Klrin. Ccn(,e. Droz.
Crll i. Ciovan Ball i1-1t a
1 <)69 /,c"::.ioni pet ral'Chesclze. rarcolt r p r cura cli C. 1gron i. Bolo!!11a. Co mm
per i t1:.ti di lirwua (ri">t. ana. t. drll"rd. Bolorrna. Romarrnoli 188-+)
[U>].
Ce ualdo. Cim anni ,\nclna
f Il Petrarcha colla .\jJOsitione di misser (,'io11a11ni 1ndrea Gesualdo. \'enezia.
CiO\anni \ntonio icolini da ' abbio fratelli.
Giacomo da Lr11tini
19?9 Poesie. edizion critiea a rnra di R. \ntonelli. Roma. Bulzoni.
Gim io. Paolo
19.)8
19.2
1999
Lei/ere. a t"t1ra di C.C. f errero. Roma. I. tituto poliirraiiro dello rato.
Cli efoui deu/i 110111i11i illustri: letterati, arti ti. uomini c/'anne. a cura di R.
Cl ('
\lrrrcrazzi. Ilo ma. l ... tit uto Policrra6ro d Ilo 'tato.
C'
, 'critti d'arte. lessico ed ecfmsi. a cura cli . \ la f ei. Pi a. uola rmale
.'up riorr .
2006 C/oui deu/i uomini illustri. a eura cli F. \ lin ozio. rino. Einaudi.
Leonardo
1.) l;) [r) Q1wsti strambotti .rrisse di sua mano in preposito di ciascaduno amatore
il nobile \lisser Leonardo !11sti11iwzo. in tramboti composti no11a111ente da
diuersi a11rtori che sono in preposito a ciaschuno che ferito d'amore, \'en -
1915
1968
zia [!') (Lorulra. Briti h , _,) .. I. .. (2-:-. )]. e. 2r-:3c.
trwnbolli e bollate, a cura di \'. Loc:cl1i, Lanciano. Carabba.
Poe ie edite e ineditr. p r cura di B. " "i ;.r. Bolona. Commi i 11 per i te li
di lingua (ri t. UJa t. dell"e I. Bologna. Roma!!noli 188:3).
Giu ti11ian. On.atto
1998 Rime. a cura di R. \ lcrcatanti. Firrnzr. l hki.
onzacru. Curzio
1;-3;- Rime del/'il/11striss.1110 :iunor Curtio Gon::aga. \ icenza. tamperia \uoYa.
159 1 Ri111r del/"il/11sl riss.11w sicrnor urlio Cou:;aua. gi ricorrei/e. ordinale. e ac-
1997
1998
<'resciute da lui, et hora di n11010 risto111pate co11 gli arr;omenti ad ogni co111-
positio11e, \'r nrzia, Al <'gno dcl Lco11 .
Rime. in Q11011datn 199 ..
Rime. a cura di ,. Rarb ro. Roma. l" artt.
Go clini. Giuliano
t -33 Rime del siunor Cialia110 Goselini. riformate e ristampate la quinta l'Offa, ac-
cresciute, con aruomenti brel'issimi dichiarate & ditise in due parti Venezia.
France o France chi.
Gottifredi. Bartolomeo
1912 pecchio d'amore. Dialogo di Messer Bartolomeo Gotti/redi nel qllale alle
giocani s 'inseuna innamorarsi. 1 Zonta 1912, pp. 249-30-.
Guasco. Annibale
1581 Il prno volume delle Rime del . Annibal Guasco alessandrino, Academico
Affidato ristampato, et riveduto dall'auttore, et insieme il secondo volume
[PaYia. Girolamo Ba.rtoli. 1 9. ad in tanza di Gio. Andrea Via.no] pur
delle rime d es o ignor Guasco, con una breve dichiaratione de i concetti
loro. Appresso una oratione, un discorso sopra La belle::.za. et un' pologia
sopra un suo sonetto del medesimo Auttore Pavia, Giovanni Andrea Viani.
Guittone d'Arezzo
19-iO Le rime, a cura di F EITT.di, Bari. La.terza.
Hirpino, Enea
1520 M . PAR. 700 della Biblioteca Palatina di Parma.
Lancelot
1980
Lancelot, roman en prose du XIII sicle. edizion ritica a cura di . Micba
Pari -Genve. Droz.
La.mo. Ale and.ro
1. 4
Leonardo da
1992
1995
Alessandro Lamo intorno alla scoltura, et pittura [1584] in o-
de. scultori ed architetti cremonesi, op rapo turna di
GiambattJ ta Zat t. pittore, ed architetto cremon e data in luce da Anton
Maria Panni. Cremona. tamperia di Pi tro Ricchjni ,' vol. II.
lllCJ
Leonardo flinci 's Paragone. A Critiral Inte17Jrelalion with a ew Edition
0
/ the Text m the ode.7: Urbinas. a cura di .J. Farago, Leiden, Brill.
Trattato della pittura. a c. di E. Carne a ca, Milano, TEA.
Liburnfo . .
1
iccol
1502 Ope t'L &
. re gen L e amorose del preclaro homo . Libumio Veneto Venezia, Pi -
cmu de Brixia.
Lomazzo Giovan Paolo
1973-1974
critti sulle arti, a ura di R.P. Ciardi Firenze Marchi e Bertolli.
346
eba tiano I a usto da
Longiano.
1532
li Petrarcha col commento di M. ebastiano Fausto da Longiano con rimario
et epiteti t ordine d'alphabeto. uovamenle stampalo, eneza Bndoni e
Pa ini.
Lu iano di amo ata
1994 Descrizioni di opere d'arte. a cura di . Maffei, Torino. Einaudi.
Luiuini , Fed rico
1913 Libro della bella donna, in Zonta 191.. pp. 221-308.
elio
1600 Rime di Celio Magno et Orsatlo Giustiniano. Venezia, Andr a Mu chio.
1997 Rime in Quondam 1997.
lanfredi . .Muzio
1580 Cento donne cantale da Mutio ,Uanfredi il Fermo cademico Innominato di
Parma, Parma, ' ra mo iotti.
1-37 Cento madrigali di J.lutio Manfredi il Fermo lnno"':inalo lnua-.
ghito di Ferrara a Donna Vittoria dt Molfetta_ sua ignora da lLLL.
dedicati con gli argomenti del medestmo a cwscun madrigale, per esser tultt
di straordinari sougetti,
1
lantova, France co O anna.
1605 Madriuali di Mutio Manfredi il Fermo Academico Olimpico &c. sopra molti
soggetti st1waaanti composti. n men di pi di sono pe1:
ciascun soggetto, all'illustrissimo e Lui.gt Cappolll
tesorier generale di J\'. ., Venezia. Rob 1io }-1errli th.
Marino. Giovan Batti ta
1966 Lettere, a ura di M. Guuli lm1etti, Torino 'inaudi.
1979 La Galeria, a cma di 1. Pieri Padova, LiYiana.
2005 La Galeria, a ura di M. Pieri e . Ruffino, Tr nto La Fine tra.
2007 La Lira, a cura di M. Iawin ki Torino. R .
MaruUo, Mi hele
1951 Carmina, a ura di . Prro a, Turici, in acdibu Th auri 1mmdi.
Marziale Mar o al rio
1996 Epigrammi, aggio intr duttivo r ne di itroni, traduzion di [.
Medi ' i
1991
1992
cndola not di E. M rli Milano R1zzoli.
Lorenzo d
anzoniere a ura di T. Zanato, Firenze. 01 chki.
11'. I l a ma di P. Orvi -
Canzoniere e omento dP miei sonet/1, lll 1utle e opere, ,
to, Roma, alerno.
34
rcto1
1981 Menander rhetor a cura e trad. di D.A. Rus cli and
1
.G. WiJson, Oxford
Clarendon Pr '
Molza. France'co
1808 Poesie, a cma di P. era si, Milrurn. ociet tipografica de' classi i ilaliarri.
Girolamo
1551 Rime dil'erse del Nfutio l11stinopolitano, Venezia, Gabriel Ciolito de F nari e
fratelli.
1968 Le amorose egloghe del Muzio Giustinopolitano alla signora 'fltllia d'Arago-
na, n Le Rime di Tullia d'Aragona, cortigiana del secolo XII, edite a cura
e studio di E. Celani Bologna, Commi ione per i testi di linaua [frtampa
dell'ed. Romagnoli-Dall'Acqua 1891], pp. 136-190.
0
1997 Rime. n Quondam 1997.
2000 Lettere, a c. di A.M. NeITTj , Ales andria, Edizioni dell'Orso.
2007 Rime, te to a cura di A.M. Negri, introduzione e note di 1 t Malinverni e A."11.
Torino. R
u .
Muzzarelli, Giovanni
1982 Amorosa opra, a cma di E. Scarpa, V rona, Libreria Unjver itaria editrice
[Amorosa Opra].
Xavagero, Andrea
1530 Andreae Nauo-erii Patricii f'eneli Orationes duae. canninaque nonnulla. Ve-
nezia, Tacuini. ,
1973 Lusus, a cura e traci. di A.E. Wilson, Nieuwkoop. De Graaf.
o, Ago tino
1973 in critti darle del Cinquecento, a curn di P. Barocchi, filano,
Ri c1rud1, II,pp. 1646-1 670.
Olimpo, Balda arre decrli Ale andri da a soferrato
1544 Gloria d'amore composta per Baldesarre Olympo de li Alexandri da , asso-
trambotti de laude. Mattinate. Litter' d'amore. Prosa. onetti. Ca-
l . .Jcrfoghe. Et con un capit,of<; agionto Venezia, G. Paclovanno [Londra,
Bnt1 h Lihrary 1071.e.14. (2. )].
Ovidio Nasone, Publio
19
89 Lettere di eroine [Heroides] con.introduzione, trad. e note cb G. Ro ati Mi-
lano, Rfazoli [Her].
Panuccio del Bagno
1977
Le rime. a curn dj F Brambilla Ageno, Firenze Accademia d Ila Crn, ca.
348
Pasqualigo
1587
LLtigi
Lettere amorose del mag. M. Alvi.se Pasqualigo Libri IV, ne i quali sollo me-
ravigliosi concetti si contengono tutti gli accidenti d'anwre Venezia, iccol
foretti.
Pa quazi, Silvio (a cura di)
1966 Poeti estensi del Rinascimento con due appendici, Firenze, Le Monnier.
Pero a, Ales andro e Spanow, John (a cura di)
1979 Renaissance Lalin f'erse: AnAnthology London. Duckworth a.ud Co.
Petrarca, France co
17. 6 Le rime del Petrarca brevemente esposte per Lodovico Caste/vetro, Venezia,
Antonio Zatta [ Z].
19 3-1942 Le.familiari, edizione critica per ura di . Ro si, Firenze, Sansom, 4 voli.
1970 Le familiari. libri 1-lV, tra d. , note e acr!l:io introduttivo di U. Dotti, Urbino,
Arcralia, pp. il3-4H [Fam].
1.993 Secretum, con introduzione, trad. note di U. Dotti, Roma, Archivio Guido
Izzi [ Secretwn).
1996a Canzoniere, edizione commentata a cma d M. antagata, Milano, Monda dori..
[ RvfJ.
l996b Trionfi, Rime estracaganti, Codice degli abbozzi. a cma di V. Pacca L. Pa-
olino, introduzione di M. antagata, Milano, Monda.dori [Trionfi].
2005 Canzoniere, a cura di R. Bettarini, Torino, Einaudi.
Pigna, Giovan Bat1ista
1965 fl ben cifrino, a cura di r. Bonifazi Boloana Commis ione per i te ti di
lingua.
1.991 Gli amori, con il Discorso 'opra Gli amori di Ora::,io MaD'nanini edizione
a cura cli D. Nolan, con revi ione di . Bullock, Bologna., Cornrn.is ione per
i testi di lingua.
Pignat lii, A canio
1996 Rime, a clLra di I. lawinski, 1orino, Res.
Plinio Gaio ' econdo
1982-1933 St:oria natwale, con prefazio1 :li L Ca.I in , aggio introduttivo di G.B. Con-
te, nota biobibliografica eh . Bmd1ie i C. . Ranucci, Torino,
Plutarco
1987
Einaudi ( 11]. '
Vita di Alessandro 1ogno, iu Vite parollele. Alessandro-Cesare. trad. e note
di D. Maguino, Milano, Rizzoli.
349
Poetesse del Cinquecento
2003 a cura di . Bianchi. lilano Mondadori.
Poeti del Dolce stil nuovo
1969 a cura di M. farti. Firenze Le Monnier.
Poeti del Duecento
1960 a cm-a di G. Contini. Milano-Napoli, Ricci.ardi.
Poeti del Cinquecento
2001 Poeti del Cinquecento. Poeti lirici, burleschi, satirici e didascalici a ura di
G. Corni M. Danzi e . Lonofo. filano-\fapoli, Riccia.rdi.
Poeti della scuola siciliana [J]
2008 I poeti della scuola siciliana. Milano, Mondadori (1 Giacomo da Lentini a
cura di R. Antonelli; II Poeti della corte di Federico II. a cura di C. Di Giroa-
mo; ID Poeti siculo-toscani, a cura d R. Coluccia).
Poliziano. Anuelo
186.
1986
Prose volgari inedite e poesie latine e greche edile e inedite. raccolte e illustra-
te da I i.doro Del LUI1uo, Firenze, Barbra.
Rime, edizione critica a cwa di D. Delcorno Branca Firenze pr or ccade-
mia della Cru ca. '
Porri.no. Gandolfo
1551 Rime. Venezia, Michele Tramezzino.
Quondam. Amedeo (a cura di)
1997 Archivio della tradizione lirica da Petrarca a Marino. Roma Lexi Pro11erti
Editoriali '
Raineri Antonfrance co
2004
altre rir:ie e pompe con la brevissima esposizione di Girolamo
Ra.men, t to e note di R. odano, Torino, Re .
Rilke, Ra:iner Maria
l995 Poesie (190 -1926) edizione con te to a fronte a cura di G. Baioni, com-
mento di A. Lavagetto Torino Einaudi-Gallimard.
Rimatori bolognesi del Quattrocento
1908 Rimatori bolognesi del Quattrocetto d" L F B l R i
Dall Acqua. ' " a ctu-a 1 . < ratt o ogna, omagno 1-
Rime del codice isoldiano (Le)
1
9
13
d
1
el codice isoldiano (Bologn. univ. 1739), pubblicate per cura di L.
rati, o ogna, Romagnoli Dall'Acqua.
350
Rime de gli Academici Eterei
1995 Rime de gliAcademici Eterei [1567], a cura di G. Auzzas e M. Pa tore toc-
chi , Padova 'EDAM.
Rime 1545
2001
Rime 1550
1550
Rime 1551
1551
Rime 15 3
1553
Rime 1555
1 55
Rirn 1556
1556
Rime 1560
1560
Rime 1561
1561
Rime 1565
1565
Rime diverse di molti eccellentissimi autori (Giolito 1545), a cura di F. Torna i
e P. Zaja, Torino, Re .
Libro ter::o de le rime di diversi nobilissimi et eccellentissimi autori nuova-
mente raccolte, cnczia, Al egno del Pozzo (Andrea Arrivabene).
Libro quarto delle rime di diversi eccellentissimi autori nella lingua volgare
nooamente raccolte, Bologna An elmo Giaccarello.
Rime di diuersi illustri signori napoletani e d'altri nobiliss. intelletti, nuova-
mente raccolte, et non pi stampate. Terzo libro Venezia, Gabriel Giolito de
FerraTi e frat ili
Il sesto libro delle rime di diuersi eccellenti autori, nuouamente raccolte et
mandate in luce. Con un discorso di Girolamo Ruscelli, enezia Al segno del
Pozzo (Gio an Maria Bonelli).
Libro quinto delle rime di diuersi illustri sianori napoletani e d altri nobilis-
simi ingegni. uovamente raccolte, e con nova additione ristampate, Venezia
Gabriel Giolito <le Ferrari e fratelli.
Rime di cliuersi signori napolitani, ed altri. uouamente raccolte et impresse.
Libro settimo enezia, Gabriel Giolito de' Ferrari e fratelli.
Rime cli diversi autori eccellentissimi. Libro nono Cremona Vincenzo onti.
Rime di diversi nobilissimi et eccellentissimi autori, in morte della ignora
Jr ne delle i<rnore di ipilimber(l'o nezia, Dom ni o Giovanni Batti ta
Guerra.
Dc le rime di cl ersi nobili poeti toscani raccolte da M. DionigiAtana(l'i, libro
secondo, Ven zia, Lodovico a.nzo.
351
I
Rime 1.)8 '?
J.)8-:'
Rime I :)QQ
J.)Q9
Ri111r di dirrw celebri poeti del/"et 110. Ira 111101<1111ente mccolte e po
1
luce da C. B. Licino. Bcramo. Comino \ rntura e' Compairui. se
111
Rime di diret"i illustri poeti de nostri tempi. di 1111oro poste i11 Iure da Cl .
.J 8 . , . . I \ 1 . (' . ' Il!
raruo orgom. nrz1a. a 1111111a .ompag111a.
Rora. lkrardino
2000 Rime. a cura clj L. .\lilitr. \ljlano. Fondazione Pit'I ro Bcmbo. P<mna. Cuanda.
Ruozzi. Cino (a cura di )
200 I LJiurammi italiani: da Jlachiarelli e lriosto a 11011 /ale e Pasolini. Torino.
Einaudi.
as o. Panfilo
1500 [ca.]
I er:i in laude de la composti per il darissi1110 poeta misPr Pamphilo
a :o llodene. <'. Bre-.cia. \li inta . .,.d.
19%
011e!ti 1-250. edizione criticar comrnrnlO a cura di \l. .\1alimwni. Pa,ia.
r Cl.
miozzo ( imone ' rdinj da i na)
1 %5 Rime. ilizionr rrili a a cura di E. Pascp1ini. Bolona. Commi . . .,ione per i lrti
di li1iuua.
'arnr
11
na11. .\laria e Bembo. Pietro
19.50 Carteggio damore (1500-1501). a nua di C. Dioni otti. J irrnzr. Lr \lonnier.
'rriLti d'arte del C'inquecPnto
19..,1-19
7
> r
- crtl/i e arte del C111q11ecenlo. a cura di P. Barorrhi. \lilaiw-\apoli. Ri"cianli.
Gror11 dr
1991
Le abinet de .lfonsieur de c11d1y. a rura di Ch. BirL rl D . .\lo11con11'huy.
Paris. Klinc:kirf'k.
'forza. \l r . andro
19.3
11
Crui::.oniere. cdizio11 critica e int roduzio11r a cura di L. Cocito. \lilano.
. \1a rzorati.
'ordcllo da Coito
19.)i
orrl. Charlr
1627-1628
Le poesie. a cura di \,J B B I I .
1
. . . I
0111. o og11a. ,1 >rrna ant1q11ana Pal111awr<"
LP fJprger Ertrwr.(T;
1
. . .
. . -
1
1::,0
11
ou rf Ps fa11/as1es a11wure1w's 011 co1d /es 1111-
P<'t t t11P11res rles Ronu ,
1
, , l p . . .
ms e r.f a oestP. Pan .. To11-;. u111c1 d11 Bra).
3.)2
,'
1
lt'roni . , '1wronc
ICJ?.) Dialo140 cf'a11wre. in 'l'([flati d'amore del Cit1querp11/o. r pri11t a cura di ..\I.
Pozzi , Homa-Bari . LatC'rza.
.'tampa.
ICJl'.3 Rime. in C. ,' ta111pa r \ '.Franco. Rinw. a cura di \. alza. Bari. Latrrza. pp. 1-22?.
19?6 Rime. a cura di H. ,eridlo. con introd11zio11c di ;\I. Brllonri. \lilano. Hizzoli.
, '1iolia11i . Tomrna. o
Il ca11::.011iero del signor camlier fra 'l'omaso , 'ti[diani. Roma. Bartolomeo
Zanctti ( rrt'dr).
, tramboti romposti 11om111e11te da dicersi auclori
1:;1.1 [ca.] tramboti romposti 1t0rame11/e da dil'er i m1ctori che sono in preposi-
/o a riasclwno che ferito cfomore. \'r11 zia [L nclra. Brith,h Library.
57.1.. (27.)].
trozzi. E.rrolc
l.) 1 :J 'tro::.ii poeta? pater et filius . \ 'cn zia, Aldo Manuzio.
:trozzi, Tito
101:3 Eroticon libri. in lro::Ji poelre pater et Jlius. Yen zia. Id
'lasso. Brmardo
tQ95 Rime. a cura cli D. Chiodo. Torin . Rr .
Tw .. io. Torquato
1583 anelli del sirrnor Torquato Tasso sopra u11 ritratto ima. t:'. eccel-
le11lissima sitrnora do1111a .llwf. a d'Este ibo marche a dt ,\lassa. Firrnz -
Giorgio
l.)9:3 Delle rime del sig. Torquato ?'asso di nuoro dalle in luce, con .1rgo111e11ti e
espositioni de/ti.stesso autore. Pietr \laria \Iarch tt1.
18S2-185. le {pi/ere di Torquato 'l'osso disposte per ordine di tempo ed illu Irate da
Guasti. Firenz '. Le \101wirr.
1898-1902
19<Ji
ICJ98
2007
le rime. Edizion critica -u i r le antiehr tamp . a cura tli .\ .
olc rti , Bolorrna, Homagnoli-DalrA qua .
Rime, a ura di B. B Roma . .'al rno.
Dialoghi. a cura dj :. Bnffeui , .\lilano. Ri zzoli.
Rime, Parte ler::.a . a ura di F. ;a\'azzr11i r \ . \larti
11
n n . ,\l e san lria. Edi-
zioni dell' r o.
Antonio
1989-1992 Ri111e. acurndiT. Ba ilerJ.-J. \larfornd. \lolrna.Pani.11i.
Theon, Aeliu
1997 Progymnasmata a cura e trad. di M. Patillon Paris, Le Belle Icttres.
ToreJJi, Pomponio
2008 Poesie,. c?n il della poe .ia lin:ca, T sti commenti critici e apparati
3
cura di N. Catelli A. Torre, A. Bianchi e G. Genovese, Parma, Guanda.
Trattati d'arte del Cinquecento
1960-1962 Trattati d arte del Cinquecento. Fra manierismo e Controriforma, a CW'a di P.
Barocchi, Roma-Bari, Laterza.
1h ino, Gian Giorgio
1981 I ritratti, in Hirdt 1981, pp. 19-28.
Varchi, Benedetto
1960 Lezione della maggioranza delle arti in Trattati d'arte del Cinquecento I
' ' pp. 1-82.
1969
1973
Liber carminum Benedicti a cura di A. Greco, Roma.
Lezione sopra un sonetto di Michel.angelo [1547], in Scritti d'arte del Cin-
quecento II, pp. 1322-1346.
Vasari, Giorgio
1966-198. Le vite de pi eccellenti pittori, scultori e architettori nelle redazioni d l 1550
e 1568, a cura di P. Barocchi e R. Bettarini, Firenze, Sansoni , poi pes [/lite
1550eVite1568].
Vellutello, Ale andro
1525 Le volgari opere del Petrarca con la esposizione di Alessandro Vellutello da
Lu.cca, Venezia Giovanni Antonio Nicolini da Sabbio e frat Ui.
Venafro, Silvano da
1533
Il Petrarcha. co.l commento di M Sylvano da Venaphro, dove sono da quatro-
cento dtchiarati diversamente da gli altri spositori, nel libro col vero
segno notati, Napoli De Jovino e Cancer.
Virgilio Marone, Publio
1985
iie, introduzione e commento di E. Pa:ratore, trad. L. Canali Mondadori,
ano.
Visconti, Gasparo
1493 Rithimi. Milano z tt
, , aro o.
1979
1996
l canzonieriperBeat1;,.e d'Este B' ,,, d. .. a
. . . "". e ianca 1naria 'Jorza, e 1z10ne cntica a cw
di P. Bongram, Milano, 11 aggiatore.
IRitimidiG . fl:. .. - . . . ,
1
c;sP,a
1
0 rzscontz, Te i di dottorato di L. Lepore, mversita d1. M1
ano, Facolta di Lettere e Filo. o:fia, Istituto di Filologia Moderna, Dottorato
354
di ricerca in storia della lingua e della letteratura italiana, VTII ciclo, coordi-
natore prof. C. Milanini.
Zane, Giacomo
1997 Rime edizione critica a cura di G. Rabitti, Padova, Antenore.
Zonta, Giuseppe (a curn di)
1912 Trattati d'amore del Cinquecento, Bari, Laterza.
1913 Trattati del Cinquecento sulla donna, Bari, Laterza.
SAGGI
Afribo, Andrea
2003 Commentare la poesia del Cinquecento, in Per leggere, IV, pp. 141-163.
Agamhen, Giorgio
1977 Stanze. La parola e il fantasma nella cultura occidentale, Torino, Einaudi.
Agosti, Giovanni
1998 Scrittori che parlano di artisti, tra Quattrocento e Cinquecento in Lombardia,
in B. gosti, G. Agosti, C. Brandon Strehlke e M. Tanzi, Quattro pezzi. lombardi
{per Maria Teresa Binaghi) , Brescia, Edizioni l'Obliquo, pp. 39-93.
Albonico, Simone
1990 Il ruginoso stile. Poeti e poesia volgare a Milano nella prna met del Cinque-
cento, Milano Franco Angeli.
1995 Appunti su Ludovico il Moro e le lettere, in Ludovicus dux, a cura di L. Gior-
dano, testi di S. Albonico [et al.] Vigevano, Dialuonia Societ storica vige-
vanese, pp. 66-92.
2003 Descrizione delle Rime di Giuliano Goselini, in Per Tasso. Studi difilologia
e letteratura italiana o..ffrti a Luigi Poma, a cura di F Ga a.z-zeni Padova,
Antenore, pp. 3-55.
2006 Ordine e numero. Studi sul libro di poesia e le raccolte poetiche nel Cique-
cento, Ale sandra, Edizi01 dell'Oro.
Albonico, Simone e Pestarino Ros ano
2002 Sul T sin piantro i tuoi laureti: poesia e vita letteraria nella Lombardia
spagnola (1535-1706) , Catalogo della mostra Pavia, Castello Visconteo 20
apri} -1 giugno 2002, Pavia Edizioni Cardano.
355
Albrecht-Bott Marianne
1976 Die bldende Kunst in der italienischen i{rrik der Renaissance und des Ba-
rock, We baden Franz teiner edag.
Alpe
1960
1984
vetlana
Ekphrasis and Aestlzetic ltitudes in Vasari's Lives in ]ournal of th War-
burg and Comtau.ld In titutes XXIlI pp. 190-21 .
Arte del descriuere. cienza e pittura nel eicento olandese [1983), Torino
Bollati BOTinghieri.
Amonelli, Roberto
1977 Rima equivoca e tradizione rimica in Giacomo da Lentini I, Le canzoni
in Boll ttino del Centro dj tudi filologici e lin.alli tici siciliani XHI pp.
2.0-12.6. ) '
Arbizzoni, Guido
2003
LJ: conze ritralt.o dell'anima, in Tra parola e immagine. lYfigi, busti,
ritrattz nellef"OJ:me Atti del Convegno Macerata-Urbino aprile
2001 ), a cura di L. Gentili e P. Oppici, Pi a-Roma, 1 rituri editoriali e poliara-
:fic internazionali. pp. 33-45.
0
Ro end
2003
I sonetti dell'arte. Aretino tra Apelle e Pigmalione, in Letteratura e arte, J.
pp. "203-212.
Baggio, Serenella
1979 L'immagine di Laura, in Giornale Storico della Letteratuxa Italiana, CL\ I,
pp. 321-334.
Baldacci, Luigi
1974 Il petrarchismo italiano nel inquecento Padova, Liviana.
Balduino, Armando
1969
:sulle :ime del (una scelta d'autore e alcuni componimenti
mediti), m GiornaleStonco della Letteratura Italiana, CXLVI pp. 52-74.
BalJarin Jessandro
1983
Gioigione. e Compagnia degli Amici: il Doppio ritratto Ludoo;i, in Storia
dell_ arte llaliana, econda. Dal Medioevo al ovecento, a cura di F.
Zen, vol. I, Dal Medwevo al Quaurocent.o, Torino, Einaudi pp. 479-541.
Baltrui aitis., Jurgi
2007 Lo specchio: rivelazioni inganni e scienceJiction [1981) Mil' d I h
J' , ano, e p i.
.356
Baran ki, Z gnnmt G. e McLaughlin, 1artiit (a C'IJJ'a cli)
2007 ltaly:s 1'hree Crowns: Reading Danle, Petrarch, and Boccaccio, Oxford, Bo-
d]eia11 Library.
Barocchi, Paola
1984 Studi vasariani, Torino, Einaudi.
1998 Pittura e scultura nei Cinquecento (a cura di) , Livorno, illabe.
Baro lini , T odolinda
2003 La {{Commedia senza Dio. Dante e l.a creazione di una realt virtuale [1992],
.Milano, Feltrinelli.
Barthes, Roland
1973 '!Z: lettura di arrasine di Balzac [1970} T01ino, Einaudi.
Bartuschat
2007
Johannes
Bath, Michael
li ritratto di Laura (&j 76- O) , in !l Canzoniere. Lettura micro e macrote-
stuale, a cura cli 1. Picone, Ravenna, Longo pp. 207-223.
1994 Speaking Pictures: Erwlish Emblem Books andRenaissance Culture. Lonclon
and New York, Longman.
Baxanclall , Micbael
"1963 A Dialogue on Art /rom the ourt o/Leonello d'Este, in Journal of the War-
burg and Courtau.lcl Jnstitutes XXVI, pp. 304-326.
1994
2009
Bcer, Marina
1996
Bclloni, Gino
1992
Giotto e u/i umanisti. Gli umanisti osservato1i della pittura in Italia e la sco-
perta della omposi-:.ione pittorica 1350-1450 [1971 ], filano, Ja a Book.
Parole per le immagini: I arte rinascimentale e la critica [200. ]. edizione
italiana a cma di F. Peri
1
Torino, Bollati Borin hie:d.
Idea del ritratto femminile e retorica del classicismo: i Ritratti di Isabella
d'Este di Gian Giorgio TI-issino Post-scriptum sul ritratto letterario, in l'o::.io
onorato. a.ggi sulla cult.ura letteraria italiana del Rwsdmento, Roma, Bul-
zoni, pp.13. -161.
Laura tra Petrarca e Bembo. tudi sul commento wnanistico-ri.nas imentale
al Canzoniere, Padova, Antenore.
Benassi .lessandro
2008 Tanto di senso copioso, e abbondante. ;ot:e sulla\ irginia di Ercole Tas-
so in on parola briel.e e con figura. Emblemi e imprese fa antico e mo-
3 7
demo. tti del ,onvegno Pi a, 9-11 dicembre 2004 a cma di L. Bolzoni e
. Voltcrrani, Pi a. Edizioni della ormale, pp. 421 -450.
B nini. andro
2000 L'inattinuibile realt dell'illusione: presen=.a ed assen::.a di Laura nel Can-
zoniere, in Petrarca e i suoi lettori, a curn di . Caratozzolo e G. Giintert,
Ravenna, Lonuo, pp. 91-107.
Benvenuti. Antonia
1963 Timoteo l'onor de Bendedei in Giornale torico d ila Letteratura Italia-
na, CXL. pp. 48- -488.
Bertolani. Maria Cecilia
2005 Petrarca e la visione del! 'Eterno Bologna, Il Mulino.
Bertone, Giorcio
2008 Il volto di Dio, il volto di Laura. La questione del ritratto: Petrarca Rvf XVI
LXXT'll. LXXVII! Genova Il melangolo.
Besomi. OttaYio
1988 chede per la Galeria, in Lettere italiane, XXXVIII pp. 510-521.
Be i. Ro sella
1987 ul commento di Francesco File/fa ai Rf!F, in Quaderni petrarche chi, IV,
pp. 230-270.
Bettini, Maurizio
1984 T:a Plinio e. ant Petrarca sulle arti figurative, in Memo-
na dell antr.co nell arte italiana a cura di . ettis, voi. I: L'uso dei classici,
Torino Einaudi, pp. 221-267.
1992 Il ritratto delL amante Torino, Einaudi.
Beyer, Andrea
2002 Das Portriit in der Malerei, Miinchen 1-lirmer Verlag.
Bianchi, Ales andro e Torre, ndrea
2003 Disegni poetici. Bajardi, Hpino, Marmitta, Torelli, in Aurea Parma,
LXXXVII, pp. 181-206.
Bianco, Monica e trada Elena (a cura di)
2001 l " h. . ., 'fi . .
Bigi. ilvia
1989
ptu vag te t ptu soavt wn. 'tudt sulle antolouie di lirica del Cinquecento
AJe sandria, Edizioni dell'Or o. b '
Le Rime di diversi a cura di Dionigi Atan.agi in antagata e Quondam
1989, pp. 239-241.
358
Boccolari Giorgio
1987 Le medaglie di Casa d'Este, pre entazione di C. Johnson, Modena. ede .\ifu-
ratoriana.
Bolzoni , Lina
1995 La stanza della memoria. Modelli letterari e iconografici nell'et della stam-
pa, Torino, Einaudi.
2002 La rete delle immagini. Predicazione in volgare dalle origini a Bernardino da
iena, Torino Einaudi.
2008 Poesia e ritratto nel Rinascimento, te ti a ura di F. Pich. Roma-Bari. Laterza.
Bongrani, Paolo
1986 Lingua e letteratura a Milano nell'et sforzesca. Una raccolta di studi, Par-
ma 1ver it d gli tudi.
Bortoletti, France ca .
2008 Egloga e spettacolo nel primo Rinascimento: da Firenze alle corti. Roma. Bul-
zoni.
Brock, Maurice
2002 Bronzino, Pari Flammarion.
Branzini
1977
Giovanni Batti ta (a cura di)
Fransci Galeoti equitis ac baronis opu.sculurn (Cod. Estense a. iv!: .32,.
MCLX Vffl: sec. X/i) in Testi e temi di Letteratura popolare, vol. 3, Ban,, drianca.
Brown, David Alan
1983 Leonardo and the fdeali::ed Portrait in Milan, in Arte lombarda, 67, pp.
1987
2001
102-116.
Andrea olario Milano, Electa.
Virtue an.d Beauty. Leonardo :S Cinel'ra de' Benci and Renai.I ance :ortra.its
of Women , Catalogo della mostra Wash.inuton, Gall ry oJ .1t 30
ettcmbre-6 gennaio 2002 Princeton Princeton UmYer 1ty Pr .
Bruni
1988
1988b
France. co (a ctu-a di) .
apitoli per una storia del cuore. aggi sulla lirica romanza, Palermo,
Biidel, O car
1975
Le costellazioni del cuore nell'antica lirica italiana, in Bnrni 1988, pp. 9-
118.
Parusia Redemtricis: Lauras Traumbesuche irz Pctrarcas Canzoniere, in
Petrarca .1304-1374. Beitriige ;:;u Werk und TVirkung n cura di F. chalk.
Frankfurt V. Klo terma.rm pp. 33- O.
359
il
Burofo. E11r>11io (a rnra di)
2001 Racconti di w11cwi11i: trentotto rnpitoli sui poteri della mppr<sento::June nel
\/edioero occidn1tale. Edi1.ioni dcli' l'!'>O.
Camille. \l ichael
1998 The .lfediernl lrt o/ Lor<'. Objects and 'ubjects o/ Desire. London. Laurrncc
1': ing.
CampbelL Lorn
1990 Renaissance Portraits. European Portrait-Painting in the /-1th, l.5th w1d
16tlz C'enturies. '\ew I Ia,cn-London. Yalc Cniwr. ity Pn
ampbelL
2006
l phen J.
The abinet o.f Eros: Renaissance t/w/oo-ical Paintw ali(/ the, 'tudiolo o/
Isabella d'Este.:'\ ,,. Hm n-London. Yalr Cni,er it) Prrs .
ardini. Rob rt oppini. DonaL Ila (a cura di )
200-t Petrarca e lo-ostino. R ma. Bulzoni.
'annata. :\ac:lla
2000 li can=oniere a stampa (J-1 ";0-1530). Tradi=ione e fortuna di un genere fra
storia del libro e lelleratura. Roma. Baaa110 Libri.
'arrai. Lefano
1993 La lirica toscana nell'et di Loren=.o. in antaaata r ,arrai 199:3. pp. 96-
1-t-t.
199.- La corrispo11de11=a poetica di Fe!iriano con Giom1111i Testa Cille11io. i11 L"an-
tiquario Felice Feliciano l'eronese tra epigrafia antirn, lettemt11ra e arti del
libro. a ura di .\ . Cont. Padorn. \ nt norr. pp. 17 . -196.
1996 Il can=oniere di Giocanni Della Casa dal progetto dell'autore al 111w1eo--
o-iame11to dell'edi=ione po tuma. in Per esare Bo=zetti. 'tudi di lettemtura
e filologia italiana. a cura cli '. lbo11iro. . omJJoni. C. Panizza '. \ 'eia,
\ lilano. F'o11dazionc Arnoldo AlhC'rto ndadori. pp. -+?1--+98.
C:a ru o. Ca1fo
1991
:W02
:2009
Paolo G'io1 io e Ciol'an Ballista Marino. in Giornale ,' 1ori"o dr Ila Lett ' ratura
Italiana>. ' L YfII. I p . . - +8-t
, 'ag{{io di <0111mento alla Galeria di (;. B . . 1/arino: 1 (esordio) e 6:2-1 (rpilo-
o-o). in e 10., p. 71-89.
/,a Ga lr ria: questioni e proposte <'.egetic/1r. in .I /arino e il Barocco, da 1\'apoli
a P((rigi. \ tti cl I rort\'Po-110 Basi lra. 7-9 "iuano 200 . a cura di E. Ru o,
\I . a miria. Edizioni dell'Or. o. pp. 185-207.
:360
Ca ini. Tonunaso
200J /,a questio11e fisio"no111ica 11ei libri di ritmi/i e biowafie di uomini illustri del
secolo \'I/. i11 Po11t1'(moli :200:3. pp. 10'.3-11 ?.
200-+ Hitmlli parlanti: collezionismo<' biografie illustmte nei secoli Xl 7 e XIT/. Fi-
nn11. Edifir.
Ca. trlnuO\'O. Enrirn
197:3 li del ritmi/o pi/torico nella societ. in 'toria d1talia. Tm-in
Einaudi. \OI. \ '. pp. 10:3:l-109-t.
2000 IA1 calledmle tasrnbile. 'cri/li di storia dell'arte. LiYOrno . . 'illab .
Ca.,toldi. ... imo
1989 Per il /Jeatrici11111. i11 c()uadcrni di Filologia c Lill!me Romanze. pp.
:3:3--+9.
1989b 7'uwteo /Jendedei e un rnn:;oniere per /Jarbara. in 't udi e problemi di cri-
tica xxrx. pp. 6. -89
.
J 999 Tmnslata proficil arbos. /_,e imprese eteree nelle R1111 del Tasso. in lta-
Jiqur. 2. pp. 81-111.
200-t Romana diffirnltas. I Cento sonetti e la tradi=ione epicrrammatica. in r -
rnmtr 200-t. pp.
Cr chi.
1991 Il Bron:dno. Be11ede110 J archi e/' lcc(l(lemia Fiorentina: 1.i poeti;
temti <'personaggi illustri della Corte Medicea. in \nt1ch1ta \ 1va. ' X.
pp. 17-28.
Chapman. 1 lugo. I Tom c Plazzotta. Carol (a cura di ) .
200-t R<d"faello da l rbi110 a Ho111a. :atalogo d Ila tra_ : :111011al
20 ottohr :WO-t- 16 grnnnio 200:-. )lilano. . C.0111 menB Ed1!1011 .
Chrssa. , ' ilvia
,aJI IT.
2005 lf proji11110 del sarro nel Ca11zonierc di Petrarrn. Fir nze.
liorrnt ina.
oriet editrice
Ch iodo, Domenico .
200? J'orc/1i rimatore: modi e forme della poesia di . .
J
. / 1-oJ_J _6 _ \ 1ti cl I comrrno Fir nze. I 6-1. licembr _00:3, a ct11 a
<lii 11 ,J J ,.. 71
di \". Brnmanti. R ma. Edizio11i di . 1oria lettera tura. pp. I. - I
'iardi, H1 brrf Pn lo
1968 rl 111 brogio fi'gino. Fin'nze. e Brrtolli.
361
C:iaY lrlla jJa, imo
1 Q92 Eros e nwmoria nella cultura del Rinascimento. in La cultura della memoria.
a cura di L. Bolzoni e P. .or i. Bol !ma. li pp. 319-' -t .
Ciccut . jJarccllo
1991 fi!{ure di Petrarca. Giotto, imone Martini. Franco bo/ocrnese, l apoli , Fedr-
1i c. :\rdia.
' ieri Yia. .laudia
199-t L'immacrine dietro al ritratto, in Il ritrailo e la memoria. Mat eriali 3, a cura
louah.
1963
di A. ntili. P. :\Iorel. . i ri Yia. Roma. Bulzoni . pp. 9-29.
cii I I.
Pietro Bembo, Madonna G .. Berenice and f'eronica Gambara. in 'omrnen-
tari dell'Ateneo di Br ia. LXII. pp. 209-217.
ola.santi. Arduino
1903
190-t
onetti inediti per Ti=iano e Jfichelangelo. in i uo\'a antoloaia, / \111.
pp. 2 9-286.
nella poesia del Rinascimento. Fonti poetiche per la storia del! arte
llaftana. in cR pertorium for Kun rni n chaft. ' X\11, pp. 193-220.
oliar ta. jfarco
1988
2003
200.
arti sorelle. Teoria e pratica del paragone, in La pillura in Italia. Il
mquecento. a cw-a di C. Briganti. Milano. IL pp. 369-. 80.
Jlodi di pre entarsi: la fio e L'suale nella ritrattistica auwnoma. in f'isuelle
topoi: Efindun
7
und tradiertes ll'issen in den Kunslen der italienischen Re-
naissance. a ura di . Pfi t rer. i\1. idei. Drut cher Kun tv rlag
pp. 131-1-19. ' ,
f e le artifig_uratice. in Benedello f'archi 1503-1565. tti dcl e nvcgno
Fir .nze, 16-1. dicembr 2003. a ura <li \ '. Bramanti. Roma, Eruzioni di
ctona r I tt ratura. pp. 1 3-18-t.
Collarile. [ ui!!i e Daniele
200-t .Yel libro di Petra1:cas Liebe:gedichte in der Renaissance =La posie
de Petrarque a la Renmssanre =La poesia lirica di Petrarca nel
Rmasc1mPnto. Ba I, chwab .
Co111boni, Andr a
198 Per L'edizione delle rime di ntonio ornazano. in e t udi di filo]oaia italiana
XL\'. pp. 101-H9.
1989
2003
Comazano. in, antagata Quondam 19 9, pp. 123-
Due canzonieri: Boiardo e ornazano. i11 Gli rnorum libri e la lirica del
Quallrocento con altri studi boiardeschi a ura di . Ti . oni B nv nuti .
. ovara. Interlinea. pp. 6 -80.
. 362
Co11li ,
1979
le andro
L'el'o!uzione dell 'artista. in wria dell'arte italiana. Questioni e metodi. a
cura di . Pr vitali , Part prima. Materiali e problemi. voi. II. Einau& Tori-
no, pp. 11 . -263.
Contini
1980
Gianfranco
Petrarca e le arti figuratil'e. in Francesco Petrarca Citi::.en of the ll'orld. Atti
orldPetrar h omrr .. -13april 19 -t ).acuradi
. . Bernardo Padova-Alban ' ntenor - 'tal l niv. of "' York Pr . pp.
11. -131.
oor. rtrud
1961 1 eroccio de ' Landi l-14--1500, P1in ton. Princ ton L'niver ity Pre
ordellier, Dominiquc (a cura di )
Documenti e fonti su Pisanello (1395-15 1 circa), a cura di O. orci lii r
( n la collaborazion di . B rg nzoni. P. :\larini. B. Py. Yaranini ),
nurner monoornfico cl lla rivi ta \'er na illu trata. 8.
Corradini Elena
1998 !fedallic Portraits of the Este: Effe. ies ad iitwn expressae, in e y on
1998, pp. 22-39.
Co utta Fabio
2004 Tra iconolocria ed esegesi petrarche ca. Xote sulla Laura Q11eriniana. m
cHumanita , LIX pp. 66-82.
o tamaO'na, Philipp
199.f Pontormo Milano. I ta.
Co irainia
006 Allra1 erso lo specchio: le petrorclzi.ste del inqllecento e /'eredit di La11ra,
in Petrarca. Canoni esemplarit, a ura cli V. Finu ci. Roma. Bulzoni pp.
11 -H .
2008 Women s ll'riting in /tal); l-J00-16.50. Baltimor , John Ilopkin "niv r ity
Pr
ran t n Jodi
2000 Tlze Poetic of Porlraiture in the ltalian Renai ance. ambri IO'e. ambridcr
ni cr. ity Pre
r manl R nzo (a cura di)
2004 La lirica del inquecento. Giomata di ludi in memoria di esare Bo::.:.etti.
AJe andria dizi ni dell 'Or o .
Cropp r. Elizabrth
1076 On Bea11t!f11/ ITomen. Pan11i{{ia11i110. Petrarc/11110 and the femornlar
in .\rt bullrtin. L\'lfl. pp. :3. -l-39-+.
198;- Prolego111e11a lo a .\'e11 /11t eqJretatio11 of Bron:;ino s Plore11ti11e Portraits in
Renaissance tudies i11 I lo11or o/ raig I lug!t 111yt!t . a cura <li A. lorrough et
al.. Il. Firrnze. imui Barbrra.
JC) 6 The Bea11z1 o/ IT0111a11: Problems in the Rhetoric ofRenaissance Portraiture.
in Re1rriti11g the Renai sance. The Di courses of ...e.mal Diffre11cr in Earlr
.llodem Europe. a ura di .\l.\r . .\I. Quilligan . . -. Yieh.rrti.
The Cniwr ity of Chicago Pre . pp. 1 5-190.
'urtiu:>. Ern t Robert
1992 Lelleratura europea e Jledio Eco latino [ 19-+8]. candicri. I a \ uorn Italia.
Dak P t r \I.
1998
literature in tlze liuht o/ the Emblem. 'trnctural Parallels betireen the Em-
blem and Literature in the i:rteenth wul ..,ecenteentlz enturies. Toronto.
C1riv r ity of Toronto Pr
o.\Jes
0
amu . france ca
:2006
Petrarca _di Ciorann! Della Casa. in Ciol'anni Della Casa: un seminario per
il ce11te11ano. a ura di \ . Quondam. Roma. Bulzoni. pp. 191-n ..
Damianaki Romano. hr\' a
1998
2000
Come_se fiLS_ i e rilrattislim e lirica cortiuiww tra Quallro e Cinque-
cento. m cB1bh th que cl f !umani me t Rrnai anre. LX. - pp. 3-+9-:39t
The female portrail busts of Francesco Laurana. \I anziana. Vrrchiarelli .
De Laud . ' ih ia
1989-1990
_ontri?utf conce::.ioni della bel/e::,::,a femminile 11el medioPl'O. l niver;.it
d1 Pana. fi ...1 di laur a. ,\nno accadC"mi<'o I 989-1990. dattil critto.
200.-
studi s11 Emst RobPrl urtius e, lf'arburg, apo-
11. lmpnnt lilm.
Drlboulle. ,\chillc
1891
. et !es wwcrontiques. Tcxte anc avcc le. t raduct rt
urntal1011 de poete du \ ' 11 irlr. 1 lan . Lrmalc.
Di B nedrtto. \rnaldo
1996
Due note sul 'l'asso P il Oella asa. in Id. . on e intorno a Torquato 'l'asso.
\apoli. Li cruori. pp. 1-+:3-1 s:3.
Di Girnlarno. 'o. tanzo
1988 Cor e co1:s: itinerari 111eridio11ali. in Bruui I 988. pp. 21-'+8.
Dilr111111i . Ci
1c 97
raio
2000
Giocanni Della Casa e il nobil cigno: a gara rol Bembo. in Per Giocarmi
Della Casa. Ricerche <' contributi. a cura cli G. Barbari i e '. BC'rra . .\liJano.
Ci alpino. pp. 9:3-122.
Da Ma11to1a a 1 apoli: i 'pretesti' asolani di GioL'llnni Muzzarelli e gostirw
La11d11/fo. in il prosi111etro nella lelleratura italiana. a cura di/\. C rnboni e \.
Di Ri rco. Trento. Dipartimento di ri<nze filolo!!"ich r toriche. pp. 31. -3-19.
Dionisotti . Carlo
I 9-+7 Ragioni mrlriche del Quallrocento. in Ciornalr ' torico della L lteratura Ita-
liana . C. XIV. pp. 1-3-t .
1962
197-t
1981
199:-
2002
.\'iccol libllmio e la lrtteratura cortiuiana. in Lrtt r italian . XI\'. pp. 33-:-8.
Fortuna del Petrarca nel Quallrocento. in cltaJia m dioeval e umani tica.
Il pp. 61-11:3.
La gallr>ria deuli 1Lo111ini illustri. in cLettere italiane. ; :Xlll. pp. -t83--+ -
, lppllnti Il arti e lettere . .\lilru10. Jaca Bo k.
critti :;u Bembo. a cura cli . \ria. Torino. Einaudi.
Doglio. \1aria Lui a
199:3 Ritrallo e maniera nelle Rime di lgostino Bea:.iano. in Il egr tario e il
principr: studi s1Llla letteratura italiana del Rinascimento . \1 andria. di-
zioni delrOr o. pp. 101-108.
2006 I zwsi d1/Jinti. 11 so11ello CXL (e altri sonetti in ritratti): in ad .. li se"retario,
la cena, i l'ersi d1/J1ti. Tre studi Sll sonelli del Petrarca . . \1 andria. dizio-
ni drll"Or.,o. pp. :39-. '....
Donato . .\lari.a 1onica
200:3 Petrarm e ali artisti. in .Il diorro: i111111aai11e e racconto . . \tti drl Conwgn
int rnazional di . tudi (Parma. :27-:30 rtt rnbr a cura di . Quinta-
vali . Elrcta. pp. 13: --+.);).
Diilb rg.
1990
ncrelica
Pril'atportriits. Ceschichtc 1111d lko11oloaie einer Gattww im 15. und 16.
Jahrl11u1dert. Brrlin. \lann.
Dundas. fodith
1988 ldrice-to-a-painter Poe111 : I lori::.011s Genre. iu Trord ali(/ f i:mal lnuwi-
11atio11. , 'tudies in thc lnteraction of Liw/ish Literalure and the I t:ual , lrts. a
rum di K.J. lloltr 11 r Erlang n- iirnh'r
1
. l'nivr:.itat-.hund. PI .
1 . - I -+6.
Duprrray. Ev
199;- L'or de 1110/s. caleria' (/"ww triade myt!tique: Ptrarque, Lr111re. f (wcltw>.
' ntni11r-de-\'n11cln;. '.
199. L'or des mot . Une lecture de Ptrarque et du mythe littraire de f'aucluse des
oriaines I ore du XXe icle, Pari . Publi ation d la orb 11n .
Ekphrasi.s
199 num ro mon araf o della ri"i ta Word & Imaac>
llero. Pia
199 llltroduzione alla retorica, MjJan , an ni.
2009 \arciso e i ileni: il ritratto mentale nella lirica da Loren:=o a Ta so in cfta-
Jjanj tira>,: ' ' II, - pp. 2 1-283.
Farmer, 1 orman K.
1984 Poet.s and the f 'i.sual rts in Renai.ssance Ena/and, u tin, niv r ity of Te a
Pre .
Fedi, Roberto
cricere ui quadri. crittura e figura nel Rinascimento in La lolla con Pro-
teo: metam01fosi del testo e testualit della critica ttj d l VI n!IT o
Al LLI. niver ity of California, L 1a le , L 6-9 ttobr 199 , a
ura di L. Ballerini. G. Bardin e 1. Ciavolella, on la collab razi n dj F.
Frontini [et al.]. Fie ole. Cadmo.
Feldman. Martha
1991 TheAcademyof Domenico Venier. Musi Literary Muse in Mid-Cinquecento
Venice. in R nai ance Quarterly:.. 44, pp. 4 6- 12.
F enzi Enrico
2003 aggi petrarcheschi. Fie ole. ad.mo.
eo. licbel (a cura di)
2003 Petrarca nel tempo: tradizioni lettori e immaaini delle opere, catalo d ila
mo tra Ar zzo. otto bie a di an F ran co. 22 novembr 200 -2 1maio
Ferrari,
1892
2004.
erino
Di alcune imitazioni e rifioriture delle 'Anacreontee
in Giornale torico d Ila L tteratura ltaJiana>.
F rroni. Giulio e Quondam. Amed o
in Italia nel secolo XT1
pp. 39 -424.
19 3 La locuzione artificiosa. Teoria ed esperienza della lirica a apoli nell'et
del Manierismo, Roma. BuJzoni.
iorio, Maria 'D r a
2000 Giovanni Antonio Bo/tra/fio: un pittore milanese nel lume di Leonardo Mila-
no, Jan<l:i api.
366
Flaminj , Francesco
1892 Francesco aleola, gentiluomo napolitano del Quallrocento e il suo inedito
ca11zoniere, in iornal toriro cl Ila Leu ratura Ilaliana. XX pp. 1-78.
1 1 O Tra f'alchiusa ed Avig11one: la cena degli amori del Petrarca. 1 ote di topo-
grafia p trar hc ca, Torino. Loc cber.
Fra . o. ,iu ppc
1990 Antonio rifo postillatore dell'incwzabolo queriniano G V 15. in Fra o, 'a-
Fra o, Giu
1990
nova andai 1990 pp. 19-H.-.
ppe, Mariani an a Giordana andai. Ennio .
Illustrazione libraria, filologia e esegesi petrarchesca tra Quattro e Cmque-
e11to. Antonio Grifo e l'incunabolo queri11iano G f' 15, Padova. Antenor .
Fr dman Luba
1991: Titian s Portrails through Lens. niv rsity Park Pennsylvania ta-
t m r ity Pr
Fri drich Huao
197 Epoche della lirica italiana Il. Il inquecenlo, J.Wano. Mur ia.
Fry Paul
1995 The I forse. What Poems see in Pictures, in A defense of poetry: Re-
fleclions 011 the Occa ion of Jl'riting. tanford. tanford niversity Pre . PP
70-90.
alland-Ilallyn P rrin
19 'f . Le reflet des fleurs. Desfl'iption et mtalanga e potique d'Homre la Re-
naissance, n' ve. Droz.
alli Aldo Pie i nini hiara Ro i. la imilian (a cura di}
' ' , F'
2007 Il ritratto nell'Europa d I Cinquecento. tti dcl onvegno ucnz
nazi naJ , di tudi ul Rina ciment -8 nO\'embre 2002. Fii nze,
Gallinaro. llaria
I tituto
l hki.
19 f castelli dell'anima: architetture della rciaione e del cuore nella letteratura
italiana. I irenz . Ol hk:i.
Crugano,
1988
CDLI
1961-2002
ntoni
imago mentis: fantasma e ueatura reale nella lirica ca tialia11a del in-
quecento in Bruni 1 88. pp. 181-2 .... 0.
rande di::.ionario della lwua italiana, t ndato da . Battarrlia, orin . l t t.
Crntili .. \ugu 10
I Da Ti:ia110 a 'll':iano. I lito e allegoria nrlla rn/turo re11e::.ia11a dr/ Ci11q
11
e-
ce11to. Roma. Bulzoni.
e mili. \ugu (O. .\lorel. Philippe e Cirri \'ia. Claudia (a Clll'H di )
1989-199-t Il rilrallo e la memoria. :} voll .. Roma. B11lzo11i .
iachino. Lui;, Ila
:..001 Dal/"effimero /eatrale alla q11ef(' delli'111111orta/it. Le rime di !sabri/a . l11drri11i.
in cCiornalr ' torico della Lctt ratura Italiana , L\,\ \Il!. pp . .'5:30-.).12.
ilbert. Cr ighton E.
t 991 Poets se<'ing lrtisls lfork. lnstances in the ltalian Renaissance. Firrnz('. 01-
!>Chki.
Ciunra. Claudio
:W02 f er. i a un de:tinatario . ... 'ag!!io sulla poesia italiana del lledioero. 11
.\ 1 uli:n o.
200.- odici. aggi sulla poesia dPl l!edioero, Bologna. Il \lui i no.
Coff n. Rona
1989 Cioranni Bellini. \ ew Ila, n-London. Yalr l niH'n.in
Corni. Cuulirlmo
1989
198%
1993
Il libro di poesia ci11quece11tesco. in 'antauata e 11ondam 1989. pp. :3:>--t 1.
Teronica e Il' altre. [mb/emi e cifre onomastiche nelle Rime del He111bo. in
I eronica Cmbara e la poesia dPI suo tempo nell'/talia settentrionale. \Ili
del Conwgno Br<' ria-Correguio. 1?-19 01 tohre 198S. a c11r11 di C. Bozz('tt.
P. ibelli.ni. F:. 'andai. Firl'nze. I d1ki. pp. -.5?.
lletrica e anali.i lelleraria. Bolo<rna. li .\Juli110.
Crrgori . .\lintJ {a rtu-a di )
1985 f ampi e la c11/t11ra artisti<'a rremonese del Ci11quecr11to. \1ilano. Elcrt11.
Crrrnblan.
1988
trphe11
' !1akespearea11 \'egotialions: tlie firculation of. 'ociaf 61erg1 in Renoi.w111ce
Oxford. Clarendo11 Prr " .
Cuthmiillrr. Bodo. l larnm. Brrnd1 Tonur nHu111. .\nrlr c1 (a rura di )
'.W06 und LitPrat: 'rhrift- und Buchk11//11r in der europiiischen Renais.mn-
ce. \\ 1e b11drn. J larra owitz.
I lag I rum. Jca11 I foward
19.-8 The i.ster hts. The Tradii io11 of Liter(lfy Pictorialism and English Poet 1y
/rom Dryden lo Gray. Chicago. l 'niver il) of Clii ago Prc;.!'i .
. 368
I lardi. 011 . (hborne Brn11 rt I
l %2 T/u> Endur1g llollwllent. I , 'tuc(r of tlir Idea of in lif Prary
Theor-y a11d Pmctice. Chap<l I liU. Thr l niH' r of orth 'arolina Pr ..
I liii . Crorgc Francis
198-t 11 Co1p11s of ltalian Medals of lhe RP1wissance Be/ore CPl!ini. Firr11zr. 'pe
(rrpri11t drlr rdizi nr Londra. Briti h \1u rum 19:30).
l lird1. \\i lii
I 981
I 98:3
Gian Gior<rio Trissws Porlral der fmbella d'Es!<>. fin Beitrag ::.ur L11kian-
Re::.eplio11 in ltalien. I lridelheru. \rint r.
, so1wllo d<'I Petrarca Per mimr Policleto a proca fiso. in .1Jiscella11ea di
studi in onor<' di littore Branca. voi. I: Dal .lledioPt'O al Petrarrn. Firrnzr.
Ol schki. pp. -t:3.)--H?.
I lollanckr . .lohn
1995 The Jiril: Poems , :peaking lo , 'i/e11/ lf'ork. o.fht. hicago. Lniver-
, ity of Chicago Press.
I lutton .
19:3:5 171e Creek 1111/iolo!n in lta(I' lo tlze lear I 00. Tthaca. Com li [ni,cr.,,,it) Pr
lunuale. Haffat' llu
199:3 Per /'edi::.io11e delle Rirnr di Bernardo lccolti detto /'l nico aretino. in cFilo-
louia e Cri1ira. \Tl!J. pp. 153-1 . -i.
Jack on-.'top:-.. (a rnra di )
198;) The Trea. 11re f lou es o( Britain: {ice lumdred years of Prirale Patmnaf{e and
lrt t' " ('Il. hlc. [ni' Pre "
.lager. Erir
2000 The Book o/lhe lleart. Chicaao. ni,er .. it\ of :hic<l"O Pre" .
.loukm sky. Franoi;,r
199 J Le bel objet . /,es pwwlis ari ificiel de la Plriade. Pa rb. Champion
Kirklrnm \ 'irtoria
I 998 /Jant e s Pl/(/nfo111, Prlmrch s ... j)rc/er: Bro11::.i110 .Por/mii c>f Laura l!att((erra
de1r/i t1111111w111ati, in I isibile parlare: lmages ofDonte i11 the Re11a1sar1ce. a
< ura di D. Park r (Lrctura Danti;., 1998). pp. o'
2006 /,aura Ra111ferra ali(/ fler Lilerary ire/e: 111 .Jntho!Of:,.11: The Other loice in
Mode;n E11ropr. :hi aYO. Cnher it) l f Chieu"o Pn'. .
369
Koo . J\lariann
:2006 Bi/dnis e des Begehrens. Das 6-rische Jl/annerportriit in der venezianisclzen
illalerei de.sfriihen l6Jahrh1111derfs: Gioruione, Ti=.ian und ihr mkreis Em-
dett n. Edition !morde. '
Krru12. Gi.bert
1981 Das Bilduedicht. Theorie. le.?.:icon. Bibliographie, Koln-Wi n Bohlau rlag.
Krieaer. Jlurray
1991 EJ.plzras. The 11/usion o/ the Xalura/ ign, Baltimore, Jolm IIopkin l ni-
,. ity Pre
Kri . Ern t e Kurz. Ouo
1980 La leuuenda dell'artista: un sauuio storico [ 19 9). Pre ntari ne di
lnuoYo. prefazion cli E.H. Gombrich Torin Bollati Borinahieri .
Km e.
2006
hri tiane
Dia_loge iiber J1edien: ;:;u Arelinos Briefen und Gedichten auf
Ti::.wns Portrals, 111 Guthmuller, Ilamrn e Tonn mann 2006, pp. 9 -120.
Land. Norman E.
199-!
The l'iell'er.as Poel. Renaissance Re :panse to Art. rniver il:) Park The
Penn ylvama tate ruv r itv Pre .
Lanaedijk, Karla
1981-198 The Portrails o/ the Medici. 15tlz-J th enluries. Firenze. pe .
Laur n . Pierr
1989
La vii1. lrvin
19 o
Uabeille dans celebration de l 'epigramme de l'epoque alexandrine
la fin de la Renmssance, Pari , Le B Ile L ttre .
On lhe ources and f eaning of the RPnaissance Portrail Bllsl in e rt uar-
terlp XXXllI. pp. 20 -226. .
L r k franoi
198
Longhi.
19 9
1989
'il via
la Chimre de Ze p t ,
il {' , l R . ,, uxts. or rall poel1qup el porlrait peinl en France et Pn
a Le a a enatssance, Tubing n, unter J\iarr rlaa.
Il lutto e le p ( L d'
. .l ne stslema L un canzoniere (Giovanni Della asa), in
e, tt urn nt1 enti 1>. XIII. pp. 26. -300.
Lellere a lpnofilo e a Teseo l r. . .
1
,
b
1 r . a voce ;emnum e nell PLem'a. in l'eronica Gm-
ara e ta poesw del suo le ll r l' . o ,
Bre eia- a . mpo ne Ifa La seltentnonalP, tti cl 1 on ano
, I I F?rr gio. 1 -19 ottobr 1985, a c11ra di C. 8 zz tti P. ib llini E.
anca. ' trenze. 01 chki pp .. 85-398. '
370
Luzio Aie
1893
2005
andro r Rrnirr, Rodolfo
Mantova e rbino: Isabella d'Este ed Elisabella onzaga nelle relazioni fa-
miuliari e nelle vicende politiche. orino-Roma. Roux.
La coltura e le relazioni lellerarie di Isabella d'Este Gonzaga. a cura cli .
lb 1co. introduzion di G. uo ti: indi i e apparati a ura cli . D Ila a a
[et al.] . Milano yl tr Bonnard.
Macola, 1 ov Ila
200 guardi e scrillure: fi. ure on libro nella ritrattistica italiana della prima
\laff i,
2004
onia
met del inquecento, nezia. I tituto eneto cli cienz . lettere arti.
piranli fattezze dei l'olti. Paolo Giovio e la descrizione degli uomini illustri
dal museo agli Elogia. in Ecfrasi. 1odelli ed esempi fra Medioevo e Rinasci-
mento, a cura di G. nturi M. arn tti. Roma. Bulzoni. pp. 23 -253.
J1a11!!i, Armando
1998 Il s e La doppia alterit: impre e e ceri in La Virginia di Ercole Tasso e in
Dli di Afaurice cve, in Id., Identit e impresa rina cimentale. Ravem1a.
Lon o, pp. 'i - 8.
2003 Il commento al oscuro>: la Dichiara:.ione> di Giuliano Goselini e la fine
del sapere rinascimentale. in Italiani ri a>, ' Xll. 1 pp. 11-28.
Maira Dani le
2007 1}posine, la dfrime mu e: formes ditoriales des canzonieri franais (15-H-
1560) , n 'v , Dr z.
Malinverni Ma imo
1998 La liri a l'ofuare padana tra Boiardo e riosto: appunti su llna hansi=ione
rimossa. in Il Boiardo e il mondo estense nel Quattrocento. tti d I on eano
cru1diano-Mod na-R aaio Emilia-Ferrara, 13-17 ttcmbre 199-:l, a ma di
. n hi T. 1atarre e pp. 69 -721.
2003 Rime liete o dolenti: influenze stilnotisliche nella Lirica settentrionale da
Boiardo ai poeti di fine eco/o in Gli Amomm Libri> e la lirica del Quat-
trocento, con altri studi boiarde chi, a cura di . Ti oni B nvenuti N \'ara.
Interlinea pp. 103-118.
1an a J
1989
2008
ph
The Presenlation of a Renaissance Lord: Portraitllre o/Ercole T d'E te, Duke
o/Ferrara(14-l-1505) in Z it h:riftfiir w1 tae chi ht >, .... ,-t.pp. - - -
5 8.
lflordpla , Gesture a11d fea11w in Leonardo da li"nci's ecilia allerani. in
rd & Tmagc, 24. 2 pp. 127-1 8.
. 1
.\Jancini. Franco
1988 Lafirum nel cuore Ira corte;ia e 111tica. \apoli. Eclizi ni cit'ntiJidu italiane.
.\lanferlotLi. l fano (a rnra di)
2000
lo scrillura e il rollo: /iown::.io11ifi:;iou110111ic/1e in le1terat111a
1
'"apol
1
' f
<' , , ,iuuon.
.\lan11. \icl1ola. r y on. Lukr
1998
The lmage o.f the lndiridual: Portraits in the Reuaissance. London. The Bri-
ti h .\Iu eum .
.\Iann. \ ichola
1998
Petrarch and Portrait . in .\lann e, y on 1998. pp. 1.- -21.
.\1antru1ari. Laura
:200;)
edite e inedite di Laura Battiferri deu/i lm111a1111ati. in ltaliani::.tica
X. XI\. 3. pp. 11-2 . .
.\Jarchand. J ru1-Ja qu
1998 1 d' d' t
_,e
1
perat 1_111to11w Te.ba/dea al mcconto dell'io, in Dal pri-
.\ lariani
1981
1990
allo scacco: I modellt narratu1 tlaliani tra Trecento e. eicento. a cura
dr G . .\1 .. \1nln11. con un amio intr dut1i,o di F R1'co R (' . . .
125-13 . r . . orna. ,aro((J pp.
'an rn. iordana
di fil/orino da Feltre Ira llanto1a e l erona. in ll'florino da
: tre e la sua scuola: umane imo. ped<wouia. arti. a I \ 1'iu111"tto.
Ftr nze. pp. 199-:212. r ura - '
Grifo illustratore dell'incunabolo o11erinia110 G I I
nan d I 1 in . .\la-
1 anorn e an a 1990. PI . 1-t . -200.
.\lartin lii. Bortolo
198.
La biblioteca (e i bem) di un p
1
. .
/
. .
/
. ,
d I . . . e tate usta.
11
1 ero111ca Gambara e la poesia
e tempo nel/ Jtalw settrnlr / cl I .
17 19 I wna e. ltr r omccruo Brr. cia-Corre11crio.
- otto >rr 198. a <ura di (' B . p .
1
. .
0
01 chki. pp. 21:3-26l. ' ozzrt11. ,, H'llmr. . .'andai. Firenz1'.
\ lazza Boccazzi. Barbara
2001
Cl pittura poes: !Jomenico Ti11torello P('r 1 I
"-I e LO lo no. in \'rnezia
que cnto. " . pp. 167-17.3.
'ili-
.\Jc-T::1u"hlin . .\lanine Panizza. L tizia (a ura di)
200. Pf>lrarclz in /Jritaiw l11temret .. I . , '
O J J O r Il .' . ,. eis, 1tulators, wuf lranslators orer -oo Jar.
x ore xwrc un er 1t) Prr
3 2
\lrnJrl ohn, Lcal rire
t Pam roni: Henedello f archis Due I zzioni and ( 'inquecenlo Art 111e01y. nn
J\rhor. l .\Il Br earch Pr
\le1walclo. Pier \'incenzo
C'
ZOO:) 7a due linguaggi. Irt e figura/ira e critica. Torino. B !lati Borinahi n .
\len 11lw1ti . .\!aria Lui a
C'
WO:> Il ritratto i11 cuore: peripe::.ie di un tema mediernle tra il profano e il sacro.
in Niscrillure del lesto mediecale. Dialogo Ira rnlture e tradizioni (Bergamo.
1+13 novembre 2 O:l ). a cura di .\f. . 'ammar ta. B raamo. e tante. pp .
.:l-83.
\lilani.
I C)8.) L"inrnnto. di I eronica Franco. in Giornale torico d Ila L tteratura ltalia-
ua. CCLXII. pf .
\linonzio. Franco
2006 L' spero di fare presto una iornndissima opera di soare e dolce brecit con
foppendice di molti eccellenti poeti (Paolo Giocio a Lelio Torelli [Di Roma,
il J:! di maggio 1 --I J). Elefantiasi manieristica e inrer. ione pro eltuale nei
l11ss11riosissi111i rersi deuli Elocria ciromm belli a cirtute ilhstrium di Paolo
Gioi io. in Periodico lrlla , ociet torica omrn c>. LX\'11.
\I nconcrhu) . Domi.nique
1992 Le pote co111111w1de w1 peintre: enjeu.r et e.ffets d'un modle potique (de
Runsard 'rndry ). in La Lic me>. pp.19-28.
\Jonta11na11i . Cri..,tiua
2006 la festa profana: paradiomi letterari e innorn::.ione nel Codice /so/diano.
Boma. Bulzon i .
\lortinu r. Ruth
196-t Catalocrue o.f Books aJl(f ,\Jwwscripts. Pt. 1. lench 16th- entw:, Book.
I lanard Colkgc Library. Drparlrnent o Prinling and Craphic Ans Carn-
l ridcr . Brlkuap Pr of IJan ar I Tnfrcr i.ty Pr ..,..,,
e. Procaceioli . Paolo e Ru (a rura di )
2009 lutowqfi dei letterati italiani. I. I li i11quece11to. 11.:;ul mm paleografie, cli
\ . Ciaralli. Roma. ,'al rno.
\fotta. liberto
200-t
Costiglion<' e il 111ito di l 'rbino. tudi 1t!la elabora::.ione del orle[iiano,
\'ita e rn.
PC'r /Jisabella. Il ritmtto della Duche sa di l'rbino nel Cortettiano di a ti-
glio11e. in Lt ttcr itnliane. L\ I, pp. L
; 73
ttola
199 t
[olfno, Aie andro e
1
atak :\lauro (a wa di)
Le muse e il principe: arte di corte nel Rina cimento padano 2
oli., M drna
Panini [Le .l/11 e].
1u u1i acchi. 1aria Pia
1989 Le rime necessarie nel roman::.o quattrocentesco, il1 antaaata Quondam
1989. pp. 111-11 .
199- L'"Cnico fonte del 1.arino, in e Ci rnale t rico della Lett ratura
Italiana> L:XH, pp .. 6- O.
1996 Le ottare epiurammaticlze di Bernardo Accolti nel ms. Ro siano 6 O. Per La
storia dell'epiuramma in io/uare tra Quattrocento e inquecento, in lnter-
pr . 1-, pp. 219-301.
' atale. (a cura di )
_oo
0
m Tura e Francesco del ossa: l'arte a Ferrara nell'et di Borsa d'Este,
Ferrara. Ferrara ,\rt .
1
uri. Anna ;\laria
1989 ulle Rime direrse di Girolamo Mu::io. in cRivi ta di 1 t:t:eratura italiana,
\1L pp. 431-446.
Negro Emilio e Roio, erta
2001 Lorenzo Costa, J.i.60-1535. Modena Aiiioli.
O'Brien. John
1995
nacreon Redil''u : a tud of Anacreontic Translation in Mid-
entury France. Ann rbor. Uni er ity f Michigan Pre .
ixteenth-
Padoan. Giorgio
19.8
e t pictura poesis: le pillure di Ariosto, Le poesie> di Tiziano, in Momenti
de/Rinascimento veneto, Pado a, ntenor. pp. 347-3 O.
Panof h rwin
'
1996 Idea: contributo alla storia dell estetica [1924], Fir nz , La Italia.
Pantani, Italo
2002
2006
La fonte d'ogni eloquenzia: il canzoniere petrarchesco nella cultura poetica
del Quattrocento ferrarese R ma, Bulzoni.
L amoroso messer Giusto da Valmontone: un protagonista della Lirica italiana
del XV secolo, Roma, alerno.
Parker, Deborah
2000 Bronzino: Renaissance Painter as Poe!, 'a.mbridg , ambrida
Pre .
374
niver ity
Pr<l r on, Jill
2008
,
I lenrico Boscano s T ola b ata: neu evidence for the Academia Leonardi Vinci
in Renaissance Milan. in R nai ancr tudi ,. 22, pp. 450-475.
Prdull, nna Maria Di Ri nzo, Michelina
19 9 Ero e thanatos nel romanzo barocco italiano. _ apoli. Edizi ni ientifi h
ltaliane.
Prlc, \1ilan
2002 lllustrium ima ines. Das Porlriilbuch der Renaissan e Leid o. Brill.
Prllerrrino, France ca
2003 Elaborazioni di alcuni principali topoi artistici nei oryciana. in Visuelle topoi:
Erfindung und tradiertes I f 'issen in den Kiinsten der italienischen R nai.ssance. a
cura di r _ Pfi t r r, \1. idei. \1iinch n. D u eh r Kun t:verl u. pp. 21 -262.
Peri, Ma imo
200-t Jfa il quarto dot '! lndauine sul topo delle belle::.=e femminili Pi a, E
Perilli. Plinio (a cura di)
1990 'toria dell'arte italiana in poesia, Fir nze. an m.
P rini . iovanna
2003
Petr echi.
19 2
Poems by Bolounese Painter. /rom the Renai sance to the Late Baroque, in
Poetry on rt. Renai. sance to Romanticism. a ura di T. Franaenb rg. baWl
Tya Donirnrton. pp. -28.
ioraio
/,,e rime del oppella. in Id., I fantasmi di Tancredi. auui sul Tas o e sul
Rinascimento, .altani tta-Roma ia eia, pp. 31' -3r.
Petteru1 i P Il arino. Pietro
2009 Ila ricer a di infiniti ensi. Il Di cor o di ontile su lift onetto di Goselini,
in Luca ontile da etona all'Europa. tti d l minari di tudi etona. 20-
21 ott br _00 , a cura di R. Gialiuc i. Ye hiar ili. pp. 6Q-139.
Pfi t rer l"I rich
2009 Ly ippus wzd eine / reunde. Liebe uaben und Gediichtni im Rom der Renai -
sance - oder Das er te Jahrfwndert der 1 dai/le, B rlin kad mi V rla
11
.
Pich, F d rica
2010 L'immagine donlla de la mente dalle Rim alla Vita 0 \' 8. nerrli Atti d I
nv imo Le Rime di Dante ( aro-nano d .1 arda, 25-:... tt mhr 2008) a
cma di . B rra P. Bora filan i alpino, in r o di tampa.
:.WlOh Per 1111a historia iconica dea;/i <!fletti: la poe.\'ia 11ello specchio della pifl11ra
(Rimr. -:'.1- -1) . in li debito delle /,fiere. Pomponio Torelli e la mlt11m diji11e
Cinquecento. a cura di,\, Bianchi. ,\ . 1rrc e l\. ,atelli. l '11i<'opli. in
orso di stampa.
Pignatli. Franco
2008 //ritmi/o del/'a111ata 11ella lirica del i11q11ece11to. in (?{fici11e del \11oro. So-
dali:.i.fra lellerati. artti l'd editori nella c11/tum italia11a ji'Cl Riforma e Con-
troriforma. \tti d I .'impo:,io inl<'rnazionale Ltrrcht. 8-9 no, rmbn 200 .. a
cura li 11. l lrndrix < P. Pr caccioli. \lanziana. \ erd1iarrlli. pp. :2()?-:HJ7.
Plazzot ta. Caro I
1998 Bron::Jno 's Laura. in e The Burlington \l agazi11e. HO. pp. 251-26:3.
Pollard. J. Crnham
198-t-198:- .lledaa/ie italiane del Rinascimento 11el .l!useo ll(onale del Rarael/o. :3. mli ..
Firenze. pe .
PoIJUni r. douard
2003 Il ritrai/o. 'torio e teorie dal Rinascimento al/"Ct dei /,umi [1998]. Torino.
Einaudi.
200 L"incen:.ionP delfortP nell'Italia del Rinascimento [:...00 . ]. Torino. F.inaudi.
Pontr moli . . \le (a cma di)
11 11 1 II' f'"
- t? o e g t /.Slognom1ca ed espresswne nelle arti del Rinascimento.
r\tt1 del romeano di studi Tori110. 28-29 n vrmhre 2001. FirrnJ:r. 01 chki.
Popr-1 Iennr .. y. John
1966 The Portmit in the RPnai.sance. Princ ton. Prinr ton l nfrrr. i1,-
Pozonr, Angela
....
19 .-+ l'n co11111'.e11tatore quallrocentes o del Petrarrn: Bemardo /l/iri11o. i
11
Alli
.\ccadr1rna Pomaniana. 11 .. ,' Hl. pp. :3?1-390.
Pozzi. CioYanui
1
9
9 cM!a do1111a nPlfa poesia rtini::.io i11q11ece11to e la pittura di Gior-
gt011e. m LC'ttC're italiane>. XXXI. pp. 1-:30.
199:3
1996
1996h
Pozzi. \lario
1989
.\Ota additita alla descn1 >fio fJll<'llae> i11 1(1 '
1
//' / d / 'b 1 /
\r
. .. ' I 01 O e l'lSl Il <' f JW' arr
dano. Adclphi. pp. 173-18-+.
''11/ in Jd .. 1/tematitn . .\.lila110. \drlplii , I p. H9-026.
Occhi bass1. 111 l<l .. Altematim. Mila11o .. Adelplti. pp.
Teoria e fenomeno/o ria della descriptio. 111 Id .. Lingua, rnlt11m, socie-
3 6
Prct<' . ,\oto11io
t. , sulla lrflrratwa italiana del ('i11q11rce11to. \le andria.
d ll"Or o. pp. 28--+0.
2001 Dello /011tw1<111::.a. in Arcipelago ,\/afi11co11ia. 'cenari e parole defrinteriorit. a
cura cli B. Frabotta, introduzione di J. I lillma11. Roma. Dorizrlli. pp. 290-30:3.
1987 Benedetto /'archi al!(/ the fi'.rnal Iris. m cJournal of thr \Yarburg ami
Courlauld 111 L. pp. 219-22-t.
Quo11dam, \ medeo
19 .-+ Petrarchismo mediato. Roma. Bulz011i.
1991 li naso di Laura. e poesia lirica 11ella tradi::.ione del lassici. mo.
d 111.L Pa11 ini .
Rama, !':lena
198:3 l"n tenlatico di rilettura della ritrallistico di Bo/tra/fio fra Quaflrocento e
i11q11ece11to. in e \rte lombarda. L I\ . pp . . 9-9:2.
Reinach. Adolphe
198:) Te.rtes arecs et latins relatifs a /'histoire de la peinture ancier111e. Recueil .llil-
liet [ 192 l]: a di '. Re in a h: int roduzionr e note di A. Romerer. Pari .
Macula.
Re11aissc111ce Faces. !(111 ,'rck to Titian
2008 a cura di L. Campi rii. \I. Falomir. J. Fletch r L. Lond n. \ational
Gallen
R \lat t o
200-t l11toportrait de /'artiste e11 feuil!e bla11clze. l'art comme mtaphore dans !es
po111es de ,\fiche/- l11ae. in e .roniqu itali 1111 ::.. 6. -+. pp. 1-21.
Ri11gho111. L' i,len
198-t /co11 lo i\'nrratil'e. The Rise o.f the Dramatic lose-l p in Fifteent!t- entury
Decotio11al Pai11tiiia. D( orn pijk. Da' aro.
Rivoh1 ti ,
:WIO
;hri tia11
uffa presenza di lriosto e di altri modelli lellemri e Jigumtiri nello Galert
di Giol'Gll /Jalli 111 ,\!arino. in Aiinste im Bildcr und Te.rie t Giambat-
tista ,llarinos Galeria, \11i d I .omrgno d I lerzog \ugust Bibliothrk-\\ ol-
f ubiil te], 1-3 111nrzo 2006. a cura di C. l\ru e<' R. tillc1 , . in corso di lampa.
Hobin. Dianu
2007
P11blishi11g Il 0111en: a/011 . the Pres es. t!te in 'i.r-
f Pe11th- e11t11ry lta(1. .hicaao. Th l ni' r ... of Cl11rago Pn...,
3T?
Ro()' r',
19 6 ormet on Female Portraitsfrom Renai.ssance 1\'orth lta6, in & lmaO'e>,
Il pp. 291- O
Ro and. Davi.cl
1981 Alcuni pensieri sul ritratto e la morte. in Giorgione e l'umanesimo l'ene::iano,
a cura di R. Pallu hini. Fir nze. 01 hki. pp. 293-. 08.
Ro enthal J.1ar()'ar t F.
199:.... The i ione t ourte an: Teronica Franco, iti::en and Writer in i:i:leenth-
Century T'enice. hicaO' . nher ity of hi a()'o Pr
Ro cnthal. Olivia
19 8 Donner 1oir: cn"tures de l'imaue dan L'art de posie au X l'le sicle, Paris,
IIonor' hampion.
Ro i. ntonio
1980 era.fino Aquilano e la poesia cortigiana. Br eia. forcelliana.
Ro i. France o (a ura di)
19 6 Ritralli lombardi e veneti dalla Accademia arrara, kira.
Ro i. 1a imiliano
2002 Da Durer a Tasso: proporzi.oni, fisio nomica e passioni per La retorica figuratil'Q
di Giomn Paol.o Gallucci, in Torquato Tasso e le arti. tti del Con egno di tudi
promo o nel i.nquant im di fondazi n d I 'entro tudi as iani 19 0-2000
(B rgamo, 30 ett mbr 2000), B fO'am . ntro di tud.i Ta i.ani , pp. 25-66.
Rothko.
2006 critti sull'arte. R ma. D nz Ili.
Rou t. J an
1981 Leurs yeux se rencontrrent. Pari . 'diti
Ruffno
200:- Gallerie . .1\tfarino e l immagine in esilio, in Marino 2005 pp.
IX- LVH.
Ru 11. Daniel .
1995 Emblemalic tructures in Renaissance French ullure. Toronto, ni er ity f
Toronto Pr
2002
H land Philip
The Omamental lmage: Memo1y. Decoration and Emblems, in Emblem l t11-
dies in honour of Peter M. Daly, a ura di M. Bath, P.F Campa, D .. Ru cli
Bad n-Baden. Ko mer. pp. 191-213.
1992 Palma Vecchio, 'ambrid(1e, w York. ambrid()'e niv r it Pr
8
abbatino, Pa quale
1997 La bellezza di Elena. Limitazione nella lelleratura e nelle arti fi.rmrative nel
Rinascimento Fir nz , 01 chki.
antagata Mar o
1979 La lirica aracronese. ludi sulla poesia napoletana del secondo Quattrocento
Padova nt nor .
1 84
1989
2
1993
La liricafellresco-romagnola del Quattrocento, in cRivi. ta di letteratura ita-
liana>, Il , pp .. 3-1 O .
Dal sonetto al anzoniere. Ricerche sulla preistoria e la costituzione di un
genere, Padova. Liviana.
Dalla lirica ' ortese alla lirica cortigiana : appunti per una storia, La
forma canzoniere, in antagata Carrai 1993. pp. 11-30 pp. 31-39.
antagata Marco e arrai t fano
1993 La lirica di corte nell'Italia del Quallrocento. Milano Fran o Angeli.
antaf1ata Marco e Quondam. Am deo (a cura di)
1989 Il libro di poesia dal copista al tipografo, tti d 1 onvem.10 Ferrara 29-31
ma()'gio 1987, Modena Panini.
aund r Ali on
1981 The teenth- entury Blason Potique B rne P ter Lang.
arpa, Emanuela
2003 chede per le rime di Giol'armi Della asa, \' r na., Fiorini.
arpati, !audio
1987 Intorno alle Rime di Ludovico Beccadelli, in Id .. Dire la ven.t al principe: ricer-
che uffa letteratura del Rinascimento filano Vita e Pen iero. pp. 45-126.
hlo er Juliu
199 La letteratura arti.stica. Manuale delle fonti della toria dell'arte moderna
[ 1924] Firenz , La uo a Italia.
hapiro M
198
heannan J
1995
2003
rr
Parole e immagini. La lettera e il imbolo nell"illu /ra;;ione di un te lo [19 3].
Parma Prati h .
ltn
Arte e spellatore nel Rinascimento italiano: on(r connecl ... [ 199 .... ], Milano,
.Taca Bo k.
R I I C' I d o e (1
1
3 160
11
" ' [ [.av n- ondon. \'aie ap 1ae lii .L:Jar.r Il o ent Ili " T - _ ,, n
niv r i1) Pr
37
her. tcphen K.
I 09-t The urrency o.f Fame: Portrait lledals o.f tlte Re11aissa11ce. London. Thamri>
and f in a" ociation \Yi!h tl1e Frick Collcc1io11.
:2000 Perspecl't' on the Re11aissa11ce .!leda/. a cura di .K. cher. \cw \ork-Lo11-
don. Garla1HI Pubi i hing . . \mcrican \fumi niatic . o i ly.
, chmi11. Lothar
2006 non I ottt ping r doeta manu . Oie heikle lllia11:; ro11 J..:iinstlem
und Gelehrten in derfriihen .\eu::.eit. in Gutbmiiller. I lam111 Tiinnc man11
:2006, pp. 195-:230.
iun rini. R dolfo
1980 Due sonelli di Filippo Xuroloni ad Jndrea llantegna. in tudi in onore di R.
ponuano. Bolouna. Boni. pp. l 6.)-1 2.
'im n . PatriC'ia
1995 Portraiture. Portraral. and ldeali=ation: Ambiuuous l11dil'id11alis111 in Rel)re-
. O I
sentations of Re11aissa11ce Il men. in Language and 111uzues of Renaissance
lta{1-. a cura cli .\.. Brown. Oxford. Clarrndon Pre:-. . . . pp. :263-:311.
mith. Palli J.
2006
Petrarch Translated a11d fllustrated in fan N111 der \oo( Thcatre (156 J. in
Petrarch and Hi Readers in the Renaissa11ce. a cura di K. . E. F.:1u nkel <' .lan
Papy. Leid n e Bo ton. Brill. pp. 289-:32.-.
pinclli. T letty (a cura di)
1892 Tersi del '-100 e del '600 attinenti a pillori od a cosP d'arte traiti da mss.
e pub?licati per le 110:;::.e f enri-.1/a:;=/i. Carpi. iu epp Ho i <o
T1p1 omunah.
'tiller-. Raincr
- 006 Bifder einer lusstellung, Ku11sluahme/1111u11<r in G'. B. Marirws Call'ra. in
u1miil1 r, I lamm e Tormr mann 2006. pp. 2.31-2. 1.
't iC'hita. \ 'ictor !.
200-t
2006
l'incen=ione del quadro (199:3). \lilano. il ,' aggiatorr.
l 'ejfello Pigmalione. Brel'e storia dei simulacri da Ocidio a Hitcltcock [2006 ].
.\lilano. il, 'augiator .
, 't inberg. Leo
197.) Ponlomzo '.s , l/essandro de' .\ledici, rn: 1 Unir I/ace Eyes .for Jo
11
in Art in
Amt>riC'a. 63. pp. 62-63.
, ' tnltlke. Cc1rl Brandon
198!)
Pontormo, , lfessandro de' Medici, and t /1<' Pala:;zo Paz:;i. i 11 Phi ladclph ia
111nof rtJ3111le1i11 .81/:H8.pp.:3-1S.
:380
Virginia
19? 1 Tlte Paintings and Orauing. of Dante Gabriel llosselli, London. larC'ndon
Pre
.\ nbro.
198-t La parola e il marmo [1976). Torino. Bollali Borinuhi ri.
Tacldro. E loardo
197-t IL manierismo letterario e i lirici rene::.iani del tardo inquecento. Roma. Bulzoni.
Tantnrli . Giuliano
]Q81 Cna rarcolta di rime di ioranni della asa. 111 tudi di filolouia italiana>.
' XL .pp.159-183.
[ '11a gestazione e un parlo uemellare: la prima e la seconda parie dei 'onetti
di Benedello I 'archi. in ltaliqm . 7. pp. -t3-100.
\nchi-.
:WOO Gioca1111i Re/lini. Milano. lecta.
Thom:on Dr Grunrnw11d.
19-:'5 n and Related fnscriptions in Giorcrione, 7tian. ancl Diirer. in c:\.n Bulle-
1 in >. L\'JI. pp.
Tinacrli . Paola
J 997 fl'omen in /talian Renai 'ance 1lrl. Gende1: Rt>presentalion. fdentit.i -.
ch t r. \!anche. ter l' ni' r .
'I oderi. Gi1N' PP e \'amwl. Fiorenza
2000 Le 111edcwlie italiane del .li 1 secolo. ;3 rnll .. Fireuz P li rampa.
Toma i. i ranro . .
200 l ;1/ uni aspelli delle anto/ouie liriche del secondo Cinquecento, 111 Bian
' trada 2001. pp.?. -111.
Torre. \ndrra
WO. Petmrchesrlzi segni di memoria. pie. postille. metafore. Pi a. Edizi ni della
\ orma le.
P I
. 11 . 11-1-6 (Raltimora. Il lrt
2008 Petrarca in emblema. er uno stuc IO <e 111.1. ' .
Gallen). in ('
0
11 parola briece e co11 figura. E111blr1111 e unpre'e. fra allttco. e:
, p q 11 d'., ili., ->OO-+ a rura d1 L. Bolzom l
111odemo. \tti dr! Conncrno . - tll 11
1
-
. Volt rrnni. Edizioni della pp. 1-86. . ...
2()()9 , 'aggio di liii rolllllll'lltO ad <'mb/emi petrarcftesrfti. in l1alia11i tica. \\\\ 11l.
2. PP 1
381
rapp. Jo eph Burn y
2001 Petrarch s Laura. The Portraiture of an Ima inary Belored, in cJournal of
th Warburu and OlLrtauld ln titut ,LXI pp. 5 -192.
Tro\'ato, Paolo
1991
?gn.i corr tlo. La stampa e le revisioni editoriali dei testi lelle-
ran 1ta!tant (1.J 0-15-0), Bolouna. Il lulino.
Turchi Marcello
19 2
Y cce arlo
199-
L'na via al Petra,-, lzi mo: il an::oniere di Enea lfirpino in e urea Parma>
L , pp. l --8.
olonna.: il codice epiA tolare della poesia femminile, in Les femmes
ecrwa'.ns en au Moyen Age et la Renaissance et du coli qu in-
temational Aix-en-Prov n e 12 13 1- nov mbre 199? p
. . , ' , - , i; - n- rov n e
ruver it de Prov nce, pp. 213-2 3.
ecchi Galli. Paola
2003
2006
erh yen,
19 1
Perc?rsi. quattrocentesca in l'olgare, in Lelegia nella tradizione
poetica LtalLOna. a ura di . Comboni D1' Ri o T t n . di
. . . . r n o 1partun nto
c1 nz filologi he e toriche. pp. 37- 9.
e poeta. Metamoifosi cinque entesche in Il petrarchismo: un modello di
poesLO per l'Europa. a cura di L. Chin , Roma, Bulzoni ol. I, pp. 189-216.
gon
The Paintings in the tud. l ,fl b ll d '1:'-
LO 0 01 sa e a I.:;;ite al 1antua,
ork ni r ity Pr
ork J w
i ker , ancy
1999
cattered Woman and callered Rh . v . .
d' . d' L yme, lil remLmsm and Renaissance tu-
ies, a cw a i . lJu on. Oxford ni er ity Pre , pp. 233-248.
illa. Aie andra
2006
illata An
2000
Istruire e rappresentare Isabella d'Est . 1 L 'b d .
Mario Equicola L p . . F . e. L L ro e natura de amore di
' ucca. aclil.l azz1.
Imo (a cura di)
urzio Conzagafedele d'amore letterato e politico
Torino 27-28 novembre 1999 Roma l' ,
ero a11e.
tti cl I on gno di tudi
illata,
1999
doardo (a cura di)
Leonardo da Vinci: i documenti l L . .
. d' p M . . e e estunonwnze contemporanee pr
z1on i . . aran1. Milano Ent ra . lta inciana. ,
nta-
82
aldman, Loui l xandrr
2000 "Tlze Modem Lysippus ": a Roman Quattrocento Medalist in onlext. in cher
2000, pp. 97-11 ..
V alt r. Jn11cborg e Zapp ri, Roberto
2006 Il ritrailo del/ amata, Roma, Donz Ili.
ebb, Ruth r lelen
1992 The Transmission of tlze Eikones of Philostratos and the Development of
Ekphra is /rom late Antiquity lo the Renaissance, te i (Ph. D). nivecity of
L ndon, Warbur11 In titute.
einrich, I Tarai l
19 9 Lete. rie e critica dell'oblio [199 ] Bolouna. li \.lulino.
el h E" lyn
199- rt and Authority in Renaissance 1ilan.
il\ Pr
w Haven-L ndon. Yal ' ni\'er-
Wil kin . Ern t lI.
1951 The Making of the anzonier and Other Petrarchan tudie . R ma. dizioni
di l ria letteratura.
Wood -Mar d n. Joanna
1987 Ritrailo al naturale: Questions of Realism and ldealism in Early Renaissance
Portraits, in Art J urna!. XLVI. pp.
1994 To11'ard a I listory of rt Patrona ere: The ase of Pietro retino, in Jollfnal of
1 di val and Renai anc tudie >. 2-. pp. 2 -299.
2001 Portrait of the Lady J.;30-1520, in Br \\'Il 200 L pp. 63-8 .
right. Ali on
2000 The Memory of Faces. Representational hoices in Fifteenth- entwy Fioren-
tine Portraiture, in rt, Mem01. and Family in Renaissance Florence. a eura
di C. iappelli e P. L e Rubin, arnbridu , Cambrid
11
"niv r ity Pr
Zapp ri Hobrrt
1 1 Al ssandro Farne e, Ciol'anni Della asa and Ti.tian' Danae in Xaple in
c]ournal of th \farbur11 and urtauld In titut > LlY, pp. 1- -1 1.
Zolln r, Frank
200r: The f otions of the Mind in Renaissance Portraits: The piritual Di men ion
of Portrailure io cZ it chrift fir Kun 1
11
chicht >. 68. pp. 23-..+0.
Zuliani, Luca .
..00 na coesione sen::.a coerenza (Rtf 11-:..0) in li Canz nier . Lettura 1111cro e
macro testuale a cura di f. Piconc. Havc1ma, L nao, PP 3-7
38
Finiro di . tamparr n I m r ~ di gi11 11110 2010
per ronto di M \Hl\ PACI'l UZlI F.OITOHE in Lucl'a
*
Potrebbero piacerti anche
- Zucca R Logos Peri Tes Sardous PDFDocumento192 pagineZucca R Logos Peri Tes Sardous PDFArcheoFerraraNessuna valutazione finora
- Marazzi FS MAYERDocumento39 pagineMarazzi FS MAYERmasmarazziNessuna valutazione finora
- Francesco Lanza e I Mimi Di Eroda: Storia Di Una Parentela ForzataDocumento171 pagineFrancesco Lanza e I Mimi Di Eroda: Storia Di Una Parentela ForzataFloraterNessuna valutazione finora
- De Planetarum Amuletis CCAG IXDocumento7 pagineDe Planetarum Amuletis CCAG IXpennyNessuna valutazione finora
- EsiodoDocumento5 pagineEsiodoPaolo RossiNessuna valutazione finora
- Tres DramasDocumento636 pagineTres DramasStavros GirgenisNessuna valutazione finora
- Di Napoli VelioDocumento153 pagineDi Napoli VelioRamón GutiérrezNessuna valutazione finora
- La Caduta Dell'Impero Ittita RecensioneDocumento4 pagineLa Caduta Dell'Impero Ittita RecensioneCostanzo ManesNessuna valutazione finora
- L'epicagreco LatinaDocumento2 pagineL'epicagreco LatinaJustin RodriquezNessuna valutazione finora
- Ulisse e Le Sirene PDFDocumento23 pagineUlisse e Le Sirene PDFMauro OrtisNessuna valutazione finora
- Aavv MemorieSeminariPavesi WebDocumento160 pagineAavv MemorieSeminariPavesi WebbuzzableNessuna valutazione finora
- OroDocumento106 pagineOroV.F.Nessuna valutazione finora
- Altro Glossario AnatomicoDocumento74 pagineAltro Glossario AnatomicoMartino HensNessuna valutazione finora
- Il Culo Parlante Da Il Pasto NudoDocumento1 paginaIl Culo Parlante Da Il Pasto Nudovanveen1967Nessuna valutazione finora
- Il Vocabolario CastellanoDocumento14 pagineIl Vocabolario CastellanoAndrea SerenelliNessuna valutazione finora
- Alfano Arcivescovo Di SalernoDocumento45 pagineAlfano Arcivescovo Di SalernomauriziusNessuna valutazione finora
- Le Tavole I-VI Della Serie Astrologica E PDFDocumento147 pagineLe Tavole I-VI Della Serie Astrologica E PDFShibtu01Nessuna valutazione finora
- Sargon Di AkkadDocumento76 pagineSargon Di AkkadGloria Gentili100% (1)
- Charmaine LeeDocumento9 pagineCharmaine LeegaetanoditriaNessuna valutazione finora
- Arquivo de Genova Século XIXDocumento230 pagineArquivo de Genova Século XIXJair DemuttiNessuna valutazione finora
- Cantar IDocumento22 pagineCantar IDario Viator GaudiusoNessuna valutazione finora
- Storici Greci D'occidente Ricostruzione Della Vita e Delle Opere Attraverso Le Fonti AnticheDocumento5 pagineStorici Greci D'occidente Ricostruzione Della Vita e Delle Opere Attraverso Le Fonti AnticheUnipaApprofondimentiNessuna valutazione finora
- Giuseppe Micali - Storia Degli Antichi Popoli Italiani Vol. 3 (1832)Documento383 pagineGiuseppe Micali - Storia Degli Antichi Popoli Italiani Vol. 3 (1832)leonardo7804Nessuna valutazione finora
- Pietro Da MOGLIODocumento10 paginePietro Da MOGLIOGennaroScannapiecoNessuna valutazione finora
- PelasgiDocumento5 paginePelasgiFederica AngeliniNessuna valutazione finora
- Abbreviazioni AutoriDocumento29 pagineAbbreviazioni AutoriRuggiero LionettiNessuna valutazione finora
- Mito Di ElenaDocumento63 pagineMito Di ElenaLunaNessuna valutazione finora
- Menico Caroli Timone Di Fliunte EuripideDocumento40 pagineMenico Caroli Timone Di Fliunte EuripideEvelinaNessuna valutazione finora
- Intrattenimenti e Spettacoli Nellegitto PDFDocumento15 pagineIntrattenimenti e Spettacoli Nellegitto PDFMaria Rita ManganoNessuna valutazione finora
- Cultraro Ex Parte Orientis. I Teresh e La Questione Dell'Origine Anatolica Degli Etruschi, 2012Documento42 pagineCultraro Ex Parte Orientis. I Teresh e La Questione Dell'Origine Anatolica Degli Etruschi, 2012Ro OrNessuna valutazione finora
- Guerre Stellari - WikipediaDocumento44 pagineGuerre Stellari - WikipediaKristina MooreNessuna valutazione finora
- Oggetti Fuori Dal TempoDocumento29 pagineOggetti Fuori Dal Tempogipi1975Nessuna valutazione finora
- Artemidoro Di EfesoDocumento3 pagineArtemidoro Di EfesoMatteoNessuna valutazione finora
- Chronicorum Canonum Libri II Angelus Mai PDFDocumento557 pagineChronicorum Canonum Libri II Angelus Mai PDFValentino NizzoNessuna valutazione finora
- Paititi La Scoperta - La ScopertaDocumento5 paginePaititi La Scoperta - La Scopertariccardofloris1Nessuna valutazione finora
- Allammiku La Sicilia Di Ibn HamdisDocumento3 pagineAllammiku La Sicilia Di Ibn HamdisessenetoNessuna valutazione finora
- Omero e La Storia P.carlierDocumento59 pagineOmero e La Storia P.carlierGildaNessuna valutazione finora
- Christine de Pizan e La Scrittura Della SagesceDocumento12 pagineChristine de Pizan e La Scrittura Della SagescemariapaneroNessuna valutazione finora
- Alessandro Magno e L IndiaDocumento38 pagineAlessandro Magno e L Indiapervincarum100% (1)
- Metamorf PDFDocumento82 pagineMetamorf PDFSara FaddaNessuna valutazione finora
- Quaderni Del Centro Mediterraneo Preclassico - Studi e Ricerche III (1) N. Bolatti Guzzo - S. Festuccia - M. Marazzi Edd. Naples 2013Documento410 pagineQuaderni Del Centro Mediterraneo Preclassico - Studi e Ricerche III (1) N. Bolatti Guzzo - S. Festuccia - M. Marazzi Edd. Naples 2013masmarazziNessuna valutazione finora
- Oro Di TroiaDocumento197 pagineOro Di TroiauomonuovoNessuna valutazione finora
- Landi, Carlo (Ed.) - Demogòrgone (Microform) - Con Saggio Di Nuova Edizione Delle Genologie Deorum Gentilium Del Boccaccio e Silloge Dei Frammenti Di TeodonzioDocumento130 pagineLandi, Carlo (Ed.) - Demogòrgone (Microform) - Con Saggio Di Nuova Edizione Delle Genologie Deorum Gentilium Del Boccaccio e Silloge Dei Frammenti Di TeodonzioVerónica Díaz PereyroNessuna valutazione finora
- Antologia Palatina. Libri IX-XI. Vol. 3Documento763 pagineAntologia Palatina. Libri IX-XI. Vol. 3Sisto PelusoNessuna valutazione finora
- Tesi Dottorato M.venutiDocumento324 pagineTesi Dottorato M.venutiNupelUfbaNessuna valutazione finora
- Rosell - de Mirabilibus Civitatis RomaeDocumento22 pagineRosell - de Mirabilibus Civitatis RomaeJoseph YarbroughNessuna valutazione finora
- Wilson Filologia Greca A BisanzioDocumento15 pagineWilson Filologia Greca A BisanzioPallino61Nessuna valutazione finora
- Hormos Ricerche Di Storia Antica 1 1Documento341 pagineHormos Ricerche Di Storia Antica 1 1alessandro coscia100% (1)
- Lebeti BronzeiDocumento53 pagineLebeti Bronzeidmarchiandi7186Nessuna valutazione finora
- Donato Loscalzo - La Catarsi TragicaDocumento19 pagineDonato Loscalzo - La Catarsi TragicaCosti TorreNessuna valutazione finora
- La Vita in Palermo Cento e Piu Anni Fa 1 Pitre PDFDocumento317 pagineLa Vita in Palermo Cento e Piu Anni Fa 1 Pitre PDFGiuseppe PassafiumeNessuna valutazione finora
- The Pyrgi Golden Tablets. A Selected BibDocumento14 pagineThe Pyrgi Golden Tablets. A Selected BibpspacimbNessuna valutazione finora
- Maraschi Andrea TesiDocumento419 pagineMaraschi Andrea Tesion77eir2Nessuna valutazione finora
- Poetry in The MorningDocumento144 paginePoetry in The MorningAntonio100% (2)
- Stalingrado. Il polittico di Vasilij Grossman.: Memorie plurali e memoria di StatoDa EverandStalingrado. Il polittico di Vasilij Grossman.: Memorie plurali e memoria di StatoNessuna valutazione finora
- La Pro Cluentio di Cicerone: Introduzione e commento dei §§ 1-81Introduzione e commento dei §§ 1-81Da EverandLa Pro Cluentio di Cicerone: Introduzione e commento dei §§ 1-81Introduzione e commento dei §§ 1-81Nessuna valutazione finora
- Archimede LatinoDocumento394 pagineArchimede Latinodumezil3729100% (1)
- Paolo Borsa - La Nuova Poesia Di Guido GuinizzelliDocumento265 paginePaolo Borsa - La Nuova Poesia Di Guido GuinizzelliBron BroniNessuna valutazione finora
- Tesi in Musica PDFDocumento59 pagineTesi in Musica PDFRita AmatoNessuna valutazione finora
- Canzoniere - AnalisiDocumento27 pagineCanzoniere - AnalisiGraziano LanzideiNessuna valutazione finora
- Talijanski - I Pronomi CombinatiDocumento2 pagineTalijanski - I Pronomi CombinatiMarijaDomovićNessuna valutazione finora
- Delpuppo Modernita e Nazione-LibreDocumento21 pagineDelpuppo Modernita e Nazione-LibreMariana AguirreNessuna valutazione finora
- Manuale Pratico Di Java - Vol. 1Documento446 pagineManuale Pratico Di Java - Vol. 1jbruiser100% (1)
- Garcia Lorca Gioco Teoria DuendeDocumento33 pagineGarcia Lorca Gioco Teoria DuendeMairondoNessuna valutazione finora
- Miles DispensaDocumento61 pagineMiles DispensaAnnaRitaNessuna valutazione finora